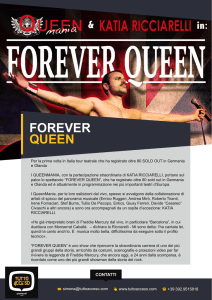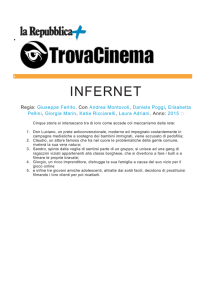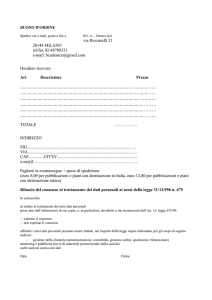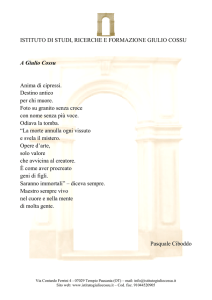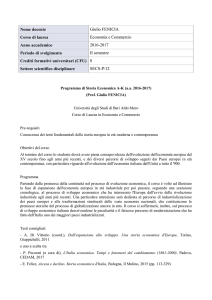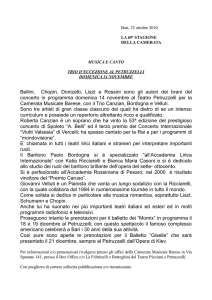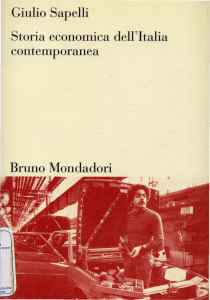IL LABIRINTO DEL SILENZIO
Giulio Ricciarelli
Titolo originale: Im Labyrinth des Schweigens. Regia: Giulio Ricciarelli. Soggetto: Elisabeth Bartel.
Sceneggiatura: Elisabeth Bartel, Giulio Ricciarelli, Amelie Syberberg. Fotografia: Martin Langer, Roman Osin.
Montaggio: Andrea Mertens. Musica: Sebastian Pille, Niki Reiser. Scenografia: Manfred Döring, Janina
Jaensch. Costumi: Aenne Plaumann. Interpreti: Alexander Fehling (Johann Radmann), André Szymanski
(Thomas Gnielka), Friederike Becht (Marlene Wondrak), Gert Voss (Fritz Bauer), Johannes Krisch (Simon
Kirsch), Johann von Bülow (Otto Haller), Robert Hunger-Bühler (Walter Friedberg), Hansi Jochmann (la
segretaria), Tim Williams (il maggiore Parker), Mathis Reinhardt (Fischer), Hartmut Volle (Alois Schulz),
Werner Wuölbern (Hans Lichter), Timo Dierkes (Peter Mertens), Susanne Schäfer (la madre di Johann).
Produzione: Jakob Claussen, Ulrike Putz, Sabine Lamby, Giulio Ricciarelli per Claussen Wöbke Putz
Filmproduktion/Naked Eye Filmproduktion. Distribuzione: Good Films. Durata: 124’. Origine: Germania,
2014.
Francoforte, 1958. Una pesante coltre di silenzio si libra sulla Germania, è nel cielo, nelle strade, nelle case, nei
tribunali, nel cuore e nella mente di tutti i tedeschi. Complice la disperata necessità di non perdere il treno dello
sviluppo economico, il Paese sconfitto durante il Secondo conflitto mondiale sembra aver dimenticato gli orrori
commessi qualche anno addietro, testimoniando il celebre allineamento tedesco che Hannah Arendt denunciò
con orrore e sofferenza.
«Sono in molti», scriveva la pensatrice nel 1948 «a condividere la responsabilità senza alcuna prova visibile di
colpevolezza», e Giulio Ricciarelli, milanese di nascita e tedesco d’adozione, dirige un film lineare e spontaneo
in cui, oltre a un’importante suggestione legata alla banalità del male, tenta di descrivere e pensare la Shoah a
posteriori, stupendosi di come le schegge di quell’esplosione mortale siano ancora conficcate nella carne e nella
coscienza delle vittime quanto dei carnefici, nonostante sia passato più di un decennio.
Il cinema si trasforma, come spesso accade nei film commemorativi, in un mezzo per testimoniare ciò che è
stato, opportunità per riaprire vecchie ferite e ripensare, tutti insieme, senza distinzione alcuna, a come i confini
che «separano i criminali dalla persone normali, i colpevoli dagli innocenti, siano stati erosi a tal punto che
nessuno in Germania era in grado di sapere se l’uomo di fronte a noi era un eroe o qualcuno che si è macchiato
di omicidi di massa».
Ricciarelli si muove proprio su questo territorio pericoloso, imbastendo un film che si muove tra la fiction e la
realtà storica, mostrandoci i disperati tentativi e le angosce morali che hanno portato al celebre processo di
Francoforte del 1963, dove, per la prima volta, la giustizia tedesca condannò ex soldati nazisti (alcuni
appartenenti alle SS) che avevano preso parte, più o meno direttamente, al genocidio ebraico.
Tra gli imputati ci fu Richard Baer, comandante dei campi di concentramento di Auschwitz e Mittelbau-Dora,
che al tempo viveva in tranquillità e serenità nella cittadina tedesca; ma non si trattò di un caso isolato: il regista
italiano, attraverso gli occhi del giovane avvocato Johann Radmann (Alexander Fehling), mostra come, grazie al
progetto di reintegrazione promosso dal cancelliere Konrad Adenauer nel 1949, moltissimi criminali nazisti
vivessero normalmente in Germania, come si fossero reinseriti nella società facendo i lavori più disparati (dal
fornaio all’insegnante) e come nessuno, nonostante gli anni trascorsi, fosse a conoscenza di ciò che avvenne nei
campi di concentramento («Cos’è Auschwitz?», chiede il protagonista all’amico Thomas Gnielka, giornalista e
sopravvissuto allo sterminio).
È proprio un labirinto verso la verità quello percorso dal giurista Fehling ma è un labirinto anche per Ricciarelli,
il quale, con lo scorrere del minutaggio, nonostante le interessanti riflessioni sulla natura umana e sui fantasmi
del passato, sembra perdersi in corridoi laterali e mancare la retta via che avrebbe condotto ad Asterione. La
pellicola, infatti, ricalca uno stile televisivo talvolta fastidioso e didascalico, in cui la regia si appiattisce su una
sceneggiatura ben strutturata ma troppo vasta, quasi onnicomprensiva, dove al vissuto personale del
protagonista, lacerato dall’amore per Marlene Wondrak (Friederike Becht) e dal crollo del mito paterno,
vengono accostati problemi filosofici, sociali e politici la cui trattazione è quanto mai banale.
Di una cosa, però, non possiamo non rimanere stupiti: il silenzio verso i carnefici che aleggiava nella Germania
del primo dopoguerra sembra, in fondo, non essersi mai completamente sciolto, anche nel Belpaese, e ritorna,
ogni volta più potente, quando ci facciamo convincere che tacere ed essere responsabili è meno grave che essere
colpevoli.
Alessandro Lanfranchi