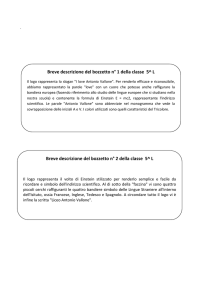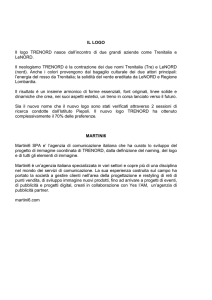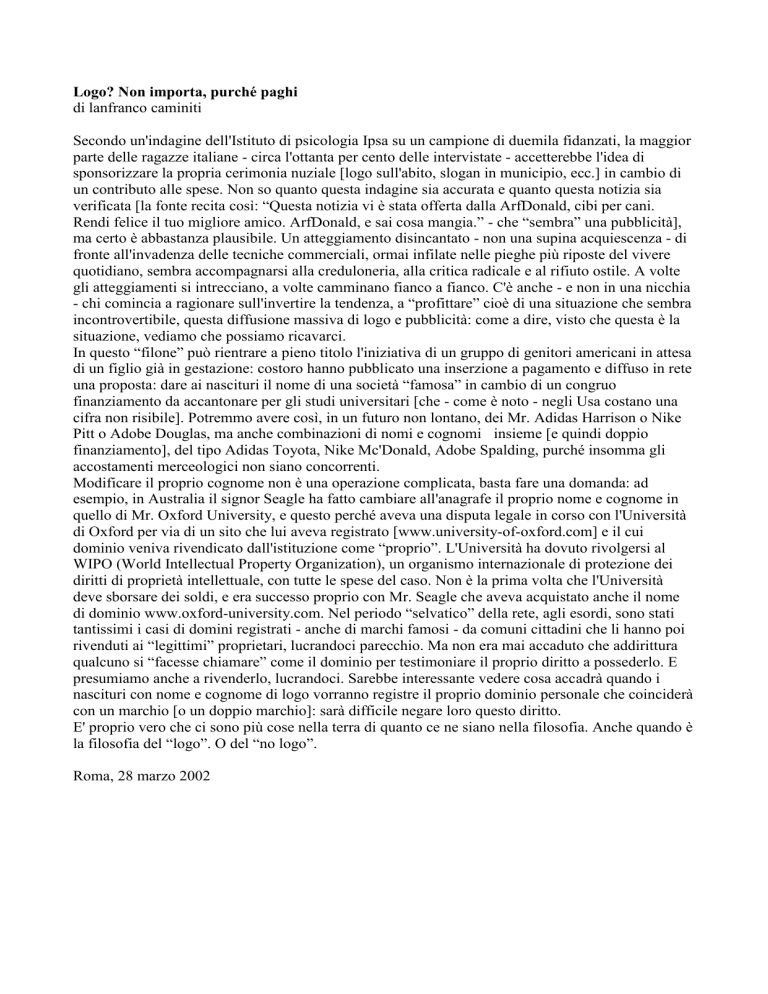
Logo? Non importa, purché paghi
di lanfranco caminiti
Secondo un'indagine dell'Istituto di psicologia Ipsa su un campione di duemila fidanzati, la maggior
parte delle ragazze italiane - circa l'ottanta per cento delle intervistate - accetterebbe l'idea di
sponsorizzare la propria cerimonia nuziale [logo sull'abito, slogan in municipio, ecc.] in cambio di
un contributo alle spese. Non so quanto questa indagine sia accurata e quanto questa notizia sia
verificata [la fonte recita così: “Questa notizia vi è stata offerta dalla ArfDonald, cibi per cani.
Rendi felice il tuo migliore amico. ArfDonald, e sai cosa mangia.” - che “sembra” una pubblicità],
ma certo è abbastanza plausibile. Un atteggiamento disincantato - non una supina acquiescenza - di
fronte all'invadenza delle tecniche commerciali, ormai infilate nelle pieghe più riposte del vivere
quotidiano, sembra accompagnarsi alla creduloneria, alla critica radicale e al rifiuto ostile. A volte
gli atteggiamenti si intrecciano, a volte camminano fianco a fianco. C'è anche - e non in una nicchia
- chi comincia a ragionare sull'invertire la tendenza, a “profittare” cioè di una situazione che sembra
incontrovertibile, questa diffusione massiva di logo e pubblicità: come a dire, visto che questa è la
situazione, vediamo che possiamo ricavarci.
In questo “filone” può rientrare a pieno titolo l'iniziativa di un gruppo di genitori americani in attesa
di un figlio già in gestazione: costoro hanno pubblicato una inserzione a pagamento e diffuso in rete
una proposta: dare ai nascituri il nome di una società “famosa” in cambio di un congruo
finanziamento da accantonare per gli studi universitari [che - come è noto - negli Usa costano una
cifra non risibile]. Potremmo avere così, in un futuro non lontano, dei Mr. Adidas Harrison o Nike
Pitt o Adobe Douglas, ma anche combinazioni di nomi e cognomi insieme [e quindi doppio
finanziamento], del tipo Adidas Toyota, Nike Mc'Donald, Adobe Spalding, purché insomma gli
accostamenti merceologici non siano concorrenti.
Modificare il proprio cognome non è una operazione complicata, basta fare una domanda: ad
esempio, in Australia il signor Seagle ha fatto cambiare all'anagrafe il proprio nome e cognome in
quello di Mr. Oxford University, e questo perché aveva una disputa legale in corso con l'Università
di Oxford per via di un sito che lui aveva registrato [www.university-of-oxford.com] e il cui
dominio veniva rivendicato dall'istituzione come “proprio”. L'Università ha dovuto rivolgersi al
WIPO (World Intellectual Property Organization), un organismo internazionale di protezione dei
diritti di proprietà intellettuale, con tutte le spese del caso. Non è la prima volta che l'Università
deve sborsare dei soldi, e era successo proprio con Mr. Seagle che aveva acquistato anche il nome
di dominio www.oxford-university.com. Nel periodo “selvatico” della rete, agli esordi, sono stati
tantissimi i casi di domini registrati - anche di marchi famosi - da comuni cittadini che li hanno poi
rivenduti ai “legittimi” proprietari, lucrandoci parecchio. Ma non era mai accaduto che addirittura
qualcuno si “facesse chiamare” come il dominio per testimoniare il proprio diritto a possederlo. E
presumiamo anche a rivenderlo, lucrandoci. Sarebbe interessante vedere cosa accadrà quando i
nascituri con nome e cognome di logo vorranno registre il proprio dominio personale che coinciderà
con un marchio [o un doppio marchio]: sarà difficile negare loro questo diritto.
E' proprio vero che ci sono più cose nella terra di quanto ce ne siano nella filosofia. Anche quando è
la filosofia del “logo”. O del “no logo”.
Roma, 28 marzo 2002
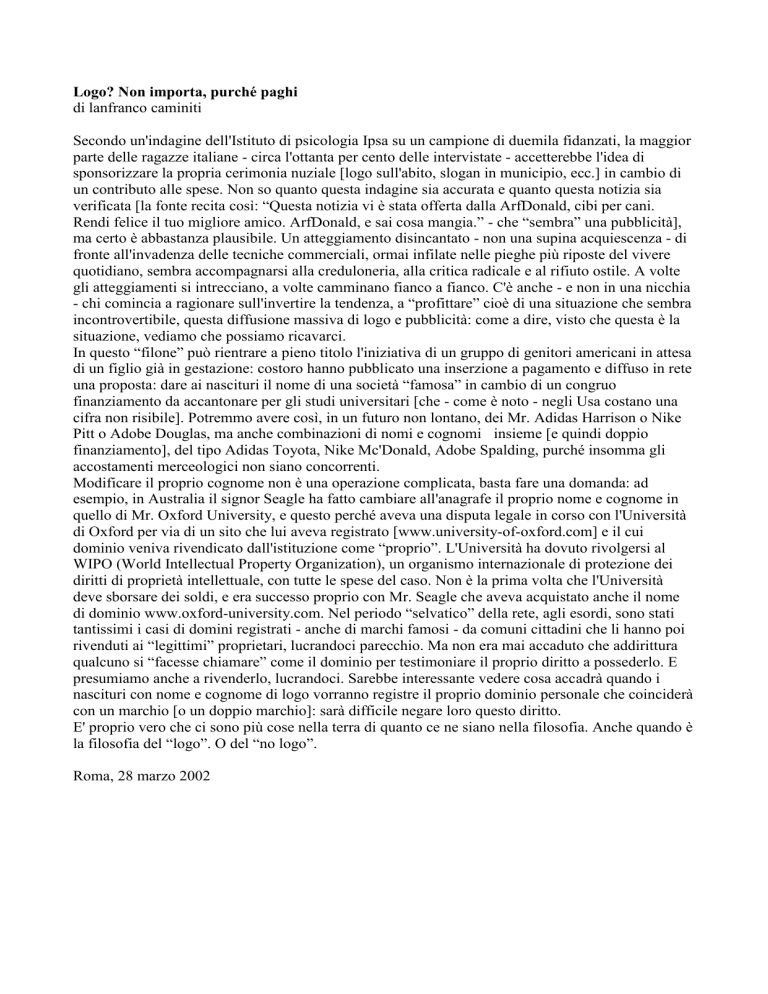
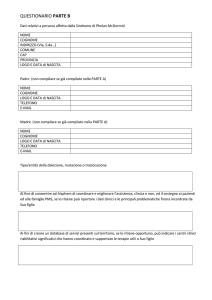
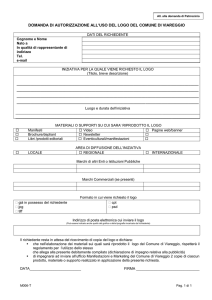
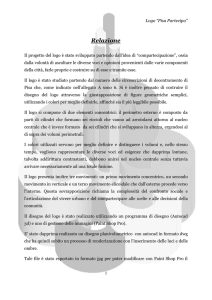

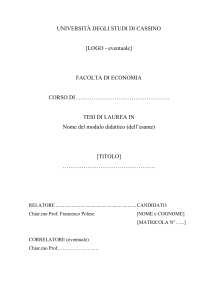
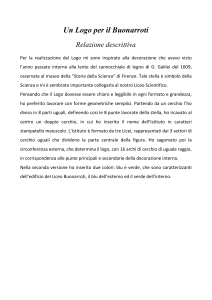

![[inserire TITOLO] - Economia@UniGe](http://s1.studylibit.com/store/data/006909177_1-1c8fc1a590f60bf6abd54c974a058545-300x300.png)