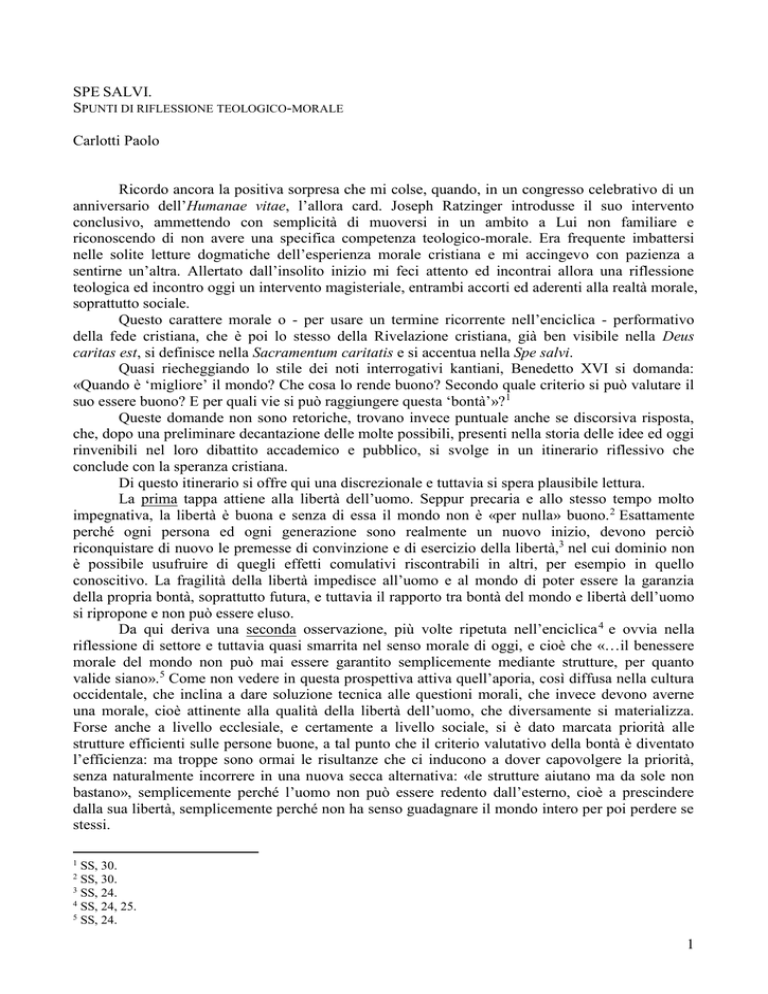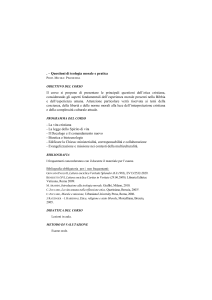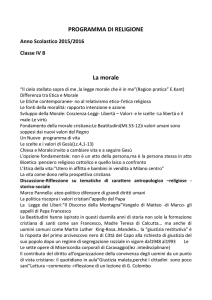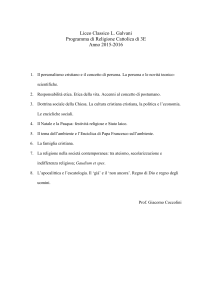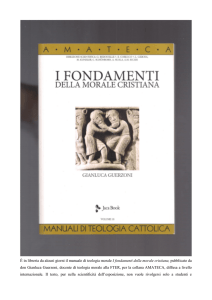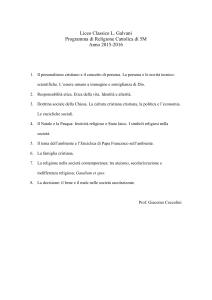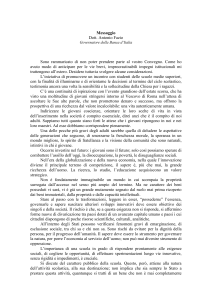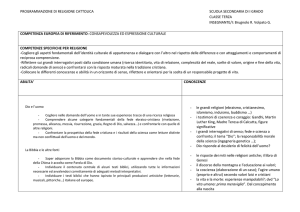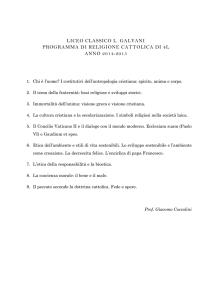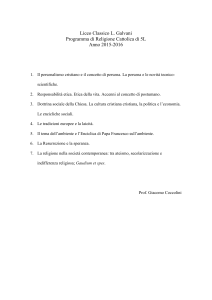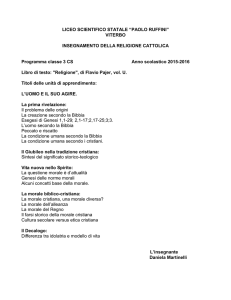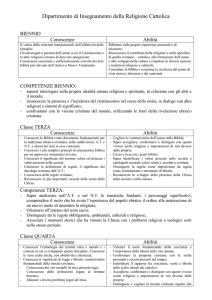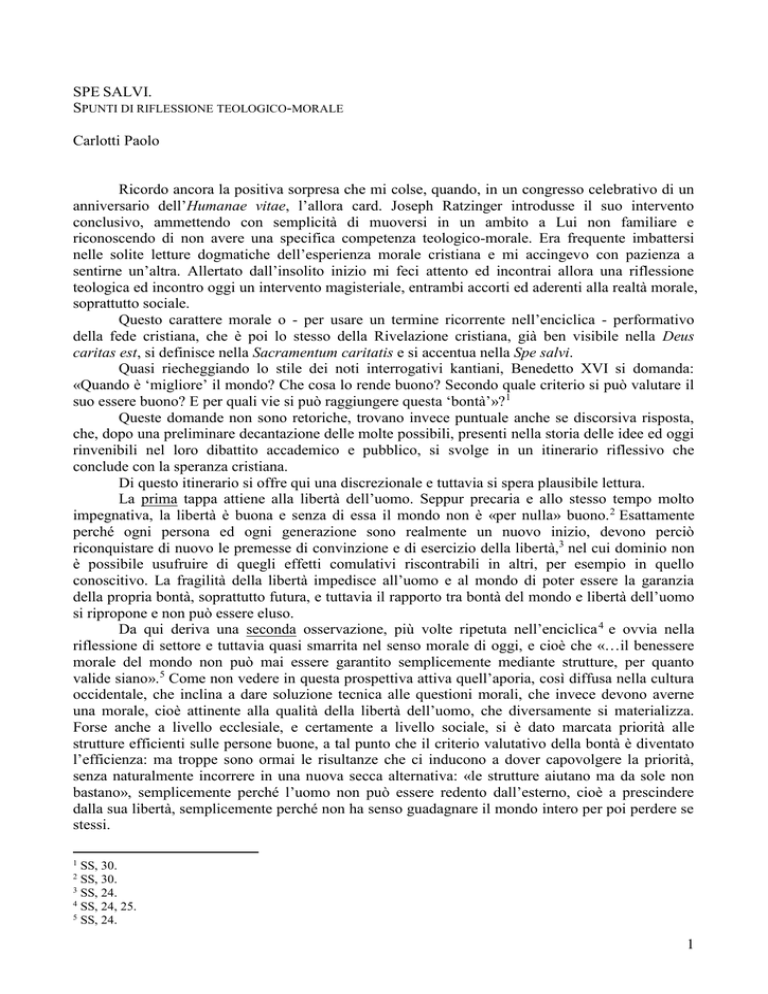
SPE SALVI.
SPUNTI DI RIFLESSIONE TEOLOGICO-MORALE
Carlotti Paolo
Ricordo ancora la positiva sorpresa che mi colse, quando, in un congresso celebrativo di un
anniversario dell’Humanae vitae, l’allora card. Joseph Ratzinger introdusse il suo intervento
conclusivo, ammettendo con semplicità di muoversi in un ambito a Lui non familiare e
riconoscendo di non avere una specifica competenza teologico-morale. Era frequente imbattersi
nelle solite letture dogmatiche dell’esperienza morale cristiana e mi accingevo con pazienza a
sentirne un’altra. Allertato dall’insolito inizio mi feci attento ed incontrai allora una riflessione
teologica ed incontro oggi un intervento magisteriale, entrambi accorti ed aderenti alla realtà morale,
soprattutto sociale.
Questo carattere morale o - per usare un termine ricorrente nell’enciclica - performativo
della fede cristiana, che è poi lo stesso della Rivelazione cristiana, già ben visibile nella Deus
caritas est, si definisce nella Sacramentum caritatis e si accentua nella Spe salvi.
Quasi riecheggiando lo stile dei noti interrogativi kantiani, Benedetto XVI si domanda:
«Quando è ‘migliore’ il mondo? Che cosa lo rende buono? Secondo quale criterio si può valutare il
suo essere buono? E per quali vie si può raggiungere questa ‘bontà’»?1
Queste domande non sono retoriche, trovano invece puntuale anche se discorsiva risposta,
che, dopo una preliminare decantazione delle molte possibili, presenti nella storia delle idee ed oggi
rinvenibili nel loro dibattito accademico e pubblico, si svolge in un itinerario riflessivo che
conclude con la speranza cristiana.
Di questo itinerario si offre qui una discrezionale e tuttavia si spera plausibile lettura.
La prima tappa attiene alla libertà dell’uomo. Seppur precaria e allo stesso tempo molto
impegnativa, la libertà è buona e senza di essa il mondo non è «per nulla» buono. 2 Esattamente
perché ogni persona ed ogni generazione sono realmente un nuovo inizio, devono perciò
riconquistare di nuovo le premesse di convinzione e di esercizio della libertà,3 nel cui dominio non
è possibile usufruire di quegli effetti comulativi riscontrabili in altri, per esempio in quello
conoscitivo. La fragilità della libertà impedisce all’uomo e al mondo di poter essere la garanzia
della propria bontà, soprattutto futura, e tuttavia il rapporto tra bontà del mondo e libertà dell’uomo
si ripropone e non può essere eluso.
Da qui deriva una seconda osservazione, più volte ripetuta nell’enciclica 4 e ovvia nella
riflessione di settore e tuttavia quasi smarrita nel senso morale di oggi, e cioè che «…il benessere
morale del mondo non può mai essere garantito semplicemente mediante strutture, per quanto
valide siano».5 Come non vedere in questa prospettiva attiva quell’aporia, così diffusa nella cultura
occidentale, che inclina a dare soluzione tecnica alle questioni morali, che invece devono averne
una morale, cioè attinente alla qualità della libertà dell’uomo, che diversamente si materializza.
Forse anche a livello ecclesiale, e certamente a livello sociale, si è dato marcata priorità alle
strutture efficienti sulle persone buone, a tal punto che il criterio valutativo della bontà è diventato
l’efficienza: ma troppe sono ormai le risultanze che ci inducono a dover capovolgere la priorità,
senza naturalmente incorrere in una nuova secca alternativa: «le strutture aiutano ma da sole non
bastano», semplicemente perché l’uomo non può essere redento dall’esterno, cioè a prescindere
dalla sua libertà, semplicemente perché non ha senso guadagnare il mondo intero per poi perdere se
stessi.
1
SS, 30.
SS, 30.
3
SS, 24.
4
SS, 24, 25.
5
SS, 24.
2
1
Ma qui ci possiamo lecitamente domandare se questo ‘ritorno alla persona’ non sia forse un
nuovo ritorno al vecchio individualismo, di cui la Gaudium et spes aveva messo in guardia proprio
l’etica cristiana?6 Non è la solita visione privata che prende a cuore solo la salvezza propria e lascia
semplicemente il mondo alla sua sorte, alla sua miseria?7
Certo che no, ma allora perché il cristianesimo moderno è individualista?
Qui siamo di fronte ad una piccola perla dell’enciclica, ad un insegnamento che scaturisce
dall’attenta riconsiderazione di un tratto di storia del dialogo della fede cristiana con il mondo di
volta in volta a lei contemporaneo. L’enciclica ammette che il cristianesimo moderno «…si era in
gran parte concentrato soltanto sull’individuo e sulla sua salvezza», 8 per questo «bisogna che
nell’autocritica dell’età moderna confluisca anche un’autocritica del cristianesimo moderno, che
deve sempre di nuovo imparare a comprendere se stesso a partire dalle proprie radici». 9 Infatti ciò a
cui il cristianesimo moderno s’è purtroppo adattato nel confronto con la modernità, è esattamente
quel posto che gli ha riservato quella nuova fede nel progresso, che a partire da Francesco Bacone
ha esautorato della redenzione quella cristiana, che si è così lasciata istradare sul binario morto di
una innocua visione solo privata, solo ultraterrena e quindi storicamente irrilevante. 10 Una fedeltà
più intensa alle proprie radici nel dialogo con la modernità, avrebbe evitato al cristianesimo
moderno questa oscillazione nel pensare teologico e nella prassi pastorale. Il dialogo non implica
certo una consegna acritica all’altro, né tantomeno questa può essere il segno di un’autentica
solidarietà. C’è da domandarsi se qualche entusiasmo non abbia bisogno di essere precisato.
L’itinerario prosegue e si delinea un terzo momento, quello della inscindibile connessione
della questione del bene con la questione di Dio, connessione di fronte alla quale solo, o almeno
particolarmente, la cultura occidentale si trova in forte disagio, mentre per le altre è ammissione
scontata e pacifica. Non è qui ricostruibile interamente la storia concettuale di quell’etsi Deus non
daretur - come se Dio non ci fosse - che molta parte ha avuto, ha e probabilmente avrà nella
plasmazione dell’ethos e soprattutto dell’etica occidentali, assioma che tuttavia non può rimanere a
lungo nello stato ipotetico. Certo, per usare le note parole della Veritatis splendor, «la Chiesa sa che
l’istanza morale raggiunge in profondità ogni uomo, coinvolge tutti, anche coloro che non
conoscono Cristo, il suo Vangelo e neppure Dio», 11 eppure sembra essere la stessa esperienza etica
a richiedere un’apertura al trascendente, senza la quale diverrebbe in se stessa praticamente
aporetica, cioè impraticabile. È ciò che Benedetto XVI afferma con forza, quasi ricorrendo ad una
sorta di postulazione pratica dell’eterno, del trascendente: «Io sono convinto che la questione della
giustizia costituisce l’argomento essenziale, in ogni caso l’argomento più forte, in favore della fede
nella vita eterna. Il bisogno soltanto individuale di un appagamento che in questa vita ci è negato,
dell’immortalità dell’amore che attendiamo, è certamente un motivo importante per credere che
l’uomo sia fatto per l’eternità…». È impensabile e impossibile continuare a vivere senza credere
che ci sarà giustizia, nonostante la limitatezza e la precarietà dei nostri tentativi per realizzarla.
L’aporia in cui un desiderio di giustizia tanto insopprimibile quanto irrealizzabile finisce, invoca
l’eterno, senza deresponsabilizzare il presente. La costruzione storica della giustizia non è inutile né
irrilevante, lo conferma il suo essere ineludibile mediazione della qualità, buona o cattiva, della
nostra personale eternità, dove ritroveremo vincente quella giustizia, che non siamo riusciti ad
instaurare, avvolta però da sovrabbondante grazia.
Qui però le nostre piccole speranze non possono più a lungo rimanere piccole e numerose,
ma debbono evolversi in una sola grande speranza, che inoltre non può rimanere a lungo anonima e
impersonale e quindi non può che incontrarsi con quella Persona di Dio che possiamo conoscere
storicamente: Gesù, il Signore nostro.
6
GS, 30.
SS, 28, 13.
8
SS, 25.
9
SS, 22.
10
SS, 17.
11
VS, 3.
7
2
Una simile speranza, che vincola al cambio di un cuore stolto, appesantito e indurito, se
prevede certo una necessaria etica della norma come iniziale avvio; richiede però molto di più:
un’etica della persona intera, che sappia pensare la disposizione e la dedicazione di sé, che tematizzi
gli atteggiamenti dei comportamenti, che osi l’ottimale del minimale, che pensi l’agire come dimora
e non come sperimento di sé: solo così ogni agire dell’uomo è «speranza in atto», 12 soprattutto
quello che è un patire per amore, testimonianza eloquente «della speranza che portiamo dentro di
noi».13
Del tradizionale corredo che accompagna la virtù teologale della speranza, l’enciclica parla
della pazienza e della compassione.
Ed infine l’enciclica intercetta un’altra questione oggi attuale quella della logica e della
dinamica delle emozioni. La speranza è contestualmente un desiderare e un decidere cosa desiderare.
Non è un semplice abbandonarsi alla foga del desiderio, implica il voler desiderare, esige il
passaggio dalla voglia indistinta e confusa al volere preciso e pertinente, che decide i propri
sentimenti, dando così un ordine al cuore - qui inteso in modo romantico come sede degli affetti.
Naturalmente per rendere operativa questa scelta, occorre prima ritenerla possibile e
praticabile. Mi sembra che occorra avere consapevolezza che quest’affermazione è discontinua
rispetto al trend culturale, che facilmente risolve e legge come inibizione ogni progetto di
educazione morale del cuore, che non sia un avvallo al puro spontaneismo. Che questo tratto
culturale non sia proprio affidabile e che sia invece possibile e auspicabile un’educazione del
desiderio, lo conferma la consegna esperienziale della fede, quando con Agostino definisce la
preghiera come esercizio del desiderio e quindi come luogo di coltivazione della speranza.
Capite da voi che si potrebbe continuare ma si deve invece concludere. Ogni bene morale è
conosciuto in profondità da chi lo pratica e non da chi soltanto lo pensa o lo predica, per questo è
bello leggere nell’enciclica: «Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo
vivere rettamente. Esse sono luci di speranza».14
12
SS, 35.
SS, 39.
14
SS, 49.
13
3