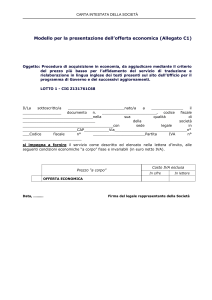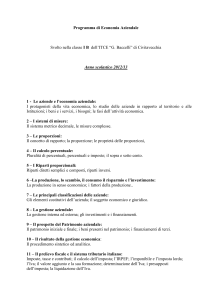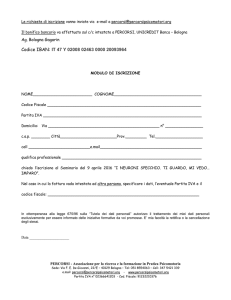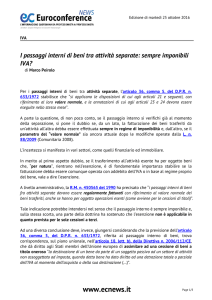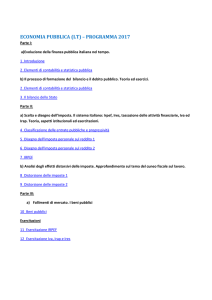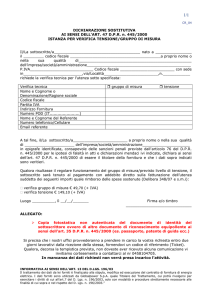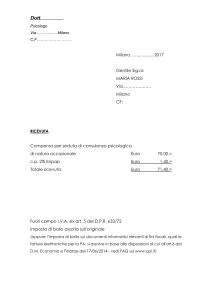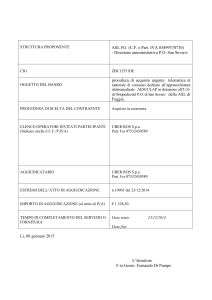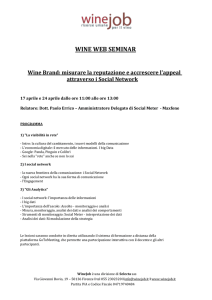L’ELUSIONE TRIBUTARIA ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
DI CASSAZIONE E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CE
Per elusione fiscale si intende, nell’accezione più elementare, l’aggiramento di una norma
tributaria allo scopo di ottenere un risparmio d’imposta, con mezzi e strumenti formalmente
ammessi ma “piegati” al solo obiettivo di risparmiare le imposte e che evitano il verificarsi dei
presupposti impositivi ovvero determinano il venire ad esistenza di presupposti fiscalmente meno
onerosi oppure positivamente vantaggiosi.
L’elusione si distingue quindi dall’evasione, che comporta invece l’inadempimento di obblighi o di
obbligazioni già sorti essendosi già verificato il presupposto impositivo.
Mentre l’evasione è quindi una condotta di per sé lecita, l’evasione è una condotta illecita in quanto
violativa delle leggi d’imposta.
L’elusione di distingue poi, sull’altro versante, dal risparmio lecito d’imposta.
Il confine fra queste due fattispecie è assai labile; cionondimeno, si è tentato di individuare criteri di
individuazione del lecito risparmio. Da un lato, nel fatto che la normativa applicata dal contribuente
si colloca su un piano di pari dignità con quella che avrebbe potuto essere applicata dando luogo
al prelievo fiscale (esempi di questa pari ordinazione e “dignità” degli strumenti giuridici utilizzati e
di quelli utilizzabili sarebbero la cessione di azienda rispetto alla cessione di quote, la
trasformazione da società di persone in società di capitali e viceversa). Di contro, si dovrebbe
parlare di risparmio fiscale “patologico” in tutti i casi in cui il soggetto d’imposta lo consegue
attingendo a disposizioni particolari o a norme lacunose e mal formulate, in modo tale da far
giudicare l’operazione uno stratagemma e un sotterfugio. Altro criterio sarebbe quello della
disapprovazione del sistema, per cui il risparmio d’imposta non sarebbe lecito, e si avrebbe
quindi elusione, in tutti i casi in cui tale risultato sia disapprovato dal sistema. E ciò anche se si
siano usati strumenti di pari dignità rispetto a quelli “normali” (ad esempio, sono istituzionali e
fisiologici i meccanismi che presiedono, da una parte, al riporto delle perdite e, dall’altra, alle
cessioni e conferimenti d’azienda. Eppure la cessione di una azienda redditizia ad una società con
solo perdite acquistata per l’occasione e al solo scopo di riportare a nuovo le perdite stesse (cd.
“bara fiscale”) è senza dubbio disapprovata dal sistema.
Nel nostro ordinamento, il contrasto al fenomeno dell’elusione fiscale è stato sempre attuato, sino
ad ora, con singoli interventi legislativi su pratiche elusive in atto o potenziali e non a livello
generale con l’adozione di norme che puniscano, come in altro ordinamenti, il cd abuso del diritto.
Nella materia, si confrontano principi di segno diverso e talora opposto, caratteristici della cultura,
della storia e della composizione sociale del nostro Paese.
-L’art. 53 della Costituzione afferma solennemente che tutti sono tenuti a concorrere alle pubbliche
spese in ragione della loro capacità contributiva. Se dunque il concorso alle pubbliche spese si
attua con il prelievo fiscale e se il prelievo fiscale nella forma indiretta è una delle forme ammesse
e legittime di prelievo, sembrerebbe consequenziale, soprattutto in materia di iva, che il soggetto
d’imposta che pone in essere una cessione o una prestazione di servizi ovvero pone in essere una
complessa operazione imponibile mediante il collegamento di più contratti o di più negozi
ottenendo il risultato di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, concorra alle pubbliche
spese in ragione dell’attività posta in essere secondo l’aliquota prevista dalla legge sia quando la
sua condotta si traduca in atti, fatti e negozi anche formalmente soggetti a tassazione, sia quando
la sua condotta si estrinsechi in atti fatti e negozi formalmente esenti da imposta o assoggettati ad
aliquota agevolata ma il cui risultato è, sostanzialmente ed economicamente, il medesimo di quello
cui sarebbe pervenuto utilizzando gli atti, i fatti e i negozi formalmente soggetti all’imposta.
-Vi è peraltro una generale disistima da parte dei soggetti di imposta e, in genere, degli operatori
economici, della propria capacità contributiva, e, per converso, una sovrastima di quella altrui, il
che porta ad una caduta delle motivazioni a “concorrere alle pubbliche spese” e a qualificare il
prelievo fiscale in genere, o almeno quello superiore ad una certa soglia, come un cinico spoglio
attuato da uno Stato “patrigno”.
-Da altro lato, ai sensi del’art. 41 Cost., l’iniziativa economica privata è libera (anche se non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale: art. 41 comma 2 Cost.), e nessuno rimprovero può
muoversi all’imprenditore o in genere al soggetto d’imposta se decide, nell’espletamento della sua
attività e nell’effettuazione delle scelte imprenditoriali, di seguire la via fiscalmente meno onerosa.
-Ancora, uno dei pilastri del nostro sistema civilistico è l’autonomia negoziale delle parti, che
possono regolare come credono i loro rapporti anche con negozi atipici e con collegamenti
negoziali o con negozi indiretti , purchè lo scopo perseguito sia ritenuto dalla legge meritevole di
tutela; ed è pacifico che l’elusione è una pratica perfettamente lecita dal punto di vista del diritto
civile.
Occorre aggiungere che oggi l’economia e i soggetti che vi operano sembrano aver smarrito
l’etica.
Molti commentatori lamentano che i contenuti etici siano esclusi dai piani di studi delle scuole di
alta economia, che additano come ideali soltanto l’interesse personale e i dividendi, lavati o meno,
da distribuire agli azionisti.
E’ una spiegazione corretta, ma non completa.
Insegnare etica nei Master di economa è certamente utile, ma non basta, in quanto l’homo
oeconomicus occidentale è impregnato della convinzione che “la cupidigia è giusta”, e che il
profitto rimane l’obiettivo primario ed esclusivo dell’impresa.
Occorrerebbe perciò inculcare i valori etici fin dalla scuola primaria (e dalle scuole sportive di grado
inferiore), insegnando ai più piccoli che la correttezza e l’onestà sono più importanti del successo a
qualunque costo e che il fine non giustifica i mezzi.
La mancanza di etica nell’economia è comunque un giudizio che non deve essere generalizzato.
Sono infatti diffusissimi, ben più di quanto si creda o venga pubblicizzato dai media,
comportamenti economicamente virtuosi in materia di economia di comunione, banche e fondi
etici, microcredito, ecc.
La giurisprudenza della Suprema Corte in materia di elusione fiscale.
Sulla liceità dell’elusione e sulla affermata impossibilità, per l’amministrazione finanziaria, di
disconoscere atti, fatti, negozi (anche collegati) nel loro aspetto giuridico-formale per recuperare a
tassazione la realtà degli effetti economico –sostanziali dai medesimi prodotti, è interessante
esaminare Cass. 18.4.2002 n. 5582 resa su ricorso avverso la decisione della Commissione
tributaria regionale della Lombardia n. 91/63/97 del 20 ottobre 1997. E’ una sentenza in materia di
posti-barca. E’ noto che la diffusione della nautica da diporto ha da tempo posto all'attenzione degli
operatori giuridici l'analisi degli strumenti idonei ad assicurare l'utilizzazione di un "posto barca".
Tale esigenza è per lo più soddisfatta mediante la stipulazione di uno specifico contratto di
scambio che, per quanto non ancora oggetto di una particolare disciplina da parte del legislatore, è
ormai sufficientemente delineato nei suoi elementi strutturali e funzionali, i quali implicano, in ogni
caso, l'assegnazione, verso corrispettivo, di un delimitato e protetto spazio acqueo antistante la
banchina, ma possono prevedere anche la possibilità di usufruire di una serie di servizi collegati
all'utilizzazione del natante ormeggiato (Cass. 2 agosto 2000, n. 10 118; 21 ottobre 1994, n. 8657).
Ebbene, una società aveva ottenuto in concessione dall'Amministrazione del demanio marittimo,
per la durata di cinquant'anni, un tratto di suolo demaniale marittimo in località Lavagna con lo
specchio di mare antistante, "allo scopo di costruire e gestire un approdo turistico". L'art. 6 dello
statuto era così formulato: "l'azionista avrà diritto, in conformità con quanto previsto dal
regolamento, all'assegnazione dei posti ormeggio per imbarcazioni, dei posti parcheggio e/o
rimessaggio autovetture ... in rapporto alle azioni da lui possedute, le quali saranno
adeguatamente raggruppate nei certificati azionari".
I soci della società concessionaria avevano stipulato preliminari di vendita delle proprie azioni con
soggetti interessati all'acquisizione dei diritti di utilizzazione dei "posti-ormeggio"; il prezzo di
acquisto era stato integralmente versato ai (soci) cedenti; i promissari acquirenti erano stati
autorizzati, nel frattempo, ad "occupare per uso personale" i "posti-ormeggio" assegnati dalla
società concessionaria "sopportando le spese gestionali"; le operazioni, così configurate, erano
state ritenute esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, n. 4, d.p.r. 633/72, in quanto aventi ad oggetto
titoli azionari.
L’Amministrazione finanziaria rettificava la dichiarazione annuale presentata dalla società
contestandole la mancata fatturazione della cessione dei posti-barca e la conseguente infedeltà
della dichiarazione, sostenendo:
- che le promesse di vendita dei certificati azionari, poste in essere dai singoli soci, erano in realtà
simulate e dissimulavano altrettanti atti di "cessione" di diritti reali di godimento su beni demaniali
compiuti dalla società e, come tali, imponibili ai fini IVA ai sensi degli artt. 2 e 11, d.p.r. 633/72;
- che la veste giuridica data dalle parti a tali operazioni era inopponibile all'Amministrazione
finanziaria, non solo perché non rispondente al loro effettivo intento negoziale, ma anche perché
frutto di una scelta effettuata al solo fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta;
- che, in ogni caso, la concreta attribuzione del "posto-barca" da parte della società aveva tutti i
requisiti per essere considerata quale "assegnazione ai soci" ai sensi dell'art. 2, n.6, d.p.r. 633/72
e, in quanto tale, come operazione imponibile, sia pure ad altro titolo.
Replicava il soggetto d’imposta:
- che l'assegnazione dei "posti-ormeggio" (o "posti-barca") da parte della società concessionaria
aveva natura meramente "ricognitiva" di un'attribuzione perfezionatasi in favore dei singoli soci nel
momento dell'acquisto dei titoli azionari;
- che, essendo il diritto all'utilizzazione dei "posti-barca" incorporato nei titoli azionari, i singoli soci
erano legittimati a disporne mediante il trasferimento dei titoli;
- che il corrispettivo della cessione dei titoli azionari era stato percepito dai singoli soci cedenti e
non dalla società.
La Suprema Corte osservava che l'utilizzazione del posto barca può essere ricollegata, come nel
caso di specie, alla titolarità di titoli azionari emessi dalla società concessionaria che ha assunto la
gestione del porto turistico, secondo uno schema per molti aspetti analogo a quello della c.d.
multiproprietà azionaria, caratterizzata dall'attribuzione, in favore dei singoli soci, del diritto di
utilizzare, per una determinata frazione temporale, beni di cui la società resta proprietaria a tutti gli
effetti (Cass. 10 maggio 1997, n. 4088; 4 giugno 1999, n. 5494). Ciò in quanto lo schema causale
della società è assai elastico e si presta ad essere utilizzato, oltre che per il perseguimento di uno
scopo "lucrativo" (e, cioè, di ricavare "utili" dall'esercizio di un'attività economica nei confronti di
terzi, destinati poi ad essere ripartiti tra i soci: art. 2247 c.c.), anche per assicurare ai soci la diretta
fornitura di beni o di servizi da parte della società (artt. 2511 e 2615, ter, c.c.). In quest'ultimo caso
il socio non si limita a partecipare allo svolgimento dell'attività comune, ma assume anche il ruolo
di destinatario dei beni e dei servizi alla cui offerta è finalizzato l'esercizio dell'attività sociale.
Appunto per questo, in detta ipotesi, la sua posizione si arricchisce di contenuti - (come, ad es., il
diritto di poter utilizzare beni appartenenti al patrimonio sociale e l'obbligo di provvedere al
versamento di somme di denaro ulteriori in aggiunta a quelle oggetto di conferimento) estranei alla
disciplina delle società "lucrative", nelle quali il ruolo del socio è solo quello di partecipante
all'impresa sociale.
Quindi, ben possono i rapporti relativi alla utilizzazione dei c.d. "posti-barca" essere ricollegati alla
titolarità di azioni emesse dalla società di gestione del porto, con la conseguenza che il diritto era
stato acquisito dai singoli soci in via originaria al momento dell'acquisto delle azioni e che,
pertanto, la loro concreta assegnazione, da parte della società, non assumeva la natura e gli effetti
di atto "traslativo" di un bene ricompreso nel patrimonio sociale, ma di atto "dovuto" di (mera)
Individuazione" dell'oggetto di diritti già sorti in capo ai singoli soci, in quanto inerenti alle azioni da
essi possedute. In conclusione, quindi, la Cassazione riteneva;
-che l’amministrazione finanziaria aveva svolto le sue difese in modo poco coerente, invocando
due differenti imotivi di inopponibilità (da un lato, aveva eccepito che le promesse di vendita dei
certificati azionari, poste in essere dai soci della società cessionaria, erano simulate e
nascondevano una cessione di beni demaniali o un’assegnazione ai soci, dall’altro sosteneva che
si trattava di atti e negozi di natura elusiva e per tale ragione inopponibili all’Amministrazione).
-che della pretesa simulazione non era stata fornita alcuna prova;
-e che non era possibile riconoscere all’'Amministrazione il potere di riqualificare i contratti posti in
essere dalle parti, assoggettandoli ad un trattamento fiscale diverso e meno favorevole di quello
che sarebbe stato altrimenti applicabile; potere che, come la Corte aveva in reiterate occasioni
statuito, avrebbe potuto essere riconosciuto solo in presenza di norme che tale possibilità
espressamente prevedessero (Cass. 9 maggio 1997, n. 4064, 28 luglio 2000, n. 9944; 3 settembre
2001, n. 11351).
Identico orientamento palesava Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 03/09/2001, secondo cui
“prima dell'entrata in vigore dell'art. 37 - bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dall'art. 7 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, - che con disposizione, non avente efficacia retroattiva,
ha attribuito all'Amministrazione Finanziaria ampio potere di disconoscere, a fini antielusivi, gli
effetti degli atti compiuti dal contribuente al fine di beneficiare di un trattamento fiscale più
vantaggioso - detta amministrazione non aveva il potere di riqualificare i contratti posti in essere
dalle parti, prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle stesse, per assoggettarli
ad un trattamento fiscale meno favorevole di quello altrimenti applicabile, neppure in virtù degli artt.
1344 e 1418 cod. civ., che sanciscono la nullità dei contratti che costituiscono "il mezzo per
eludere l'applicazione di una norma imperativa". Tali disposizioni, infatti, considerano l'illiceità
quale causa di nullità e non di conversione del contratto in frode alla legge nel contratto che
costituisce presupposto per l'applicazione della norma, che le parti intendevano eludere; inoltre le
norme tributarie, essendo poste a tutela di interessi pubblici di carattere settoriale e non ponendo,
in linea di massima, divieti, pur essendo inderogabili, non possono qualificarsi imperative,
presupponendo tale qualificazione che la norma abbia carattere proibitivo e sia posta a tutela di
interessi generali, che si collochino al vertice della gerarchia dei valori protetti dall'ordinamento
giuridico”.
Il caso nasceva perché una società di leasing aveva posto in essere operazioni di locazione
finanziaria nelle quali le prestazioni normalmente a carico del concedente erano poste a carico di
due diverse società, scorporando gli obblighi di carattere finanziario da quelli più specificamente
riferite alla concessione in godimento del bene, imputandole a due diverse società dello stesso
gruppo; le prestazioni di carattere finanziario consistevano, in particolare, nel garantire, con una
cauzione pari al costo del bene non coperto dai canoni anticipati e con una fideiussione illimitata,
l'adempimento degli obblighi dell'utilizzatore verso la società concedente, per un corrispettivo
versato anticipatamente dall'utilizzatore al momento della stipulazione del contratto di leasing.
L’amministrazione finanziaria osservava che tali pattuizioni, anche se collocate in contratti distinti
stipulati tra soggetti diversi, rappresentavano, dal punto di vista funzionale e strutturale, elementi
tipici del contratto di locazione finanziaria e, come tali, costituivano costituendo parte integrante di
un unico contratto trilaterale; e che risultato pratico di questa (artificiosa) scissione era stata la
riduzione della base imponibile, mediante l'imputazione delle componenti del corrispettivo riferite
alla parte "finanziaria" ad una diversa società che le aveva fatturate in esenzione, ai sensi dell'art.
10, nn. 1 e 9, d.p.r. 633/72, quali prestazioni di finanziamento e di garanzia.
Il ricorso proposto dalla società era accolto dalla Commissione tributaria di primo grado, la quale
osservava che l'articolazione della complessa operazione in due contratti tra loro collegati
rispondeva a valide ragioni economiche ed era quindi pienamente efficace anche sotto il profilo
fiscale, dovendosi escludere che essa fosse stata adottata per scopi elusivi. L'appello dell'Ufficio
era respinto dalla Commissione tributaria di secondo grado. Nè diverso era l'orientamento
manifestato dalla Corte d'Appello di Bologna che respingeva l'ulteriore impugnazione avanzata
dall'Amministrazione.
La Suprema Corte ha osservato che è indubbio che la qualificazione di un contratto non dipende
dal nomen iuris eventualmente adottato dalle parti, dovendo il suo inquadramento in uno piuttosto
che in altro schema "giuridico" essere effettuato sulla base di quanto disposto dalla legge e, quindi,
in termini rigorosamente obbiettivi. Ma è altrettanto certo che tale inquadramento deve essere
correlato alla "comune intenzione" dei contraenti, accertata alla stregua dei criteri stabiliti dagli
artt.1362 e segg. c.c., se del caso anche sulla base di elementi estrinseci (Cass. 6 maggio 1991, n.
4994; 9 aprile 1991, n. 3726) e tenendo conto di situazioni complesse, caratterizzate dal
collegamento di più fattispecie negoziali (Cass. 14 aprile 1998, n. 3791): se così non fosse, le parti
verrebbero, infatti, ad essere vincolate da effetti giuridici privi di ogni collegamento con la loro
volontà, in contrasto con il principio di autonomia privata, il quale implica che, nei limiti imposti
dalla legge, tali soggetti abbiano il potere di liberamente determinare il contenuto del contratto (art.
1322 c.c.) e che gli effetti giuridici siano congruenti con lo scopo da essi perseguito.
La Suprema Corte escludeva quindi che l'Amministrazione finanziaria potesse, nella fattispecie,
determinare la natura di un contratto come un unico contratto trilatero e non come più contratti
collegati, prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle parti e in contrasto con
essa.
Nè valeva osservare, in contrario, che l'art. 20, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce che ogni atto
sottoposto a registrazione va tassato "secondo la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici",
ancorché non corrispondenti "al titolo e alla forma apparente, perché tale disposizione (che non
assume, comunque, il valore di una clausola generale, essendo specificamente riferita all'imposta
di registro) si limita a stabilire che l'imposta deve essere applicata sulla base di quanto risulta
dall'atto sottoposto a registrazione, e non autorizza quindi a ritenere che ai fini della sua
qualificazione possa prescindersi dalla "comune intenzione" dei contraenti.
Nè, per altro verso, valeva richiamarsi agli artt. 1344 e 1418 c.c. che sanciscono la nullità dei
contratti che costituiscono "il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa". Non è
sufficiente, infatti, che una norma sia inderogabile perché possa essere sia qualificata come
"imperativa", essendo a tal fine necessario che essa sia di carattere proibitivo e sia posta, altresì, a
tutela di interessi generali che si collochino al vertice della gerarchia dei valori protetti
dall'ordinamento giuridico (Cass. 8 novembre 1995, n. 11598). Caratteri, questi, certamente non
ravvisabili nelle norme tributarie, in quanto esse sono poste a tutela di interessi pubblici di
carattere settoriale e, in linea di massima, non pongono divieti, ma assumono un dato di fatto
quale indice di capacità contributiva (Cass. 5 novembre 1999, n. 12327; 8 novembre 1995, n.
11598; 19 giugno 1981, n. 4024). Del resto, le disposizioni del codice civile considerano l'illiceità
quale causa di nullità e non di conversione del contratto in frode alla legge in quello che costituisce
presupposto per l'applicazione della norma che le parti intendevano eludere: resta così
confermato, anche sotto tale ulteriore profilo, che neppure tali norme offrono argomenti per
giustificare l'attribuzione all'Amministrazione finanziaria del potere di riqualificare i contratti posti in
essere dalle parti al fine di beneficiare di un trattamento fiscale più vantaggioso.
Concludeva quindi la Suprema Corte che il potere di disconoscere, ai fini tributari, gli effetti degli
atti compiuti dal contribuente è stato riconosciuto per la prima volta, in modo espresso, dal
legislatore con l'art. 10, legge 29 dicembre 1990, n. 408, con la quale si consentì
all'Amministrazione finanziaria di "disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di
fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale, poste in essere senza
valide ragioni economiche e allo scopo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta". Tale
norma ha visto il suo ambito di applicazione progressivamente ampliarsi fino ad essere assorbito
in quello dell'art. 7, dlgs. 8 ottobre 1997, n. 358, che ha introdotto l'art. 37 bis nel d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600.
In altre decisioni in materia di Iva, fin dal 1991(Cass. 3726/91) la Suprema Corte aveva peraltro
superato l’impostazione sopra palesata.In particolare, aveva richiamato e ritenuto applicabile l'art.
8 del R.D. 30.12.1923 n. 3269, considerato un principio di portata generale, secondo cui "le tasse
sono applicate secondo l'intrinseca natura degli atti o dei trasferimenti, se non vi corrisponda il
titolo o la forma apparente" (cfr. ora anche art. 19 D.P.R. 634-1972 e art. 20 D.P.R. 26.4.1986 n.
131). Inoltre, aveva osservato che lo stesso concetto di "imponibilità dell'operazione” di cui agli art.
1 e ss. del D.P.R. 633-1972 richiama l'attenzione sull'intento perseguito dalle parti e cioè, in ultima
analisi, sulla funzione economico-sociale in concreto assegnata all'atto.
Anche in precedenza, in altra fattispecie (Cass. Sez. 1 n. 4987 del 1998), il dato formale-giuridico
è stato superato dalla Cassazione in ragione degli effetti economico-sostanziali avuti di mira e
conseguiti dai soggetti di imposta, con conseguente riqualificazione dell’operazione posta in
essere dal soggetto d’imposta.
Il caso si origina da una articolata operazione mediante la quale una società, con il ricorso
all'istituto giuridico del conferimento di cui all'art. 2342 c.c., aveva ceduto n. 32.929 capi di bovini
del valore di stima pari a lire 52.742.000, nonché debiti connessi all'acquisto per lire
52.206.552.605, ad una società agricola, acquisendo il 41,66% del relativo capitale sociale (pari a
L. 500.000.000). Con il conferimento la conferente aveva conseguito un credito IVA di lire
10.020.980.000 (quella pagata all'acquisto) mentre la società agricola aveva conseguito nell'ambito successivo - vantaggi tributari per l'ammontare di L. 6.479.039.189.
L'Ufficio IVA, sul presupposto che con l'operazione si fosse effettuata, in sostanza, una cessione di
beni con relativo obbligo di fatturazione e assoggettamento ad IVA - omessi nella specie, in quanto
ritenuti non dovuti ex art. 2 DPR 633/72, notificava avviso di rettifica, accertando un minor credito
di imposta di lire 10.020.980.000 e comminando sanzioni, oltre ad accessori.
La Commissione Tributaria di primo grado respingeva il ricorso della società, avendo considerato il
conferimento - atto non soggetto ad IVA - simulato per dissimulare il passaggio dei bovini dalla
conferente alla conferitaria nell'ambito di un rapporto di commissione - atto soggetto ad IVA concluso fra i suddetti enti anche per l'acquisto del bestiame, come poi per la vendita.
La società sosteneva che il conferimento era atto reale e realmente voluto, in quanto utile per
conseguire le dichiarate finalità economiche (concentrarsi sulla macellazione facendo ricorso, per
l'allevamento da poco intrapreso, alla conferitaria società agricola e, sul piano fiscale, meno
oneroso di una cessione. Sostanzialmente, ammetteva la natura elusiva di tutta l'operazione ma
ribadiva l'assenza, all'epoca dei fatti, di norme antielusione di carattere generale.
La Commissione Tributaria Regionale riteneva
a) nella specie le parti intendevano raggiungere lo scopo di un trasferimento o cessione degli
animali da soggetto commerciale in regime ordinario, che avrebbe potuto portare integralmente in
detrazione l'Iva assolta e chiederne il rimborso, a soggetto operante in regime speciale agricolo,
che come tale avrebbe in sede di vendita riscosso l'Iva quantificando la detrazione in modo
forfetario, ai sensi dell'art. 34 comma 1, D.P.R. n.633/1972;
b) il conferimento non aveva riguardato solo beni, i bovini, ma ha anche sostanzialmente
ricompreso delle passività, e cioè in gran parte lo stesso debito per l'acquisto, riducendo il valore
del conferimento stesso al risultato della somma algebrica, pari a L. 500.000.000;
c) il conferimento de quo ai fini della applicazione della norma fiscale, non era l'intero valore dei
beni in natura, ma solo il netto ricavo dell'operazione, vale a dire l'importo effettivamente iscritto in
bilancio a tale titolo;
d) la ordinaria definizione di conferimento non prevede il trasferimento di una passività, quale
appunto il prezzo d'acquisto del bene o di altri debiti;
e) è lo stesso dato normativo ad escludere che il conferimento cui si riferisce l'art. 2 lett. b) del
D.P.R. n. 633 sia quello comprensivo di attività e passività
f) per l'importo di L.500.000.000, pari al controvalore della parte di bovini conferiti in cambio della
quota di capitale sociale acquisito, non v'è dubbio che si tratti di conferimento ricadente sotto la
previsione dell'art.2 lett.e) citato, e come tale escluso dalla imposizione IVA e soggetto invece
all'imposta di registro;
g) a conclusioni esattamente opposte si deve pervenire per la qualificazione della parte di beni
nominalmente conferiti, ma il cui valore viene ad essere annullato dai debiti di importo
corrispondente passati in capo alla società conferitaria, non essendo per questa parte il
conferimento altro che una cessione onerosa dalla società a quella agricola,cessione onerosa il cui
corrispettivo è costituito proprio dall'accollo di debiti di valore corrispondente operato dalla società
cessionaria;
h) ne consegue quindi l'assoggettabilità ad IVA della operazione di conferimento dei bovini per la
parte eccedente il capitale di L. 500.000.000 conferito, vale a dire per L.52.200.000.
Ribadiva la società, nel ricorso per cassazione, che la legittimità dell'atto di conferimento non
poteva essere sindacata attraverso nessuna delle norme antielusive esistenti (art. 10 della legge n.
408 del 1990, art. 20 del DPR n. 131 del 1986 e art. 37 del DPR n. 600 del 1973), mentre mancava
nel diritto tributaria una norma generale antielusiva, sicché l'Amministrazione finanziaria non
poteva riqualificare operazioni o semplici negozi ritenendo di far prevalere la sostanza economica
degli effetti prodotti dagli atti sulla forma rivestita da questi.
Anzitutto La Suprema Corte, con riferimento all'affermazione, contenuta nella decisione
impugnata, secondo cui l'ordinaria definizione di conferimento non preveda il trasferimento di una
passività, riteneva che il conferimento di beni in una società non muta la sua natura quando esso
comporti anche il trasferimento di passività. Tale trasferimento assume carattere di normalità nei
casi di conferimento di azienda, che implica di per sè la coesistenza di attività e passività e, quindi,
la successione della società conferitaria nei debiti facenti capo al precedente titolare dell'azienda,
ma la situazione non cambia quando le passività ineriscano ad un conferimento in società di beni
che non costituiscono un'azienda.
Tanto premesso, osservava, però, che nella specie la conclusione cui era pervenuta la
Commissione Regionale - e cioè che il trasferimento dei bovini dalla società ricorrente alla società
agricola fosse configurabile, ai fini fiscali, per la sua quasi totalità, come una cessione di beni e non
come un conferimento in società – era rettamente fondata sulle particolari caratteristiche che
aveva assunto l'operazione in questione, ed in particolare sul rapporto esistente tra il valore dei
beni trasferiti ed i debiti accollati a seguito del trasferimento. La Commissione Regionale aveva
ben osservato che non è ammissibile dal punto fiscale la possibilità di trasferire beni, in esenzione
di IVA, conferendoli unitamente a debiti, quali il loro prezzo di acquisto, di importo quasi pari al
valore dei beni conferiti. In tal modo con il simbolico conferimento "netto" di una lira potrebbero in
realtà cedersi beni del valore di miliardi, con il semplice accorgimento di accompagnarli al
contestuale trasferimento di partite debitorie idonee a sostanzialmente annullarne il valore. In
realtà, il conferimento in questione era da ritenersi "simbolico" proprio in conseguenza del suddetto
rapporto tra bovini ceduti e passività trasferite, consistenti in debiti per l'acquisto degli stessi bovini,
e doveva quindi dedursi che esso, in effetti, aveva dato luogo ad una cessione onerosa di beni, il
cui corrispettivo era costituito dall'accollo dei debiti da parte della società agricola.
In conclusione la Suprema Corte, considerato:
-che effettivamente il valore dei debiti trasferiti rappresentava il 99 per cento circa del valore dei
beni ceduti e riguardava passività relative all'acquisto degli stessi beni;
-che a siffatto elemento, già di per sè altamente significativo, andavano aggiunte le particolarità
dell'intera operazione quali: - il risultato complessivo dell'operazione, unitariamente considerata,
sotto il profilo del regime dell'IVA allora applicabile, rispettivamente, alla società ricorrente ed alla
società agricola; - il quasi immediato trasferimento, a distanza di 17 giorni, da parte della società
della quota acquisita nella società agricola a terzi- il fatto che i bovini oggetto del conferimento non
abbiano mai subito spostamenti fisici e siano, anzi, rimasti nelle stesse stalle, i cui proprietari erano
dapprima depositari della società ricorrente e, quindi, soccidari di quella agricola;
-che si trattava di un complesso di circostanze rivelatrici di aspetti non coerenti con le finalità di un
conferimento di beni in società, destinato a dotare la medesima di mezzi opportuni per lo
svolgimento dell'attività economica programmata;
-che ciò giustificava sul piano logico e giuridico le conseguenze che ne ha tratte la Commissione
Regionale, e cioè che nella specie vi era stata una cessione di beni dalla società ricorrente alla
società agricola, come tale da assoggettare ad IVA.
Fortemente innovativa è la decisione di Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10352 del 05/05/2006,
secondo cui “In tema di IVA, nell'ordinamento comunitario, in base all'art. 17 della direttiva CEE 17
maggio 1977, n. 388, e, quindi, anche in quello interno (cfr. la pronuncia del 21 febbraio 2006, resa
dalla Corte di Giustizia CE, in causa C - 419 - 2002), deve considerarsi in ogni caso vigente (anche
a prescindere dall'applicabilità "ratione temporis" di norme interne antielusive, quale quella
introdotta dall'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973) il principio di indetraibilità dell'IVA assolta in
corrispondenza di comportamenti abusivi, volti cioè a conseguire il solo risultato del beneficio
fiscale, senza una reale ed autonoma ragione economica giustificatrice delle operazioni, che,
perciò, risultano eseguite in forma solo apparentemente corretta ma, in realtà, sostanzialmente
elusiva.
Il principio del cd. abuso del diritto, di matrice ed applicazione comunitaria, viene quindi
esplicitamente recepito dalla Corte.
La fattispecie era costituita dalla rettifica operata dall’ufficio Iva nei confronti di una società che
aveva la titolarità di un solo immobile, che aveva proceduto alla sua ristrutturazione assolvendo
l’Iva sugli acquisti e sulle prestazioni ricevute per poi vendere l’immobile ristrutturato ad un socio
portando in detrazione l’Iva pagata per la ristrutturazione.
Con l'avviso di rettifica l'Ufficio sosteneva il carattere elusivo dell'attività di acquisto e vendita
dell'immobile, in quanto dirette a portare in detrazione l'Iva assolta con la ristrutturazione
dell'immobile.
La Suprema Corte riteneva che - in tema di IVA - un'operazione economica isolata, compiuta da
una società commerciale, non diretta al mercato, quand'anche l'atto costitutivo o lo statuto sociale
prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita e
locazione d'immobili, di per sè sola non può valere a dare consistenza ad un'attività imprenditoriale
capace di giustificare l'inerenza dell'operazione passiva all'attività svolta, salvo che la società
dimostri o che l'operazione, apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in una
specifica attività imprenditoriale, oppure che essa s'inserisca in una attività immobiliare vera e
propria, così che - in ambedue i casi - sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in
proprio favore.
Il soggetto d’imposta ha eccepito che mancava una clausola antielusiva, all'epoca dei fatti oggetto
della controversia, nel nostro ordinamento giuridico, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la
circostanza, richiamando la precedente sentenza n. 22932 del 2005 e affermando che, nella
disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis introdotto
dal D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 7, pur non esistendo nell'ordinamento fiscale italiano una
clausola generale antielusiva, non poteva negarsi l'emergenza di un principio tendenziale,
desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso del diritto elaborato dalla giurisprudenza
comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici da operazioni intraprese ed eseguite al solo
scopo di procurarsi un risparmio fiscale.
La Suprema Corte ha fatto riferimento, sul punto, ad una pronuncia del 21 febbraio 2006 (il
riferimento è piuttosto impreciso, in quanto cita la causa C-0419-2002 mentre il principio è stato
enunciato in relazione alle coeve decisioni sulle cause 255/02 e 223/03) della Corte di Giustizia
delle Comunità europee, che chiarisce che la 6Halifax direttiva CEE n. 77/388/CEE, direttamente
applicabile in quello nazionale, aggiunge alla tradizionale bipartizione dei comportamenti tenuti dai
contribuenti in tema di Iva, fra quello fisiologico e quello patologico (proprio delle frodi fiscali), il
primo idoneo a consentire una piena detraibilità dell'imposta assolta ed il secondo la sua assoluta
indetraibilità, una sorta di tertium genus, in dipendenza del comportamento abusivo ed elusivo del
contribuente, comportante il recupero dell'Iva detratta e l'eventuale rimborso in favore del soggetto
che abbia posto in essere l'operazione elusiva.
La Cassazione conclude che, pertanto, nell'ordinamento comunitario e, quindi, anche in quello
interno deve considerarsi vigente il principio di indetraibilità dell'Iva (art. 17 della citata direttiva n.
77/388/CEE) assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi, volti cioè a conseguire il solo
risultato del beneficio fiscale, senza una reale ed autonoma ragione economica giustificatrice delle
operazioni economiche che, perciò, risultano eseguite in forma solo apparentemente corretta ma,
in realtà, sostanzialmente elusiva; che la valutazione del carattere abusivo ed elusivo
dell'operazione economica svolta dal contribuente è giudizio spettante al giudice del merito il quale
è tenuto a darne conto con una motivazione adeguata e logica;
Come si vede, qui i supremi giudici abbandonano i tentativi di giustificare gli accertamenti fiscali
anti elusione con singole disposizioni delle leggi d’imposta (quali l’art. 8 RD 3269/23,
effettivamente di ardua applicazione) ovvero sulla scorta di disposizioni codicistiche civili sulla
nullità della causa dei contratti o sulla sua illiceità, ma si spingono ad affermare l’esistenza, nel
nostro diritto interno, di un principio generale anti elusione, quanto meno in materia di iva.
Il caso nasce da un avviso di rettifica, relativo al periodo di imposta 1990, notificato ad una società
a responsabilità limitata, con il quale l’allora ufficio iva negava la detrazione dell’imposta pagata
sugli acquisti da tale società in base all’art. 19 del DPR 633/72. Secondo l’Ufficio, la società non
aveva realizzato lo scopo sociale poiché la stessa aveva acquistato un solo immobile, ristrutturato
e venduto ad un suo socio con il fine esclusivo di detrarre l’Iva assolta con la ristrutturazione.
La società ricorreva alla Commissione provinciale e poi a quella regionale, ma entrambi i giudici
ritenevano fondato l’avviso di rettifica, osservando che in cinque anni, l’attività della società si era
limitata all’acquisto di un solo immobile e questo, dopo la ristrutturazione, era stato ceduto ad un
socio.
La Suprema Corte ha confermato la pronuncia d merito, appunto affermando
-che un'operazione economica isolata, compiuta da una società commerciale per meri scopi di
fruire di un beneficio fiscale, non diretta al mercato, quand'anche l'atto costitutivo o lo statuto
sociale prevedano che il sodalizio possa compiere operazioni di acquisto, ristrutturazione, vendita
e locazione d'immobili, di per sè sola non può valere a dare consistenza ad un'attività
imprenditoriale capace di giustificare l'inerenza dell'operazione passiva all'attività svolta, salvo che
la società dimostri o che l'operazione, apparentemente singola, non sia isolata e che sia inserita in
una specifica attività imprenditoriale, oppure che essa s'inserisca in una attività immobiliare vera e
propria, così che - in ambedue i casi - sia destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in
proprio favore;
-che non rileverebbe la pretesa mancanza di una clausola antielusiva, all'epoca dei fatti oggetto
della controversia, nel nostro ordinamento giuridico, essendo inapplicabile retroattivamente la
disciplina dell’art. 37 bis DPR 600/73 introdotta dal D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 7, in quanto,
come sottolineato anche dalla precedente sentenza n. 22932 del 2005, , pur non esistendo
nell'ordinamento fiscale italiano una clausola generale antielusiva, non potrebbe negarsi
l'emergenza di un principio tendenziale, desumibile dalle fonti comunitarie e dal concetto di abuso
del diritto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui non possono trarsi benefici da
operazioni intraprese ed eseguite al solo scopo di procurarsi un risparmio fiscale.
La Suprema corte coglie l’occasione per riaffermare la diretta applicabilità nel diritto interno delle
direttive comunitarie. Nel caso in esame, troverebbe quindi immediata e diretta applicazione
nell’ordinamento italiano la direttiva 77/388/CEE che sancisce il principio di in detraibilità dell’Iva
assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi, volti cioè a conseguire il solo risultato del
beneficio fiscale, senza una reale ed autonoma ragione economica giustificatrice delle operazioni
economiche che, perciò, risultano eseguite in forma solo apparentemente corretta ma in realtà
sostanzialmente elusiva.
(Ad avviso di chi scrive, malgrado vada sempre più affermandosi, nella giurisprudenza di
legittimità, il principio della diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale delle direttive
comunitarie, anche se pregiudizievoli per il singolo, nel caso di specie non vi erano, a rigori, gli
estremi per ravvisare un ‘ipotesi di direttiva autoapplicativa o self-executing, proprio in ragione
della mancata specificità dispositiva e del carente dettaglio normativo della direttiva in questione).
Da ultimo, con ordinanza n. 12301 del 24.5.2006, la quinta sezione tributaria della Cassazione ha
investito della questione le Sezioni unite. Tale sollecito di intervento peraltro, non deriva da un
contrasto giurisprudenziale interno o esterno alla sezione, ma riguarda la corretta identificazione
della elusione fiscale. Nell’ordinanza, infatti, si chiede ai Collegi riuniti di individuare in modo
sistematico i caratteri tipici del fenomeno elusivo, elaborando dei principi che, diversamente da
quanto avvenuto sino ad ora, siano in grado di essere utilizzati e applicati universalmente,
prescindendo dal caso concreto di volta in volata sottoposto al vaglio di legittimità della Suprema
Corte. A cui spetterà quindi l’arduo compito di determinare gli aspetti peculiari del fenomeno
elusivo e di tracciare i suoi labili confini con il lecito risparmio d’imposta cui tutti gli operatori
tendono.
La giurisprudenza comunitaria
Gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE emergono chiaramente dalle tre
recenti sentenze rese nella cause C-255/02, C-419/02 e C-223/03 e di cui dianzi si è trattato.
Le tre controversie hanno ad oggetto operazioni realizzate allo scopo di conseguire un beneficio
fiscale in termini di diritto alla deduzione dell’Iva.
La Corte si è pronunciata, in primo luogo, sul quesito se operazioni effettuate al solo scopo di
rendere possibile il recupero dell’imposta assolta possano costituire un’”attività economica” nel
senso dell’art. 4 comma 2 della sesta direttiva (ricordiamo che si tratta della Direttiva del Consiglio
1l 17.5.1977 n. 777388/CEE in materia di armonizzazione degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto:base imponibile uniforme)
In secondo luogo, la Corte ha risposto al quesito se sia possibile applicare la dottrina sull’”abuso
del diritto” nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto per respingere domande di deduzione
dell’Iva avanzate dai soggetti all’imposta.
L’avvocato Generale ha rassegnato le proprie conclusioni con atto presentato il 7.4.05, in cui
esamina approfonditamente ed esaurientemente i vari aspetti delle questioni.
1-Sul quesito se operazioni effettuate al solo scopo di rendere possibile il recupero del’imposta
assolta possano costituire un’”attività economica”, ricordiamo che l’art. 4 comma 2 della sesta
direttiva definisce “attività economiche” tute le attività di produttore, di commerciante o di
prestatore di servizi.
Nella causa 255/02, una banca (Halifax), specializzata in servizi finanziari eSenti da Iva,
intendeva costruire dei call-centers su quattro terreni presi in locazione o di sua proprietà. I suoi
fiscalisti elaborarono un piano che permetteva alla banca di recuperare la quasi totalità dell’iva sui
lavori di costruzione; ciò coinvolgendo altre società del gruppo, una delle quali (LPDS) fungeva da
intermediaria per l’acquisizione dei terreni e per coordinare l’appalto delle costruzioni, mediante un
cospicuo finanziamento della Halifax (esente da Iva), altra ancora (CWPI) aveva l’incarico di
occuparsi dei vari appalti con i singoli costruttori e professionisti indipendenti.
I Commisioners (Uffici fiscali del Regno Unito) respingevano le richieste di rimborso Iva per 7
milioni di sterline presentata dalla LPDS (corrispondenti all’importo addebitatole dalla CWPI per
eseguire i lavori edilizi sui terreni) e quelle formulate dalla CWPI (relativamente all’Iva pagata sulle
prestazioni dei vari costruttori indipendenti). Ritenevano che, di fatto, le uniche vere prestazioni di
servizi di costruzione erano state effettuate dai costruttori indipendenti direttamente in favore della
Halifax, e che un’operazione, qualunque fosse la sua natura, condotta al solo fine di eludere
l’applicazione dell’Iva, non costituisse un atto compiuto nell’ambito di una attività economica”.
Conseguentemente, assumevano che né gli obblighi assunti dalla LPDS nei confronti della Halifax
né gli obblighi di costruzione assunti dalla CWPI nei confronti della LPDS rappresentavano
“cessioni” o “prestazioni” nel senso della Sesta direttiva.
La Halifax, la LPDS e la CWPI impugnavano il rigetto avanti al VAT (Value Added Tax) and Duties
Tribunal di Londra, che respingeva i ricorsi poi, restituitale la causa dalla High Court of Justice of
England, sottoponeva alla corte di Giustizia CEE i quesiti di cui sopra.
Nella causa 419/02, una società inglese che si occupava della gestione di ospedali privati e di
fornire ai medesimi farmaci e protesi (attività in cui pagava l’Iva sugli acquisti a monte di farmaci e
protesi ma non a valle sulle forniture ai suoi clienti, soggette ad aliquota pari a zero), allo scopo di
eludere una normativa di assoggettamento all’Iva di tali operazioni che il Regno Unito si accingeva
ad adottare, nel periodo compreso tra l’annuncio di tali norme e la loro entrata in vigore, stipulava
accordi di pagamento anticipato che neutralizzavano l’impatto della nuova legge sulla sua
posizione finanziaria. L’idea era di acquistare, pagandone in anticipo il prezzo, una gran quantità di
farmaci e protesi con il risultato che, anche se le merci fossero state specificate e consegnate
dopo l’abolizione del regime dell’aliquota zero, non sarebbe stata addebitata l’iva, trattandosi di
beni pagati mentre ancora sussisteva il diritto al rimborso dell’imposta assolta. Il fornitore da
pagare in anticipo veniva individuato in una società del gruppo, mentre altre due società del
medesimo gruppo concludevano accordi di pagamento anticipato uguali ma contrari.
I Commissioners rifiutavano di autorizzare la deduzione Iva e, dopo il vano ricorso al VAT and
Duties Tribunal di Londra, il giudice di appello sottoponeva alla Corte di Giustizia i quesiti di cui
sopra.
Nella causa C-223/03, un’Università aveva progettato di ristrutturare due edifici di cui aveva la
disponibilità per svolgere servizi didattici esterni e i suoi fiscalisti elaborarono alcuni piani per
permetterle di recuperare l’intero importo dell’Iva sui lavori di ristrutturazione attraverso una serie
di operazioni che coinvolgevano altre e distinte persone giuridiche.
Anche in questo caso, i Commissioners, negando la deduzione dell’imposta assolta sui lavori
edilizi ricevuti, liquidavano l’imposta secondo l’aliquota di legge, osservando che un’operazione
realizzata al solo scopo di evadere o eludere l’iva non poteva considerarsi un’attività economica
nel senso voluto dalla sesta direttiva, che essa non costituiva cessione di beni o prestazione di
servizi ai sensi della predetta normativa comunitaria e che, in subordine, si trattava di operazione
che non poteva essere presa in considerazione nella sua formale natura giuridica perché
concretante un abuso del diritto e che invece occorreva fare riferimento alla sua vera natura
giuridica, e applicare la sesta direttiva.
Il VAT and Duties Tribunal di Manchester, investito della questione, chiedeva lumi alla Corte di
Giustizia CE su tali tre aspetti.
La Corte ha risposto ai giudici nazionali come segue:
1-quanto alla nozione di attività economica, ha stabilito che, per i principi di neutralità del
sistema comune e di certezza del diritto (in forza del quale l’applicazione della normativa
comunitaria deve essere prevedibile per coloro che vi sono sottoposti), che tale nozione è in tutto
e per tutto oggettiva, e prescinde dallo scopo e dai risultati avuti di mira dai soggetti.
2-Così anche per le cessioni e le prestazioni di servizi, che vanno valutate nella loro oggettività
senza tenere conto dei motivi, scopi e ragioni , cioè degli stati soggettivi, dei contribuenti che le
hanno poste in essere (ricordiamo che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 dela Sesta direttiva, sono
“attività economiche” tutte le attività di produttore, di commerciante e di prestatore di servizi” e che,
termini dell’art. 5 comma 1, si considera cessione di un bene il trasferimento del potere di disporre
di un bene materiale come proprietario; mentre, ex art. 6 comma 1, si considera prestazione di
servizi ogni operazione che non costituisce cessione ai sensi dell’art. 5 comma 1).
3-Circa la nozione di abuso, la Corte ha individuato due parametri per accertare pratiche abusive
e quindi elusive, il primo dato dalla sussistenza di un insieme di circostanze oggettive dalle quali
risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla norma comunitaria,
l’obiettivo perseguito dalla normativa non è stato raggiunto; il secondo, dato da un elemento
soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa
comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento.
Ad avviso della Corte, pertanto, si configurerebbe un principio interpretativo del diritto
comunitario in genere, e della normativa in materia di Iva in particolare, nel senso di contrastare
ogni forma di abuso del diritto. Del resto, anche in precedenti controversie, l’Avvocato Generale
aveva sostenuto che “ogni ordinamento che aspiri ad un minimo di completezza deve contenere
delle misure, per così dire, di autotutela al fine di evitare che i diritti da esso attribuiti siano
esercitati in maniera abusiva, eccessiva o distorta.
4-Circa la questione particolare sollevata nella causa C-419/02, la Corte ha statuito che il
pagamento di un acconto per beni imprecisati o solo genericamente indicati in un elenco dal
quale il compratore può scegliere in futuro uno o alcuno o nessuno di essi e in circostanze in cui
l’acquirente può risolvere unilateralmente il contratto in qualsiasi momento e recuperare l’importo
versato, non può ritenersi un “pagamento di acconti anteriore alla cessione o alla prestazione di
servizi” ai sensi dell’art. 10 n. 2 della Sesta direttiva (che fa riferimento invece al pagamento di
acconti per beni e servizi specificati e individuati) e non rende pertanto l’imposta esigibile all’atto
dell’incasso dell’acconto stesso.
Dopo aver esaminato gli orientamenti pregressi e attuali della Suprema corte di Cassazione e della
corte di Giustizia Europea, occorre esaminare, per concludere, la situazione normativa oggi
esistente.
Ricordiamo che sino al 1998, a differenza di altri ordinamenti, in cui esisteva già una norma
generale anti elusione, nel nostro ordinamento si è sempre privilegiata l’adozione di misure di
contrasto speciali, che colpivano cioè precise operazioni elusive.
Ora l’art. 37 bis DPR 600/73, introdotto dal D.lgs 398797, stabilisce che:
“1. sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro,
privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento
tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. l'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i
negozi di cui al comma 1,applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto
delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
3. le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di
cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme
prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di
aziende;
c)cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti
d'attivo e scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di
cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c -bis) e c -ter), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della
tassazione di gruppo di cui all’art. 117 del tuir;
f ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all’art. 26 quater qualora detti pagamenti siano effettuati
a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o piu’ soggetti non residenti in uno stato
dell’unione europea.
4. l'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e
2.
5. fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere
specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e
le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al
comma 2.
6. le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2
sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio,
unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. i soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono
richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti
dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione
giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli
interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
8. le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento
tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente
l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione.
Con decreto del ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.."
I requisiti richiesti per l’applicazione della norma in esame possono così indicarsi:
1-anzitutto, deve trattarsi di atti, fatti e negozi inquadrabili in una delle operazioni previste dalla
norma. L’elencazione di cui al comma 3 deve considerarsi tassativa, in quanto si tratta di norma
fiscale speciale e/o eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica;
2-poi, deve trattarsi di atti, fatti, negozi, anche collegati tra loro, “diretti ad aggirare obblighi o
divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi
altrimenti indebiti”. Si tratta di requisito avente caratteristiche miste, oggettive e soggettive, nel
senso che la finalità di “aggiramento” delle norme dell’ordinamento tributario costituiscono lo scopo
della condotta elusiva, sono quindi espressione della volontà elusiva del soggetto d’imposta, ma
devono estrinsecarsi in elementi obiettivi, senza rimanere nel foro interno del soggetto stesso, e
pervenire al risultato del risparmio d’imposta. La volontà di conseguire un vantaggio fiscale deve
quindi tradursi in uno o più fra gli atti, fatti e negozi previsti dal comma 3 che risultino “aggiranti”,
l’aggiramento deve essere effettivo e il risparmio di imposta reale ed economicamente
apprezzabile.
3-ai suindicati elementi positivi va aggiunto l’imprescindibile elemento negativo costituito dalla
“assenza di valide ragioni economiche”, requisito sul quale si tornerà nel prosieguo.
Solo in presenza di tutti e tre questi requisiti, si verifica l’effetto previsto dalla norma, cioè la non
opponibilità all’amministrazione finanziaria degli atti, dei fatti e dei negozi, anche collegati, posti in
essere dal soggetto d’imposta.
E quindi solo al ricorrere di tutte e tre queste condizioni la stessa Amministrazione potrà
disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti, i negozi di cui sopra ed
all’applicazione delle imposte determinate in base alle disposizioni eluse (ovviamente, al netto di
quanto pagato dal contribuente sulla base degli atti, fatti e negozi posti in essere).
Deve essere sottolineato che la norma di cui all’art. 37 bis DPR 600/73 non richiede né prevede,
quale elemento necessario per concretizzare una fattispecie di elusione, l’anormalità degli atti o
della concatenazione di atti né il cd. abuso delle forme giuridiche che in altri ordinamenti (es., in
quello tedesco) ha da sempre costituito l’elemento qualificante dell’elusione. Anche se
l’aggiramento da cui deve essere oggettivamente connotata la condotta del soggetto d’imposta
implica inevitabilmente un uso anomalo degli strumenti civilistici impiegati, e cioè o nell’impiego di
atti o negozi tipici in funzione atipica o nell’utilizzazione di negozi e contratti atipici ovvero, ancora,
nel collegamento di negozi tipici e/o atipici per finalità atipiche e quindi aggiranti.
Riservando ad altra sede l’analisi più approfondita degli elementi sopra elencati, è importante
sottolineare che la norma dell’art. 37 bis DPR 600/73 non può quindi essere considerata una
norma generale antielusiva, in quanto il comma 1, di portata generale, va combinato con il disposto
del comma 3, e quindi la fattispecie è circoscritta ad atti, fatti, negozi, in definitiva a operazioni
comunque individuate e tassativamente elencate.
Anzi, l’ultimo comma contiene una disposizione “generale” di segno opposto.
Precede infatti il comma 8 che “ le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri
che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. a tal fine il contribuente
deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo
compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione."
Da ultimo, appaiono essenziali alcune considerazioni di ordine procedimentale.
A-L’accertamento ex art. 37 bis DPR 600/73 è nullo se non è preceduto da una richiesta formale
di chiarimenti al contribuente in cui devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i
commi 1 e 2 (inopponibilità degli atti alla p.a. e disconoscimento dei vantaggi conseguiti);
B-l’accertamento deve contenere, oltre a tutti gli elementi di cui all’art. 42 dpr 600773, anche – a
pena di nullità – una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente in
esito alla richiesta di cui al punto A.
Queste previsioni di ordine formale e sostanziale dimostrano, da un lato, l’estrema cautela del
legislatore nel consentire agli uffici di avvalersi della norma anti elusione ma, da altro lato,
sembrano introdurre in modo surrettizio una sorta di inversione dell’onere della prova, nel senso
che toccherebbe al soggetto d’imposta, autore di atti, fatti, negozi ecc. contemplati dal comma 3,
fornire giustificazioni (implicanti necessariamente deduzione di circostanze, produzione di
documenti, richiami a leggi d’imposta e/o a norme prevedenti agevolazioni, deduzioni, ecc.,) circa
la mancanza della finalità di aggiramento e della esistenza di valide ragioni economiche nelle
operazioni poste in essere e su cui si è incentrata l’attività accertativa dell’amministrazione.
Deve allora essere ben chiaro che nelle fattispecie di cui all’art. 37 bis DPR 600/73, come anche in
tutte le altre ipotesi in cui nessuna legge ponga presunzioni iuris tantum o iuris et de iure a favore
dell’erario, l’onere della prova della condotta elusiva rimane pur sempre a carico
dell’amministrazione, che riveste la qualità di attore sostanziale nel processo tributario.
Di conseguenza, in caso di silenzio del contribuente a fronte della raccomandata di richiesta di
chiarimenti, non soltanto non potrà ricavarsi alcun elemento negativo o di sfavore in danno del
soggetto d’imposta, ma incomberà pur sempre all’ufficio, anzitutto, di motivare adeguatamente
l’atto impositivo e poi, in sede contenziosa, di provare tutti gli estremi della condotta elusiva.
In difetto, la Commissione tributaria dovrà annullare l’accertamento.
Torino, 15 febbraio 2007
Paolo Roggero