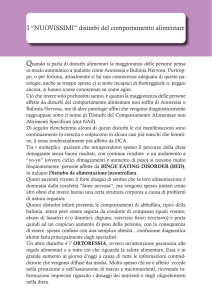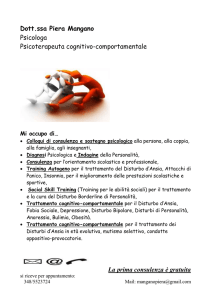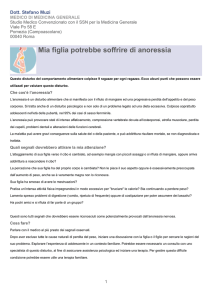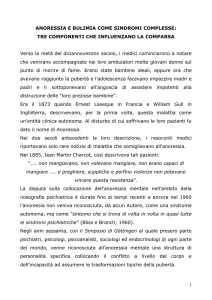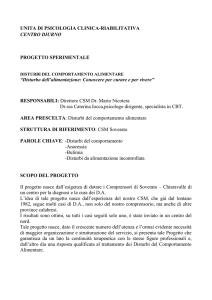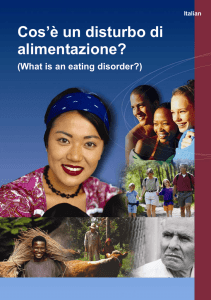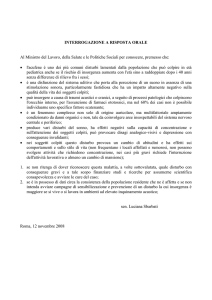Giovanni Cutolo
Già Primario psichiatra ASL 9 Zona 1
Già Responsabile Centro D.C.A. ASL 9 (GR) 2000- 2008
Professore a contratto di Psicoterapia Università di Siena
IRRAZIONALITA’ E COERENZA NEI DISTURBI ALIMENTARI PSICOGENI
Approccio cognitivista post-razionalista e modalità organizzative
(l'esperienza del Centro Aziendale di Grosseto)
1) COSA SONO I D.C.A.
Negli ultimi anni la presenza dei Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) ha investito i
Servizi pubblici di salute mentale. La richiesta di intervento per questi nuovi disturbi, che sembrano
interessare le persone con modalità inattese e diverse rispetto ai disturbi “tradizionali” come le
psicosi, sta mettendo a dura prova la funzionalità e la organizzazione dei Servizi, perché mette in
crisi i tradizionali modelli della gestione clinica e della “presa in carico” basati su un intervento
psico-farmacologico (che nei D.A. è poco utile), un intervento psicoterapeutico (spesso di difficile
attuazione), un intervento riabilitativo (in genere non praticabile e comunque poco accettato). Nello
stesso tempo tutto ciò preme per un rinnovamento dei metodi e, prima ancora, dei modelli
epistemologici che definiscono gli interventi terapeutici.
a)Epidemiologia
La frequenza epidemiologica nella popolazione europea e nordamericana mostra l’anoressia con
una prevalenza dello 0,5-1%; la bulimia è ritenuta in costante aumento, attestandosi attualmente
intorno al 2-3%. Il tasso di incidenza totale dei D.A. sarebbe di 20 persone su 100.00 all’anno, di
cui 8 anoressiche e 12 bulimiche. In Italia si calcola che su 100 ragazze tra i dodici e i venticinque
anni, più di dieci soffrano di disturbi del comportamento alimentare, ma sicuramente questo dato
comprende in maniera confusa e confondente situazioni conclamate, situazioni “sotto-soglia” e
situazioni non riconosciute e/o non trattate. Su dieci pazienti, nove sono femmine e uno è maschio.
b) Fattori storici, sociali e culturali
Sebbene presente in precedenti epoche storiche, a partire dal Medio Evo, in forme “isolate”,
l’anoressia non veniva considerata un disturbo fisico o mentale, ma una particolare modalità
“volontaria” di rinuncia al cibo attraverso la quale si esprimeva una tendenza alla spiritualità, al
raggiungimento di uno stato mistico che staccava la donna dal mondo terreno per avvicinarla a Dio,
come si ritrova nelle storie di alcune sante, ad es. Santa Caterina da Siena (Bell 1985, Zorzetto e
al.1999). Tale modalità sembra diffondersi, in quell’epoca, all’interno di famiglie nobili e ricche, le
uniche che non hanno certo problemi di nutrimento, e rappresenta un tentativo di manifestare
l’autonomia personale, con una modalità estrema ed oppositiva da parte di giovani donne destinate
altrimenti al silenzio e alla scomparsa dalla vita civile dell’epoca (Reda e Sacco 1999).
Entrati nella psicopatologia psichiatrica fin dal XIX°, i disturbi alimentari sono emersi, nelle società
occidentali, con prepotenza, nell’ambito dei disturbi psichici, in particolare negli ultimi
cinquant’anni.
I D.C.A. sono tuttora rari nelle società povere del terzo mondo, ma non tra gli emigrati di queste
regioni nelle società ricche, come se la presenza di un fattore concreto, la lotta per la sopravvivenza,
1
per la conquista del cibo là dove esso rappresenta un problema quotidiano, sia una condizione che
ne impedisca il manifestarsi. Mentre gli emigrati provenienti dai paesi poveri possono manifestare il
disturbo senza sostanziali differenze rispetto agli abitanti del paese di residenza. Per questo
anoressia e bulimia potrebbero essere considerate sindromi “culture bound” cioè legate a specifiche
culture quali quelle delle società avanzate1. Significativo da questo punto di vista il lavoro di
Becker et al nelle isole Fiji (2002): questi hanno valutato nel ’95 63 studentesse di 17 anni, un mese
dopo che iniziava a diffondersi la televisione attraverso il satellite nella regione; 38 mesi dopo sono
state studiate altre 65 ragazze confrontabili per età, peso e altre caratteristiche con il campione
originario. L’11% del campione del 98 si procurava il vomito per controllare il peso (contro lo 0%
del 95) e il 29% era a rischio di Disturbi Alimentari e il 75% diceva di sentirsi troppo grassa.
Se proseguiamo in una linea di analisi antropologico-culturale, vediamo come nella società
occidentale che abitiamo, definita post-moderna, perdono importanza i valori tradizionali legati alla
religione, alle ideologie, che regolavano una continuità e stabilità dell’individuo nel corso del suo
ciclo di vita, con una prevalenza del sentirsi legati all’ “interno” di un contesto sociale e familiare
che forniva valori, regole di vita chiare, ed il supporto affettivo di famiglie “allargate”. Aumentano
invece, nella famiglia mono-nucleare odierna, gli aspetti legati all’immagine, al “dover essere
momento per momento” in relazione alla variabilità dei contesti sociali, per cui la costruzione
dell’identità personale dipende sempre più dal modo in cui si è visti dagli altri, con la prevalenza
del sentirsi legati all’ “esterno”.
Questa identità personale appare dunque continuamente mutevole, legata ai ruoli sociali che si
impersonano, ai contesti in cui ci si muove volta per volta durante la vita e nell’arco della stessa
giornata. E’ una identità poco definita che il sociologo Zygmut Bauman chiama “identità liquida”
(Bauman, 2002). Aumenta la distanza e la difficoltà a conciliare il “come ci si sente dentro” con il
“come ci si sente visti dagli altri”, tra la propria interiorità e l’immagine sociale.
In ogni caso, se pure è indubitabile la pressione sociale e culturale nei confronti della “spinta alla
magrezza”, come cornice necessaria per l’emergenza del disturbo, l’insorgenza del D.A. segue
percorsi e modi che sono comprensibili solo all’interno dei percorsi individuali e soggettivi. Ben
poche sono le persone, tra la moltitudine di ragazze che “fanno la dieta” o che sono sensibili alla
moda, che svilupperanno la malattia conclamata.
c) Differenze di “genere”
In questo passaggio epocale il cibo non è più “nutrimento” per la sopravvivenza, ma tende a
diventare, specie per il genere femminile, lo strumento che permette di formare e controllare in
maniera pronta, “immediata”, la propria immagine. Per chi attribuisce estrema importanza al
giudizio degli altri, il modo con cui si appare all’esterno diventa il modo con cui si può regolare la
distanza emotiva dagli altri, specie gli altri significativi, e ancor più il modo con cui si può regolare
il “senso di sé” dentro la famiglia e i contesti sociali.
E’ interessante, da questo punto di vista, notare la differenza tra femmine, che presentano
statisticamente in maggioranza il disturbo, e i maschi che apparentemente ne sono meno interessati,
e vedere se ci sono e quali siano, i corrispondenti comportamenti di “genere” maschile.
Nei maschi oggi non è tanto l’aspetto estetico del corpo ad essere lo strumento regolatore
dell’immagine di sé, bensì il comportamento virile (sessualità e coraggio), cosa che li porta ad una
maggiore attenzione e preoccupazione per gli aspetti esteriori visibili della virilità e della sessualità
(dimensioni degli organi sessuali e relative prestazioni) per cui tutti i disturbi di questo tipo
(impotenza, eiaculatio precox, ecc.) sono caratteristici e corrispondenti al disturbo alimentare delle
femmine.
Negli ultimi anni comunque è diventata sempre più frequente l’attenzione dei maschi per il proprio
aspetto fisico (es. masse muscolari, distribuzione dei peli), con modalità che si avvicinano a quelle
1
Così non avviene, dato il loro inserimento nei sistemi nosografici tradizionali.
2
delle femmine. Sotto questo punta di vista altri disturbi emergenti negli ultimi anni possono essere
accomunati ai D.C.A., per esempio la dismorfofobia e la fobia sociale, nuovi comportamenti
adolescenziali a rischio, con aggressività auto ed etero-diretta..(vedi ad esempio i “lanciatori di
sassi” sull’autostrada, i motociclisti ed automobilisti delle gare di corsa notturne, i giocatori alla
“roulette russa”, ecc.. ) Seppure con caratteristiche molto diverse l’uno dall’altro, questi
comportamenti hanno come comun denominatore uno degli aspetti caratteristici dei DCA: la
confusione rispetto alle sensazioni, alle emozioni, agli stati interni, che viene vicariata
dall’esposizione a situazioni “adrenaliniche”: nella sensazione di ebbrezza e di pienezza che
provocano, esse fanno sentire alla persona di “esistere”, e di esistere spesso sotto lo sguardo
“ammirato” degli altri (sia diretto, che indirettamente nel racconto).
d) Caratteristiche cliniche e fenomenologiche
I D.A. sono, più di qualsiasi altro disturbo psichiatrico, sorprendenti e spiazzanti il senso comune: la
deliberata sistematicità con cui l’anoressica porta avanti, arrivando in alcuni casi alla morte, il suo
programma di “magrezza”, l’incontenibile bisogno di abbuffate seguite dalle condotte eliminatorie
della bulimica, appaiono totalmente “irrazionali” di fronte al “buon senso comune”, ancor più se
appartenenti ad una persona che appare per il resto, generalmente, perfettamente normale e
“razionale” sia nei comportamenti che nei pensieri.
E anche quando la persona non riconosce la “volontarietà” del proprio atteggiamento di
controllo/non-controllo nei confronti del cibo, è innegabile, agli occhi di un osservatore esterno, che
esso appare come una scelta più o meno consapevole, come riconoscono gli stessi tradizionali
sistemi di classificazione nosografia dei disturbi psichici: “una deliberata perdita di peso, indotta e/o
sostenuta dal paziente” come recita lo I.C.D.-10 (W.H.O. 1992) o un “rifiuto di mantenere il peso
corporeo al di sopra del peso minimo normale..” (DSM IV, 1994).
La difficoltà clinica di accettare (e poi di curare) un disturbo con conseguenze mediche devastanti
generato da una “scelta” , per quanto essa possa essere confusa e apparentemente non consapevole,
ha prodotto incomprensioni, equivoci e ritardi nel trattamento che durano ancora oggi. Resta
veramente difficile, in un mondo ancora dominato dalla cultura razionalista e positivista incarnata
nel modello medico, concepire un disturbo che nasce da un atto volontario dell’individuo. La storia
della psichiatria ci fa vedere come anche i disturbi psichici vengono individuati e “costruiti”
all’interno della cultura e degli schemi scientifici accettabili in quell’epoca storica (v. anche Kuhn
1962), per cui spesso solo pochi decenni fa l’anoressia veniva disconosciuta o confusa con disturbi
chiaramente “organici”.
Ricordo un evento personale all’inizio della mia carriera psichiatrica, negli anni ’70. Era la prima
paziente “anoressica” che avevo incontrato. Aveva fatto tutte le analisi, il dimagrimento non era
spiegabile con malattie organiche. Lei stessa però riconosceva la volontarietà del sintomo. Le
proposi dei colloqui psicoterapeutici…accettò volentieri. Il suo medico di base mi prese per matto e
minacciò di denunciarmi perché riteneva che “ci doveva essere comunque una qualche causa
organica che non era stata evidenziata”…
Un altro episodio che mi sembra esplicativo di questo clima di non riconoscimento del problema
mi è accaduto recentemente, leggendo alcuni scritti che mi ha portato una paziente bulimica che
seguo da molti anni e che ha avuto anche alcune crisi psicotiche… La signora, che ora ha circa 60
anni, aveva una sorella morta negli anni ‘50 in Ospedale all’età di 14 anni, per una grave forma di
“cachessia”, deperimento organico che fu attribuito ad una atrofia ipofisaria o Morbo di
Simmonds… Beh, nel diario della sorella morta, che questa mia paziente conservava con
3
devozione, la stessa scriveva più volte di come nascondesse costantemente il cibo che le davano in
Ospedale…, cosa di cui nessuno del personale ospedaliero, apparentemente, si era accorto.
E’ interessante notare in questo “caso” che nella storia familiare della mia paziente, ben due
fratelli erano stati ricoverati in Ospedale psichiatrico con diagnosi di schizofrenia, ma tutti e due
avevano evidenti disturbi alimentari (bulimia e obesità) ed una forma di “fobia sociale” che li
aveva portati ad un evitamento totale di qualsiasi confronto con situazioni affettive, sociali e
lavorative e conseguente chiusura autistica. Inoltre altre due sorelle della paziente, tuttora viventi,
manifestano chiari sintomi “sottosoglia” di tipo alimentare, l’una di tipo anoressico, l’altra
bulimico. La famiglia d’origine, molto religiosa, era estremamente rigida, rispettosa della forma,
esigente e con elevate aspettative nei confronti dei figli ma con evidenti difficoltà a fornire loro un
supporto emotivo2.
E’ sorprendente come ancora oggi i D.C.A. siano ancora poco conosciuti e ri-conosciuti. Nella
esperienza del nostro Centro abbiamo visto che il contatto con una agenzia specialistica avviene in
genere molto dopo l’inizio della sintomatologia, spesso dopo anni, e come sia tuttora scarso l’invio
fatto dal medico di base, in particolare per la bulimia che nella prima fase può non dare nessun
segno esteriore facilmente evidenziabile.
Un punto importante è comprendere come ci sia una continuità, un “continuum” tra forme, oggi
sempre più diffuse, di restrizione alimentare (diete), forme iniziali di discontrollo e forme c.d.
“sottosoglia”, sino alle forme a sintomatologia conclamata. Le statistiche disponibili purtroppo non
sono chiare sulla distinzione tra questi differenti aspetti, anche se le forme gravi appaiono piuttosto
rare e probabilmente sono inferiori ai dati dichiarati. Solo una piccola percentuale delle ragazze che
iniziano una dieta diventano anoressiche o bulimiche.
Un altro aspetto riguarda il “continuum” tra anoressia-bulimia-obesità. Riporto qui uno schema
comunemente accettato nella letteratura:
Anoressia restrittiva – Anoressia con condotte di eliminazione – Bulimia con condotte di
eliminazione - Bulimia senza condotte di eliminazione – Obesità (B.E.D. o Disturbo da
alimentazione incontrollata)
Il passaggio dall’una all’altra di queste forme (nei due sensi) può avvenire anche nella stessa
persona. L’analisi fenomenologica (ovvero lo studio del fenomeno così come appare nelle sue
modalità quotidiane e nel suo evolversi nel tempo) ci mostra che le due modalità di controllo sul
cibo, “anoressica” e “bulimica”, tendano a configurare atteggiamenti disposizionali diversi nei
confronti di sé, degli altri e del mondo esterno, sebbene entrambi accomunati dalla medesima
“sensibilità al giudizio esterno”.
Più attiva, centrata sul controllo “vincente” dei propri impulsi la modalità anoressica, con un
atteggiamento relazionale apertamente “oppositivo” fino alla sfida.
Più passiva con fasi di “non-controllo” rappresentate dalla così detta “abbuffata” e con un
atteggiamento oppositivo più articolato e oscillante, la modalità bulimica.
Ancora più “passiva” la modalità tendente all’obesità (B.E.D. o disturbo da alimentazione
incontrollata), nella quale l’abbuffata e l’iperalimentazione corrispondono ad un senso di sconfitta
su di una realtà vissuta come immodificabile e incontrollabile.
Il continuum si può concretizzare poi nella storia evolutiva della stessa persona: nella nostra
esperienza il passaggio dall’una all’altra forma del disturbo è molto frequente sia nella storia
passata che nel corso della terapia.
Cito questo caso per sottolineare come una “organizzazione di personalità” tipo Disturbi Alimentari Psicogeni
possa ritrovarsi in altri disturbi psicotici o nei Disturbi di Personalità
2
4
e) Aspetti descrittivi e classificazioni nosografiche
Anoressia e bulimia appaiono oggi, nell’ambito della psicopatologia classificatoria, degli attuali
sistemi nosografici (DSM e ICD), come entità sintomatologiche definite, dai confini precisi, a
differenza di altre entità nosografiche, come la depressione o la schizofrenia: rispetto agli altri
disturbi inclusi nei sistemi classificatori psichiatrici, i D.A. appaiono comunque come i disturbi più
caratterizzati in maniera chiara e unitaria, con poche ambiguità anche in senso descrittivo e
categoriale.
In psichiatria i sistemi classificatori, o nosografici, hanno la caratteristica di essere
prevalentemente descrittivi, ovvero descrivono un insieme di sintomi e segni che ricorrono più
frequentemente per designare quella entità clinica. A differenza dei sistemi classificatori delle altre
malattie fisiche, in psichiatria si rinuncia ad un criterio eziopatogenetico, ovvero a stabilire quale
sia l’origine precisa per quel disturbo: si parla infatti di disturbi e non di malattie (viceversa per le
malattie fisiche si riconosce in genere una ezio-patogenesi documentabile anche con criteri
“oggettivi” come esami clinici, radiografie, ecc). L’accordo su un disturbo all’interno del sistema
classificatorio psichiatrico permette una intesa fra gli operatori e i ricercatori nei vari contesti, che
così sanno che cosa intenda il collega quando parla di “schizofrenia” o di depressione. Parlare ad
esempio di depressione in termini classificatori, oltre a non essere un’impresa facile, non ci dice
nulla dell’origine, delle cause, e della sua possibile evoluzione. Pertanto i sistemi classificatori
psichiatrici scontano questa limitazione, tanto che gli stessi (ICD,DSM) raccomandano di
“personalizzare” la diagnosi e l’intervento con gli strumenti dell’indagine psicopatologica, la
relazione interpersonale, l’approfondimento della storia e del contesto individuale, familiare e
sociale della persona. Ovviamente questa personalizzazione può essere fatta all’interno di una
“teoria” esplicativa che utilizzi dati sufficientemente validati dalla ricerca e dalle osservazioni
cliniche.
Sono presenti, all’interno del mondo psichiatrico, numerose teorie che prendono in considerazione
fattori biologici, psicologici e sociali. E’ evidente l’importanza di una teoria esplicativa di un
disturbo, perché da essa deriverà conseguentemente un tipo di intervento piuttosto che un altro.
Nei due casi personali di cui ho parlato sopra, ad esempio, una teoria strettamente “organicista”
prevalente fino a 20-30 anni fa, e tuttora presente oggi (che presuppone cioè che i disturbi siano
localizzabili in un organo e comunque staccati dai processi mentali) il disturbo alimentare
“psicogeno” non poteva essere trattato in quanto non veniva neppure riconosciuto nella sua
esistenza: come fenomeno soggettivo non esisteva.
2) VERSO UNA PSICOPATOLOGIA ESPLICATIVA:
COSTRUTTIVISTA E “POST-RAZIONALISTA”
UN MODELLO COGNITIVO-
Nel tentativo di un inquadramento diagnostico “esplicativo”, ovvero di capire cosa sono i DCA,
molti autori li hanno accomunati, di volta in volta, a quasi tutti i disturbi psichici esistenti:
depressivi (per la tendenza alle oscillazioni di umore, il senso di sconfitta e la bassa autostima
propria specialmente delle bulimiche), ossessivi (per il perfezionismo, la ritualità e precisione con
cui attraversano tutte le fasi di preparazione e ingestione del cibo), fobici (per la considerazione del
cibo come “oggetto fobico”), fobico sociali (per l’evidente evitamento o prevenzione delle
situazioni di esposizione al giudizio sociale), psicotici (per il carattere francamente delirante che
assumono nei confronti della propria immagine corporea), dissociativo-isterici (per la teatralità con
cui si vivono e manifestano le loro emozioni), psicosomatici (per la stretta commistione coi sintomi
organici), tossicomanici (per il carattere compulsivo e ripetitivo che assume la “dipendenza” da uno
stato di non bisogno del cibo), di personalità tipo borderline (per la frequente associazione con altri
disturbi specifici come l’impulsività, l’auto-aggressività, la discordanza affettiva, ecc,)…trovando
5
di volta in volta associazioni significative che sono state spesso estremizzate per sottolinearne la
somiglianza con la categoria nosografia prescelta.
Paradosso sorprendente, a mio avviso, se si considera che, pur essendo collegabile a ciascuno dei
disturbi menzionati, il Distubo Alimentare (D.A). appare nella maggior parte dei casi sia sul piano
fenomenico della sintomatologia che nel resoconto individuale, piuttosto netto e non confondibile
con altri, una entità del tutto “autonoma”. Il tentativo di ricondurre il D.A. a categorie nosologiche
preesistenti e consolidate ha generato una confusione epistemologica che a mio avviso deriva dalla
non distinzione tra una psicopatologia “descrittiva” ed “ateorica” quale quella dei sistemi
nosografici come il DSM IV e l’ICD X, ed una psicopatologia “esplicativa” propria dei sistemi
teorici come appunto la psicoanalisi, il cognitivismo, ecc.
In una direzione che cerca di andare al di là dell’apparenza fenomenica delle diagnosi nosografiche,
Guidano e Liotti (1983) hanno evidenziato la specificità e l’autonomia di questo disturbo dagli altri,
e Guidano, nella fondazione di una psicopatologia esplicativa basata sull’integrazione di scienze
psicologiche, biologiche ed antropo-sociologiche3 ha ipotizzato (Guidano1987, 1992) l’esistenza di
una specifica “organizzazione di significato personale” tipo Disturbi Alimentari Psicogeni (DAP),
che prende il nome appunto dalla sua espressione psicopatologica più esplicita ed evidente, il
disturbo alimentare psicogeno, ma che ha una valenza “trans-nosografica”, comprendendo cioè una
serie di disturbi “nosograficamente” molto vari, come ad esempio la fobia sociale, la dismorfofobia,
disturbi sessuali, malattie psicosomatiche, disturbi c.d. di personalità, fino a forme francamente
psicotiche.
Inoltre Guidano, ed il movimento costruttivista da lui promosso sotto il nome di “postrazionalismo”, ha ipotizzato come le “organizzazioni di significato personale” caratterizzino non
soltanto disturbi di tipo “nevrotico” ma siano applicabili alle categorie della “normalità” e della
“psicosi” in un continuum che è basato sulle capacità di elaborazione dell’esperienza tipo
concretezza-astrazione, integrazione-non integrazione, capacità di sequenzializzazione, di
generatività, di narrazione (Guidano 1988, 1992, 2007, 2008).
Da quanto detto sinora ritengo ci sia già materiale per elaborare alcune ipotesi “esplicative”
sull’origine e il mantenimento dei disturbi alimentari. Esporrò qui quella cognitivo- costruttivistapost-razionalista elaborata da Vittorio Guidano, che cerca di capire i D.A. “dal punto di vista della
persona”, con un approccio non riduzionista alla soggettività (approccio in prima persona) e con
una prospettiva “evolutiva” inserita nella storia del suo sviluppo. Il D.A., conclamato o meno,
corrisponde allo strutturarsi nel tempo di uno specifico “significato personale” cioè uno stile, una
modalità particolare di costruire l’identità del soggetto, il proprio “senso di sé”e la relazione con l’
“altro” e con il mondo.
L’alimentarsi è una delle prime modalità con cui l’essere umano regola i processi che costruiscono
il senso di essere un sé. Il senso di sé si struttura sin dalla prima infanzia sulla base di ritmi psicofisiologici che si organizzano nella sintonia e “reciprocità” con le figure di attaccamento, la
presenza delle quali è indispensabile per stabilizzare gli schemi sensoriali, immaginativi, emotivi,
ancora poco organizzati.
Le percezioni e le sensazioni entero-cettive, provenienti dal corpo, connesse al senso di fame o di
sazietà possono essere messe a fuoco, individuate e regolate se vengono convalidate nella
interazione con le figure di attaccamento. Queste figure genitoriali costruiscono i primi schemi di
A partire da un modello cognitivo-comportamentale, Guidano ha proposto una visione “sistemicoprocessuale” che integra teorie evolutive, come la teoria dell’attaccamento (Bowlby), con le teorie dello sviluppo
cognitivo elaborate da Piaget. “Costruttivista” vuol dire considerare la natura evolutiva, costruttiva appunto, della realtà
da parte del soggetto. “Post-razionalista” vuol dire considerare i processi psico-patologici come forme di esperienza e di
conoscenza che hanno uno specifico significato per il soggetto, anche se fuori dalla razionalità e dal “senso comune”,
nel determinare i quali concorrono fenomeni emotivi, oltre che cognitivi.
3
6
riconoscimento di sé: se il bambino ha fame può gradualmente identificare tale sensazione grazie
alle risposte di convalida e di conferma che riceve dal “prestatore di cure”. L’identificazione della
fame, così come di altre sensazioni più complesse, tende poi a stabilizzarsi e permette di dare
continuità ai suoi stati interni e a costruire una “prevedibilità” di quello che può accadere, dalle
risposte che si può aspettare dagli altri. Questo succede naturalmente, oltre che per le sensazioni,
anche per le emozioni di base e quelle più complesse (c.d. cognitive o emozioni auto-coscienti, v.
Lewis 1995 ) che emergono man mano che cresce.
A seconda del tipo di reciprocità e della qualità dell’attaccamento che si instaura con i “care givers”
(vengono così chiamati in letteratura le figure che si prendono cura del bambino), queste percezioni
contribuiscono a costruire i primi schemi mentali di risposta emotiva e comportamentale (es.
accettazione/opposizione) a queste figure di attaccamento. Gli schemi mentali, che pertanto sono
emotivi e cognitivi insieme, costituiscono un primo modello che permette al bambino di orientarsi
nel mondo e rispondere alle sue necessità senza ogni volta ripartire da zero (Bowlby, 1984).
E’ intuitivamente evidente come, insieme ai possibili altri fattori come quelli genetici-ereditari (di
cui oggi conosciamo ancora poco) l’organizzarsi di questi schemi dipenda strettamente dalle
modalità personali con cui viene elaborata l’esperienza affettiva e relazionale della persona.
In questo senso la tendenza al D.A. si origina già durante lo sviluppo infantile quando sono
interferiti meccanismi di “messa a fuoco” di stati percettivi, sensoriali ed emotivi “interni”, per una
non buona sintonizzazione sui ritmi delle figure d’attaccamento. Ad esempio la persona che si
prende cura del bambino potrebbe non riconoscere i suoi (di lui bambino) stati interni e viceversa
cominciare a “ridefinire” quello che il bambino “prova” in base alle proprie convinzioni e
aspettative, piuttosto che cercare di capirle prima, e di aiutare il bambino a riconoscerle poi. E’
evidente che tale interferenza nei ritmi e nelle modalità, per essere “patologicamente” significativa,
deve essere continua, intensa e riguardante ambiti di vita fondamentali per la sopravvivenza, fisica o
emotiva del bambino. E’ anche evidente come una certa “ridefinizione” di stati interni sia
fisiologica ed inevitabile, anzi necessaria perché il bambino possa “dare un nome” a quello che
prova. Ma questa tendenza ridefinitoria da parte della figura di accudimento sia una “scorciatoia”
che può venire attuata, al posto dell’ascolto e della sintonizzazione emotiva, in quanto assai più
breve, semplice e comoda.
Questi bambini, non potendo raggiungere uno stato di confidenza con le sensazioni e le emozioni
che provano, tendono a modellarsi su “criteri” sensoriali ed emotivi esterni, ovvero ad affidarsi
prevalentemente alle figure di riferimento presenti, per avere un senso di sé sufficientemente stabile
e coerente. Si parla di una specifica modalità di attaccamento denominata “attaccamento ambiguo o
confuso” (Guidano, 1988, 1992, 2007). Questa modalità di attaccamento mira pertanto, con una
sintonizzazione sull’esterno, a prevenire una totale imprevedidibilità di quanto accade sia dentro
che fuori di sé: viene pertanto chiamata modalità orientata all’esterno (outward).
Altra caratteristica tipica delle “famiglie con D.A.” è una più generale “sensibilità al contesto”
sociale, alla “forma”, all’immagine, alla aderenza a modi e modelli di vita che vengono seguiti nei
vari ambiti sociali (parentali, professionali, politico-religiosi) che possono essere in contrasto tra
loro ma che spingono queste famiglie a perseguire ideali di perfezione in ciascuno di questi settori
di vita, anche se in ognuno di essi si deve di volta in volta “cambiare pelle” per sentirsi sempre
perfetti e all’altezza dei ruoli e dei compiti richiesti. Questa modalità è stata chiamata da Guidano
“sensibilità al campo” o campo-dipendenza. Nardi (2007) chiama contestualizzate questo tipo di
personalità.
Da ultimo la necessità di aderire momento per momento nel contesto che si sta vivendo per avere un
senso di sé stabile e all’altezza della situazione, indirizza la persona ad elicitare modalità
immediate, pronte da usare al momento presente, per essere in quel momento ed in quel contesto al
massimo immaginabile della prestazione richiesta, o viceversa, ad un evitamento prima selettivo,
poi sempre più generalizzato delle situazioni di “esposizione”.
7
In questa situazione sono le emozioni primarie, basiche, biologiche come paura, curiosità, rabbia,
disperazione, gioia, che appaiono interferite e sfuocate, in quanto non sempre consone alla
situazione sociale, mentre tendono a prevalere e a stagliarsi le emozioni sociali o “cognitive” come
la vergogna, l’imbarazzo, la colpa (Lewis 1995), quelle che si mettono a fuoco e si organizzano
nella costante attenzione e riferimento all’ “altro” significativo, il genitore da cui non si può
prescindere.
La ragazza con D.C.A., avendo difficoltà a decodificare i propri stati interni (detto banalmente:
sapere quello che prova) tenderà a costruire una specifica modalità di organizzazione
dell’esperienza individuale, e di “narrazione” di questa esperienza, basata sull’orientamento
costante ai giudizi e alla “prevenzione” delle critiche esterne, mediante la scelta di una figura di
riferimento tendenzialmente controllabile e non disconfermante. Qualora questo non sia possibile,
cercherà di fare questo attraverso l’evitamento del confronto, il sotterfugio o la bugia, oppure da
ultimo l’opposizione espressa con più o meno aggressività.
Questa modalità era già stata messa in evidenza da tre dei pionieri della terapia dei D.A., che li
hanno studiati prima e durante gli anni in cui Guidano metteva a punto il suo progetto di ricerca, e
che sembrano evidenziare, con i diversi linguaggi dei loro modelli, gli stessi fenomeni.
M.Selvini Palazzoli (Terapista familiare, da “L’anoressia mentale” 1963): Conformemente alla
ricostruzione dettagliata dell’infanzia di queste pazienti così ben curate, e a cui tutto era dato, si
notava un cospicuo deficit nell’incoraggiare le loro espressioni spontanee e peculiari, nel
rinforzare ciò che esse, ed esse sole, desideravano fare. Il risultato, nella fase premorbosa, era la
compiacenza come stile di vita, minante alla base l’autocoscienza anche corporea, il senso di
distinzione propria dagli altri, di autonomia.
H.Bruch (Psicoanalista, da “Patologia del comportamento alimentare” 1977)
Questi pazienti non si sentono padroni del loro comportamento, delle loro necessità e dei loro
impulsi, hanno l’impressione di non possedere il loro corpo, di non avere dentro di sé un centro di
gravità. Si sentono invece sotto l’influenza e il controllo di forze esterne e agiscono come se il loro
organismo e il loro comportamento fossero il prodotto dell’influsso e delle azioni altrui. Dalla
ricostruzione particolareggiata della loro storia di sviluppo si è visto che hanno in comune certe
esperienze fuorvianti, cioè l’assenza o la scarsità di risposte appropriate e di conferma ai segnali
con i quali indicavano le loro esigenze….
S. Minuchin (Terapista familiare, da “Famiglie psicosomatiche – L’anoressia mentale nel contesto
familiare” 1980 ): L’enmeshement (invischiamento) si riferisce a una forma estrema di prossimità
e di intensità nelle relazioni familiari. Dal punto di vista individuale, la differenziazione
interpersonale in un sistema invischiante è molto scarsa. Nelle famiglie invischiate l’individuo
diventa perso nel sistema, cioè diventa un ostaggio del sistema, i confini che definiscono la sua
autonomia individuale sono così deboli e così lassi che funzionare in modo autonomo e
differenziato è radicalmente impedito. I membri familiari intrudono l’uno sull’altro e non c’è
confine alcuno tra i pensieri dell’uno e le emozioni dell’altro…
Con l’emergenza della pubertà e della fisiologica crisi adolescenziale, caratterizzata da profonde
trasformazioni somatiche e dall’aumento delle capacità di astrazione, la ragazza ha il problema di
come stabilizzare un senso di identità personale in un momento del suo ciclo vitale in cui le
vengono richieste prepotentemente nuove competenze affettive, relazionali e sociali nei diversi
mondi in cui vive. L’autonomia personale, l’individuazione rispetto agli altri, diventano un
obiettivo non rinviabile.
8
Il problema è come raggiungere questo obiettivo se si vive un senso di confusione rispetto al
proprio corpo trasformato, al proprio “sentire” vago e indistinto, alla difficoltà di mettere a fuoco e
sentire come proprie le emozioni provate nei diversi contesti. Questo a maggior ragione in quelle
ragazze che hanno avuto un attaccamento, appunto, ambiguo e confuso. In altre parole “come
raggiungere e mantenere un senso di competenza personale” a partire da una situazione di
oscillazione tra il senso di vuoto percepito internamente e l’adesione ad una figura esterna troppo
invischiante e ridefinente il senso di sé.
Ecco allora che il controllo sulla propria immagine corporea attraverso il controllo sul cibo e
l’iperattività fisica, permette di “demarcarsi” in maniera concreta ed immediata dal giudizio esterno,
dando un senso di competenza personale altrimenti non raggiungibile in altri settori di vita.
Potremmo chiamarla una “attività diversiva” che permette di convogliare tutte le energie in un
obiettivo nel quale non sono possibili interferenze esterne, ad es. dei genitori. Nei casi più gravi,
nelle forme conclamate, la concretezza con cui si persegue l’obiettivo di una immagine corporea
esile ed emaciata tende a diventare pervasiva, continua e totalizzante, uno “scopo di vita”. E’ bene
però non dimenticare l’aspetto dimensionale, evolutivo e processuale del disturbo, per cui possiamo
vedere vari livelli di coinvolgimento della persona nel problema, cosa che dovrebbe consigliare la
prudenza in interventi immediatamente invasivi, come il ricovero, ed attuare piuttosto interventi
graduati e correlati alla gravità espressa (approccio stepped care, ovvero cura a passi, a fasi,
v.Todisco 2003).
Spesso il passaggio dalla dieta al disturbo è collegato con eventi di vita in cui sono attivate potenti
emozioni di base che la persona non riesce ad identificare nel Sé e sulle quali non riceve un
adeguato riscontro da parte delle figure di attaccamento significative (esempio frequente nelle
nostra casistica la morte, in famiglia, di un nonno cui si era particolarmente legati. La perdita di un
nonno è spesso la prima perdita affettiva che statisticamente avviene frequentemente per un
adolescente: questa situazione attiva forti emozioni di cordoglio, che devono essere “regolate” e che
spesso non vengono convalidate adeguatamente dai genitori, per cui la persona rimane come
bloccata in una sensazione di perdita che non viene elaborata).
Oppure le informazioni che riceve dal mondo portano ad una “delusione” riguardo
all’atteggiamento percepito dalle figure di attaccamento: es. la scoperta che l’immagine sino ad
allora idealizzata di uno dei due genitori non corrisponde a quanto sinora percepito, essendo
intervenuta una situazione concreta, una scoperta, nella quale i dati di realtà contrastano con questa
immagine. Situazione fisiologica nell’adolescenza, spesso acuita da situazioni “oggettive” di
cambiamenti di atteggiamento dei genitori (es. per separazione della coppia) A volte, più che di
delusione, possiamo parlare di una dinamica incantamento-disincanto. L'anoressica rimane in una
situazione di sospensione della presa d'atto delle nuove emergenze di vita, come se non riuscisse a
collocarle, per cui rifiuta costantemente di entrare in una situazione che comporterebbe la delusione
e il disincanto. La bulimica invece passa continuamente in situazioni di incantamento
(es.innamoramento) per poi volgersi rapidamente al disincanto, che corrisponde alla abbuffata.
La stessa cosa può succedere, all’inverso, a seguito di una valutazione sul proprio atteggiamento
visto come “deludente” verso le figure di attaccamento (es. per il fallimento in un compito, es.
scolastico come un esame, che comporta una revisione, inaccettabile al Sé, dell’immagine di
“perfezione” mostrata ai genitori). In una “cornice” di questo genere, basta anche un commento, ad
es. in famiglia o nel gruppo dei pari, avvertito come critica su di sé, per attivare un senso totale di
disconferma che attiva/acuisce un comportamento alimentare magari già precario (dieta).
Da aggiungere poi le delusioni sentimentali, per cui l’inevitabile critica, disconferma, delusione da
parte dell’altro, o viceversa una sensazione di inadeguatezza in qualche momento del rapporto
sentimentale o sessuale, provoca una percezione di totale vuoto o insicurezza esistenziale.
Non si capisce l’anoressica se non si riesce a comprendere “dal di dentro” la sensazione di potenza
prima, e di onnipotenza poi, che può dare alla ragazza la scoperta della capacità di controllare la
9
fame ed il proprio aspetto fisico, raggiungendo così l’indipendenza da qualsiasi interferenza esterna.
E di come l’esercizio di questa competenza, il cui potere riesce a dominare e tiranneggiare
l’ambiente familiare, sociale e spesso anche quello terapeutico, renda la ragazza disposta ad arrivare
alle estreme conseguenze pur di mantenere questa sensazione “inebriante” di potere, non
raggiungibile con altri mezzi.
In questo senso la terapia del D.A. e dell’anoressia in particolare, non può trascurare questa
sensazione interna di competenza, controllo e potere, che pervade la persona come se fosse una
droga, dagli effetti distruttivi come appunto una droga, e che un intervento basato solo sulla
persuasione o sulla coercizione può spesso stimolare in una sfida mortale piuttosto che ridurre e
contenere. Naturalmente non si vuole qui sottovalutare l’importanza di utilizzare sistemi normativi
nel trattamento del disturbo alimentare, quanto di sottolineare come la sottovalutazione degli
elementi soggettivi di sfida facciano parte di una modalità comportamentale che ha a che fare con
elementi profondi costituenti e parte integrante del Sé.
Allo stesso modo ritengo che l’uso di strumenti interpretativi sia controproducente in quanto
acuiscono, senza metterlo in discussione, la compiacenza e il senso di sentirsi in balìa del giudizio
dell’altro, specie se significativo.
D’altra parte lo stabilizzarsi col tempo di questo meccanismo in un gruppo familiare tende, se non
identificato, analizzato ed affrontato, a perpetuare una situazione di interazioni in cui tutta la
famiglia organizza la vita esclusivamente intorno alle esigenze della ragazza, arrivando a situazioni
di vera e propria “tirannia” del sintomo. E’ interessante notare come i familiari, mentre subiscono
impotenti qualsiasi imposizione dettata dal sintomo anoressico, imposizione che si estende spesso a
settori non alimentari della vita familiare, accolgono con sollievo lo “svelamento” di questa
situazione durante la terapia, rimanendo però poi assai perplessi sulle possibilità di modificare il
loro atteggiamento.
La potenza dei cambiamenti che il sintomo anoressico è in grado di portare all’interno della
famiglia, e delle relazioni più intime della ragazza, contrasta con la sua inefficienza e incompetenza
in buona parte delle relazioni sociali esterne alla famiglia, dove il meccanismo esibito è quello
dell’evitamento, ovvero il non affrontarle, oppure della prevenzione di un possibile giudizio critico,
ottenibile con varie strategie (es. perfezionismo, compiacenza verso gli altri, ecc.).
A volte il sintomo anoressico si modifica fino alla risoluzione, altre volte il senso di controllo viene
perso più o meno stabilmente, dando forma a situazioni di bulimia o di franca obesità (B.E.D. o
Disturbo da Alimentazione Incontrollata), ma non per questo scompare necessariamente il senso di
inefficienza ed incompetenza personale che mantengono la ragazza lontana dalle occasioni di
rapporto sociale. Alcuni miglioramenti terapeutici sono prevalentemente sintomatici, permanendo la
limitazione della vita affettiva e sociale, nei casi ad andamento migliore viene ridimensionato il
livello di aspettative “massimali” sino ad allora presente e la persona si permette gradualmente una
“esposizione” crescente.
In alcuni casi più gravi la modalità “alimentare” tende a diventare un meccanismo stabile di
regolazione degli stati interni e delle relazioni affettive e sociali, ovvero la modalità prevalente con
cui la ragazza affronta, reagisce o previene qualsiasi variazione dello stato emotivo, ogni minima
delusione. In alcuni casi “cronicizzati” sembra quasi che questa modalità si “stacchi”
dall’esperienza reale della persona e tenda a diventare automatica, pervasiva, e relativamente
indipendente dal contesto emotivo. Rimane però sempre un collegamento, se pur spesso difficile da
ricostruire in terapia, con gli eventi emotivi della persona, specie quelli legati a disconferme,
critiche e delusioni, anche minime. Spesso in questi casi il giudizio esterno è semplicemente
“immaginato” piuttosto che realmente sperimentato, nel senso che in ogni situazione “di confronto”
o anche solo di possibile confronto, la persona stessa diventa il giudice, spietato, di sé stessa.
110
0
3) LINEE DI INTERVENTO TERAPEUTICO
Visto in questo modo, pertanto, il sintomo assume un significato di apparente stabilizzazione
rispetto ai problemi emergenti, un tentativo di mantenere la “coerenza” individuale. Tengo a
sottolineare l’importanza di tenere conto di quanto sia “vitale” per la ragazza mantenere questa
coerenza. In questo senso il sintomo, dal suo punto di vista, più che un “meccanismo di difesa” è
una modalità costituiva della sua identità. Quello che agli occhi dell’osservatore esterno è una
impuntatura irrazionale e distruttiva da eliminare e annullare, per la persona è l’unica modalità
trovata per avere un senso di competenza e stima personale contro le intrusioni esterne.
La terapia dei disturbi alimentari, con un modello cognitivista costruttivista e post-razionalista,
parte da qui. Nel tentativo cioè, di aiutare la persona a ri-costruire un senso, un significato, di quello
che lei stessa ha costruito per non sentirsi vuota/inesistente.
L’obiettivo della terapia pertanto consiste nell’aiutare la persona a “conoscere” e ri-conoscere i
propri stati interni, ad esempio le sensazioni, le emozioni di base provate inevitabilmente, e,
attraverso una maggiore conoscenza e articolazione dei vissuti personali, ridurre la dipendenza dal
giudizio esterno che alimenta il sintomo.
La relazione terapeutica di comprensione e di affidamento diventa fondamentale per permettere alla
persona di esplorare questo mondo emotivo per lei così delicato e misterioso.
La relazione permette di costruire la motivazione al cambiamento, in genere assente nelle prime
fasi. Abbiamo visto nella nostra esperienza la difficoltà di questo processo di motivazione: Spesso il
trattamento viene falsamente accettato per compiacere i genitori o il terapista stesso, mentre la
persona rimane abbarbicata alla sua rigida disciplina alimentare. Quando la persona dispone di
strumenti che le permettono di “comprendere emotivamente” quello che le accade, allora inizia a
cambiare. Per arrivare a questo è necessaria spesso una perturbazione motiva che accade all’interno
della stessa relazione terapeutica.
Un’ipotesi esplicativa di questo tipo permette di intervenire nei diversi contesti e con le specifiche
modalità psicoterapeutiche (consulenza, terapia individuale, familiare, di gruppo) e deve comunque
integrarsi con le altre professionalità coinvolte (medico internista, medico di base, nutrizionista,
dietista ecc.) facendo sì che tutti gli operatori che entrano a contatto con la situazione clinica
tengano presenti questa particolare modalità di “organizzare un significato personale”, caratterizzata
da aspetti invarianti, rigidi e abbastanza prevedibili nelle modalità relazionali.
In tutti questi setting dovrebbe essere esplicitamente affrontato il tema del giudizio a partire
dall’evidenziare, nell’interazione diretta col singolo, famiglia, o gruppo, l’intento costruttivo e non
valutativo degli interventi effettuati nel programma terapeutico. Questa “disposizione” alla
comprensione senza critica è un elemento basilare di tutti gli interventi; vista la spontanea tendenza
della persona e dei familiari all’auto-colpevolizzazione e alla colpevolizzazione reciproca. Tale
atteggiamento disposizionale “non giudicante” è una costante, se pur difficile, da perseguire con
ostinazione da parte dei terapisti, che potrà essere abbandonato o modificato quando la persona lo
avrà sufficientemente compreso emotivamente.
Un secondo aspetto di base dell’intervento è quello che riguarda il clima di ambiguità, confusione, a
volte con la presenza evidente di “cose che non si possono dire” e che ufficialmente vengono
ignorate dalla paziente verso i familiari e viceversa, o da questi verso i terapeuti. Questo
atteggiamento di “non poter riconoscere ciò che è già conosciuto da tutti”, che Guidano ha
denominato autoinganno, ad esempio il fatto che la ragazza vomita da mesi senza che
“ufficialmente” questo venga riconosciuto da lei o detto in famiglia mentre è a conoscenza di tutti
(o, per altri versi, il fatto che ci sia in famiglia una situazione critica tra i coniugi, ad esempio che
uno dei due genitori abbia una relazione extra-coniugale) è una delle caratteristiche che necessita di
111
1
una particolare attenzione e delicatezza, da parte del terapista; egli dovrà scegliere le modalità, i
tempi, e le situazioni in cui affrontare esplicitamente, ma più spesso implicitamente (rispettando
così un codice non scritto della famiglia) il problema.
In molti casi tale modalità, unita alla naturale tendenza di queste famiglie di smorzare tutte le
espressioni esplicite e genuine di affetto, porta ad una sottovalutazione della gravità della
situazione, ad esempio quando la sintomatologia fisica mette in pericolo la vita della ragazza, tale
da indurre il terapista ad una drammatizzazione necessaria per affrontare quanto sta accadendo
(Selvini).
Un terzo aspetto generale dell’intervento parte dall’atteggiamento costante, da parte della ragazza,
di oscillazione tra l’accondiscendenza e la compiacenza che dimostrano nei confronti dei familiari e
dei terapeuti, e la sfida, l’oppositività, gli atteggiamenti provocatori. Questa oscillazione è stata
definita da Guidano comportamento “bifasico”: l’esempio tipico è quello della ragazza che parte in
quarta per affrontare la madre prevaricatrice salvo poi, di fronte ad una espressione critica o
sprezzante di questa, cedere completamente col pianto, senso di vergogna, il ritiro in buon ordine. Il
fatto di doversi confrontare con queste modalità continuamente cangianti tra comportamenti
apparentemente così diversi (che rappresentano per la persona una necessità esistenziale e non una
modalità di richiamare l’attenzione) richiede al sistema terapeutico una attenta valutazione di
quando e quanto sia opportuno “scendere in campo” per contrastarlo. Ma quando lo si fa bisogna
essere sicuri di vincere la partita: le perturbazioni al sistema devono essere strategicamente
orientate.
a) La fase consulenziale
E’ la fase dell’accoglienza, quella in cui la persona capirà quanto potrà “fidarsi” e “affidarsi” alle
persone che affronteranno con lei il suo problema. Per noi operatori, oltre ad essere il primo
momento di valutazione (“assessment”) del caso, è principalmente la prima occasione di
costruzione di una “alleanza terapeutica”. Viene fatta dalla psicologa che nel giro di tre o quattro
incontri, valuta la situazione clinica anche attraverso la somministrazione di un test (EDI II). Nei
casi gravi, in cui esiste una evidente compromissione fisica, viene attivata subito la consulenza
medica che valuterà la necessità di interventi specifici fino al ricovero in area medica.
Si pone molta attenzione a come viene effettuata la richiesta, in particolare abbiamo verificato due
elementi fondamentali:
La fonte di invio.
E’ il canale attraverso cui viene effettuata la domanda, l’agenzia, sanitaria o sociale che la effettua.
Abbiamo visto come maggiore è la fiducia dell’inviante verso la nostra struttura terapeutica,
migliore è l’andamento della terapia. Questo dato, che può sembrare ovvio, induce viceversa a
riflettere, considerato che la maggior parte degli invii vengono fatti tardivamente, dopo numerosi
passaggi ad altre agenzie che spesso sottovalutano, misconoscono o viceversa drammatizzano il
problema. E’ evidente come un invio fatto come “ultima spiaggia” dopo precedenti fallimenti, mette
i terapisti in una posizione difficile. Altre implicazioni derivano da un invio fatto da persone
importanti, in genere coinvolte nelle dinamiche familiari, che magari conoscono i terapisti e che
possono condizionare, anche con le aspettative implicite di un particolare percorso terapeutico, le
mosse dei terapisti stessi (v. l’inviante prestigioso della Selvini).
Queste considerazioni spingono ad una politica di prevenzione, e di facilitazione dell’accesso ad
una struttura terapeutica che sia visibile e facilmente accessibile, connotata come specialistica ma
con più evidenti aspetti ambulatoriali e consulenziali, piuttosto che a quelli medico-sanitari o
addirittura istituzionali.
L’agente della domanda.
112
2
E’ la persona fisica che fa la domanda (telefonata o prima visita) al Servizio. In un’ottica di
attenzione alla soggettività, questo dato ci da informazioni preziose sulla disponibilità del soggetto
al trattamento, sul grado di consapevolezza di quanto rappresenti per lei un problema, e quindi della
motivazione ad affrontarlo. E’ assai frequente infatti che l’invio rifletta più la preoccupazione
dell’inviante (familiare, medico, insegnante) che il reale grado di percezione soggettiva del
problema da parte della persona interessata.
E’ assai raro nella pratica clinica che la domanda venga effettuata dal soggetto stesso, e non soltanto
per l’età. Questa constatazione apre il tema dell’importanza di distinguere il punto di vista di chi fa
la domanda e il punto di vista della persona che presenta il problema, tema che deve essere
evidenziato e affrontato pena la costruzione di una equivocità della terapia che peserà e si
interfaccerà successivamente con l’abitudine al sotterfugio, all’ambiguità, al clima di inganno che è
presente in queste famiglie.
Qualora la domanda sia portata dalla persona stessa, la modalità con cui avviene ci da informazioni
sul grado di consapevolezza che il soggetto interessato ha del suo problema.
b) La restituzione
Alla fine della consulenza verrà data una risposta, verbale e scritta, sulla valutazione effettuata e su
quello che si consiglia alla ragazza. Nella restituzione è implicita anche una “contrattazione” sulla
valutazione, sull’accordo che la persona presenta nei confronti di “quanto è scritto”: questo servirà
per consolidare il lavoro “costruttivo” che dovranno fare il terapista e la persona, lavoro che
presuppone una disponibilità del soggetto a “cercare di capire” insieme i significati di quello che sta
succedendo.
c) L’intervento di psicoterapia individuale
Il nostro approccio cognitivista segue un modello che cerca di esplorare le aspettative, le credenze, i
desideri riguardo al momento di vita che la persona sta attraversando, cercando i collegamenti con
gli aspetti di vita critici che sono collegati al problema alimentare. Questa modalità segue, come
modalità che ci piace accomunare a quella che viene chiamata psicologia ingenua, popolare, o
“folk psychology” (Cutolo e al. 2000) può essere descritta anche come o psicoterapia naif
(Rezzonico e Meyer 1989)
Per altri aspetti essa si rifà anche a quelle correnti fenomenologiche che cercano di sviluppare una
attenzione alla soggettività (esperienza in prima persona).
Vittorio Guidano ha operato una sintesi di queste modalità proponendo lo studio dell’esperienza
soggettiva, analizzandola cioè insieme al soggetto “dal punto di vista della persona che la prova” e
garantendogli la vicinanza di un terapista cognitivamente ed affettivamente esperto dei processi che
costituiscono gli “umani” nel loro sviluppo e nelle loro relazioni all’interno della società moderna.
Secondo questo modello la terapia è orientata alla comprensione, piuttosto che alla persuasione o
all’interpretazione. La terapia è esplorazione della propria esperienza, si costruisce un contesto
collaborativo, in cui l’obiettivo è la ricerca del significato del comportamento sintomatico.
Come detto vengono evitati da parte del terapista tutti quegli atteggiamenti di giudizio, specie non
verbali, tendenti ad una implicita colpevolizzazione od altre “emozioni cognitive” come la
vergogna, l’imbarazzo, la colpa. E’ evidente che queste emozioni verranno comunque
inevitabilmente sollecitate a partire anche da minimi ed involontari accenni o mosse da parte dei
terapisti: sarà opportuno in queste evenienze affrontare con delicatezza il problema emerso
approfondendolo gradualmente con l’instaurarsi di un rapporto di fiducia.
Per quanto riguarda le caratteristiche della relazione terapeutica essa è basata sulla costruzione di
un rapporto di affidamento in cui il terapista si propone come “base sicura” che garantisce alla
persona la possibilità di esplorare la propria esperienza nelle condizioni di massima sicurezza
affettiva (J.Bowlby 1984).
113
3
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’ assessment e della strategia terapeutica, vengono usate
tecniche come l’auto-osservazione (sia in “diretta” nella seduta terapeutica che mediante i “compiti
a casa”) e il c.d. metodo della moviola (Guidano 1988, 1992, 2008).
Esempio: Descrizione dell’episodio “critico”
*come la persona “accade”: i fatti
*come la persona “si è sentita”
*come la persona “spiega” come si è sentita
Gli obiettivi sono:
Aumento delle capacità di astrazione (vedersi da altri punti di vista),
Aumento della flessibilità e delle capacità narrative
Aumento della consapevolezza nelle aree critiche.
d) L’intervento con la famiglia
Quando ci si occupa di minore o di persona ancora residente nella famiglia d’origine, gli interventi
vengono contrattati e concordati con la ragazza e con la sua famiglia. Ma spesso anche in alcune
adulte già “svincolate” dalla famiglia, è opportuno considerare il legame ancora forte, spesso
invisibile all’osservatore superficiale, esistente con la famiglia o con un genitore, anche fisicamente
lontano, legame che ha caratteristiche più o meno “concrete” tali da influenzare il comportamento
della figlia.
L’intervento con la famiglia ha come primo obiettivo quello di “ottenere il consenso” dei genitori, o
comunque di “negoziare” il trattamento individuale della figlia. Per questo si passa da una fase di
“accoglienza” e di conoscenza possibilmente fatta insieme alla paziente. In questa fase si osservano
le interazioni tra i vari membri della famiglia per valutare l’invischiamento reciproco (quanto è
possibile alla ragazza parlare senza essere interrotta, l’espressione diretta o camuffata di critiche,
eventuali comportamenti coercitivi o vincolanti da parte della paziente sul resto della famiglia). Si
valuta anche il tipo di attaccamento in atto e una breve storia della famiglia per valutare
l’andamento dell’attaccamento in passato.
Vengono comunque fornite ai familiari informazioni generali sul disturbo sottolineandone gli
aspetti psicologici (sensibilità al giudizio, difficoltà a decodificare le emozioni), specie se
nell’interazione tra loro risaltano tali modalità. Si cerca di differenziare questi aspetti centrali del
disturbo, dalle conseguenze fisiche e mediche del D.A..
Nei casi più lievi la famiglia può essere “congedata” dopo il primo contatto, o seguita con periodici
ma non frequenti incontri, in genere con la paziente, allo scopo di fornire un sostegno ed assicurarsi
il proseguimento della collaborazione fornita in precedenza.
Nei casi più gravi i genitori possono essere seguiti con l’esplicito obiettivo di aiutarli ad affrontare il
loro difficile compito genitoriale, sia con suggerimenti comportamentali riguardo alla interferenza
su settori alimentari, sia più esplicitamente su aspetti affettivi della loro relazione con la figlia.
Viene generalmente distinto l’intervento familiare rispetto ai compiti genitoriali (attuabile ad es.
anche in caso di genitori separati) da un eventuale, successivo e non sempre possibile e opportuno
intervento familiare rispetto a problemi di coppia, che può essere effettuato solo previa
riformulazione degli obiettivi.
E’ da ribadire comunque che l’esperienza insegna la estrema delicatezza di un intervento familiare:
il semplice contatto col terapista, in qualsiasi setting avvenga, attiva automaticamente nella famiglia
una inevitabile reazione di “colpevolizzazione” che se non considerata (o, peggio, se considerata
una resistenza) può pregiudicare fin da subito i successivi interventi.
e) L’intervento di gruppo
Nella nostra esperienza l’intervento di gruppo rappresenta in genere il complemento di una terapia
individuale già iniziata, e dovrebbe essere successivo ad essa. Insieme a questi gruppi,
114
4
esplicitamente terapeutici, sono utili gruppi di informazione alimentare con la presenza qualificata
di una nutrizionista.
f) L’intervento coercitivo
Per quanto non da escludere nei casi estremi, l’intervento coercitivo viene costantemente messo
come ultima possibilità da utilizzare quando esiste un pericolo di vita o quando la situazione
relazionale della persona è diventata insostenibile.
L’intervento coercitivo diretto (es. Trattamento Sanitario Obbligatorio) è difficilmente realizzabile
sia per l’età della anoressica, spesso minorenne, sia per la difficoltà “medico legale” di attuarlo nei
casi gravi cronicizzati, in cui manca l’elemento di acuzie necessario secondo la legge. Spesso
inoltre i genitori stessi si oppongono fermamente all’attuazione dello stesso.
In questi casi abbiamo sperimentato come un intervento familiare in cui i genitori vengono aiutati a
riprendere una posizione genitoriale “forte” (specialmente da parte del padre) può mettere la
ragazza nella situazione di interrompere il “gioco al massacro” che sta attuando “oggettivamente”
verso sé stessa. Il terapista, in particolare qui la figura dello psichiatra, può e deve utilizzare il
potere istituzionale che gli viene attribuito “socialmente” nelle situazioni di gravità sintomatologica
ed “usarlo per cercare di non usarlo”, esplicitando la possibilità del T.S.O., ad esempio per spingere
un genitore ad uscire da una posizione di passività.
E’ da sottolineare da ultimo come, a differenza di altre situazioni di acuzie psichiatrica, l’intervento
“coercitivo” nelle forme gravi di anoressia (a volte necessario per impedire la morte della ragazza)
sia di difficile attuazione perchè ancora culturalmente poco accettato dagli stessi operatori del
settore psichiatrico.
4) ANDAMENTO E FASI DELLA TERAPIA: POSSIBILITA’ E LIMITI
La terapia con le persone che soffrono di disturbi alimentari è particolarmente difficile. Nelle linee
guida internazionali il ruolo riservato ai farmaci è ancora limitato alle prime fasi della bulimia,
mentre per l'anoressia gli interventi consigliati sono quelli della psicoterapia individuale e familiare
specie nelle ragazze minori.
Sono più definiti i criteri che indicano l’opportunità di un ricovero ospedaliero: gravità
psicopatologica (ad es. rischio suicidarlo), gravità delle condizioni fisiche, condizioni familiari
negative, fallimento di precedenti interventi ambulatoriali.
Incerta e controversa l’opportunità di una separazione dalla famiglia, legata spesso più alle scelte
metodologiche dell’osservatore che non a obiettive necessità relazionali.
La difficoltà principale, e si capisce da quanto detto prima, è l'egosintonia del sintomo alimentare
con la personalità del soggetto. Specie nelle fasi iniziali ed in quelle centrali del disturbo la
tendenza anoressica al controllo del cibo è un impegno “a tempo pieno” totale e difficilmente
modificabile se non con metodi persuasivi, o addirittura coercitivi. Questo spiega il successo dei
trattamenti comportamentali (ai quali spesso la paziente “si arrende” magari dopo una strenua
resistenza, o a cui si adatta col suo stile compiacente) ma anche il rapido fallimento di questi
quando la forza persuasiva ed il controllo esterno si attenuano, ad esempio dopo la dimissione
dall'ospedale o da una clinica specializzata. L'espressione luna di miele anoressica o fase di
contemplazione spiega abbastanza bene questo sposalizio della persona col sintomo, ma denota
anche la distanza che corre tra una modalità esterna “oggettiva” di osservazione e la pregnanza
“soggettiva” con cui questa condizione viene vissuta dalla persona. E’ più chiaro allora perchè sia
necessario, come abbiamo detto prima, di lavorare sulla motivazione ad un cambiamento che,
specie all'inizio, può sembrare veramente difficile.
Nella nostra esperienza l'obiettivo principale consiste nell'ottenere una motivazione soggettiva al
cambiamento che non avviene quasi mai con una modalità “tutto o nulla” ma è un processo
graduale, spesso a salti, segnato da alti e bassi. Questo obiettivo è segnalato e ritmato da episodi
soggettivi o inter-soggettivi (ad es. nelle relazioni familiari) in cui la persona “scopre” cose su di sé
115
5
e sugli altri che fino ad allora sembrava ignorare. La capacità del sistema terapeutico nel modulare
interventi soft con altri più duri e decisi, diventa una abilità che si apprende nel “farsi” della terapie
e nello scambio continuo tra gli operatori.
Alla luce di questo e della nostra esperienza riteniamo più opportuna all’inizio la scelta di un
trattamento psicoterapeutico ambulatoriale, un setting all’interno del quale si costruisce e si modula
una relazione terapeutica che sarà la base di tutti gli interventi, anche di quelli medici o dietologici,
spesso inevitabili per le condizioni generali.
Particolarmente positiva la collaborazione con la dietista/nutrizionista che si muova in sintonia con
questo tipo di intervento psicoterapeutico centrato sul livello di motivazione raggiunto, ovvero sulla
possibilità/disponibilità della ragazza a modificare il regime dietetico, che in genere è correlata col
livello di consapevolezza raggiunto nella terapia.
4) CONCLUSIONI
L’irrompere dei D.A. nel territorio dei disturbi mentali ha messo in crisi le epistemologie lineari e
semplicistiche di tipo medico che vedono nel disturbo essenzialmente una disfunzione da cancellare
o da modificare in quanto estranea al normale sviluppo della persona; così come hanno messo in
crisi anche i modelli psicoterapeutici “razionalisti” propri di gran parte delle correnti prevalenti
(dalla psicoanalisi, alla sistemico-relazionale, fino alla cognitivo-comportamentale), o almeno alle
forme classiche di questi approcci, basati su modalità persuasive che non distinguono un approccio
“oggettivo” da un approccio attento alla soggettività, che non tengono conto della distinzione tra ciò
che appare all’osservatore e ciò che si costruisce nel mondo dell’ “osservato”.
Già la stessa definizione nosografica “rifiuto di mantenere il peso corporeo” del DSM IV è
abbastanza indicativa di un qualcosa che nasce da un atto di volontà del soggetto e come tale
andrebbe considerato prima di attuare interventi persuasivo-pedagogici nei quali la volontà della
persona viene considerata come una complicazione fastidiosa da eliminare o da superare con
modalità ingannatorie (es. la somministrazione di farmaci che aumentano l’appetito o il peso
corporeo).
D’altra parte l’anoressica mette in discussione anche un semplicistico modello psico-sociale che
vede nella riduzione dello stigma uno degli obiettivi per alleviare la sofferenza psichica. Ad
esempio quando l’anoressica arriva a manifestare, in una fase avanzata del disturbo, atteggiamenti
di vera e propria esibizione, quasi una glorificazione della sua emaciazione che presenta al mondo
senza timore di essere derisa, eliminando così l’utilità dei tradizionali atteggiamenti di non
designazione e non stigmatizzazione che potrebbero essere utili in altri gravi disturbi mentali (se si
può accettare una persona che delira, come si fa a tollerare una persona che lucidamente ti sbatte in
faccia la sua magrezza chiedendoti di apprezzarla?). Ricordo la pervicacia e la naturalezza con cui
un’anoressica di 28 chili si esibiva in costume al mare nello stabilimento frequentato dai genitori, i
quali avevano assunto un atteggiamento giustificatorio verso di lei e di estrema critica verso gli
sguardi ed i commenti dei vicini di ombrellone, loro amici.
Inoltre anche più raffinati modelli psicoterapeutici basati sul raggiungimento di una maggiore
consapevolezza di sé rischiano di infrangersi di fronte all’apparente capacità di comprensione che
hanno le DAP del loro modo di funzionamento e delle modalità di relazionarsi con gli altri, unita
alla ferrea volontà di non modificarle.
I D.A.P. impongono una revisione dei modelli tradizionali medici e psicoterapeutici e ci spingono a
considerare altre modalità di comprensione e di intervento sui fenomeni psicopatologici.
In questa direzione “non razionalista” un’ipotesi di lavoro da approfondire riguarda proprio il tema
dell’auto-inganno, e la sua assunzione come centrale nel lavoro psicoterapeutico. Il tema della non
distinzione tra l’ingannare gli altri e l’ingannare sé stessa è costitutivo del comportamento
anoressico-bulimico. L’impressione è che la ostinata convinzione di avere un corpo troppo grasso e
ingombrante, che l’ingestione di una quantità di cibo anche esigua possa modificarlo facendole
diventare obese, sia spesso una “finzione” di cui loro stesse sono ben consapevoli e che ammettono
116
6
candidamente se si riesce ad avere con loro un rapporto più sincero e naturale: il mantenimento
dell’emaciazione non è tanto una distorsione cognitiva quanto un obiettivo da perseguire ad ogni
costo sia per scopi individuali (che oscillano dall’adesione perfetta e totale ad un ideale di bellezza
propugnato dai media, ad una opposizione fino alla morte di una posizione esistenziale tipo “non
sarò mai dei vostri”) sia per obiettivi relazionali (non mi farò mai definire dal giudizio di nessuno su
questo “terreno alimentare”). Per l’anoressica è molto più semplice “mentire” affermando di fronte
al mondo e a sé stesse che si è grasse piuttosto che entrare in un contenzioso razionalista in cui
potrebbero essere facilmente perdenti. Ricordo la descrizione di uno “scontro” con una anoressica
su questo, raccontato da Guidano (2008), nel quale solo una estemporanea “perturbazione
strategicamente orientata” effettuata all’interno di un rapporto terapeutico che veniva duramente
messo alla prova dall’atteggiamento seduttivo della paziente, riuscì a sbloccare la situazione.
In questa direzione interessante è il fenomeno della “guarigione” o del miglioramento che non
avviene durante il rapporto terapeutico, ma dopo che esso si sia interrotto. A volte è l'anoressica
stessa che richiede l'interruzione o fa in modo di diradare le sedute prima che il miglioramento
avvenga. Questo si spiega col fatto che la persona ha tutte le condizioni per farlo, ma questo non gli
è possibile perchè si sentirebbe troppo definita dal fatto che lo potrebbe fare per esaudire le
aspettative del terapista. L'interruzione è un modo semplice e funzionale per demarcarsi e
differenziarsi da queste acquisendo una posizione autonoma.
Vorrei concludere esprimendo quello che mi ha insegnato lavorare con queste persone: la curiosità
per i modi sempre diversi con cui si declina una difficoltà esistenziale di “essere nel mondo”, il
senso di limitatezza derivante dal non riuscire spesso a modificare un atteggiamento auto-distruttivo
specie se si usano modalità “pedagogiche” o comunque “razionaliste”, il senso profondo di rispetto
per la loro sofferenza, la comprensione delle difficoltà relazionali dei loro familiari; da ultimo, la
maggiore conoscenza di me e delle mie modalità relazionali e affettive che nasce dalle
“perturbazioni” emotive innescate dalla relazione terapeutica con le pazienti, chiarite spesso nelle
discussioni successive con i colleghi del gruppo di lavoro. Quest’ultimo aspetto, insieme alla
capacità riflessiva sviluppata nel gruppo stesso, costituisce non solo la difesa più importante contro
l’esaurimento emotivo dell’operatore (es. burn out) ma diviene uno dei fattori prognostici più
importanti per un buon esito dell’intervento.
5) APPENDICE: C’E’ UN RUOLO PER L’INFERMIERE (E GLI OPERATORI “NON
PSICO”) NEI D.C.A ?
Lavoro da trentacinque anni nel settore psichiatrico e per trenta sono stato responsabile di un
Servizio costituito in gran parte da infermiere. Ho imparato che le capacità operative di questa
figura professionale sono fondamentali per costruire un Servizio multidisciplinare, se l’infermiere
possiede la flessibilità di intervenire nelle situazioni più complesse costituendo il “collante” che
tiene uniti i diversi interventi. Io ritengo che l’infermiere può avere un ruolo centrale all’interno del
trattamento delle persone con D.C.A. per la sua funzione di “persona capace di prendersi cura di”
ovvero di instaurare una relazione significativa ma non confusiva con la persona, e allo stesso
tempo in grado di gestire gli inevitabili aspetti medici e assistenziali necessari nel seguire le persone
attraverso i vari luoghi e momenti della terapia. Questa duplice capacità può essere il raccordo, il
collante che permette alla persona di seguire il percorso, psicologico e medico, del trattamento,
riacquistando e mantenendo l’unicità del proprio “senso di sé”, sia quando affronta i nodi dolorosi
della propria insicurezza emotiva, sia quando deve intraprendere analisi mediche, pasti assistiti o
riabilitazioni nutrizionali.
Per quanto riguarda il primo aspetto, quello relazionale, esso si basa sulla capacità di gestire una
relazione particolarmente delicata in cui un opportuno coinvolgimento personale deve prestare
attenzione alle facili identificazioni (o rifiuto) con i problemi dell’altra. La capacità relazionale deve
117
7
essere accompagnata da una approfondita conoscenza psicologica delle modalità personali con cui
l’altra persona richiede atteggiamenti fusionali o viceversa “vede” e “sente” la presenza intrusiva
dell’operatore esibendo atteggiamenti oppositivi.
Il secondo aspetto riguarda le conoscenze specifiche sulle conseguenze mediche del disturbo
alimentare, così come le competenze “nutrizionali”, ovvero quelle relative agli effetti del cibo, alla
variabilità degli alimenti utili, alle diverse modalità con cui si dispiega l’assunzione/rifiuto del cibo
che diventa il tema centrale della vita della persona, conoscenze indispensabili per “far sentire” alla
persona che si è capito il suo problema. La necessaria conoscenza di questi aspetti “tecnici”, settore
in cui le persone con D.C.A. sono esperte quanti altri mai, dovrà comunque aiutarla a mantenere
una posizione di fermezza ma non eccessivamente “up”. E’ sottile la linea di demarcazione che
corre tra una posizione tipo “ti comprendo quando senti di poter perdere il controllo di fronte al cibo
e ti aiuto a rispettare le regole concordate” ad una tipo “so IO quello che ti succede, per cui devi
semplicemente seguire le nostre indicazioni…”
Forte di queste competenze, conoscenze e disposizioni affettive, l’infermiere potrà essere la persona
capace di inserirsi in tutti i contesti terapeutici in cui si svolge l’accoglienza e la cura della persona
con D.C.A. e fungere da raccordo sia tra i vari luoghi di cura, sia nei confronti dei vari operatori che
nel tempo si occupano del caso, lo psicoterapeuta, il medico, la nutrizionista. E’ un ruolo che,
probabilmente, potrà nel tempo diventare più specifico e non sostituibile.
BIBLIOGRAFIA
*Bauman Z. (2002) “Modernità liquida” Laterza ed.
*Becker, A. E., Burwell, R. A., Gilman, S. E., et al (2002) Eating behaviours and attitudes following prolonged
exposure to television among ethnic Fijian adolescent girls. British Journal of Psychiatry, 180, 509 -514.
*Bell R. (1985-1992)“La santa anoressia. Digiuno e misticismo dal Medioevo a oggi” Oscar Mondadori
*Bruch H. (1977) “Patologia del comportamento alimentare” Feltrinelli, Milano
*Bowlby J. (1984) “Una base sicura” Cortina ed.
*Cutolo G., Marsicovetere V, Foschi A, Lombardi G (2000) : “Teoria della mente, psicosi, servizi di salute
mentale” su Psicobiettivo 2000 n.3
*Cuzzolaro M. (2004) “Anoressie e bulimie” Il Mulino ed. Bologna
*Guidano V.F. (1988) “La complessità del Sé” Bollati Boringhieri, Torino
*Guidano V.F. (1992) “Il Sé nel suo divenire” Bollati Boringhieri, Torino
*Guidano V.F. (2007) (a cura di A.Quinones) “Psicoterapia cognitiva post-razionalista” F.Angeli ed.
*Guidano V.F. (2008) (a cura di G.Cutolo) “La psicoterapia tra arte e scienza” F.Angeli ed.
*Guidano V.F., Liotti G. (1983) “Cognitive processes and emotional disorders” Guildford Press, N.Y.
*Khun T. (1962) “La struttura delle rivoluzioni scientifiche” Einaudi
*Lewis M. (1995) “Il sé a nudo. Alle origini della vergogna” Giunti ed.
*Minuchin S. (1980) “Famiglie psicosomatiche – L’anoressia mentale nel contesto familiare” Astrolabio-Ubaldini
ed.
*Nardi B. . (2007) “Costruir-si” F.Angeli ed.
*Reda M., Sacco G. (1996) “Anoressia e santità in S.Caterina da Siena” in: Informazione in psicologia,
psicoterapia, psichiatria, n. 26, Roma, 1996, pp.3-10) reperibile su internet al sito
http://www.neurolinguistic.com/proxima/james/jam-29.htm
*Rezzonico G., Meier C. (1989) “Un approccio costruttivista alla terapia della schizofrenia:schizofrenia come
ipotesi” su Psicobiettivo Vol.IX, 1989
*Scrosati Crespi L. (1998) “La relatività del concetto di guarigione” in “I gruppi ABA. Interruzioni e conclusioni
della cura” a cura di Scrosati Crespi L. e Speranza A.M. F.Angeli ed. Milano
*Selvini M. (2004) “Reinventare la psicoterapia. La scuola di Mara Selvini Palazzoli” Cortina ed. Milano
*Selvini Palazzoli M.(1963) “L’anoressia mentale” Feltrinelli, Milano
*Todisco P. (2003) “Insuccessi terapeutici nei disturbi del comportamento alimentare” McGraw-Hill ed
*Zorzetto S., Inglese S., Cardamone G. (1999) “Per un’analisi etnopsichiatrica delle sindromi anoressiche” in
“Djon Djongonon” di G.Cardamone, S.Inglese, S.Zorzetto, Ed.Colibrì
118
8