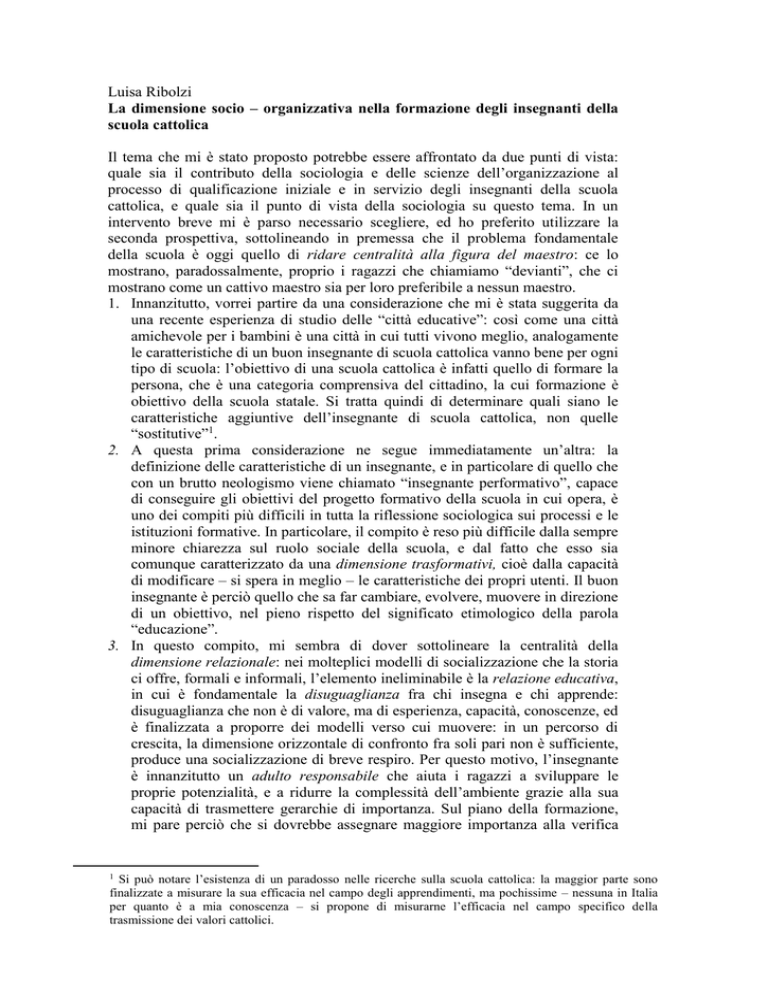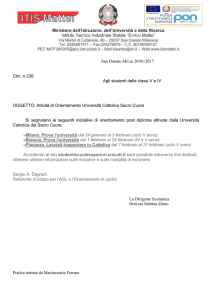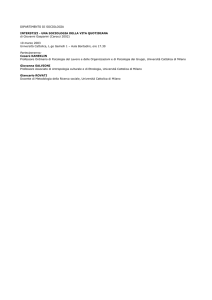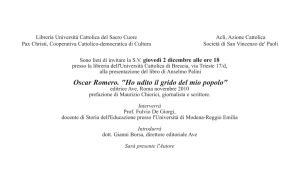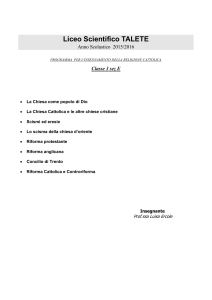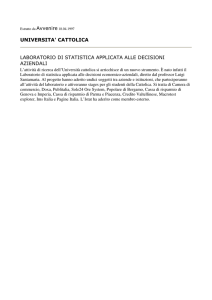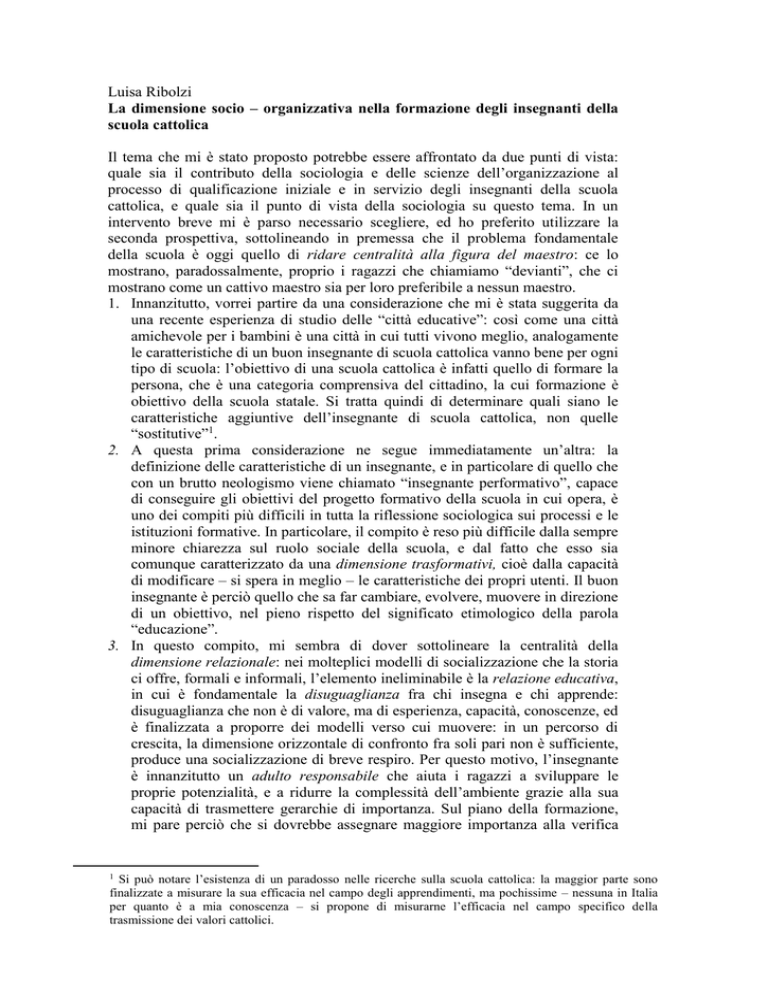
Luisa Ribolzi
La dimensione socio – organizzativa nella formazione degli insegnanti della
scuola cattolica
Il tema che mi è stato proposto potrebbe essere affrontato da due punti di vista:
quale sia il contributo della sociologia e delle scienze dell’organizzazione al
processo di qualificazione iniziale e in servizio degli insegnanti della scuola
cattolica, e quale sia il punto di vista della sociologia su questo tema. In un
intervento breve mi è parso necessario scegliere, ed ho preferito utilizzare la
seconda prospettiva, sottolineando in premessa che il problema fondamentale
della scuola è oggi quello di ridare centralità alla figura del maestro: ce lo
mostrano, paradossalmente, proprio i ragazzi che chiamiamo “devianti”, che ci
mostrano come un cattivo maestro sia per loro preferibile a nessun maestro.
1. Innanzitutto, vorrei partire da una considerazione che mi è stata suggerita da
una recente esperienza di studio delle “città educative”: così come una città
amichevole per i bambini è una città in cui tutti vivono meglio, analogamente
le caratteristiche di un buon insegnante di scuola cattolica vanno bene per ogni
tipo di scuola: l’obiettivo di una scuola cattolica è infatti quello di formare la
persona, che è una categoria comprensiva del cittadino, la cui formazione è
obiettivo della scuola statale. Si tratta quindi di determinare quali siano le
caratteristiche aggiuntive dell’insegnante di scuola cattolica, non quelle
“sostitutive”1.
2. A questa prima considerazione ne segue immediatamente un’altra: la
definizione delle caratteristiche di un insegnante, e in particolare di quello che
con un brutto neologismo viene chiamato “insegnante performativo”, capace
di conseguire gli obiettivi del progetto formativo della scuola in cui opera, è
uno dei compiti più difficili in tutta la riflessione sociologica sui processi e le
istituzioni formative. In particolare, il compito è reso più difficile dalla sempre
minore chiarezza sul ruolo sociale della scuola, e dal fatto che esso sia
comunque caratterizzato da una dimensione trasformativi, cioè dalla capacità
di modificare – si spera in meglio – le caratteristiche dei propri utenti. Il buon
insegnante è perciò quello che sa far cambiare, evolvere, muovere in direzione
di un obiettivo, nel pieno rispetto del significato etimologico della parola
“educazione”.
3. In questo compito, mi sembra di dover sottolineare la centralità della
dimensione relazionale: nei molteplici modelli di socializzazione che la storia
ci offre, formali e informali, l’elemento ineliminabile è la relazione educativa,
in cui è fondamentale la disuguaglianza fra chi insegna e chi apprende:
disuguaglianza che non è di valore, ma di esperienza, capacità, conoscenze, ed
è finalizzata a proporre dei modelli verso cui muovere: in un percorso di
crescita, la dimensione orizzontale di confronto fra soli pari non è sufficiente,
produce una socializzazione di breve respiro. Per questo motivo, l’insegnante
è innanzitutto un adulto responsabile che aiuta i ragazzi a sviluppare le
proprie potenzialità, e a ridurre la complessità dell’ambiente grazie alla sua
capacità di trasmettere gerarchie di importanza. Sul piano della formazione,
mi pare perciò che si dovrebbe assegnare maggiore importanza alla verifica
Si può notare l’esistenza di un paradosso nelle ricerche sulla scuola cattolica: la maggior parte sono
finalizzate a misurare la sua efficacia nel campo degli apprendimenti, ma pochissime – nessuna in Italia
per quanto è a mia conoscenza – si propone di misurarne l’efficacia nel campo specifico della
trasmissione dei valori cattolici.
1
delle caratteristiche di personalità di chi aspira ad un ruolo docente,e allo
sviluppo delle attitudini considerate più desiderabili.
4. Questa dimensione relazionale mi sembra particolarmente sviluppata nella
scuola cattolica, che è caratterizzata dall’esistenza di un progetto condiviso fra
insegnanti e genitori (e, per i più grandi, studenti). Una seconda fondamentale
caratteristica del ruolo docente deve quindi essere ulteriormente potenziata, ed
è la capacità di interloquire con i genitori, oltre a quella di operare come
gruppo all’interno della scuola. Una grande quantità di ricerche mostra
l’esistenza generalizzata del cosiddetto “effetto scuola cattolica”2, che consiste
in un migliore apprendimento (sistematico anche se a volte molto ridotto)
nelle scuole cattoliche, misurato tenendo sotto controllo le caratteristiche
socio economiche dei ragazzi: questo effetto viene attribuito all’esistenza di
un capitale sociale di tipo relazionale, in quanto tutti i soggetti presenti nella
scuola condividono la medesima impostazione culturale3 e sono disponibili a
lavorare insieme per il raggiungimento di fini comuni.
5. Questo non significa che il contenuto di ciò che viene trasmesso (conoscenze
e competenze) sia irrilevante: possiamo forse precisare che ne viene
sottolineata la caratteristica strumentale e particolare, in quanto nella scuola
cattolica forse più che in quella “laica” sembra importante sottolineare il
legame fra le singole informazioni trasmesse e l’unità di fondo dei saperi. E’
evidente che non si può insegnare quel che non si conosce, né si può essere
chiari se manca un’adeguata preparazione che possiamo genericamente
definire “didattica”: per questo sia la preparazione disciplinare degli
insegnanti che quella metodologica (con un’accentuazione, a mio parere, sulla
capacità di individualizzare l’insegnamento in relazione alle caratteristiche
ambientali, della classe e in qualche misura anche dei singoli, e sulla capacità
di sintesi) costituisce un obiettivo di fondo del percorso formativo.
Se queste considerazioni sono corrette, ne conseguono a mio parere due
conseguenze, l’una sulle caratteristiche del processo di formazione degli
insegnanti, e l’altra sulle modalità di reclutamento.
Nella formazione iniziale e in servizio, è opportuno affidare la
responsabilità primaria alle università, ma è necessario lasciare più
spazio alla scuola: il sistema deve riconoscere alle scuole la capacità di
creare cultura su se stesse, configurandosi come una comunità di
apprendimento, come il solo luogo in cui l’insegnante apprende ad agire
come “professionista riflessivo”, secondo la nota definizione di Schön4,
applicando alle singole situazioni problematiche non solo le categorie
teoriche che ha appreso durante la formazione, ma quel che egli o altri
hanno ricavato dall’esperienza. L’attenzione è alla formazione di
2
Il termine è stato utilizzato da Coleman nei suoi lavori sulla scula pubblica e private (citiamo il primo,
COLEMAN J.S., T.HOFFER, Public and Private high schools: the impact of communities, Basic, New
York 1987) e da Bryk nelle sue prime ricerche (BRYK A. DRISCOLL M., The High School as a
Community: Contextual Influences and Consequences for Students and Teachers, National Center for
Effective Secondary Schools, Madison ( Wis. ), 1988.
3
Per una più ampia trattazione, si può vedere L. RIBOLZI Famiglia, scuola e capitale sociale in
DONATI P. (a cura di), Famiglia e capitale sociale nella società italiana, Ottavo Rapporto CISF sulla
Famiglia in Italia, San Paolo, Milano 2003
4
SCHÖN D., Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale,
Dedalo, Bari, 1993,
competenze disciplinari solide e aggiornate, ma anche all’agilità nel
coglierne le relazioni; alla capacità di utilizzare e selezionare metodi e
strumenti; alla capacità di leggere le necessità dell’ambiente e dei
ragazzi; a progettare, valutare e modificare il suo insegnamento
(capacità che vengono definite trasversali). Ma ad un certo punto tutte
queste competenze devono essere spese in situazione, non solo nel
tirocinio, ma nella pratica della classe. Per questo, oltre a determinate le
caratteristiche dell’insegnante e a formarlo, è centrale la definizione
delle capacità dei tutor e dei mentor, cioè di quei docenti in possesso di
esperienza che svolgono il ruolo delicatissimo dell’addestramento dei
giovani docenti, durante il corso di studi e nel periodo di pratica, a cui
dovrebbe essere a mio parere affidato anche il compito di valutare
l’effettiva capacità dei giovani a lavorare come insegnanti5.
Nelle procedure di reclutamento, se tutto si gioca sull’autonomia e sul
progetto formativo, il punto di arrivo deve essere la possibilità per le
scuole (sia paritarie che autonome statali) di assumere direttamente gli
insegnanti, sia pure all’intero di un preciso sistema di regole fissato
centralmente, a tutela della libertà di insegnamento. Questo significa
allora che nella scuola cattolica (ma il discorso vale per tutte le scuole
che vengono definite “di tendenza”) possono insegnare solo i docenti
cattolici? Nella misura in cui l’elemento qualificante di una scuola, che
determina la sua diversità riconoscibile, è il POF, la risposta dovrebbe
essere sì, e dovrebbe essere estesa anche alle scuole non confessionali:
diciamo però che un docente deve quantomeno condividere con spirito
amichevole il progetto formativo della scuola in cui insegna,
impegnandosi a rispettarlo. Se questo è possibile anche per un docente
non cattolico, non sono in grado di affermarlo con certezza.
Uno dei comportamenti più negativi nell’approccio usuale al tema degli
insegnanti è che essi tendono ad essere considerati molto più come problema che
come risorsa, trascurando il fatto che nessuna riforma, nemmeno la migliore sulla
carta, può essere attuata senza il coinvolgimento degli insegnanti. Se li si
considera come puri e semplici trasmettitori di un sapere elaborato altrove (ma
ritenevo che questa teoria fosse morta insieme alle “vestali della classe media”!)
diventa facile rifiutare il principio di reciprocità nei rapporti fra la scuola e i suoi
docenti, e – prima – fra l’università e gli studenti-insegnanti. Se non è chiaro che
cosa deve essere / fare l’insegnante (e mi pare che non lo sia, almeno non in
misura sufficiente), non è chiaro nemmeno che cosa debba fare l’università per
formarli, e non sono definibili neppure le caratteristiche di chi forma gli
insegnanti, ruolo che appare sempre più determinante. Nel caso della scuola
cattolica, poiché gli insegnanti che operano in essa devono comunque essere
formati dall’università, possiamo pensare di dar loro qualcosa di più o di diverso,
ma dobbiamo in ogni caso puntare su di una formazione di qualità per tutti, con
la costruzione di un’alleanza fra le università e il sistema delle scuole cattoliche,
cui potrebbe spettare un ruolo cruciale sia nel momento del praticantato, sia nella
formazione in servizio.
Per questo motivo, insisto nel considerare sbagliato l’inserimento in ruolo al termine del percorso
universitario, senza collegarlo con decisione al superamento con esiti positivo del periodo di
praticantato.
5