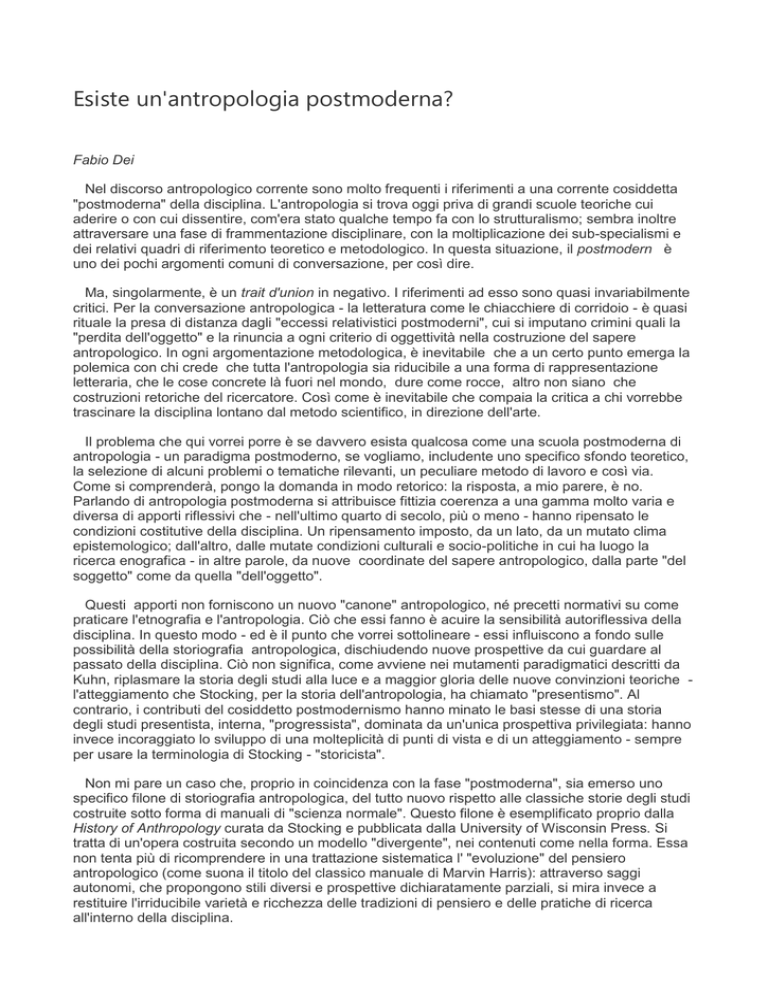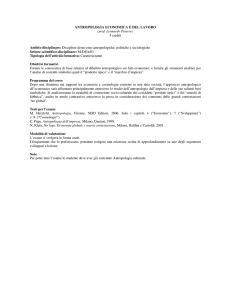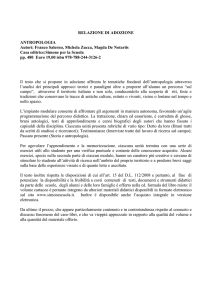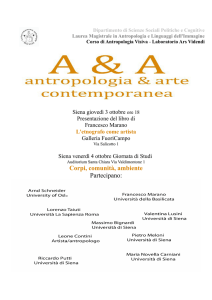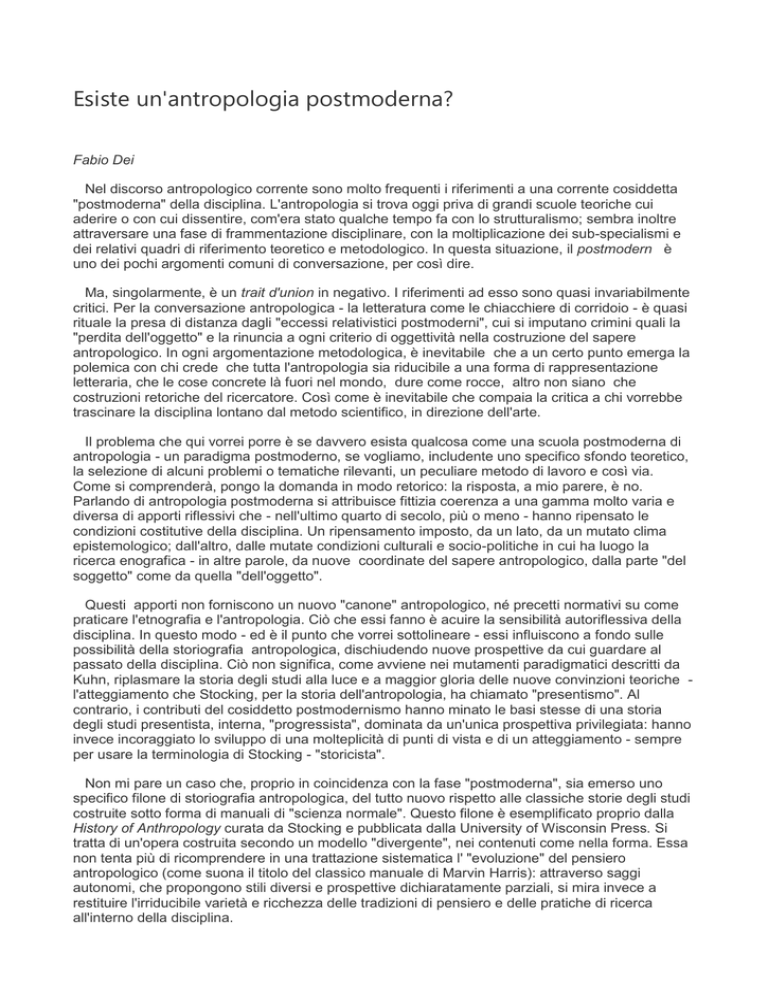
Esiste un'antropologia postmoderna?
Fabio Dei
Nel discorso antropologico corrente sono molto frequenti i riferimenti a una corrente cosiddetta
"postmoderna" della disciplina. L'antropologia si trova oggi priva di grandi scuole teoriche cui
aderire o con cui dissentire, com'era stato qualche tempo fa con lo strutturalismo; sembra inoltre
attraversare una fase di frammentazione disciplinare, con la moltiplicazione dei sub-specialismi e
dei relativi quadri di riferimento teoretico e metodologico. In questa situazione, il postmodern è
uno dei pochi argomenti comuni di conversazione, per così dire.
Ma, singolarmente, è un trait d'union in negativo. I riferimenti ad esso sono quasi invariabilmente
critici. Per la conversazione antropologica - la letteratura come le chiacchiere di corridoio - è quasi
rituale la presa di distanza dagli "eccessi relativistici postmoderni", cui si imputano crimini quali la
"perdita dell'oggetto" e la rinuncia a ogni criterio di oggettività nella costruzione del sapere
antropologico. In ogni argomentazione metodologica, è inevitabile che a un certo punto emerga la
polemica con chi crede che tutta l'antropologia sia riducibile a una forma di rappresentazione
letteraria, che le cose concrete là fuori nel mondo, dure come rocce, altro non siano che
costruzioni retoriche del ricercatore. Così come è inevitabile che compaia la critica a chi vorrebbe
trascinare la disciplina lontano dal metodo scientifico, in direzione dell'arte.
Il problema che qui vorrei porre è se davvero esista qualcosa come una scuola postmoderna di
antropologia - un paradigma postmoderno, se vogliamo, includente uno specifico sfondo teoretico,
la selezione di alcuni problemi o tematiche rilevanti, un peculiare metodo di lavoro e così via.
Come si comprenderà, pongo la domanda in modo retorico: la risposta, a mio parere, è no.
Parlando di antropologia postmoderna si attribuisce fittizia coerenza a una gamma molto varia e
diversa di apporti riflessivi che - nell'ultimo quarto di secolo, più o meno - hanno ripensato le
condizioni costitutive della disciplina. Un ripensamento imposto, da un lato, da un mutato clima
epistemologico; dall'altro, dalle mutate condizioni culturali e socio-politiche in cui ha luogo la
ricerca enografica - in altre parole, da nuove coordinate del sapere antropologico, dalla parte "del
soggetto" come da quella "dell'oggetto".
Questi apporti non forniscono un nuovo "canone" antropologico, né precetti normativi su come
praticare l'etnografia e l'antropologia. Ciò che essi fanno è acuire la sensibilità autoriflessiva della
disciplina. In questo modo - ed è il punto che vorrei sottolineare - essi influiscono a fondo sulle
possibilità della storiografia antropologica, dischiudendo nuove prospettive da cui guardare al
passato della disciplina. Ciò non significa, come avviene nei mutamenti paradigmatici descritti da
Kuhn, riplasmare la storia degli studi alla luce e a maggior gloria delle nuove convinzioni teoriche l'atteggiamento che Stocking, per la storia dell'antropologia, ha chiamato "presentismo". Al
contrario, i contributi del cosiddetto postmodernismo hanno minato le basi stesse di una storia
degli studi presentista, interna, "progressista", dominata da un'unica prospettiva privilegiata: hanno
invece incoraggiato lo sviluppo di una molteplicità di punti di vista e di un atteggiamento - sempre
per usare la terminologia di Stocking - "storicista".
Non mi pare un caso che, proprio in coincidenza con la fase "postmoderna", sia emerso uno
specifico filone di storiografia antropologica, del tutto nuovo rispetto alle classiche storie degli studi
costruite sotto forma di manuali di "scienza normale". Questo filone è esemplificato proprio dalla
History of Anthropology curata da Stocking e pubblicata dalla University of Wisconsin Press. Si
tratta di un'opera costruita secondo un modello "divergente", nei contenuti come nella forma. Essa
non tenta più di ricomprendere in una trattazione sistematica l' "evoluzione" del pensiero
antropologico (come suona il titolo del classico manuale di Marvin Harris): attraverso saggi
autonomi, che propongono stili diversi e prospettive dichiaratamente parziali, si mira invece a
restituire l'irriducibile varietà e ricchezza delle tradizioni di pensiero e delle pratiche di ricerca
all'interno della disciplina.
Precursore del postmodern è generalmente considerato l'approccio interpretativo di Clifford
Geertz - nonostante gli espliciti e insistenti dinieghi di quest'ultimo a tale paternità putativa. Ma il
nucleo forte del movimento è identificato in un gruppo - non particolarmente numeroso, peraltro - di
studiosi statunitensi, accomunati dalla partecipazione a quel libro-manifesto che è stato Writing
Culture, del 1986 (Clifford-Marcus, 1986). Writing Culture, come si sa, è dedicato all'analisi delle
etnografie come testi. Smascherando le pretese di oggettività e di neutralità - epistemologica e
politica - dell'antropologia classica, il libro mostra come i resoconti etnografici siano invece costruiti
sulla base di strategie retoriche che a loro volta nascondono relazioni politiche di dominio. Rendere
trasparenti la politica e la poetica dell'etnografia, come suona il sottotitolo, è il progetto di Writing
Culture. A tale progetto partecipano antropologi, storici delle idee, critici letterari; e in esso
vengono messi in gioco strumenti analitici e orientamenti teorici abbastanza nuovi per
l'antropologia, presi in prestito soprattutto dalla critica letteraria e culturale: in modo particolare,
giocano un ruolo importante il decostruzionismo e gli studi foucaultiani sulle relazioni tra sapere e
potere.
Writing Culture introduce un linguaggio analitico e un atteggiamento critico verso l'antropologia
classica che, nel corso degli anni '80 e dei primi anni '90, ha una certa diffusione. Su questa scia
nascono altri testi significativi, da parte di autori quali James Clifford (1988) , Vincent Crapanzano
(1992), Renato Rosaldo (1989), Stephen Tyler (1987), Louise Pratt, e in particolare il volume di
Marcus e Fisher Anthropology as Cultural Critique, divenuto il più diffuso manuale di "antropologia
critica" all'inizio degli anni '90. George Marcus, docente di antropologia alla Rice University, è stato
forse lo sponsor più convinto e sistematico di questo filone di studi, anche attraverso la sua
direzione della rivista Cultural Anthropology.
Ma bastano alcuni autori, un manuale e una rivista a fondare un movimento, anzi una vera e
propria svolta paradigmatica? Su un piano puramente fattuale, ciò non sembra affatto probabile,
né verosimile. La mia impressione è che stia accadendo col postmodern quel che era avvenuto
con il relativismo nel dibattito degli anni '60 e '70. Si sentiva allora, come oggi, il bisogno di
etichettare una posizione estrema, dalla quale prendere le distanze. Ma quanti antropologi o
filosofi, in quegli anni, si dichiaravano apertamente relativisti? Allo stesso modo, quanti antropologi
si dichiarano oggi a chiare lettere fautori di un approccio post-moderno? L'unico che lo abbia fatto
esplicitamente, nel gruppo di Writing Culture, è forse Stephen Tyler, il quale ha provocatoriamente
sostenuto l'abbandono della nozione stessa di rappresentazione culturale come telos della
disciplina (1986, 1991). Tutti gli altri autori citati non amano definirsi postmoderni, né si
attribuiscono etichette di scuola di nessun altro tipo. Ma il bisogno di rappresentarsi posizioni
estreme cui reagire è forte. L'orientamento di analisi testuale è così trasformato in un paradigma
teorico, e gli sono attribuite caratteristiche che non possiede affatto.
In primo luogo, lo si tratta come un movimento compatto, che tenta di sviluppare posizioni
unitarie e di conquistare una sorta di egemonia internazionale. Ma ciò è a dir poco fuorviante. E'
nota e nettissima, ad esempio, la contrapposizione tra Geertz e il gruppo di Writing Culture; ma
anche all'interno di quest'ultimo coesistono gli approcci, i programmi di ricerca e gli stili di scrittura
più diversi, che non tentano neppure di amalgamarsi in qualcosa di simile a un canone. Inoltre, non
ha alcun fondamento l'idea di una egemonia sul quadro contemporaneo degli studi che viene
spesso attribuita a questo indirizzo. Negli stessi U.S.A., dove è più diffuso, l'approccio testuale
resta minoritario. Gran parte dei dipartimenti di antropologia continua a lavorare su progetti di
ricerca di tipo tradizionale, e in un quadro di riferimenti metodologici e teoretici che non rompe
certo con l'impianto dell'antropologia classica, pur affinandolo ed eliminadone certe ingenuità. Le
principali riviste internazionali di antropologia, come Man, L'Homme, Current Anthropology,
American Ethnologist e American Anthropologist, negli ultimi dieci anni si sono occupate del
postmodern solo saltuariamente e con articoli quasi invariabilmente critici, talvolta vere e proprie
stroncature (con l'eccezione dei più recenti numeri di American Anthropologist; ma è significativo
che le aperture "postmoderne", proposte dal 1994 dai nuovi direttori Barbara e Dennis Tedlock,
abbiano suscitato una vera e propria rivolta tra gli antropoliogi americani; v. Saunders, 1995: 18
sgg.)
E' vero, semmai, che l'antropologia testuale ha contribuito a diffondere un nuovo lessico, fatto
prevalentemente di prestiti dalla critica decostruzionista, e che talvolta assume l'aspetto di un
gergo un po' fastidioso. Ed è vero, in positivo, che ha contribuito a diffondere nella disciplina una
più alta sensibilità, come si dice, auto-riflessiva, una accresciuta consapevolezza delle più comuni
strategie di costruzione dei documenti e delle rappresentazioni etnografiche. Ciò ha inferto un
colpo decisivo a un certo modo di scrivere i resoconti etnografici. Oggi è ad esempio improponibile
l'uso acritico di vecchie convenzioni retoriche, quali il presente etnografico (una rappresentazione
culturale non collocata in coordinate storiche) o la prospettiva dell' "occhio di dio" (l'osservatore
non incluso nella descrizione del contesto osservato). In generale, la consapevolezza che la
scrittura non è un mezzo neutrale di rappresentazione è un grosso passo avanti per l'antropologia
(anche se non necessariamente questo porta a scrivere etnografie migliori). Ma, ancora una volta,
tutto ciò non fa certo una "scuola".
Soprattutto, è importante sottolineare come le critiche al realismo ingenuo dell'antropologia e
dell'etnografia classiche non implichino necessariamente la proposta di un nuovo canone, di una
guida normativa alla pratica di ricerca e alla produzione di resoconti. Writing Culture non apre un
movimento d'avanguardia, non pretende di dire come si deve fare e scrivere correttamente
l'antropologia. Il suo eccessivo carico autoriflessivo, per così dire, lo priva dell'ingenuità necessaria
per proporre nuovi stili o nuove teorie totalizzanti. Questa, in effetti, è una caratteristica in comune
con i movimenti postmodernisti che, in arte come in filosofia, non si sono mai presentati come
avanguardie. Piuttosto, essi hanno giocato con i vecchi stili e con le vecchie teorie,
scomponendole e ricomponendole in nuove configurazioni.
Nell'antropologia degli ultimi anni, ad esempio, termini come "dialogico" o "polifonico" sono stati
erroneamente intesi come proposte di scrittura di avanguardia, alternative alla classica monografia
realista interamente dominata dal potere e dal sapere dell'autore. Pretendere di produrre testi
integalmente "dialogici" o "polifonici" piuttosto che "realisti" o "monologici", come talvolta è stato
fatto, equivale a fraintendere il senso in cui questi termini sono stati introdotti nella riflessione sulle
basi epistemologiche della disciplina. La componente del dialogo e la molteplicità delle voci sono
caratteristiche necessariamente inerenti all'incontro etnografico, e che in modo più o meno diretto
si manifestano, magari inconsapevolmente, in tutti i resoconti degli antropologi - come necessaria
e ineliminabile in qualsiasi scritto etnografico è la componente autoriale, l'orchestrazione delle voci
da parte dell'autore, anche quando questa si manifesti nella finzione del dialogo non mediato,
come nel discusso Moroccan Dialogues di Kewin Dwyer (1982) o in Tuhami di Crapanzano (1980).
Dunque, le nozioni di dialogicità e polifonia, su cui ha insistito in modo particolare James Clifford
(prendendole in prestito da Baktin), alludono più a una dimensione di lettura applicabile a ogni
forma di etnografia, che non a un nuovo canone di produzione etnografica. Come Marcus e
colleghi hanno esplicitamente riconosciuto, esse riguardano le condizioni della ricezione più che
quelle della produzione del testo.
"Il punto - essi affermano - non è tanto cambiare radicalmente le pratiche di scrittura, come
qualcuno teme, quanto cambiare le condizioni di ricezione del lavoro antropologico: vale a dire,
creare un ambiente aperto, più di quanto non accada oggi, a molte e alternative letture delle opere
di antropologia. Non si tratta di far emergere una 'nuova letteratura' da 'tutto questo parlare'
[l'antropologia testuale]; al contrario, il senso di tutto questo parlare sta proprio nell'impedire
l'avvento di una nuova letteratura, rifiutando di prescrivere ciò che dovrebbe essere, e
caratterizzando invece ciò che già è" (Tyler-Marcus 1987: 274).
Lo stesso vale per la nozione di riflessività, che non è affatto un invito a forme di scrittura
diaristica e incentrata sulla soggettività del ricercatore - "confessionale", come l'ha definita Geertz anche se la scrittura confessionale diviene una possibilità legittima di organizzazione del resoconto
etnografico.
L'unica proposta in positivo che viene dal gruppo di Writing Culture, in particolare da George
Marcus, è quella di aprire una fase sperimentale, come viene definita ( con espressione a mio
parere infelice), di produzione di resoconti etnografici (Marcus-Fisher 1986; Marcus 1992, 1994). In
questa nozione di etnografia "sperimentale", piuttosto ambigua, vi è certamente il senso di una
rottura con il passato; ma non vi è la proposta di un mutamento paradigmatico, di passaggio ad
una nuova fase di "scienza normale", o, se vogliamo, di affermazione di un nuovo genere
letterario. Piuttosto, si sottolinea la pluralità degli approcci e delle strategie di rappresentazione
culturale, e il loro carattere necessariamente "ironico" - per usare un altro termine entrato nel
gergo, a indicare la consapevolezza della natura retorica del proprio discorso, del fatto che non vi
è alternativa all'uso di strategie che colgono la realtà in modo limitato e "letterario". Ironia è il
sognare sapendo di sognare, secondo la celebre espressione di Nietszche. Per inciso, è questo
che si intende quando si raffronta il resoconto antropologico alla letteratura di fiction - e non certo
la raccomandazione di scrivere le etnografie sotto forma di romanzi, né l'assurda affermazione,
attribuita al postmodern dai suoi critici, che non v'è alcuna differenza tra letteratura e antropologia.
Dietro l'invito di Marcus alla sperimentazione vi è l'idea che l'antropologia debba rimodellarsi
sulle nuove condizioni che definiscono oggi l'incontro etnografico. Qui tocchiamo il cuore del
problema. Le riflessioni che troviamo accomunate sotto l'ombrello postmodern non sono soltanto
l'ultima moda americana, l'ultimo prodotto di importazione dai mercati fascinosi ma torbidi
dell'ermeneutica e del decostruzionismo, l'ultimo fastidioso gergo specialistico. Esse esprimono
l'esigenza di comprendere le mutate condizioni di possibilità del sapere antropologico,
profondamente diverse rispetto alla fase classica della disciplina, quella rappresentata dalle scuole
di Boas e Malinowski. Lo fanno forse in forme talvolta troppo radicali e pretenziose, ma con un
grado di consapevolezza epistemologica che non mi pare altrettanto sviluppato in altri indirizzi
dell'antropologia contemporanea. Il problema che si trovano ad affrontare, in un certo senso, è
quello della periodizzazione della storia dell'antropologia, dei momenti di discontinuità nelle
condizioni - interne ed esterne - del suo sapere.
Ciò che non si è capitp è che Writing Culture è, in definitiva, un libro di storia degli studi. Cerca
di rispondere alla domanda: quali condizioni hanno consentito all'inizio del secolo la nascita
dell'antropologia moderna? E cerca di rispondere alla maniera degli storici delle idee, uscendo
dall'autorappresentazione interna alla disciplina e indagando le sue relazioni con contesti culturali
e sociali più ampi. Schematizzando fortemente, queste condizioni sono indicate nella costruzione
di modelli standard di oggetto etnografico e di soggettività etnografica; modelli poggianti su basi
politiche (il colonialismo, essenzialmente, la separazione e l'asimmetria di potere tra l'Occidente e
il Resto del Mondo) ed epistemologiche (il positivismo, il realismo, a loro volta non slegati dal
dominio politico). L'ulteriore domanda che viene posta è che cosa accada dell'antropologia quando
queste condizioni politiche ed epistemiche vengono meno o mutano radicalmente.
Questo è un problema centrale non solo per l'approccio testuale. E' diffusa la convinzione che in
qualche momento e da qualche parte, a partire dagli anni '60, l'antropologia sia entrata in crisi e le
sue condizioni costitutive siano mutate. Crisi dell'oggetto - con la decolonizzazione e le sue
conseguenze nei rapporti tra Occidente e Resto del Mondo; crisi del soggetto, con la progressiva
perdita di fiducia nelle possibilità di una rappresentazione oggettiva, distaccata ed eticamente
neutrale dell'Altro, e con la crescente consapevolezza del coinvolgimento della soggettività
antropologica nell'incontro etnografico e nelle stesse strategie descrittive. Stocking, che non ha
certo simpatie postmoderne (1992: 7 sgg.), ha di recente letto questa rottura in termini di
cambiamento di "tradizioni paradigmatiche". E' chiaro, egli scrive, che il periodo classico
dell'antropologia moderna è giunto alla conclusione dopo il 1960, con l'apertura di una lunga fase
di "crisi". Stocking ritiene che dagli anni '80 in poi la crisi possa dirsi, come si esprime,
"addomesticata", il periodo di transizione concluso, e che negli Stati Uniti, ad esempio, i maggiori
dipartimenti universitari abbiano ripreso una normale routine di ricerca, anche se con maggiori
difficoltà, non da ultimo economiche, rispetto al passato. E tuttavia, aggiunge, il "lavoro ordinario",
the usual business, di questa antropologia post-classica differisce per molti aspetti significativi da
quello che era stato in passato. Ecco come: "Con la fine degli imperi coloniali, [...] i popoli
tradizionalmente studiati dagli antropologi sono divenuti parte di 'nazioni nuove', orientate verso un
rapido muamento socio-culturale [...] A fronte di un rapido mutamento sociale e di restrizioni
nell'accesso ai luoghi di ricerca, non è più apparso realistico, neppure sul piano normativo,
considerare come obiettivo privilegiato dell'inchiesta antropologica la scoperta di una 'alterità' non
europea pura e incontaminata. Nè è stato più possibile considerare tale inchiesta come neutrale
sul piano etico, o priva di conseguenze su quello politico. Una nuova consapevolezza della
riflessività inerente all'osservazione partecipante ha messo in discussione le assunzioni sia
metodologiche che epistemologiche della tradizionale ricerca etnografica di terreno" (Stocking,
1990: 358-59).
Non molto diversa è la prospettiva delineata da Geertz nel suo ultimo libro, After the fact
(anch'esso, per inciso, un impotante contributo di storia degli studi). che sintetizza le "alterazioni
nelle condizioni del lavoro etnografico" nei seguenti punti. Prima di tutto, l'antropologia ha risentito
della "vertigine morale ed epistemologica che ha colpito la cultura nell'età post-strutturalista, postmodernista, post-umanista, l'età delle svolte e dei testi, del soggetto evaporato e del fatto
costruito...". Una vertigine che ha dato origine a un' "ansia radicale", articolata nelle seguenti
"preoccupazioni", come le definisce Geertz :"preoccupazione sulla legittimità del parlare a nome
degli altri; preoccupazione per gli effetti distorcenti delle assunzioni occidentali sulla percezione
degli altri; preoccupazione per il ruolo ambiguo che il linguaggio e l'autorità svolgono nella
raffigurazione degli altri (1995: 128-29).
Dall'altro lato, dice Geertz, non sono state solo le "idee" a cambiare, ma il mondo stesso. La fine
del colonialismo ha trasformato le modalità di accesso al "campo" e il ruolo di potere e di distacco
di cui l'antropologo classico godeva; gli antropologi non lavorano più in contesti intellettualmente
"vergini", ma devono confrontarsi con il lavoro di altri studiosi, spesso nativi; infine, il numero degli
antropologi è aumentato a dismisura, e ciò non è privo di conseguenze sulla pratica della ricerca e
sulle modalità di scrittura (Ibid.).
Usare la nozione di antropologia "post-classica", come fa Stocking, è forse più elegante e meno
impegnativo che non dire "post-moderna" - espressione, quest'ultima, che si porta dietro un
ingombrante fardello dal dibattito filosofico e artistico. I due termini hanno però in comune l'idea di
uno sviluppo degli studi che procede per rotture epistemiche e non per continuità. Comprendere la
natura della rottura post-classica, e comprendere le condizioni che rendono possibile oggi un
sapere antropologico, sono i problemi che pone il cosiddetto postmodern, che in questo pare
tutt'altro che una frivola moda ma, anzi, un erede della più seria riflessione storiografica ed
epistemologica.