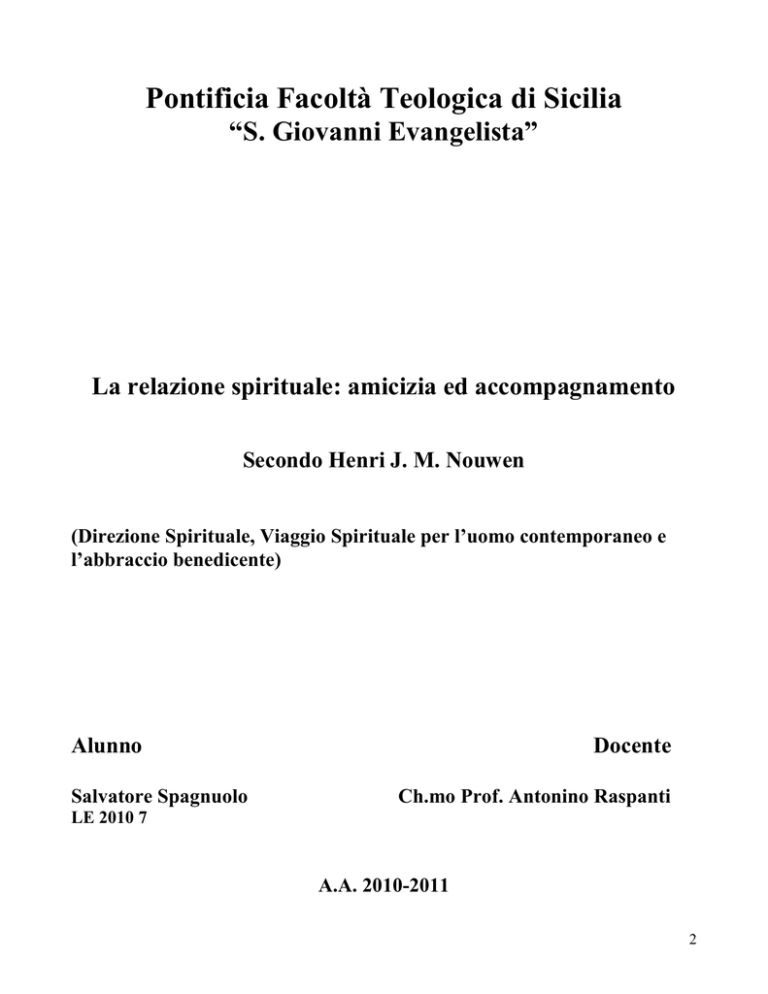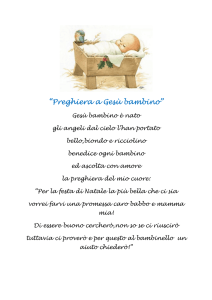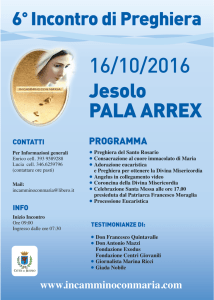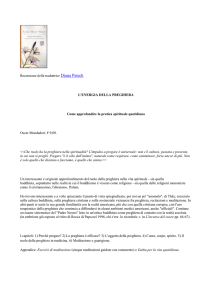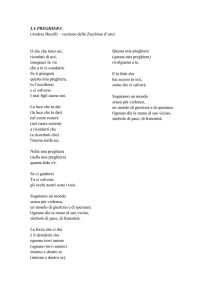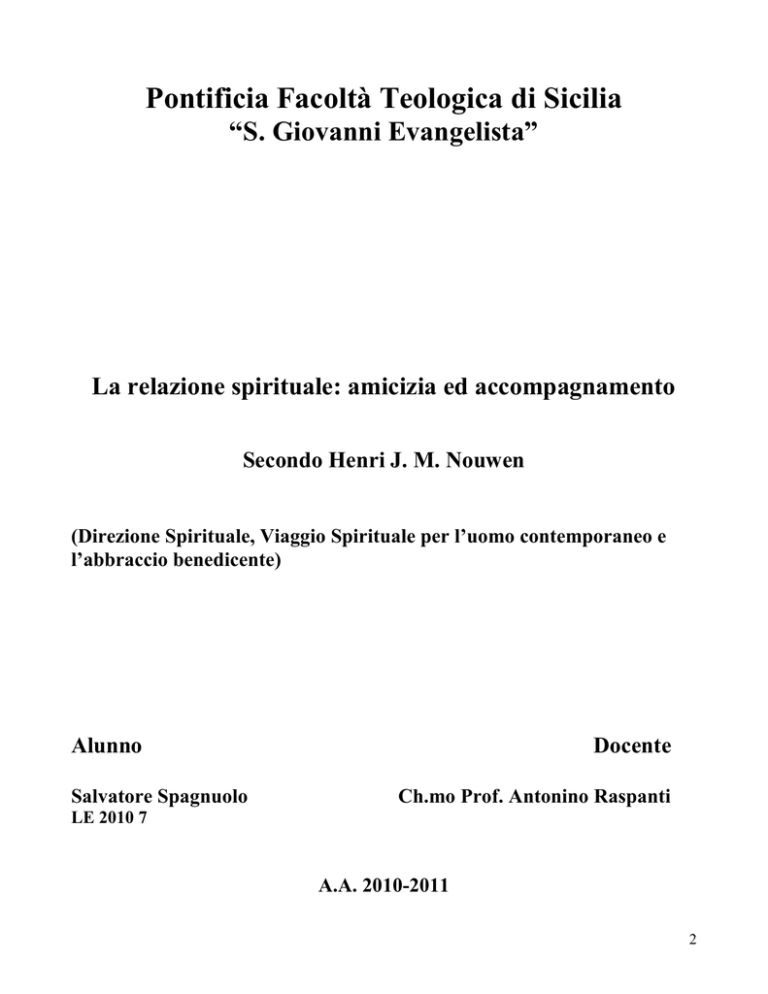
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia
“S. Giovanni Evangelista”
La relazione spirituale: amicizia ed accompagnamento
Secondo Henri J. M. Nouwen
(Direzione Spirituale, Viaggio Spirituale per l’uomo contemporaneo e
l’abbraccio benedicente)
Alunno
Salvatore Spagnuolo
Docente
Ch.mo Prof. Antonino Raspanti
LE 2010 7
A.A. 2010-2011
2
Cenni Biografici
Henri J. M. Nouwen, prete e professore, è uno degli esponenti della spiritualità del ‘900 ha scritto oltre
quaranta libri sulla vita spirituale.
Fu un grande comunicatore, qualità messa a frutto sia nelle conferenze e nei suoi ritiri spirituali, che nei
molti amici. Si legava molto alle amicizie, in modo particolare si legò con un suo amico, che in un
secondo momento (l’amico) si allontanò, perché si sentiva oppresso da Henri e questo portò Nouwen
ad una profonda sofferenza, andò da uno psicologo che gli disse di aver sbagliato di intraprendere la
vita celibataria. Dalla vicenda si potrebbe supporre che avesse tendenze omosessuali.
Nasce il 24 gennaio del 1932 a Nijkerk, in Olanda, fratello maggiore di due fratelli e una sorella.
Sin dalla infanzia, crescendo in un ambiente sicuro, fu un bravo studente ed espresse il desiderio di
diventare sacerdote a sei anni, e celebrava la messa nella mansarda della nonna materna, addirittura la
nonna gli fece l’altare e i paramenti su misura.
Da bambino fu guidato da due voci: la voce di sua madre, che lo lodava e stimava per quello che era e
lo invitava ad amare sempre Gesù e la voce del padre, che orgoglioso lo incoraggiava a diventare una
persona migliore.
Nouwen disse che ha vissuto la prima parte della sua vita ascoltando il padre la seconda ascoltando la
madre.
Fu educato presso i gesuiti, studiò il ministero pastorale attraverso l’aiuto della psicologia nonostante
fosse avvertita come minaccia dalla Chiesa.
Dopo l’ordinazione presbiterale nel ‘57, gli fu permesso di continuare gli studi in psicologia
laureandosi nel 1963. Dal 1964 al 1966 fece il praticantato nella Clinica Menninger (Stati Uniti), nel
dipartimento di Religione e psichiatria.
La sua missione è stata quella di combinare la psicologia con la teologia.
Dal 1966 al 1985 insegnò teologia pastorale e spiritualità nel nuovo dipartimento di Psicologia di Notre
Dame, nei Paesi Bassi, ad Yale e nel frattempo conseguì il dottorato in teologia nel 1971.
Visse anche ascoltando il silenzio da monaco trappista a New York.
Dal 1981 al 1982 fece molte conferenze in America Latina sul rapporto politica-teologia;
dal 1983 al 1985 insegnò nella scuola di spiritualità di Harvard e continuò la missione in America
Latina. A causa del burnout, notte spirituale, nel 25º anniversario sacerdotale, si lasciò l’insegnamento
ad Harvard, posto umanamente ambito, per abitare presso la comunità l’Arca, fondata da Jean Vanier a
Trosly in Francia dal 1986 al 1996, anno della sua morte, la comunità che accoglie disabili, divenne
dopo la depressione la casa che l’abbraccio come il Padre Buono della parabola.
3
Viaggio spirituale per l’uomo contemporaneo
I Tre movimenti della vita spirituale
Cosa significa vivere la vita nello Spirito di Gesù Cristo? E’ questa la domanda che Henri J. M.
Nouwen si pone e a cui risponde nei suoi testi personali ed esperienziali generati da lotte.
Questa domanda non ha ricette pronte ma è la ricerca di un’autentica spiritualità cristiana degna di
sforzo e di pena perché nel mezzo di questa ricerca si possono scorgere dei segnali che ci offrono
speranza, coraggio e fiducia.
In questo viaggio spirituale conquistiamo uno spazio libero e amico dove uno deve scoprire il proprio
cammino solitario, perché la vita spirituale sfiora il nocciolo dell’esistenza.
Si tratta di un’esperienza terribile ed esilarante: è la grande esperienza dell’esser soli, soli nel mondo,
soli di fronte a Dio.
La vita spirituale è un estendersi fino al nostro io più riposto, fino ai nostri fratelli umani, fino a Dio per
esplorare direttamente la nostra irrequietezza interiore.
Prigioniero dalle sue passioni e debolezze Nouwen da “guaritore ferito” entra in relazione con noi per
essere amico o direttore spirituale.
Nouwen va in cerca della pace interiore, dei rapporti creativi con gli altri e della esperienza di Dio
attraverso i processi psicologici coniugati alla teologia al punto da avere il dubbio - lo stesso Nouwen se è un uomo più o meno spirituale.
La vita spirituale è quel moto costante fra i seguenti poli:
La prima polarità: dall’isolamento alla solitudine riguarda il relazione con noi stessi;
La seconda polarità: dall’ostilità all’ospitalità dice il relazione con gli altri;
La terza polarità: dall’illusine alla preghiera dà struttura alla relazione con Dio.
La vita nuova nasce dai travagli di quella antica senza aggiramenti. Se aggiriamo l’isolamento, l’ostilità
e l’illusione non arriveremo mai alla solitudine, all’ospitalità e alla preghiera.
4
Primo movimento: dall’isolamento alla solitudine
Estenderci fino al nostro io più riposto ci fa penetrare nell’esperienza dolorosa dell’isolamento che
riguarda la vita di ognuno, ad esempio nel non aver un amico, quello dell’isolamento è per Nouwen
uno strano dolore sordo interiore, fame mentale, inquietudine.
L’isolamento è una delle esperienze umane più universali anche nelle città più popolose si è circondati
da individui silenziosi, nessuno parla ad un estraneo eppure le nostre città sono tappezzate da immagini
che parlano d’amore, di gentilezza, di tenerezza e di gioiosa fraternità tra persone spontanee.
Per Nouwen l’uomo del ‘900 si rende conto di vivere in un mondo in cui anche i rapporti (relazioni)
più stretti partecipano alla competizione e alla rivalità.
A mio avviso Nouwen subisce l’influenza della filosofia di Sartre che afferma “l’altro è l’inferno per
me” ma ancor più di Levinas “l’altro mi guarda e mi riguarda e dice: tu non mi ucciderai” sa bene
Nouwen - ne fa esperienza - che l’altro non ci lascia indifferenti, ci interroga, ci turba ma anche ci dà
forza.
Frutto dell’isolamento è la pornografia, intimità da vendere, il giovane, l’adulto e il vecchio isolato
guarda immagini pornografiche e non vuol farsi riconoscere e immagina che un’estranea disperderà il
proprio senso di isolamento, il discorso vale anche per l altro sesso.
Oggi l’isolamento è una delle fonti più universali di sofferenza umana. Gli psichiatri e gli psicologi ne
parlano come uno dei malanni espressi più frequente e come radice non solo di un numero crescente di
suicidi ma anche di alcolismo, di droga, mal di testa continui.
In un mondo in cui l’individualismo competitivo tenta di riconciliarsi con un acultura che parla di
familiarità, di unità e di comunità come ideali cui tendere tutti siamo sempre più esposti alla malattia
contagiosa dell’isolamento.
Il linguaggio che usiamo dice l’isolamento “entri, prego…sono felice di vederla…torni presto” e quindi
il desiderio di essere amichevoli e ricettivi.
Nouwen osserva che la nostra cultura si è fatta raffinatissima nell’evitare il dolore, non solo quello
fisico ma anche quello emotivo e mentale, seppelliamo le nostre pene come se in realtà non ci fossero,
è difficile tastare il proprio dolore.
Sintetizzerei questo concetto con un termine medico: ci auto-anestetizziamo o meglio per essere più
vicini a Nouwen - anche se lui non lo dice direttamente - si tratta del processo psicologico della
rimozione.
5
Purtroppo il dramma dell’isolamento è presente anche nelle famiglie dove ognuno vive da isolato
cercando di amarsi pur senza riuscirci.
A causa dell’isolamento le nostre relazioni sono malate, c’è molta sofferenza mentale, l’isolamento ci
trascina lontano da noi stessi, sovente (termine che nei suoi scritti è quasi un ritornello) rischiamo di
inibire l’espressione di libera amicizia e di amore.
Amicizia ed amore non possono svilupparsi in forma di ansioso attaccamento reciproco; essi vogliono
un dolce spazio privo di trepidazioni dove l’uno e l’altro possono muoversi in entrambe le direzioni.
I desideri inappagati e non realistici di unità, di tranquillità interiore e con l’esperienza ininterrotta della
comunione ci puniscono a vicenda.
Sorprende il vedere uomini e donne, dopo aver avuto rapporti difficili con i genitori, con fratelli e
sorelle, possano gettarsi ciecamente in preda a relazioni precipitose di grande portata, sperando che da
quel momento in poi le cose cambieranno completamente.
Se non proteggeremo con molta cura il nostro intimo mistero non saremo mai capaci di formare una
comunità. E’ questo intimo che ci attrae l’un l’altro e ci permette di fondare amicizie e di sviluppare
rapporti d’amore duraturo. Un rapporto intimo fra persone esige non solo la franchezza reciproca ma
anche una mutua protezione, rispettosa dell’unicità di ognuno.
E’ ingannevole pensare che nulla dovrebbe rimanere segreto e che tutto dovrebbe essere detto, espresso
e comunicato. La nostra vocazione è quella di custodire il nostro intimo santuario, per proteggere noi e
servire i fratelli con cui vogliamo entrare in comunicazione creativa.
Le parole perdono forza se non sono generate dal silenzio, l’apertura perde significato se manca la
capacità di essere chiusi.
Una sintesi poetica di quanto detto la troviamo in Kahil Gibran:
Cantate e danzate insieme e siate felici,
ma lasciate che ciascuno di voi sia solo.
Anche le corde del liuto sono sole
pur se vibrano con la stessa musica.
State insieme ma non troppo vicini
perché i pilastri del tempio sono separati.
E la quercia e il cipresso
non crescono l’uno all’ombra dell’altro.
6
Il cammino aspro è quello della conversione dall’isolamento alla solitudine, non dobbiamo fuggire
dall’isolamento ma cambiarlo in solitudine feconda, per farlo occorre entrare nel deserto del nostro
isolamento, trasformandolo con sforzi gentili e persistenti in un giardino di solitudine. Questo richiede
coraggio ma soprattutto fede profonda.
La conversione dal deserto al giardino fiorito è la stessa dall’irrequietezza dei sensi alla pace dello
spirito.
La vera guida spirituale è colui che invece di dirci che cosa dobbiamo fare o dove dobbiamo andare
ci offre l’occasione di stare da soli e di affrontare il rischio di penetrare nella nostra esperienza. Egli ci
fa constatare come non serva versare un po’ d’acqua sul nostro terreno arido ma come, scavando a
fondo sotto la superficie dei nostri malanni, troveremo invece un pozzo vivo.
Nella solitudine scopriremo che ascoltando attentamente il nostro cuore inquieto, potremo accorgerci
che al centro della tristezza c’è gioia, al centro dei timori c’è pace, al centro dell’avidità è possibile la
compassione e che invero, al centro del nostro spiacevole isolamento, si può scoprire l’inizio di una
quieta solitudine.
La solitudine che conta non è tanto quella fisica ma quella del cuore, talvolta anche quello fisico è
necessario perché la solitudine del cuore si sviluppi, ma certo non è un aspetto essenziale altrimenti
sarebbe prerogativa dei monaci ed eremiti.
La vita spirituale che cambia l’isolamento in solitudine ci allontana dal pettegolezzo e dalla
condanna delle azioni altrui che sono segno di dubbio nei nostri propri riguardi piuttosto che
frutto di convinzioni solidamente fondate.
- Una persona isolata non ha tempo interiore né tranquillità interiore per aspettare e per ascoltare, essa
vuole le risposte e le vuole subito;
- In solitudine, invece, si può prestare attenzione al proprio io. La solitudine non ci trascina lontano dai
nostri fratelli ma rende piuttosto possibile una vera e reale amicizia.
Scrive Thomas Merton:
In questa solitudine profonda scopro la bellezza che ci permette di amare realmente i frateli. Più vivo
da solitario più provo affetto per loro. E’ un affetto puro e pieno di reverenza per la solitudine altrui.
La solitudine non solo approfondisce il nostro affetto per gli altri ma è anche il luogo dove diviene
possibile una comunità reale.
Anche Merton insiste sulla solitudine del cuore e non quella fisica.
7
Senza la solitudine del cuore, nei nostri rapporti con gli altri noi saremo poveri ed avidi, viscidi e
soffocanti, dipendenti e sentimentali, sfruttatori e parassiti, perché senza la solitudine del cuore non
potremo percepire gli altri come diversi da noi stessi ma solo come persone da usare per il
soddisfacimento dei nostri bisogni personali, spesso celati.
E’ Dio che stringe in un abbraccio unico amici ed amanti, ed offre la libertà di amarsi l’un l’altro,
perché Egli ci ha amati per primo.
Gli amici si avvicinano nel silenzio: “il silenzio che cresceva tra noi era caldo, gentile e vibrante... è
bello essere ancora insieme…quando ti guardo è come se fossi alla presenza di Cristo…è Cristo in te
che riconosce Cristo in me”.
L’amicizia è uno dei doni più preziosi della vita, ma la vicinanza fisica può essere sia mezzo che
ostacolo al suo realizzarsi.
L’amicizia è anche il presupposto della comunità infatti amicizia e comunità sono qualità interiori che
permettono all’umana socievolezza di essere la gioiosa espressione di una realtà molto più vasta. Il
senso interiore dell’amicizia e della comunità rende liberi di vivere un’esistenza in cui nessuno è
escluso dalla nostra solitudine.
Una vera vita spirituale ci rende vigili e consapevoli del mondo che ci circonda, che tutto ciò che esiste
e che accade entra a far parte della nostra contemplazione e della nostra meditazione, invitandoci a
rispondere liberamente e senza timore ricordandoci che non ci sarà mai guarigione completa senza
solidarietà di cuore.
Nella solidarietà del cuore, si può prestare orecchio attento ai dolori del mondo perché essi non ci
appaiono estranei e sconosciuti bensì nostri.
Per l’uomo solidale e pietoso le manifestazioni del male vengono viste come occasioni per convertire
se stesso ed i propri fratelli.
Chi non sfugge ai nostri dolori ma li tocca pietosamente ci guarisce e ci rafforza, il paradosso consiste
che l’inizio della guarigione risiede nella solidarietà in quel dolore.
Volere alleviare il dolore senza condividerlo è come voler salvare un bambino da una casa in fiamme
senza correre il rischio di ustionarsi.
La solidarietà pietosa prende forma nella solitudine.
Il moto dall’isolamento alla solitudine non è un movimento di ritirata ma un impegnarsi maggiormente
nei problemi del nostro tempo, ci estendiamo nel nostro intimo per trovare la capacità di guarire come
dono da spartire con gli altri ed è per questo che il moto dall’isolamento alla solitudine ci conduce al
moto dall’ostilità all’ospitalità.
8
La Parola ai testimoni
Chi sono io?
Michael - tu che hai conosciuto padre Nouwen - come pensi che lui avrebbe risposto alla domanda
fondamentale “chi sono io”?
Certamente avrebbe cominciato così:
Un antico racconto talmudico getta luce sulla vera identità e sul vero valore di ogni singolo essere
umano al suo livello più profondo:
Il fuggiasco e il Rabbi
Un giorno un giovane fuggiasco che cercava di nascondersi al nemico arrivò ad un villaggio. Gli
abitanti lo accolsero con cortesia e gli offrirono un posto dove rimanere. Ma quando i soldati che lo
inseguivano domandarono dove si nascondeva, tutti furono impauriti. I soldati minacciarono di
incendiare il villaggio e di uccidere tutti gli uomini se il giovane non fosse stato consegnato prima
dell’alba. La gente del villaggio andò dal Rabbì e gli chiese che cosa fare. Lacerato dal dilemma se
consegnare il ragazzo al nemico o fare uccidere la sua gente, si ritirò in camera e aprì la Bibbia,
sperando di trovarvi una risposta prima dell’alba. Dopo molte ore, di prima mattina, il suo sguardo
cadde su queste parole: “E’ meglio che perisca un solo uomo piuttosto che si perda tutto il popolo”.
Il Rabbì chiuse la Bibbia, chiamò i soldati e indicò loro il nascondiglio del ragazzo. E dopo che i
soldati ebbero portato via il fuggiasco per ucciderlo, al villaggio vi fu una festa perché il Rabbì aveva
loro salvato la vita. Ma il Rabbì non si unì ai festeggiamenti. Oppresso da profonda tristezza rimase
nella sua stanza. La notte un angelo gli chiese: Che cosa hai fatto?. Ed egli rispose: Ho consegnato
il fuggiasco al nemico. L’angelo allora disse: Ma non sai che hai consegnato il Messia? Come avrei
potuto?, replicò il Rabbì angosciato. E l’angelo: se invece di leggere la Bibbia fossi andato una sola
volta a trovare quel ragazzo e lo avessi guardato negli occhi, lo avresti saputo.
Come ci suggerisce il racconto nella nostra vita quotidiana siamo chiamati a guardare in fondo agli
occhi della gente che incontriamo, ma ancor prima dobbiamo scorgere il nostro sguardo nel nostro
intimo, così vedremo il volto di Dio riflesso sul nostro.
9
Continuerebbe padre Henri dicendo:
La tentazione del dubbio su chi sei veramente
Le tentazioni di Gesù nel deserto vogliono deformare l’identità di Gesù, facendogli credere che:
tu sei quello che può trasformare le pietre in pani;
tu sei quello che può saltar giù dal tempio;
tu sei quello che può far prostrare gli altri dinanzi al suo popolo. Gesù ha detto: No, no, no. Io sono il
diletto di Dio.
La peggiore insidia dell’esistenza non è il successo, la polarità o il potere, ma il rifiuto di sé, il dubbio
su chi siamo veramente.
Il rifiuto di sé può manifestarsi come una mancanza di fiducia quanto in un eccesso di orgoglio.
Essere i “diletti” esprime la verità centrale della nostra esistenza. Siamo amati come creature, con i
nostri limiti e la nostra gloria
La tentazione di sentirsi sotto pressione
Accanto alla tentazione di avere dubbi su chi si è veramente, vi è la tentazione di sentirsi sotto
pressione.
Ti muovi a casaccio, sempre ansioso e inquieto, sempre voglioso di qualcosa, arrabbiato, mai
pienamente contento.
E’ la strada dell’esaurimento e della rovina spirituale. E’ la via che porta alla morte spirituale.
Non dobbiamo sperperare la vita e lacerarci. Noi siamo i diletti di Dio.
Siete i figli diletti di Dio
Come cristiano sono convinto che il momento decisivo della vita pubblica di Gesù fu il suo Battesimo,
quando udì l’annuncio divino: “Tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto”. In questa
esperienza fondamentale viene ricordato a Gesù, al livello più profondo, chi egli è veramente.
Vi è in ciascuno di noi una voce interiore d’amore che dice: “Tu sei il diletto di Dio!”. Voglio che tu
dichiari di essere amato.
10
Secondo movimento: dall’ostilità all’ospitalità
Dal cambiamento del rapporto con noi stessi può fruttificare un rapporto sempre nuovo con i nostri
fratelli.
L’estenderci fino al nostro intimo ci porta ad estenderci fino alla folla di estranei che incontriamo nel
cammino dell’esistenza.
In un mondo popolato da estranei assistiamo alla ricerca dolorosa di un luogo ospitale dove la vita
possa essere vissuta senza timore e dove si possa trovare una comunità.
E’ possibile per tutti - ed è obbligatorio per i cristiani - offrire uno spazio aperto ed ospitale dove questi
estranei possono spogliarsi della loro estraneità divenendo nostri fratelli.
Il moto dall’ostilità all’ospitalità è irto di difficoltà.
La nostra società è sempre gremita di persone che temono, che stanno sulla difensiva, che
aggrediscono, aggrappandosi ansiosamente a ciò che possiedono, che sono inclini a guardare con
sospetto il mondo che le circonda e sono sempre in attesa di un nemico che spunta.
Eppure, la nostra vocazione è proprio questa: convertire il nemico in ospite, invitando, creando lo
spazio libero e senza paure in cui possa nascere ed essere sperimentata la fraternità.
La Sacra Scrittura non ci indica solo quanto è importante l’obbligo di ospitare bene lo straniero in casa
nostra, ma ci dicono anche che gli invitati recano doni preziosi, che sono ansiosi di mostrare a colui che
accoglie.
I tre stranieri ricevuti a Mamre da Abramo, il quale offrì loro acqua, pane ed un vitello tenero e grasso,
gli si rivelarono come il Signore e gli annunciarono che la moglie Sara gli avrebbe partorito un figlio
(Gn 18,1-15).
Quando la vedova di Sarepta offrì cibo e riparo ad Elia, questi le si rivelò come uomo di Dio,
offrendole in abbondanza farina e olio e le resuscitò il figlio (1Re 17, 9-24).
Quando i due viandanti di Emmaus invitarono a trattenersi per la notte lo straniero che si era unito a
loro lungo il cammino, quegli, spezzando il pane, si fece riconoscere come Signore e Salvatore (Lc 24,
13-35).
Le storie bibliche ci aiutano a renderci conto che l’ospitalità è una virtù importante, ma ancor più che,
nel contesto dell’ospitalità, ospite e invitato possono rivelarsi a vicenda dei regali preziosi, donandosi
11
una vita nuova.
La psicologia del Novecento - ci ricorda Nouwen - ha contribuito enormemente ad un nuovo
intendimento dei rapporti interpersonali.
Il concetto di ospitalità potrebbe dare una nuova dimensione alla nostra comprensione di un rapporto
benefico e alla formazione di una comunità, nuovamente creativa, in un mondo che soffre di
alienazione e di estraniamento.
Pertanto, il termine ospitalità non dovrebbe limitarsi al senso letterale di ricevere un estraneo in casa pur senza escluderlo - ma come atteggiamento fondamentale verso i nostri fratelli, suscettibile di
esprimersi in molti modi.
Spesso il timore e l’ansietà ci impediscono di invitare gli estranei nel nostro mondo.
Per apprezzare pienamente il significato di ospitalità potrebbe essere necessario, anzitutto, divenire
estranei a noi stessi.
Si desidera dimostrare simpatia verso i poveri, gli isolati, i senza tetto, i derelitti, ma i sentimenti verso
lo straniero che bussa alla porta chiedendo cibo ed alloggio e generalmente dagli estranei non ci si
aspetta nulla di buono. Per l’uomo di oggi gli estranei sono un pericolo potenziale.
Nel cuore possiamo anche desiderare di nutrire gli affamati, visitare i carcerati, offrire rifugio ai
viandanti; ma nello stesso tempo siamo circondati da un muro di paura e di sentimenti ostili.
Purtroppo anche tra gli studenti, gli insegnanti, il personale negli ospedali regna l’ostilità, la paura, il
sospetto e persino un’aperta aggressione.
Anche tra le quinte non manca l’ostilità, mentre gli attori recitano le scene d’amore più intime, più
tenere e più commoventi la scena era pervasa dall’odio, dallo sgarbo e dal sospetto.
Gran parte del nostro mondo assomiglia ad un palcoscenico dove la pace, la giustizia e l’amore sono
recitati d attori pronti poi a mutilarsi l’un l’altro con reciproca ostilità.
Svariati ministri del culto e preti sul pulpito predicano pace e amore che non riescono a viverla.
Solo quando avremo visto i contorni dolorosi della nostra ostilità saremo in grado di esser ospitali.
La parola tedesca che dice l’ospitalità significa: amicizia per l’invitato;
La parola olandese che dice l’ospitalità significa: libertà dell’invitato.
12
Quanto detto ci mostra che l’ospitalità intende offrire all’invitato amicizia e libertà senza per questo
abbandonarlo.
Ospitalità significa offrire uno spazio libero dove lo straniero possa entrare per diventare amico
invece che nemico.
Ospitalità non significa mutare le persone ma offrire loro uno spazio dove il mutamento possa avvenire.
Gli stranieri si scoprano se stessi come creature libere; libere di cantare le loro canzoni, di parlare la
loro lingua, di danzare le loro danze, liberi di andarsene per seguire la loro vocazione.
Chi ospita ritiene spesso di dover parlare continuamente con gli invitati, intrattenendoli con cose da
fare, posti da vedere, persone da visitare. Ma, riempiendo ogni angolo vuoto e occupando ogni
momento vuoto, la loro ospitalità diventa più opprimente che liberatrice.
Dunque l’ospitalità è un atteggiamento molto importante. Non si può cambiare il mondo con i piani,
con i progetti, con le nuove idee, non si può cambiare la gente con le convinzioni, le storie, i consigli,
le proposte personali, ma si può offrire uno spazio dove gli altri odano un invito a gettare le armi, a
lasciare da parte occupazioni e preoccupazioni per ascoltare attentamente le voci che parlano dal loro
stesso centro.
La conversione dall’ostilità all’ospitalità esige la creazione di uno spazio vuoto ed amico in cui ci si
possa estendere fino ai fratelli umani, invitandoli ad un rapporto nuovo. Tale conversione è un evento
interiore che non può essere manipolato ma deve svilupparsi dal di dentro.
In altri termini, non si può forzare nessuno ad operare un mutamento di cuore tanto intimo e personale
ma si può invece offrire lo spazio dove il mutamento possa aver luogo.
Il moto dall’ostilità all’ospitalità determina i nostri rapporti con gli altri, perché come detto sopra
l’ospitalità crea uno spazio libero e amico, in cui si possa estenderci fino agli stranieri, invitandoli a
diventare amici, questo accade a molti livelli e in numerosi rapporti. Lo straniero non è solo colui che
parla una lingua diversa e ha costumi diversi, è importante, prima di tutto, individuare chi è lo straniero
nella nostra stessa cerchia familiare.
Una volta acquistata la capacità di ospitare bene chi è vicino, potremo espandere l’ospitalità verso
orizzonti più lontani.
Uscendo ed entrando ognuno dal mondo dell’altro in momenti diversi e in modi diversi succede che
siamo tutti figli e genitori, allievi e insegnanti, guaritori e pazienti.
Il concetto dell’ospitalità potrebbe portare una dimensione unificatrice al problema dei rapporti
13
interpersonali. Esso ci potrebbe aiutare a vedere come essi siano tutti raggruppati sotto lo stesso
comandamento: “Amerai il prossimo tuo come te stesso”.
Relazione tra genitori e figli
Può scandalizzare ma i figli sono gli ospiti più importanti, perché i figli non sono una proprietà d a
possedere e da dirigere, ma doni da custodire e curare teneramente. I figli sono stranieri che dobbiamo
imparare a conoscere. Hanno i loro modi, il loro ritmo, le loro capacità, nel bene e nel male.
I genitori devono imparare ad amare i figli, l’amore non è una reazione automatica.
La dimora ospitale è quella dove padre, madre e figli possono svelarsi le doti personali, essere presenti
gli uni negli altri come membri della stessa famiglia umana e sorreggersi l’un l’altro nella lotta comune
per vivere e far vivere.
Il difficile compito dei genitori è di aiutare i figli a sviluppare una libertà che permetterà loro di stare in
piedi da soli, fisicamente, mentalmente e spiritualmente, permettendogli poi di partire, ognuno nella
propria direzione.
Relazione tra insegnanti ed allievi
L’ospitalità è modello di interscambio creativo tra persone. Nel campo dell’educazione è necessario
uno spirito nuovo, una spiritualità che libera e redime.
Assistiamo ad una resistenza enorme verso l’apprendere - è difficilissimo farsi ascoltare - e lo sviluppo
emotivo e mentale sia inibito da un ambiente educativo in cui gli allievi percepiscono i docenti più
come padroni esigenti che come guide alla ricerca di conoscenza e di sapere.
Talvolta gli insegnanti parlano di amore, odio, timore, gioia ecc. gli alunni alcuni prendono appunti
altri guardano annoiati fuori dalla finestra questo perché ciò che ascoltano non ha come sorgente le
proprie domande.
Gli ambienti educativi dove allievi e maestri sono profondamente affeti dal timore di rifiuti, da dubbi e
insicurezza sulle capacità personali, e da reciproci rancori, sovente inespressi, sono nocivi
all’educazione.
Nessuno mette in luce le proprie doti migliori di fronte a chi teme.
Se osserviamo l’insegnamento in termini di ospitalità possiamo dire che il maestro è chiamato a creare
per gli allievi uno spazio dove non esiste paura ed in cui può aver luogo uno sviluppo mentale ed
emotivo.
14
Il docente ospitale deve rivelare agli allievi che essi hanno qualcosa da offrire.
Ospita bene colui che non solo aiuta gli invitati a scoprire che hanno doti nascoste ma è anche colui che
sa aiutarli a sviluppare ed approfondire tali doti, cosicché essi possano proseguire il cammino da soli,
con rinnovata fiducia in se stessi.
Relazione tra assistenti e assistiti
Medici, assistenti sociali, consiglieri, ministri di culto…tutti dobbiamo ricordare a noi stessi che non
siamo i proprietari di chi ha bisogno delle nostre cure, altrimenti c’è il rischio che l’assistenza diventi
mezzo per esercitare il potere, invece di servire.
Alcuni hanno paura dei preti e dei ministri di culto, altri provano verso di loro ostilità e rancore, molti
non si aspettano grande aiuto e solo pochissimi si ritengono liberi di bussare alla porta senza
imbarazzo. Agli occhi e al cuore di molti dolenti le chiese appaiono più come sedi di potere che come
luoghi ospitali.
Questo vale anche per le altre professioni. Quanti lasciano l’ospedale guariti nel fisico ma feriti nel
sentimento per il trattamento impersonale che vi hanno ricevuto?
Certamente non vogliamo accusare nessuno e spesso le condizioni di lavoro sono davvero pessime,
tuttavia, colui che assiste deve continuare a sforzarsi di raggiungere una spiritualità che impedisca la
violenza interpersonale e che crei lo spazio in cui chi assiste e chi è assistito si estendano l’uno verso
l’altro come compagni di viaggio che condividono la stessa condizione umana.
Dal punto di vista della spiritualità cristiana è importante sottolineare che ogni essere umano è
chiamato ad aiutare e a sanare.
In sintesi direi che siamo tutti dei guaritori che possono estendersi per offrire salute e siamo tutti
pazienti in costante bisogno di cure.
Ogni opera di guarigione è uno sforzo teso a conoscere sempre meglio il paziente in tutte le sue gioie, i
dolori, i piaceri, le sofferenze, gli alti e bassi… infatti guarire significa creare uno spazio vuoto ma
amico dove chi soffre possa raccontare la sua storia e qualcuno che lo ascolta con attenzione reale.
L’ascolto è un’arte da sviluppare, non una tecnica da applicare, l’ascolto richiede una presenza reale ed
è una delle forme più alte di ospitalità.
15
Guarire è il compito umile, ma esigentissimo, di creare ed offrire uno spazio vuoto ed amico dove gli
stranieri possano riflettere sul dolore e sulle sofferenze senza timore alcuno, conquistando la fiducia
che li manderà in cerca di nuove strade.
Ricettività e confronto
Come genitori e figli, maestri ed allievi, guaritori e pazienti, in tutti questi modi di relazioni, il concetto
di ospitalità ci aiuterà a capire che non siamo chiamati a possederci, bensì a servirci l’un l’altro e a
creare uno spazio dove ciò sia possibile.
In questi tre tipi di rapporto l’accento è posto sulla recettività. Infatti, lo straniero deve essere ricevuto
in uno spazio amichevole e libero in cui possa rivelare le sue doti e diventarci amico.
L’essenza della spiritualità cristiana consiste nel ricevere il prossimo nel nostro mondo senza imporre il
nostro punto di vista religioso, come condizioni per la carità, l’amicizia e l’attenzione.
La ricettività è solo un lato dell’ospitalità, l'altro lato è il confronto. Il confronto è il risultato di una
presenza palese, la presenza entro i confini, dell’ospite di fronte all’invitato al quale egli offre se stesso
come punto d’orientamento e come base di riferimento.
Non si è ospitali se si abbandona la casa a mano degli estranei, permettendo di usarla a proprio
piacimento. Una casa vuota non è una casa ospitale.
Ricettività e confronto sono due aspetti inseparabili della testimonianza cristiana. E questi due aspetti
devono rimanere in perfetto equilibrio.
-
Una ricettività senza confronto conduce ad una blanda neutralità che non è di servizio a
nessuno;
-
Un confronto senza ricettività conduce ad un’oppressione aggressiva che ferisce chiunque.
A conclusione di questo movimento dall’ostilità all’ospitalità desidero collegarlo al primo movimento
dall’isolamento alla solitudine, perché finché siamo isolati non possiamo essere ospitali perché le
persone isolate non sanno creare uno spazio libero.
16
La parola ai testimoni
Chi sono gli altri per me?
Rebecca tu che hai avuto un’amicizia spirituale con Henri J. M. Nouwen, uno dei più grandi autori
spirituali del nostro tempo, come pensi che lui avrebbe risposto alla domanda “Chi sono gli altri per
me”?
Henri iniziava spesso le sue riflessioni da esperienze personali e credo che lo avrebbe fatto anche per
rispondere a questa domada.
Nel testo “Il dono del compimento” scrive…
I due trapezisti
Due trapezisti, un uomo e una donna, entrano nella pista del circo e salutano il pubblico consorrisi e
giravolte che fanno turbinare attorno a loro le ampie cappe d’argento. Si issano insieme nella grande
rete e cominciano ad arrampicarsi sui gradini di corda che portano sulle postazioni situate a grande
altezza nel tendone. Quando la trapezista si lancia dalla base del piedistallo, esegue delle capriole e
volteggia liberamente nel vuoto, per essere poi saldamente afferrata dal suo compagno.
L’esperienza dei trapezisti, i Flying Rodleighs, che si esibiscono nel circolo tedesco Simoneit-Barum,
rimase fissa nella mente di Henri, fu affascinato dai Rodleigh che libravano nell’aria, volavano e si
afferravano a vicenda come eleganti ballerini.
Divenne subito un ammiratore dei trapezisti al punto che fu invitato e viaggiò con loro nella roulotte.
Il leader dei Rodleigh parlando dei lanci gli disse: quando mi lancio volando devo avere completa
fiducia nel mio compagno che deve afferrarmi, la vera star non sono io che mi lancio, ma Joe - il mio
compagno - che con la massima concentrazione deve prendermi nel vuoto. Quando volo verso Joe,
devo semplicemente tendere le braccia e mani e aspettare che mi afferri e mi porti al sicuro.
Conoscere i Rodleighs me ha avviato verso una nuova immagine di essere amato. Presi coscienza che
la vera vita spirituale è una vita incarnata, che chiama a una nuova spiritualità del corpo. Credere
nell’Incarnazione - Dio che si fa carne - è rendersi conto che Dio entra in un corpo. Affinché tu possa
toccare un corpo, nel modo in cui tocchi la vita divina. Non vi è vita divina al di fuori del corpo, perché
Dio ha deciso di diventare uno di noi.
17
Pertanto alla domanda “chi sono gli altri per me”? rispondo: Sono dei fratelli nella fede, resi grazie
all’Evento - Incarnazione figli nel Figlio e diletti dal Dio Amore, con cui sono chiamato (attraverso la
spiritualità incarnata) a tessere relazioni di fiducia reciproca, come il trapezista che si getta, vola perché
affidandosi all’altro sa di essere afferrato.
Reciprocità nel ministero
Il mio individualismo e il mio desiderio di successo personale mi hanno costantemente tentato a fare da
solo e a esigere per me stesso il compito del ministero. Il ministero non si esercita da soli, ma in
comunità. Non esercitiamo il ministero verso qualcuno, ma con gli altri e fra gli altri e così agiamo nel
nome del Signore.
Gratitudine e compassione
La reciprocità nel ministero può essere caratterizzata da due parole: gratitudine e compassione.
Gratitudine significa fondamentalmente “ricevere i doni di Dio e degli altri: dire grazie”.
Per gli altri la gioia più grande è rendersi conto che sono loro che hanno qualcosa da darci.
Il ministero è riconoscere e ricevere i doni degli altri. Una delle tentazione più grandi della vita è
provare risentimento. Il risentimento è l’opposto della gratitudine.
La compassione significa “soffrire con” è viscerale. Gesù, mosso a compassione, sentì nelle proprie
viscere il dolore della madre. Lo sentì così profondamente che la sua compassione richiamò alla vita il
figlio.
Il ministro trova il coraggio di stare con il malato, il morente, i poveri nella loro debolezza e nella
nostra impotenza; non possiamo risolvere i loro problemi né rispondere alle loro domande, ma osiamo
essere con gli altri in una reciproca vulnerabilità.
Dio è un Dio che soffre con noi e ci chiama alla gratitudine e alla compassione in mezzo alla
sofferenza.
Sapere che sei amato ti consente di andare nel mondo e toccare la gente, guarirla, parlare con le persone
e renderle consapevoli che sono amate, elette e benedette. Non grazie lla nostra forza, ma con la nostra
semplice presenza in mezzo alla sofferenza noi mostriamo agli altri il nostro amore e la nostra
gratitudine. Questo è il mistero del ministero.
18
Abbassamento volontario
Nel ministero la compassione e la gratitudine sono possibili attraverso la mobilità volontaria verso il
basso. Lo stile di Gesù è radicalmente diverso dallo spirito del mondo. E’ lo stile della mobilità verso il
basso, cioè rimanere nei posti dietro e scegliere l’ultimo posto! Lo stile di Gesù è quello del regno che
porta alla vita eterna.
19
Terzo movimento: dall’illusione alla preghiera
Una vera vita spirituale diventa possibile solo smascherando le illusioni della nostra esistenza, la
solitudine e l’ospitalità - esplicitati precedentemente - porteranno frutti durevoli solo quando saranno
impiantate in una realtà più vasta, più profonda e più alta dalla quale riceveranno la loro vitalità.
E’ per mezzo del moto dall’illusione alla preghiera che noi ci estendiamo fino a Dio e ci conduce gli
altri due moti precedenti al nucleo della vita spirituale.
La preghiera pur essendo l’espressione di un intimo rapporto, è anche il tema di cui è più difficile
parlare e diventa agevolmente oggetto di banalità e di luoghi comuni. Pur essendo la più la più umana
delle azioni umane, essa è considerata facilmente come l’attività più superflua e più superstiziosa.
Paradossalmente dobbiamo seguitare a parlare della preghiera, perché se non entriamo in quel campo di
tensione interiore in cui si realizza il moto dall’illusione alla preghiera, la solitudine, l’ospitalità,
perderanno ben presto di profondità. E allora, invece di essere essenziali alla vita spirituale, esse
diverranno devoti ornamenti di una esistenza moralmente rispettabile.
L’illusione dell’immortalità è il più grande ostacolo alla preghiera.
Avvenimenti apparentemente innocenti ci confermano con quanta facilità noi eterniamo noi stessi e il
mondo. Basta una parola ostile per farci sentire tristi e isolati. Basta un gesto di rifiuto per sommergerci
nell’autocommiserazione, basta solo una lieve incrinatura per denudare la nostra illusione di
immortalità e per rivelare come siamo diventati vittime del mondo che ci circonda, suggerendoci che
“siamo ai comandi”.
I due sintomi più visibili della grande illusione sono: il sentimentalismo e la violenza.
Sentimentalismo perché ogni volta che scarichiamo sulle spalle dei fratelli umani la soma delle nostre
aspettative immortali la separazione, o la minaccia di questa, possono scatenare sentimenti
incontrollabili.
L’intimità può condurre alla depressione e alla disperazione quando si maschera d’immortalità. Se
siamo incapaci di guardare oltre i confini della familiarità, ancorando la nostra vita a Dio, che è la
sorgente di ogni intimità.
La violenza alberga nel cuore dell’uomo insieme al sentimentalismo, ad esempio molti ricordano
Hitler commosso fino alle lacrime dalla vista di un bambino, la medesima illusione che lo portava alle
20
lacrime lo portava a torturare.
I rapporti umani cadono facilmente in preda alla violenza e alla distruzione, quando si tratta la vita
propria e degli altri come proprietà da difendere o conquistare e non come doni da ricevere.
Spesso il seme della violenza si rivela al centro dei rapporti più intimi.
I confini tra il baciare e il mordere, l’accarezzare e il percuotere, l’ascoltare e lo spiare, il guardare con
tenerezza e il guardare con sospetto sono fragilissimi.
Appena l’illusione nascosta dell’immortalità comincia a predominare, non ci vuol molto perché il
desiderio di essere amati si converta in violenza bramosa.
Per raggiungere un’intimità non violenta si deve smascherare l’illusione d’immortalità, accettare
pienamente la morte come destino dell’uomo ed estendersi oltre i limiti dell’esistenza, fino a Dio, dalla
cui intimità fummo generati.
La nostra vocazione è quella di estenderci fino a Dio, non solo da svegli ma anche nel sonno, con
pazienza e costanza si deve smascherare lentamente l’illusione dell’immortalità.
Nel moto dall’illusione alla preghiera noi ci spostiamo dal rifugio umano alla magione di Dio, è in
questo dinamismo che la nostra solitudine e la nostra ospitalità troveranno sostegno.
Tutto quello che è stato detto a proposito della solitudine e dell’ospitalità indica Qualcuno che è più in
alto del punto cui possono arrivare i nostri pensieri, qualcuno che è più profondo di quanto i nostri
cuori possano sentire e più vasto di quanto le nostre braccia possano afferrare, qualcuno sotto le cui
ali si possa trovare rifugio (Sal 90), e nel cui amore si possa riposare, qualcuno che noi chiamiamo
Dio nostro.
Il paradosso della preghiera alla base delle relazioni
La preghiera, come intimità d’amore con Dio, è il terreno in cui affondano le radici la solitudine e
l’ospitalità, mi preme ricordare che: una vita spirituale senza la preghiera è come un Vangelo senza
Cristo e la preghiera è la base di tutti i rapporti con noi stessi e con gli altri.
La preghiera vive un paradosso che consiste nella necessità di imparare a pregare mentre invece la
preghiera è solo un dono.
Tutti i santi, i direttori spirituali, dicono che dobbiamo imparare a pregare perché la preghiera è il
nostro primo dovere, oltre ad essere la vocazione più alta. Essi ci rammentano tante volte le parole di
San Paolo: Pregate incessantemente (1 Ts 5,17).
21
Esistono anche diverse scuole di preghiera, ad esempio l’esicasmo russo.
Gli stessi santi e direttori spirituale giustamente ci ricordano che la preghiera è dono di Dio; tutti i
mistici sottolineano che la preghiera è grazia, libero dono di Dio, al quale possiamo solo rispondere con
gratitudine.
La preghiera è l’alito attraverso il quale partecipiamo all’intimità della vita divina, nascendo ad una vita
nuova.
Pertanto, il paradosso della preghiera è che essa richiede un grande sforzo mentre può essere ricevuta
solo come dono.
La vita spirituale è attesa sofferta in cui le numerose esperienze di mancato appagamento ci
rammentano l’assenza di Dio. Ma essa è anche una pazienza aspettativa che ci permette di riconoscere i
primi segnali dell’arrivo di Dio al centro dei nostri dolori.
Il mistero della presenza di Dio, si può sfiorare solo attraverso una profonda coscienza della sua
assenza.
Nella preghiera la presenza di Dio non è mai separata dalla sua assenza e l’assenza di Dio non è mai
separata dalla sua presenza.
Nel centro del nostro anelito per il Dio assente, noi scopriamo le sue orme e ci accorgiamo che il nostro
desiderio di amare Dio nasce dall’amore con cui Egli ci ha toccato. Nell’attesa paziente dell’amato
scopriamo quanto egli abbia già riempito la nostra vita. Come i figli imparano ad apprezzare i genitori
dopo essersi allontanati da casa, come gli amanti si riscoprono a vicenda nei lunghi periodi d’assenza.
Una volta infranta l’illusione dell’immortalità sarà possibile creare lo spazio aperto in cui allargare le
braccia verso Dio, attraverso una danza di silenzi e parole.
La parola conduce al silenzio e il silenzio conduce alla parola. La parola nasce nel silenzio e il silenzio
è la risposta più profonda alla parla.
La parola e il silenzio, hanno entrambi bisogno di guida, un direttore spirituale, un consigliere che ci
aiuti a distinguere fra la voce di Dio ed il coro di voci che nascono dalla nostra confusione e dalle
potenze incontrollabili delle tenebre.
-
Ci serve qualcuno (il direttore spirituale) che ci incoraggi quando saremo tentati di gettare le
armi ed arrenderci, cadendo in preda alla disperazione.
-
Ci serve qualcuno (il direttore spirituale) che ci scoraggi quando ci avviamo speditamente in
una direzione oscura o corriamo fieramente verso una meta avvolta nella nebbia.
22
-
Ci serve qualcuno (il direttore spirituale) che ci dica quando è tempo di leggere e quando è
tempo di tacere, su quali parole riflettere e come comportarci quando il silenzio produce molta
paura e poca pace.
La Bibbia, il silenzio e il direttore spirituale sono le tre guide importanti per cercare una strada
personalissima onde entrare in intimo rapporto con Dio.
23
La parola ai testimoni
Chi è Dio per me?
Michael come pensi che Nouwen - da prete molto travagliato - avrebbe potuto rispondere alla domanda
di senso: Chi è Dio per me?
Nouwen - dice Michael - per rispondere alla domanda Chi è Dio per me? Che richiama le domande
Che cos’è la preghiera? E Come pregare? Avrebbe raccontato la parabola inventata da Lev Tolstoj che
va al cuore della vera preghiera.
Tre monaci su un’isola
Tre monaci russi vivevano su un’isola remota. Nessun andava mai là, ma un giorno il loro vescovo
decise di farvi una visita pastorale. Quando arrivò, scoprì che i tre monaci non conoscevano neppure il
Padre nostro; allora spese tutto il suo tempo e le sue energie per insegnare il Padre nostro, e poi se ne
andò, soddisfatto della sua opera pastorale. Ma quando la sua barca lasciò l’isola e tornò in mare
aperto, all’improvviso vide i tre eremiti che camminavano sulle acque: essi correvano infatti dietro la
barca! Quando la raggiunsero, gridarono: “Caro Padre, abbiamo dimenticato la preghiera che ci ha
insegnato!”. Il vescovo sopraffatto da quel che vedeva e udiva, disse: “Ma cari fratelli, allora come
fate a pregare?”. Essi risposero: “Beh, diciamo semplicemente: “O Dio, ci sono tre di noi e tre di te,
abbi pietà di noi!”. Il vescovo colpito dalla loro santità e semplicità, disse: “Tornate alla vostra isola e
andate in pace”.
Dalla parabola di Tolstoj notiamo che c’è differenza tra imparare delle preghiere e lo spirito di
preghiera. Il fervore del cuore è più profondo e alla fine più importante delle preghiere particolari che
vengono dette.
Lo spirito di preghiera coltivato spiritualmente durante tutto il giorno rendono possibile l’invito di
Paolo a pregare incessantemente.
24
La preghiera: un grido a Dio
La preghiera è prima di tutto un grido a Dio che parte dal nostro cuore. Porgi orecchio alle mie parole,
o Signore, e intendi il mio lamento è una preghiera che viene dal cuore. Gridare a Dio e portare le
nostre paure alla presenza di Dio che dice: Non temere sono con te.
Presentando a Dio le nostre paure, reiezioni, odio e amarezza possiamo sperare di essere guariti dalle
nostre paure, dal rancore, dall’odio.
La preghiera come dialogo
La preghiera è un semplice ed intimo colloquio col Signore che ci ama. Pregare incessantemente, come
ci chiede san Paolo, sarebbe totalmente impossibile se significasse pensare a Dio o parlargli
costantemente. Pregare incessantemente non significa pensare a Dio in contrasto con il pensare ad altre
cose, o parlare a Dio anziché parlare ad altri. Significa invece pensare, parlare e vivere alla presenza di
Dio. La preghiera come dialogo implica che tutti i nostri pensieri - belli o brutti, nobili o bassi,
orgogliosi o vergognosi, dolorosi o gioiosi - possono essere pensati ed espressi alla presenza di Dio.
Trasformare il nostro incessante pensare in un incessante pregare ci fa passare dal monopolio centrato
su noi stessi al dialogo centrato su Dio.
La preghiera come contemplazione
La preghiera è l’atteggiamento aperto del cuore, in silenziosa sintonia con lo Spirito di Dio, che si
rivela nella gratitudine e nella contemplazione. La preghiera non è soltanto gridare a Dio perché ci
aiuti, o parlare con Dio dei nostri pensieri; la preghiera è un silenzio ascolto che conduce alla
contemplazione alla presenza di Dio.
Più di ogni altra cosa la preghiera è ascoltare e aspettare. Ascoltiamo Dio in un atteggiamento di
apertura del cuore, di umiltà di spirito e di calma dell’anima.
Lasciamo che la mente discenda nel cuore e qui rimaniamo alla presenza di Dio.
25
L’abbraccio benedicente
Dio si serve anche di un poster per farci comprendere sotto una nuova luce la nostra vocazione e per
viverla con più forza.
Nouwen nell’autunno del 1983 nella cittadinanza di Trosly, in Francia, dove stava trascorrendo qualche
mese presso l’Archè, una comunità che ha aperto una casa a persone con handicap mentali, fondata nel
1964 da un canadese, Lean Vanier, fu attratto dal poster del Ritorno del figlio prodigo di Rembrandt.
Di questa esperienza scrive:
Non riuscivo a distogliere gli occhi. Mi sentivo attratto dall’intimità tra le due figure, il rosso caldo del
mantello dell’uomo, il giallo dorato della tunica del ragazzo, e la luce misteriosa che avvolgeva
entrambi. Ma soprattutto furono le mani - le mani del vecchio - mentre toccavano le spalle del ragazzo
a colpirmi interiormente in un punto dove mai ero stato raggiunto prima.
A San Pietroburgo - all’Ermitage - ebbe l’opportunità di riflettere con calma sulla parabola il Padre
buono e i due figli prodighi. La vita spirituale di Nouwen grazie alla contemplazione della parabola
tramite il dipinto fu un climax, una graduale crescita nella vita spirituale, da guaritore ferito ha
imparato ad abbracciare perché per primo ha ricevuto l’abbraccio benedicente.
In relazione col figlio minore
La prima istanza è stata l’esperienza di essere il figlio più giovane. I lunghi anni di insegnamento
universitario e il mio intenso coinvolgimento nelle questioni del Sud e del Centro America mi avevano
lasciato la sensazione di essermi perduto. Avevo girato in lungo e il largo, incontrato persone di
condizioni di vita e di convinzioni del tutto diverse. Alla fine ho però avvertito di essere senza casa e
molto stanco. Quando ho visto la tenerezza con cui nil padre toccava le spalle del figlio più giovane e
lo teneva vicino al cuore, ho sentito profondamente di essere figlio perduto e ho desiderato tornare,
come lui, per essere abbracciato in tal modo.
26
In relazione col figlio maggiore
La seconda fase nel mio viaggio spirituale ebbe inizio una sera mentre parlavo del dipinto di
Rembrandt con Bart Gavigan, un amico inglese che nell’ultimo anno aveva avuto modo di conoscermi
molto bene. Mentre spiegavo a Bart quanto fossi riuscito a identificarmi col figlio più giovane, lui mi
guardò intensamente e mi disse: Mi chiedo invece se tu non sia piuttosto come il figlio maggiore.
Nella mia famiglia sono davvero il figlio maggiore sempre ligio al dovere, a sei anni già volevo farmi
prete e non ho mai cambiato idea. Sono sempre stato obbediente ai miei genitori, insegnanti, vescovi e
al mio Dio. Non sono mai scappato di casa, non ho mai sprecato il mio tempo e il mio denaro nella
ricerca del piacere e no mi sono mai perduto in dissipazioni e ubriachezze.
Immergendomi nel figlio maggiore della parabola ho visto la mia gelosia, la mia rabbia, la mia
permalosità., il mio astio e soprattutto la sottile convinzione di essere sempre nel giusto. Ho visto
quando mi lamentavo e quanto i miei pensieri e sentimenti fossero rosi dal risentimento.
Ero il figlio maggiore, ma perduto come il figlio minore, anche se ero rimato a “casa” tutta la vita non
avevo gustato pienamente la gioia di essere a casa.
Nei mesi successivi alla celebrazione del XXX anniversario della mia ordinazione sacerdotale entrai
gradualmente in notti interiori molto oscure e cominciai a sperimentare un’immensa angoscia
spirituale.
Trovai conforto nel leggere la tormentata vita del pittore olandese e nel conoscere l’itinerario
straziante che, alla fine, lo rese capace di dipingere questa opera sublime.
In relazione col Padre buono
La terza fase fu segnata dalle parole lapidarie di una sua amica - Sue Mosteller - che gli disse: “Che tu
sia il figlio più giovane o il figlio maggiore, ti devi render conto di essere chiamato a diventare
padre”.
Cito Nouwen: “Le sue parole furono mi colpirono come un fulmine perché, dopo tutti gli anni che ero
vissuto con il dipinto e avevo guardato l’uomo anziano stringere il figlio, non mi era mai passato per
la mente che fosse il padre ad esprimere più pienamente la mia vocazione nella vita…Hai cercato
amici per tutta la vita, hai desiderato ardentemente affetto da quando ti conosco”.
Essere un padre che può accogliere con calore i propri figli senza far loro alcuna domanda e senza
27
volere niente in cambio.
Non abbiamo bisogno di te come un buon amico e nemmeno come un fratello generoso. Abbiamo
bisogno di te come un padre.
28
Conclusione
Correlazione tra direzione spirituale e psicologia
Giunge momentaneamente a termine il viaggio a tre tappe che Henri attraverso i suoi scritti, e le
testimonianze su di lui, ci hanno permesso di intraprendere:
dall’isolamento alla solitudine, dall’ostilità all’ospitalità, dall’illusione alla preghiera, avendo come
apice - di questo percorso graduale e crescente - l’abbraccio benedicente.
Nouwen, riconoscendosi guaritore ferito, è capace di un abbraccio paterno e materno perché ha
sperimentato il dolore della ferita e il gaudio sanante dell’abbraccio del Padre.
Facendo un’analisi critica degli scritti studiati, a mio avviso, Henri sottolinea troppo la drammaticità
della realtà, in altri termini, seziona come un chirurgo le tenebre e tratta la luce, il tanto bene che il
Sommo Bene continuamente semina nei solchi della nostra vita, da pittore smemorato.
Mi si potrebbe obiettare che i tre moti - che in Nouwen dicono la vita spirituale - hanno un dinamismo
dal negativo al positivo.
Ma il positivo è solo auspicato non è tanto un dato di fatto, inoltre, a sostenere la mia tesi, vi è
l’avverbio di frequenza “sovente” che come una sorta di ritornello, di appuntamento prenotato,
puntualmente annuncia - come l’allarme di un appartamento scassinato - la drammaticità che l’uomo
vive.
Tutto ciò sovente rimbomba, e a volte stona, nella mente del lettore.
I riferimenti biblici sono rarissimi, nel nostro percorso solo parlando dell’ospitalità evincono nel giusto
modo. Non è un fatto di poco conto visto che, il nostro autore scrive testi di spiritualità, e la spiritualità
è vita nello Spirito che ha come linfa vitale la Parola di Dio.
Nouwen fa del rapporto teologia - psicologia, da dottore in teologia e da psicologo, il suo cavallo di
battaglia.
L’aver unito le due discipline è certamente un vantaggio e un merito per evitare di essere autoreferenziali e lo stile di apertura è lo stile di Gesù, che siede con i peccatori e va in cerca della pecorella
smarrita; se non avessimo questa apertura non saremmo Chiesa bensì setta.
Quindi l’interazione tra le due discipline è necessaria.
29
Vi sono dei punti d’incontro e di competenza tra lo psicologo e la guida spirituale, entrambi usano lo
stesso strumento della parola e della relazione per svolgere il proprio ruolo, ma possiedono
caratteristiche diverse.
I due campi devono collaborare, ma non devono confondersi l’un l’altro come a volte avviene in
Nouwen.
Dalla mia lettura, nei testi di Henri non si vede sempre il confine e anche se sono testi di spiritualità cosa innegabile - marca troppo la mano sulla psicologia, a volte sposta nel campo psicologico ciò che è
prettamente teologico, e parla con naturalezza di processi psicologici pur senza nominarli tali.
Dunque gli obiettivi delle due discipline sono diversi:
-
per la psicologia è aiutare la persona a funzionare correttamente a livello psichico nella
relazione con sé e con gli altri;
-
per la religione sta nel favorire la persona ad aprirsi all’esperienza del trascendente e alla
ricerca di senso nella propria vita.
Il rapporto tra gli interlocutori è diverso:
-
nella psicologia il servizio richiesto dal cliente al medico è retribuito;
-
il direttore spirituale offre il suo tempo nella fraternità e quindi gratuitamente.
I tipi di relazioni sono diversi:
-
nell’ambito psicologico è “a due” tra lo psicologo e chi chiede il suo aiuto;
-
nell’ambito teologico è “a tre” in quanto sia la persona che chiede aiuto, sia l’operatore hanno
come riferimento il Trascendente.
Certamente quando la guida spirituale intraprende il suo servizio pastorale di ascolto e
accompagnamento spirituale entra nell’ambito psichicologico.
La stessa cosa dovrebbe accadere in un sano accompagnamento psicologico (cosa che raramente
avviene).
30
Se non si distinguono i due ambiti succede che:
si domanda alla guida spirituale la soluzione di problematiche che non sono di sua competenza,
sofferenze psichiche, psichiatriche, spesso comunicate al confessore o al sacerdote.
Similmente si carica di significato religioso problemi e sofferenze legate al vissuto psicologico malato.
E’ doveroso in questi casi che l’operatore pastorale attento, aiuti queste persone a rivolgersi alla
competenza dello psicologo o della psichiatra.
Così come può accadere che allo psicologo, vengono poste domande di natura essenzialmente spirituali
e parimenti è doveroso per lo psicologo rivolgersi all’operatore pastorale competente.
A conclusione auspico che si lavori in equipe, ricercando l’inter-disciplinarietà capace di co-agire in
vista della crescita ed equilibrio della totalità della persona e non solamente di un polo.
Si possa cooperare in sinergia al fine di aiutare l’uomo a recuperare tutte quelle necessarie dimensioni
che atrofizzate portano solo a squilibri e dunque a sofferenza.
31
Sommario
Cenni biografici
Introduzione ai tre movimenti della vita spirituale
Primo movimento: dall’isolamento alla solitudine (Relazione con se stessi)
La parola ai testimoni
Chi sono io?
- La tentazione del dubbio su chi sei veramente
- La tentazione di sentirsi sotto pressione
- Siete i figli diletti di Dio
Secondo movimento: dall’ostilità all’ospitalità (Relazione con gli altri)
La parola ai testimoni
Chi sono gli altri per me?
- Reciprocità nel ministero
- Gratitudine e compassione
- Abbassamento volontario
Terzo movimento: dall’illusione alla preghiera (Relazione con l’Altro - Dio)
La parola ai testimoni
Chi è Dio per me?
- La preghiera: un grido a Dio
- La preghiera come Dialogo
- La preghiera come contemplazione
Climax: L’abbraccio benedicente
- In relazione col figlio minore
- In relazione col figlio maggiore
- In relazione col Padre
Conclusione
Correlazione tra direzione spirituale e psicologia
32