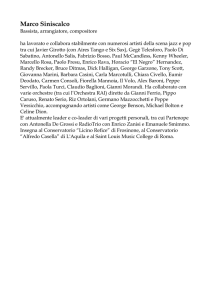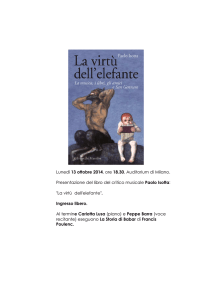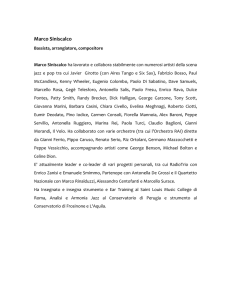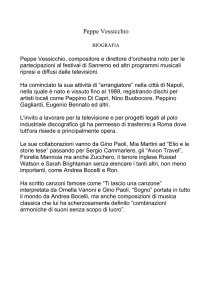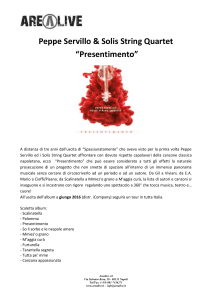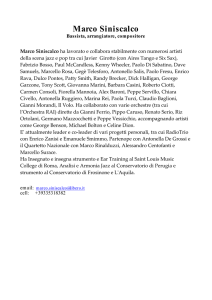Don Peppe D’Emilio
Seduto a un tavolino del bar Scardillo don Peppe Dǽ Migghiǽ esercitava la nobile arte dello
scrivano, resa celebre da Totò nell’Oro di Napoli. Scriveva e leggeva lettere, istanze, compilava
moduli: all’aperto, quando era bel tempo, o nel bar quando era maltempo, commentando e
spiegando ad alta voce. La professione di don Peppe era pubblica e della privacy – parola allora
sconosciuta - non importava nulla agli stessi interessati. I signori del paese lo chiamavano don
Peppe D’Emilio, affettavano di frequentarlo alla pari, ma tenendo le distanze, infatti lo chiamavano
don Peppe e mai Peppe o Peppino. Solo tra veramente pari si toglie il don.
Il lavoro era tanto: lettere da scrivere o da leggere, in partenza e in arrivo a o da soldati sui vari
fronti delle varie guerre, a o da emigranti di prima e dopo la seconda guerra mondiale in ogni
angolo del mondo, a o da carcerati. Le prestazioni di don Peppe non avevano tariffa e non era
neanche obbligatorio pagarle. Gli si dava quello che si poteva, quello che la coscienza dettava,
generosa al massimo che la miseria consentiva. Intascava il liberale compenso e dalla stessa tasca
estraeva una sigaretta, che accendeva al mozzicone della sigaretta precedentemente fumata,
consunto fino a totale consunzione, stretto tra lunghe unghie giallomarrone, che, bruciando,
crepitavano. Regolandosi sull’entità degli incassi, ordinava ogni tanto un caffè, che a fine giornata
non si contavano.
Alloggiava in un locale della Badia, messogli gratuitamente a disposizione da don Rocchino
Benevento rettore dell’antica piccola chiesetta.
La vita di don Peppe era un leggendario mistero. Il suo cognome era conosciuto solo nella forma
dialettale Dǽ Migghiǽ e la traduzione D’Emilio è stata una libera interpretazione del dialetto degli
abitanti della piazza e dintorni, che davano vita a una orrenda lingua illudendosi di elevarsi dal puro
dialetto dei due quartieri d’origine araba: la Rabata e la Saracena.
Don Peppe capitò a Tricarico da non si sa dove. La leggenda lo voleva ultimo rampollo di una
ignota famiglia principesca o giù di lì, di Stigliano o di San Mauro Forte o di chi sa dove. Si
favoleggiava di smisurate ricchezze sperperate al gioco e con le donne, di una sua profonda e vasta
cultura, di una brillante carriera come ufficiale di cavalleria, dei suoi pranzi con posate e stoviglie
d’oro serviti da stuoli di camerieri con la sciammerica.
Il Magazine del Corriere della Sera La Lettura dell’11 marzo 2012, mi induce a congetturare –
bisogna pur ancorare la leggenda a qualcosa di concreto! - che don Peppe fosse un rampollo per
dispersi rami della nobile famiglia de Mabilia di Irsina, una volta Montepoloso, paese che domina la
valle del Bradano e guarda in faccia Tricarico. I montepelosani cambiarono il nome del paese, che
non aveva nulla di peloso ma doveva quel peloso al greco ploùsos, che significa terra fertile e ricca,
e lo chiamarono Irsina dal vicino monte Irsi. Pare con scarso successo, considerato che gli abitanti
stentano a farsi chiamare irsinesi e restano montepelosani.
Il Magazine del maggiore quotidiano italiano, dunque, dava la strabiliante notizia che la statua in
pietra di Santa Eufemia nella cattedrale di Irsina fosse opera di Andrea Mantegna. Tutto comincia a
Padova dove un prete di Montepeloso, don Roberto De Mabilia, esercitò la professione di notaio e
nel 1454 fece dono alla cattedrale del suo paese di alcune pregevolissime opere d’arte, tra cui due di
Mantegna. La scoperta fu conosciuta prima dagli inglesi attraverso il quotidiano «The Guardian» e
poi dagli italiani attraverso la mostra «La scultura al tempo di Andrea Mantegna» curata da Vittorio
Sgarbi nel 2006, a Mantova, città natale del grande artista.
Don Peppe talvolta comiziava dalla cappella di San Pancrazio. Non parteggiava per questa o per
quella parte, ma continuava sotto altra forma la sua opera di scrivano, mettendo a disposizione del
popolo la sua antica cultura, per dare consigli, in nome del popolo, alle massime autorità dello
Stato. «Amici» o «Compagni» o «Cittadini» non erano gli appellativi con cui iniziavano i suoi
comizi. Egli aveva un unico cumulativo appellativo: «On. Signor Presidente della Repubblica, On.
Signor Presidente della Camera dei Deputati, On. Signor Presidente del Senato, On. Signor
Presidente del Consiglio dei Ministri», quindi si inchinava verso l’avv. De Maria, che stava ad
ascoltarlo, divertendosi un mondo, e faceva seguire con enfasi l’ultimo e più solenne appellativo:
«Maestro!».
«Bisogna vincere la miseria e donare benessere a tutto il popolo – comiziava con voce impostata e
solenne -. Non ci vuole tanto: basta dare uno stipendio sufficiente a tutti. Si obietta che mancano i
soldi. E io a mia volta obietto: - Ma chi stampa questi benedetti soldi? Li stampa lo Stato! E, allora,
per quale malvagia volontà lo Stato non stampa tanti soldi quanti occorrono?»
Avevano tutti questa logica stringente i comizi di don Peppe, ai quali i vari governi non hanno mai
dato soddisfazione. Ma a don Peppe bastava e avanzava l’applauso dell’avv. De Maria.