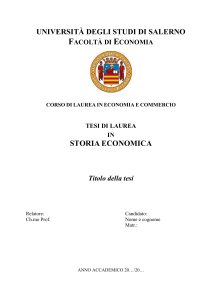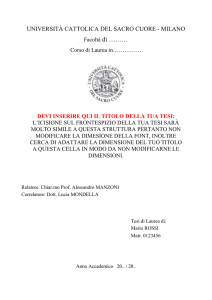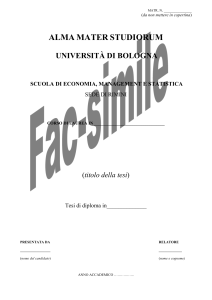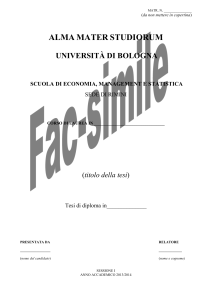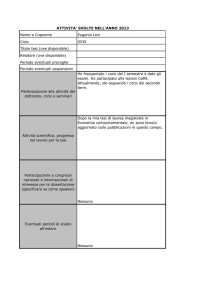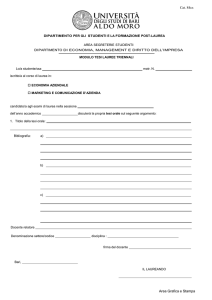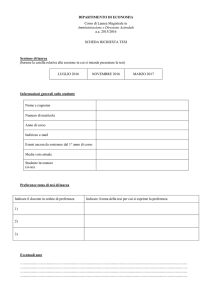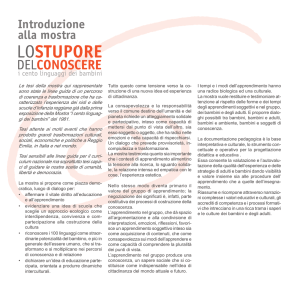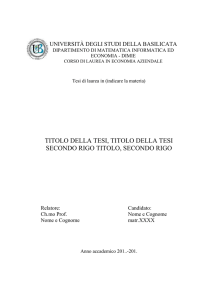Nota Metodologica PRIN 2008:
“La qualità dell’argomentazione pubblica: discorsi, pratiche, istituzioni”
Una rivisitazione del modello di S. Toulmin
per l’analisi dell’argomentazione1
F. CORRADI
Premessa
L’intenzione di “rivisitare” alcuni elementi e aspetti del modello proposto da S.
Toulmin per l’analisi dell’argomentazione non è frutto di ambizioni
astrattamente teoriche, ma è un’esigenza metodologica emersa nella pratica di
analisi empirica, ben presto segnata da difficoltà non immediatamente
risolvibili rifacendosi al semplice (e unico) esempio proposto dall’autore per
illustrare il suo schema di analisi2. Di fronte alle prime incertezze
nell’applicazione del modello, anziché abbandonarlo completamente o in
alternativa procedere a una qualche sua sbrigativa semplificazione (di cui è
facile trovare esempi nella gran messe di studi che ne hanno fatto uso 3), si è
invece deciso di provare a riesaminarlo in termini analitici e di specificarlo ove
necessario, senza timore di renderlo eventualmente più complesso.
A incentivare tale riesame è stata non solo la convinzione che il modello di
Toulmin fosse adatto ad analizzare discorsi politici, ma anche e soprattutto
l’idea – rivelatasi poi fattibile – che la sua applicazione avrebbe permesso una
valutazione della ricchezza argomentativa di un discorso a partire da rilevazioni
di natura quantitativa. Se infatti si ammette che tra le proprietà positive, o le
virtù, di un discorso politico – verità, coerenza, correttezza logica, assenza di
fallacie, consapevolezza e tolleranza dell’ambivalenza… – vi sia anche la
ricchezza argomentativa, non sarà sufficiente disporre di una definizione che si
limiti a identificare genericamente tale ricchezza con la quantità di “argomenti”
portati a sostegno di certe tesi o posizioni espresse, ma bisognerà disporre di
una definizione più articolata, capace di distinguere tra diversi livelli di
argomentazione.
A questo scopo il modello di Toulmin appare particolarmente adatto,
perché permette non solo di ricostruire l’anatomia di qualsiasi argomentazione,
ma anche di contare quante “parti” della struttura argomentativa siano esibite
dall’oratore (o dallo scrivente) oltre alle tesi stesse (e loro eventuali
specificazioni), ossia di conteggiare quante “garanzie” (il termine con cui è di
solito tradotta la nozione di “warrant”) siano esplicitate, quante informazioni
(dati) siano portate a supporto delle tesi e quante a supporto delle garanzie.
Prima versione provvisoria 2010, revisione definitiva 2011.
Per una sintetica descrizione del modello di Toulmin si veda la scheda allegata.
3 Cfr. per esempio, R.P. Hart, On Applying Toulmin: The Analysis of Practical Discourse, in
Explorations in Rhetorical Criticism, (Ed.) G.P. Morhmann, C.J. Stewart, D.J. Ochs, The
Pennsylvania State University Press, University Park and London, 1973, pp. 75-95. Hart
considera unicamente tre elementi del modello di Toulmin (claim, data e warrant), evita di
ricostruire passo per passo l’argomentazione enumerandone tutte le tesi, riporta solo la tesi di
fondo dell’oratore ed elenca i data e i warrants “principali”, ossia quelli che egli ritiene possano
essere ragionevolmente considerati tali dall’uditorio. Tale selezione appare quantomeno
discutibile.
1
2
1
Inoltre, il modello prevede altri elementi – backing, qualifier e rebuttal – che
costituiscono ulteriori indizi di ricchezza e il cui ruolo, come si dirà, non
necessariamente deve essere vincolato alla posizione strutturale loro assegnata
da Toulmin.
Senza dubbio, alla qualità di una argomentazione possono contribuire
anche aspetti che l’autore non prese in considerazione, per esempio, l’apertura
dialettica, intesa come la disponibilità dell’oratore a dare voce anche alle tesi
avversarie, e l’impegno dialettico, inteso come la prontezza a discutere le tesi
avversarie per accoglierle o rigettarle, in parte o completamente, sulla base di
dati ed eventualmente di garanzie esplicite, quindi in modo non apodittico. Un
ulteriore fattore di ricchezza può essere la presenza di figure retoriche, il cui
ruolo però andrà valutato caso per caso, tenendo presente, da un lato, che esse
possono assolvere varie funzioni all’interno di un discorso, oltre a quella
persuasiva (ad esempio una funzione estetica, mirante a conferire eleganza o
addirittura bellezza al “testo”), e, dall’altro, che non ogni intento persuasivo
realizzato mediante figure retoriche è a priori e necessariamente fallace o
addirittura “menzognero”, come già Perelman e Olbrechts-Tyteca avevano
sostenuto mentre indagavano le origini e gli effetti della svalutazione della
retorica4.
Prima di riesaminare il modello di Toulmin elemento per elemento, al fine
di adattarlo agli obiettivi delle nostre indagini, può essere utile contrapporlo a
un altro celebre modello, costruito non per l’analisi delle argomentazioni
politiche, ma per l’analisi della spiegazione scientifica5: il cosiddetto modello
nomologico-deduttivo, nella versione proposta da Hempel-Oppenheim6. Da
tale confronto emergeranno infatti importanti considerazioni in merito
all’anatomia, alla fisiologia e ai limiti del modello di Toulmin e probabilmente
appariranno più evidenti i vantaggi derivanti dalla sua applicazione.
1. Logica della spiegazione scientifica e logica dell’argomentazione
A dieci anni di distanza dalla pubblicazione di Studies in the Logic of Explanation,
il celebre saggio di Hempel e Oppenheim apparso nel 1948 sulla rivista
“Philosophy of Science”, e contemporaneamente alla pubblicazione del Traité
de l’argumentation di C. Perelman e Olbrechts-Tyteca (1958), S. Toulmin dà alle
stampe il suo libro The Uses of Arguments, in cui, come noto, propone un
modello per l’analisi dell’argomentazione costruito in aperta polemica con il
Cfr. C. Perelman e Olbrechts Tyteca, Logica e retorica (1952), in C. Perelman, Teoria e pratica
del’argomentazione, Antologia di scritti, Rubettino 2005, pp. 87-118; Cfr. anche C. Perelman e
Olbrechts Tyteca, (1958) Trattato sull’argomentazione. La nuova retorica, Einaudi 2001, p. 180 e ss.
5 Si noti che manca l’aggiunta “di tipo causale”. Ciò è dovuto al fatto che Hempel e
Oppenheim insistono molto, nel testo citato, sul fatto che la forma logica della spiegazione
nomologica deduttiva possa essere rintracciata anche nelle spiegazioni di tipo teleologico,
laddove tra le condizioni antecedenti siano posti i motivi o le ragioni dei soggetti.
6 Come ben noto, la prima formulazione del modello nomologico-deduttivo da parte di C.G.
Hempel risale al 1942, anno di pubblicazione del saggio The Function of General Laws in History,
apparso sul “Journal of Philosophy”. Qui si è preferito però fare riferimento al saggio
successivo, scritto nel 1948 con Oppenheim, perché Studies in the Logic of Explanation è
interamente dedicato al modello nomologico-deduttivo ed esso trova qui la sua più precisa
formalizzazione logica. Per un’analisi di The Function of General Laws in History, dove Hempel
tratta anche del modello probabilistico-induttivo, si rimanda a Von Wright, Comprensione e
spiegazione, Il Mulino, Bologna, pp. 29 e ss.
4
2
riduzionismo dei logici formali, portati a considerare necessariamente veritiera
(e completamente razionale) solo l’inferenza di tipo deduttivo, tipica del
sillogismo analitico/matematico (con premesse universali e conclusioni
logicamente implicite nelle premesse). Per differenza rispetto a tale paradigma,
Toulmin si impegna a costruire un modello per l’analisi di argomentazioni di
tipo “sostanziale”, ossia con conclusioni non logicamente implicite nelle
premesse, a partire dalla convinzione che la maggior parte delle argomentazioni
non sia riconducibile allo schema proposto dai logici – che procede more
geometrico – ma piuttosto a un diverso schema, capace di ammettere sia
inferenze deduttive di tipo statistico (quindi non strettamente “nomologiche”
nel senso Hempeliano7), sia inferenze induttive, di tipo statistico o “legiforme”
(con regole di connessione aspiranti alla generalità), il quale dovrebbe
procedere, secondo la sua espressione (forse un po’ riduttiva, date le ambizioni
di versatilità del suo modello), more giuridico 8.
La vis polemica che muove Toulmin (soprattutto) nelle prime cinquanta
pagine de Gli usi dell’argomentazione ottiene certamente l’effetto di persuadere
dell’originalità e dell’utilità di un nuovo modello per l’analisi delle
argomentazioni, diverso dal sillogismo analitico dei logici (che pure secondo
Toulmin non è privo di ambiguità, si veda scheda), ma nello stesso tempo
rischia di oscurare importanti affinità tra il nuovo modello proposto e il
modello nomologico-deduttivo, spesso associato al nome di Hempel, ma già
prefigurato, seppure non in termini formali, da Popper nel 19349.
Affinità
La prima, evidente affinità tra il modello di Hempel-Oppenheim e il modello di
Toulmin è che entrambi si applicano a enunciati: non direttamente a fatti, ma a
descrizioni verbali di fatti. Benché ciò possa apparire del tutto ovvio, dalla
natura proposizionale del contenuto dei modelli deriva una conseguenza
epistemologica molto rilevante (su cui infatti Hempel e Oppenheim insistono
molto nel loro testo): le questioni di verità (o in termini più formali
l’assegnazione di valori di verità), potranno essere risolte, in entrambi i modelli,
presupponendo un isomorfismo tra logica e realtà (che il linguaggio sarebbe in
grado di esibire); entrambi i modelli implicano perciò una teoria della verità come
corrispondenza tra linguaggio e mondo (una questione che qui non può essere
approfondita ulteriormente, ma che è comunque bene tenere presente)10.
La seconda affinità, meno evidente ma ben più importante per i fini della
presente nota metodologica, è rintracciabile nella definizione data da HempelOppenheim di explanans (ciò che spiega l’explanandum, il fatto o la legge11 da
Per una chiara disamina delle differenze tra spiegazione nonomologo-deduttiva e altri tipi di
spiegazione basati su inferenze Cfr. G. Boniolo e P. Vidali, Introduzione alla Filosofia della
Scienza, Campus, DATA, p. 122 e ss.
8 L’analogia giuridica porta Toulmin anche a proporre una nuova definizione di logica come
“giurisprudenza generalizzata”.
9 Cfr. K.Popper, La logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino, 1970.
10 Si noti che una teoria della verità come corrispondenza tra linguaggio e mondo è, da ultimo,
anche alla base del libro di F. D’Agostini, Verità avvelenata. Buoni e cattivi argomenti nel dibattito
pubblico, Bollati Boringhieri, 2010.
11 Solo di passaggio, si ricorda che il modello nonomologico-deduttivo è applicabile, secondo
Hempel-Oppenheim, anche a leggi.
7
3
spiegare). Come noto, nel modello nomologico-deduttivo esso è composto
non da un solo elemento, ma da due diversi elementi: le leggi generali (definite
anche “leggi di copertura”12) e le condizioni antecedenti. In tutti gli esempi
forniti dagli autori, le leggi generali sono (descrizioni verbali di) leggi fisiche
pertinenti al fenomeno da spiegare, le condizioni antecedenti sono (descrizioni
verbali di) “fatti” occorsi “immediatamente prima o nello stesso tempo” del
fenomeno da spiegare. Semplificando, e per ora senza tenere conto delle
quattro condizioni di adeguatezza13 che devono essere soddisfatte affinché il
modello conduca a una spiegazione scientifica valida, Hempel e Oppenheim
sostengono quindi che per spiegare un fenomeno occorrono condizioni
antecedenti e leggi generali sotto cui “sussumerlo”. L’affinità tra i due modelli è
dunque di carattere anatomico: infatti, i tre elementi di base del modello di
Toulmin – claim, data e warrant – rispecchiano piuttosto fedelmente i tre
elementi essenziali del modello di Hempel-Oppenheim: il claim corrisponde
all’explanandum, inteso però in senso ampio (ciò che deve essere spiegato o
argomentato, dimostrato vero o giusto, anche in senso morale), i data
assolvono (principalmente ma non esclusivamente, come si dirà) la funzione di
condizioni antecedenti, e i warrants, essendo regole o “garanzie” per “passare
dai data al claim” (o viceversa, come si preciserà in seguito), contengono
l’elemento normativo. A questo punto però iniziano a sorgere importanti
differenze tra i due modelli, di cui converrà trattare più diffusamente in
seguito.
La terza e ultima affinità tra i due modelli risiede nel riconoscimento di una
sorta di analogia tra spiegazione/argomentazione e previsione. Secondo
Hempel-Oppenheim, la forma logica del modello nomologico-deduttivo,
comprese le quattro condizioni di adeguatezza, “si applica alla previsione
scientifica esattamente come alla spiegazione. La differenza tra le due è di
carattere pragmatico”14. Per Toulmin, le previsioni sono buoni esempi di
argomentazioni sostanziali, e dunque certamente suscettibili di essere analizzate
mediante il suo modello; l’unica differenza tra previsioni e argomentazioni non
predittive, a suo avviso, è che nel caso delle previsioni si potrà tenere conto ex
post dell’esattezza/erroneità dei dati sulla base dei quali la previsione è stata
elaborata. Va però notato che il tipo di previsione a cui Hempel e Oppenheim
si riferiscono rimane di tipo strettamente deduttivo, mentre in Toulmin le
previsioni possono essere anche di tipo probabilistico-induttivo15.
Boniolo e Vidali precisano però che “non ogni spiegazione ricorrente a leggi di copertura è
una spiegazione nomologica deduttiva”. Infatti, i modelli statistici deduttivi e i modelli statistici
induttivi, che pure sono modelli a leggi di copertura, non sono modelli nomologico-deduttivi.
13 Di queste quattro condizioni di adeguatezza (di cui tre logiche e una empirica) si tratterà
successivamente. Non si farà invece riferimento al dibattito sul carattere di necessità e sul
carattere di sufficienza di tali condizioni, per cui si rimanda a Boniolo e Vidali, cit. p. 124 e ss.
14 Hempel e Oppenheim, cit. p. 138. Per esplicitare l’analogia gli autori rinominano in nota la
spiegazione “post-dictability” e la previsione “pre-dictability”.
15 La differenza è ben chiarita da Von Wright: “la funzione principale del modello nomologicodeduttivo è quella di spiegare perché certe cose sono accadute. Pertanto, esso ci dice anche, in
seconda istanza, perché ci si doveva aspettare queste cose. Potevamo aspettarcele, perché
dovevano accadere. Nel modello probabilistico-induttivo le funzioni sono invertite. Esso
spiega, in primo luogo, perché ci si doveva (o non ci si doveva) aspettare certe cose che sono
accadute. Solo secondariamente esso spiega perché quelle cose sono accadute e precisamente
perché esse erano altamente probabili. Mi sembra, tuttavia, preferibile evitare di dire che il
modello probabilistico-induttivo spiega ciò che accade, e limitarsi invece a dire che esso
12
4
Differenze
Le differenze che Toulmin stesso marca tra il proprio modello e il sillogismo
analitico riguardano innanzitutto la forma logica, ed esse possono essere colte
ugualmente bene dal confronto con il modello nomologico-deduttivo. La
forma logica del modello di Toulmin è diversa16 da quella del modello
nomologico-deduttivo perché non soddisfa la prima condizione di adeguatezza
logica del modello Hempel-Oppenheim, in base alla quale l’explanandum deve
essere una conseguenza logica dell’explanans, ovvero l’explanandum deve essere
logicamente deducibile dalle informazioni in quello contenute. Il modello di
Toulmin non soddisfa questo requisito perché si applica ad argomentazioni
“sostanziali”, che egli definisce anche come argomentazioni “la cui correttezza
può essere messa in discussione senza contraddizioni (di natura logica)”: in
altre parole, le tesi, in Toulmin, tipicamente aggiungono “qualcosa” che non
era logicamente deducibile né dai dati, né dalle garanzie, o da entrambi, oppure,
come anche immagina l’autore, “stabiliscono nuove garanzie” (come il modello
Hempel-Oppenheim può stabilire nuove leggi), senza però che tali “aggiunte”
siano derivabili in senso strettamente logico.
La principale differenza tra i due modelli, tuttavia, è contenuta
nell’elemento normativo che permette il passaggio dalle premesse alle
conclusioni. In Hempel-Oppenheim tale elemento normativo deve essere
(l’espressione verbale di) una legge generale (seconda condizione di
adeguatezza logica) dotata di contenuto empirico e come tale suscettibile di
essere verificata mediante l’osservazione (terza condizione di adeguatezza
logica)17. In Toulmin, l’elemento normativo è invece contenuto nel warrant, per
il quale, però, egli non pone alcuna specifica condizione di adeguatezza, né
logica, né empirica: egli ribadisce solo che il warrant deve essere un’asserzione de
jure, dotata di un preciso ruolo strutturale, cioè quello di fare da “ponte” tra i
dati e le tesi. Nell’unico esempio offerto da Toulmin per illustrare il suo
modello, il warrant è un’asserzione de jure derivante da leggi vigenti18; ma in
nessun luogo del suo testo l’autore afferma che il warrant debba
necessariamente contenere norme giuridiche, anzi in più occasioni sostiene che
sia “field-dependent” (legato al contesto) e aggiunge che – in generale, ma non
necessariamente – sia (ri)formulabile mediante proposizioni ipotetiche del tipo
“se…allora”. L’ambiguità intrinseca alla nozione di warrant, come si vedrà, ha
già sollecitato altri autori a individuarne possibili tipi.
giustifica certe aspettative e previsioni”. Cfr. Von Wright (1971), Spiegazione e comprensione, Il
Mulino, Bologna, 1977, p.33.
16 Solo di passaggio e per evitare fraintendimenti, si ricorda che la forma logica del modello di
Toulmin non può in alcun modo essere definita induttiva, unicamente per differenza rispetto al
modello nomologico-deduttivo, perché il modello di Toulmin ammette inferenze sia di tipo
induttivo sia deduttivo, e perché Toulmin stesso mette in guardia dall’impiego della coppia
induttivo/deduttivo per descrivere la forma logica del suo modello (si veda scheda).
17 Come è stato notato, la terza condizione di adeguatezza logica appare ridondante rispetto alle
prime due, ma la sua funzione è quella di prevenire la formulazione di ipotesi ad hoc.
18 S. Toulmin, Gli usi dell’argomentazione, p. 88. Harry è nato a Bermude (Data), dunque
presumibilmente Harry è un cittadino britannico (Claim), dato che un uomo nato nelle
Bermude è generalmente un cittadino britannico (Warrant), in base alle seguenti norme e leggi
…(Backing), a meno che entrambi i suoi genitori fossero stranieri (Rebuttal).
5
Un’ulteriore differenza tra la logica della spiegazione scientifica
formalizzata da Hempel e Oppenheim e la logica dell’argomentazione
analizzata da Toulmin risiede nel grado di attenzione al problema della verità
sostanziale della spiegazione o dell’argomentazione (una questione diversa da
quella prima sollevata in termini gnoseologici a proposito della teoria della
verità come corrispondenza). Nel testo di Hempel e Oppenheim il problema
della verità è esplicitamente discusso e trova espressione formale nella quarta
condizione di adeguatezza (empirica), in base alla quale “gli enunciati che
costituiscono l’explanans devono essere veri”. Siccome un modello di tipo
nomologico-deduttivo necessita di premesse universali vere per garantire la
verità delle conclusioni, la rilevanza accordata alla verità degli enunciati
contenuti nell’explanans non stupisce; in aggiunta, Hempel e Oppenheim
illustrano diffusamente le ragioni per cui, in quella formulazione del modello,
abbiano privilegiato la nozione di verità rispetto a quella di validità “fino a
prova contraria”, che di fatto contraddistingue la maggior parte delle leggi di
natura19. Sorprende invece che Toulmin non affronti analiticamente il
problema della verità delle tesi sostenute, per quanto esso emerga in relazione
alle previsioni, dove è riformulato in termini di correttezza, e per quanto si
mostri qua e là a proposito di altri elementi: si intravede a proposito dei data e
traspare nella discussione intorno ai qualifier (qualificatori) e ai rebuttal
(ricusazioni), che, se usati a proposito, possono attenuare i rischi di
generalizzazioni indebite. Esso non emerge invece in merito alla nozione di
warrant, dove però si prevede la possibilità che un enunciato fattuale (il backing)
sia impiegato per dissipare eventuali dubbi sulla legittimità della garanzia20.
Infine, è degno di nota che, mentre il modello di Hempel-Oppenheim
non permette alcuna variazione nella posizione dei suoi elementi (nemmeno, di
fatto, nel caso delle previsioni21), il modello di Toulmin si distingue per una
straordinaria mobilità delle sue parti: la tesi può essere prima espressa e poi
argomentata, o viceversa22, può essere accompagnata da più warrants seguiti dai
dati o anticipati dai dati, più tesi possono essere giustapposte in sequenza, e poi
essere supportate da un unico warrant posizionalmente lontano o da un backing
esplicito (con warrant implicito) oppure viceversa. Sebbene tale mobilità possa
talvolta rendere complessa l’operazione di suddivisione di un’intera
Cfr, Hempel-Oppenheim, cit. pp.137-138.
Questa reticenza ad affrontare il problema, tanto più strana se si rammenta l’analogia
giuridica che ispira Toulmin, non sembra spiegabile a partire dal fatto che egli estenda il
dominio dell’argomentazione ben oltre la spiegazione scientifica (fino a includere la morale, la
filosofia, l’estetica…). Piuttosto, l’interesse per il “funzionamento” e la “forza” di
un’argomentazione, anziché per la verità sostanziale delle tesi di volta in volta sostenute,
sembra connesso al background pragmatista dell’autore.
21 Infatti anche nelle previsioni le leggi generali e le condizioni antecedenti sono date (given) e
l’explanandum (in questo caso, il fatto previsto) è derivato prima dell’occorrenza del
fenomeno. Cfr. Hempel-Oppenheim, p. 138.
22 Quando il warrant e i dati sono enunciati prima della tesi (la quale si presenta così nella veste
di conclusione) essi occupano formalmente la posizione dell’explanans, ma la similitudine
posizionale con il modello nomologico-deduttivo non garantisce affatto, da sola, che la forma
logica dell’argomentazione sia di quel tipo (ciò dipenderà, infatti, dal tipo di regola che è
contenuta nel warrant, dal carattere necessario e sufficiente dei dati e dalla correttezza logica
con cui, nella tesi, si deducono le conseguenze della presenza congiunta del warrant e dei dati).
Sulla possibilità che in un’argomentazione non scientifica possa inserirsi un ragionamento di
tipo causale si veda anche in seguito la voce “warrant”.
19
20
6
argomentazione in argomenti, essa non è realmente d’ostacolo al
riconoscimento delle singole parti del modello, a patto che le loro specifiche
funzioni siano chiare e distinte.
Da questo pur sommario confronto tra i due modelli, dovrebbe essere
emerso che i limiti del modello di Toulmin – in particolare, l’assenza di
specifiche condizioni di adeguatezza logica ed empirica e l’indeterminatezza di
alcuni elementi – essendo sufficientemente controbilanciati da una struttura
dotata di una chiara “divisione del lavoro” tra le parti, accrescono la duttilità
del modello, e permettono anche di apportarvi modifiche senza alterarne la
fisiologia. La possibilità di riconoscere immediatamente il modello di Toulmin,
dopo che sia stato modificato, risiederà perciò non tanto o non solo nel fatto
che tutti i diversi elementi siano utilizzati (conservandone o meno le
denominazioni), quanto piuttosto nel fatto che essi, mantenendo il ruolo
strutturale originario, anche se non la posizione, siano ancora in grado di
mostrare se e come “funziona” un’argomentazione, realizzando il fine per cui il
modello è stato concepito.
Sarà ora nostro compito proporre specificazioni e trasformazioni che
rendano il modello ancora più adatto ad analizzare la complessità e la ricchezza
di argomentazioni politiche pronunziate in occasioni solenni (in cui si ipotizza
che l’autore del discorso profonda massimo impegno argomentativo). Per dare
un ordine alla nostra rivisitazione analitica, si riuniranno i sei elementi che
compongono il modello di Toulmin in due triadi, la prima composta dagli
elementi basilari o fondamentali (senza cui non vi è argomentazione) e la
seconda dagli elementi “accessori”.
2. I basilari: claim, data e warrant
Claim (C), data (D) e warrant (W) costituiscono lo schema basilare di
un’argomentazione e le loro relazioni possono essere rappresentate
graficamente come segue23:
Data
Claim
Warrant
Dire che questa triade costituisce lo schema basilare di un’argomentazione
non implica che tutti gli elementi debbano necessariamente essere espressi:
anche il semplice proferimento di una tesi può ammettere l’applicazione del
modello, a patto, però, che la tesi proferita contenga almeno un warrant
implicito o un dato esplicito. Invece tesi espresse senza l’aggiunta di dati e
senza warrant espliciti, né warrant impliciti individuabili con una certa
sicurezza, sono tipicamente apodittiche24.
Il warrant, collocato graficamente a un livello più basso solo per chiarezza , di fatto è la linea
tratteggiata che connette data e claim.
24 L’analisi dei testi, comunque, dimostra che, se un discorso è dotato di una certa coerenza
interna, tale per cui le tesi di fatto si richiamano tra loro e si sostengono reciprocamente, una
23
7
Claim/tesi
Il claim – o tesi, come per ora intendiamo tradurre questa nozione25 –,
rispondendo alla domanda: “cosa vuoi sostenere/affermare?”, è il primo
elemento basilare del modello, la cui presenza (anche se non in posizione
iniziale) è indispensabile non solo per l’analisi dell’argomentazione, ma per dare
vita a qualunque argomentazione. Da questo primo elemento occorre dunque
iniziare la nostra rivisitazione analitica.
Anzitutto, la scelta di tradurre “claim” con “tesi” (o con “affermazione”),
anziché, come d’uso, con il termine “pretesa”, deve essere giustificata. “Claim”
deriva dal verbo “to claim”, il cui primo significato in inglese è “rivendicare un
diritto” (la scelta lessicale di Toulmin è quindi coerente con l’intenzione di
proporre un modello plasmato sull’argomentazione di tipo giuridico).
“Pretendere” (sulla base di un diritto), di conseguenza, è la traduzione più
fedele di “to claim”. Tuttavia, l’ambizione di Toulmin di fornire un modello di
analisi applicabile a tutti i tipi di argomentazione sostanziale (non solo di tipo
giuridico) invita a disancorare il claim dal suo intrinseco riferimento al diritto,
pur offrendone una traduzione che ne rispetti il ruolo, entro il modello. Dal
momento che il claim è ciò che deve essere dimostrato vero o giusto, e può
trovarsi sia in posizione di premessa, sia in posizione di conclusione – senza che ciò
ne modifichi il ruolo – la parola “tesi” (o “affermazione”) sembra più adatta
della parola “pretesa” (e senz’altro più adatta di “premessa”) a comunicare
questo ruolo strutturale; inoltre, l’abbandono del termine “pretesa” manifesta la
nostra intenzione di non predeterminare il tipo di garanzia legittimo,
ammettendo così warrants legali-razionali nel senso più ampio, non solo di tipo
strettamente giuridico (si veda la voce “warrant”).
Questa scelta terminologica non riduce, ma semmai accentua, la necessità
di riconoscere che vi siano diversi tipi di tesi. In precedenza, più sulla base di
uno sforzo di immaginazione teorica che confrontandosi con le concrete
difficoltà dell’analisi empirica, si era giunti a concludere – e ciò aveva riscosso
un certo consenso – che vi fossero almeno tre diversi tipi di tesi: tesi fattuali,
tesi normative, e tesi affermanti qualche genere di relazione tra fatti. Questa
iniziale classificazione, però, adesso mal si concilia con un’analisi più attenta del
modello, in particolare con il riconoscimento che in Toulmin sia il warrant la
sede della regola – di diversi tipi di regole, come si dirà – per connettere tesi e
dati: se quindi ammettessimo che le tesi contengano anche regole di
connessione tra fatti, rischieremmo di confondere l’explanandum con (una
parte del) l’explanans, oppure di considerare il warrant un tipo di claim (ciò
può anche essere in un certo senso corretto, ma solo se l’oratore vuole
dimostrare la validità di una nuova garanzia a partire da una garanzia già
consolidata).
Per specificare la nozione di tesi e proporne una classificazione, quindi, è
sembrato opportuno ripartire dalla distinzione, già presente in Toulmin, tra
asserzioni de facto e asserzioni de jure (che egli mette in campo per chiarire la
differenza tra data e warrants). Le affermazioni fattuali possono avere (almeno)
affermazione apparentemente apodittica (senza dati e senza warrants) può non essere
realmente tale. Per alcuni esempi, si veda l’analisi del discorso di Obama.
25 Una traduzione alternativa potrebbe essere “affermazione”.
8
due diversi “riferimenti”, mondo e sé: distingueremo così innanzitutto tra
asserzioni su stati del mondo e asserzioni su stati di coscienza, che chiameremo
rispettivamente tesi di tipo [M] e tesi di tipo [S]. Le prime sono tipicamente
suscettibili di essere sottoposte a verifica empirica, mentre le seconde possono
esserlo, ma solo in certe particolari condizioni.
Accogliendo per il momento la proposta di H. Putnam26, secondo cui le
asserzioni valutative possono essere agilmente “tradotte” in asserzioni di fatto,
considereremo provvisoriamente le valutazioni, a seconda del loro riferimento,
come tesi di tipo M o tesi di tipo S, senza per ora distinguere questi due tipi in
ulteriori sottotipi27(avremo però cura di segnalare in nota il criterio di
valutazione sottostante al giudizio).
A questi due tipi di tesi, poi, ne è stato aggiunto un terzo, quando si è
constatato che i testi analizzati fossero ricchi di affermazioni relative ad azioni
da intraprendere o ad atteggiamenti da tenere, esprimenti dunque non stati di
cose già realizzati, ma ancora da realizzare: provissoriamente, quindi, in attesa
di capire se questo tipo di tesi (de jure) debba rimanere distinto dagli altri tipi o
esservi in qualche modo assimilato, si è stabilito di chiamare normative [N] tesi
affermanti proposte di policies o esortazioni generalizzate a realizzare certi
valori.
Infine, avendo visto che talvolta gli oratori interpongono nei loro discorsi
affermazioni atte a esibire l’ordine espositivo, o a rivelare la struttura interna
della loro argomentazione, è sembrato utile aggiungere un quarto tipo di tesi,
che chiameremo di tipo[O]: si tratta di tesi di ordinamento, che generalmente
non necessitano di essere argomentate (ma che comunque sono indizio di una
certa attenzione da parte dell’oratore nei confronti della chiarezza espositiva) .
Deve comunque essere noto che le riflessioni intorno a possibili
classificazioni delle tesi28 hanno sollecitato una riflessione sul modo in cui il
claim veniva inizialmente identificato, ossia senza attuare alcuna parafrasi,
semplicemente riportando le parole originali. Questo metodo, per quanto
avesse certamente il pregio di tributare massima fedeltà al testo, si è rivelato
poco analitico, perché in molti casi portava a considerare parte della tesi anche
altri elementi del modello, non soltanto qualifiers (avverbi come generalmente,
H. Putnam, Fatto/valore. Fine di una dicotomia e altri saggi, Fazi Editore, 2004.
In realtà, un tentativo in questa direzione è già stato fatto, mediante la distinzione tra
descrizioni e volizioni. Tuttavia, ben presto è risultato chiaro che la tipologia risultante non
fosse di agile applicazione.
28 Una possibile classificazione alternativa è rappresentata dalla tipologia dei giudizi di Searle
(La costruzione della realtà sociale, pp. 12-15), costruita mediante due variabili dicotomiche:
soggettivo/oggettivo e ontologico/epistemico. Sebbene l’opportunità di applicare questa
tipologia debba ancora essere valutata più attentamente, la prima impressione è che essa non
sia molto adatta a livello di giudizi normativi. Un’altra proposta di classificazione meritevole di
essere considerata è quella di Fulkserson, il quale suggerisce di distinguere quattro tipi di tesi:
tesi fattuali, tesi valutative, tesi contenenti definizioni, tesi contenenti policies (Cfr. R.
Fulkerson, The Toulmin Model of argument and the teaching of composition, in E. Barbara, P Resch, D.
Tenney, Argument revisited: argument redefined, Tousand Oaks, CA, Sage, pp. 45-72). L’aspetto più
interessante di questa classificazione riguarda il quarto tipo di tesi, ossia le tesi contenenti
policies, di cui, in effetti, è facile riscontrare innumerevoli esempi nei discorsi analizzati.
Tuttavia, anche questa classificazione presenta per noi dei limiti: distingue tra tesi fattuali e tesi
valutative (mentre Putnam considera le affermazioni valutative agilmente traducibili in tesi
fattuali) e confonde le tesi contenenti definizioni con un particolare uso dei dati (si veda
seguito).
26
27
9
presumibilmente…) e rebuttals (recusazioni: a meno che, con l’eccezione di…),
che Toulmin assegna unicamente alle tesi (su questo punto si veda
seguito).Così, ci si è accorti che le tesi sono spesso specificate o precisate in
modo non puramente avverbiale, ma con l’aggiunta di qualche informazione
fattuale (si tratta, evidentemente, di una funzione dei data che Toulmin non
aveva preventivato). Noi chiameremo le informazioni aggiuntive o i dati posti a
corollario delle tesi non con un nome radicalmente diverso, ma più
semplicemente {Dc} (dati che specificano le tesi), per distinguerli da un altro
uso dei dati, che verrà discusso nel prossimo paragrafo29.
Data/dati
I data sono, nel modello di Toulmin, asserzioni di fatto che dovrebbero essere
comunemente note, o verificabili da chiunque sia interessato a verificarli. Per
quanto Toulmin preveda che i dati possano presentarsi in diverse forme
(statistiche, casistiche, esempi, aneddoti, storie personali…), egli assegna loro
un ruolo strutturale poco definito, tanto che molti suoi commentatori hanno
tradotto la nozione di data con quella di grounds, che indica in modo ancora più
generico “le prove” o “i supporti” a sostegno delle tesi (con il rischio, tra
l’altro, di confondere il ruolo strutturale di data e warrants).
Essendo i dati indubbiamente elementi di ricchezza di un discorso, occorre
quindi tentare di precisare i loro possibili usi. Uno di questi è già stato
menzionato alla voce “claim”: essi possono sostenere, specificare o precisare la
tesi {Dc}. Queste diverse funzioni delle informazioni che accompagnano le tesi
meritano tuttavia ulteriori precisazioni: in alcuni casi le informazioni
ribadiscono, riformulano o specificano le tesi, in altre le supportano mediante
informazioni aggiuntive e collaterali. La distinzione può essere meglio percepita
rifacendosi al ruolo degli antecedenti nel modello di Hempel-Oppenheim, di
cui Von Wright opportunamente sottolinea l’indipendenza logica rispetto alle
conclusioni. Classificheremo come data claim solo le informazioni logicamente
indipendenti dalla tesi che l’oratore intende argomentare.
Un altro possibile uso dei dati, che Toulmin aveva assegnato al backing (si
veda prossimo paragrafo), è il ruolo di sostegno del warrant: quando un oratore
esplicita la “regola” che crede giustificare la sua tesi può essere motivato a
mostrare che la regola impiegata è valida oppure pertinente e può avvalersi a
tale scopo di informazioni o esempi. Noi chiameremo questo uso dei data
{Dw} (dati a sostegno del warrant).
La nostra rivisitazione della nozione di “data” riguarda perciò
sostanzialmente due aspetti relativi all’uso dell’informazione. Da un lato, si
riconosce il fatto che non solo le tesi, ma anche le garanzie poggino su basi
fattuali, su informazioni che possono essere vere o false ed eventualmente
sottoposte a verifica (un’intuizione che già era in Toulmin, ma che il modello
A proposito delle tesi rimarrebbero da analizzare due ulteriori questioni: il loro eventuale
carattere implicito e i rapporti reciproci tra più tesi. La prima questione non è trattata da
Toulmin, il quale prevede che tutte le tesi siano esplicite, ma da altri autori che hanno
commentato e rivisto il modello di Toulmin (cfr. Fulkerson); la seconda potrà essere affrontata
quando altri strumenti concettuali (contraddizione, ambivalenza, ambiguità) saranno stati messi
a punto.
29
10
non riesce ad esibire immediatamente per l’ambiguità della nozione di
“backing”). Dall’altro, la nostra rivisitazione della nozione di “data” mira ad
ampliare i possibili usi dell’informazione ben al di là della funzione di diretto
supporto alle tesi o alle garanzie prevista da Toulmin: i dati possono essere
utilizzati per precisare o specificare le affermazioni e le garanzie, senza
costituirne necessariamente una “prova”.
Indipendentemente dai possibili usi dei dati, ad ogni modo, resta vero che
l’atto di presentarli espone l’oratore alla verifica, offre elementi agli eventuali
oppositori per screditare le tesi che egli, con quei dati, ha sostenuto. Per questo
motivo considereremo l’appello o il richiamo a dati tendenzialmente un fatto
positivo, salvo riservarci la possibilità di condannare la messa in campo di dati
palesemente falsi o distorti a fini persuasivi; non saremo allora semplicemente
critici, come verso una fallacia argomentativa, ma denunceremo un oltraggio
alla verità.
Warrant/garanzie
Ed eccoci al vero cuore del modello di Toulmin: il warrant, la garanzia, il suo
“dato che”. Espressione o traduzione, quest’ultima, ingannevole, perché anche
i dati possono ben essere tutti introdotti, senza forzatura, da un “dato che” (o
da un “infatti” se la tesi è espressa in posizione di premessa). Ma il warrant non
è un dato, perché, come dice Toulmin, è una asserzione de jure, e non de facto.
Ma ciò non basta ad esaurire e risolvere almeno due diverse questioni.
La prima è che ci sono tanti tipi di asserzioni de jure che possono essere
utilizzati in funzione di garanzie per attuare il passaggio dai dati alle tesi (o
viceversa): per esempio, norme giuridiche, le weberiane “regole di esperienza”,
i “sillogismi pratici” analizzati prima da Anscombe e poi da Von Wright30.
Proprio su questa questione i commentatori di Toulmin hanno profuso le
maggiori energie per specificare il modello originario. Qui basterà ricordare la
proposta di R. Fulkerson31, secondo cui vi sarebbero sei principali tipi di
warrants (facilmente memorizzabili mediante l’acronimo GASCAP):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Generalizzazione
Analogia
Sintomo/Indizio
Causalità
Autorità
Principio
L’aspetto più interessante della classificazione, ormai ampiamente diffusa e
consolidata nell’ambiente accademico anglosassone, è la previsione che per
ciascun tipo di garanzia possano darsi particolari fallacie. Per esempio, nel caso
Von Wright descrive in questi termini la nozione di sillogismo pratico: “la premessa
maggiore del sillogismo menziona una cosa a cui si aspira, o un fine dell’azione; la premessa
minore collega un’azione con questa cosa, all’incirca in una relazione mezzo-fine; la
conclusione, infine, consiste nell’uso di questo mezzo per ottenere il fine”. Così descritto, in
effetti, assomiglia, come sostiene Von Wright, a una spiegazione teleologica “rovesciata”. Cfr.
Von Wright, Spiegazione e comprensione, cit. p. 46-47.
31 Cfr. R. Fulkerson, cit. p. 60 e ss.
30
11
della causalità, che il warrant sia simil-causale, per via di una confusione tra
correlazione e causazione, o per l’applicazione del post hoc, ergo propter hoc.
Per quanto l’idea che le fallacie argomentative (di cui disponiamo un’ampia
rassegna tratta dal libro di F. D’Agostini) si annidino soprattutto nei warrants
sia certamente condivisibile, in questa fase della nostra analisi una
classificazione dei possibili tipi di garanzie non appare indispensabile per
valutare la ricchezza di una argomentazione; decisiva, invece, sembra un’altra
questione, ossia il carattere esplicito o implicito delle garanzie.
In termini puramente teorici, potremmo aspettarci che un’argomentazione
con molti warrants espliciti sia una argomentazione migliore di una con
warrant prevalentemente impliciti, perché l’oratore si impegna a mostrare “i
ponti” – da oltrepassare o da abbattere – per passare dai dati alle tesi: ma sarà
forse “cattiva” una argomentazione strutturata in modo tale che i warrants,
anche se per lo più impliciti, siano facilmente deducibili da quanto si dice? O
forse sarà cattiva una argomentazione che ha troppi warrants dubbi o
controvertibili, indipendentemente dal fatto che siano espliciti o impliciti? Per
provare a rispondere a queste domande, inizieremo a distinguere warrants
espliciti [E] e warrants impliciti [I], suddividendo entrambi i tipi in evidenti [e]
e dubbi [d]. Avremo poi cura di analizzare i warrants dubbi, dove è più
probabile che si nascondano le fallacie argomentative.
WARRANT
Esplicito
Implicito
Evidente
Ee
Ie
Dubbio
Ed
Id
WARRANT esplicito evidente: [Ee]
WARRANT esplicito dubbio: [Ed]
WARRANT implicito evidente: [Ie]
WARRANT implicito dubbio: [Id]
3. Gli “accessori”: backing, qualifier e rebuttal
La scelta di definire “accessoria” la traide costituita da backing (B), qualifier (Q) e
rebuttal (R) non è intesa a svalutare l’importanza di questi elementi, né
all’interno del modello di Toulmin, né per il nostro modello “rivisitato”. La
nozione di accessorio, invece, intende anzitutto comunicare l’idea – assente in
Toulmin – che questi elementi possano assolvere il loro ruolo strutturale
indipendentemente dalla posizione che si trovano a occupare. Ciò vale
certamente, come si spiegherà, per qualifier e rebuttal – che Toulmin assegna
posizionalmente solo alla tesi – ma anche per il backing, che Toulmin colloca
posizionalmente “sotto” al warrant, per evidenziarne il ruolo di
supporto/fondamento della garanzia. Tutti questi elementi possono essere poi
considerati “accessori” anche nel senso che un’argomentazione può
12
perfettamente “funzionare” senza che essi siano esibiti o impiegati: se si
presentano, però, l’argomentazione risulterà tendenzialmente più ricca.
Backing
Nel modello di Toulmin, il backing (B) è un’asserzione fattuale atta a sostenere
la legittimità della garanzia, o, come suggerisce il termine stesso, a “coprire le
spalle” al warrant, dissipando dubbi sulla sua validità. Esso avrebbe quindi,
almeno apparentemente, una chiara funzione strutturale. Stando però
all’esempio che Toulmin propone – dove il backing legittima il warrant
ricordando l’esistenza di leggi vigenti, da cui deriva la norma espressa nel
warrant32 – non risulta per nulla chiaro in cosa il backing di fatto si distingua da
un dato, se non per la diversa posizione rivestita nei due casi dall’asserzione
fattuale. Nel tentativo di conservare la nozione di backing, e di distinguerla da
quella di data warrant, da noi introdotta, si era pensato che il backing potesse
avvalorare il warrant appellandosi a un maggiore grado di generalità. A ben vedere,
però, la distinzione era fragile e malferma perché l’esistenza di certe leggi
vigenti rimane innanzitutto un fatto (un dato), non necessariamente più
generale. Per questo motivo si è deciso di eliminare il backing nel nostro
modello rivisitato.
Qualifier
Il qualifier (Q) in genere è un avverbio (per esempio, presumibilmente,
necessariamente, probabilmente, verosimilmente), o un’espressione (la maggior
parte, in alcuni casi…) mediante cui l’oratore attenua o precisa il significato
delle proprie affermazioni. In Toulmin, esso rappresenta le possibili traduzioni
lessicali dei quantificatori e dei qualificatori modali. Stranamente, però, egli
assegna i qualifiers solo alle tesi, mentre, come si sarà notato, un qualifier è
presente nel warrant del suo stesso esempio “(dato che) un uomo nato nelle
Bermude è generalmente un cittadino britannico (W)”. Non si vede dunque
perché limitare l’uso di qualificatori e quantificatori modali solo alle tesi. Perciò
noi considereremo la possibilità che qualifiers siano presenti anche nei warrants e
nei dati e tendenzialmente considereremo il loro uso come un indizio di
prudenza e/o di accortezza argomentativa.
Rebuttal
Il rebuttal o anche reservation (R) è in genere introdotto da espressioni come “a
meno che”, “con l’eccezione di”. La sua presenza associata a una tesi, in
Toulmin, segnala che l’oratore ammette eccezioni alla sua posizione,
anticipando obiezioni o contro-esempi. Anche in questo caso, non si vede
perché limitare la presenza di riserve alle tesi: molte regole (warrants)
ammettono eccezioni, e alcuni dati possono essere impiegati anche con riserva.
A proposito del rebuttal, alcuni commentatori di Toulmin hanno
ritenuto utile ampliarne l’area semantica fino a considerare rebuttals tre diversi
tipi di ricusazione: 1) concessione strategica: riconoscimento di alcuni meriti delle
“(dato che) un uomo nato nelle Bermude è generalmente un cittadino britannico (W), in
base alle seguenti norme e leggi …(B)”.
32
13
tesi avversarie; 2) refutazione: dimostrazione delle debolezze o delle conseguenze
implicite (negative) di un’argomentazione avversaria; 3) dimostrazione di
irrilevanza.
Dal momento che queste forme di ricusazione possono costituire essi stessi
“argomenti” complessi (dunque suscettibili di essere analizzati mediante il
modello), non accoglieremo completamente questa proposta (anche se avremo
cura di valutare l’apertura e l’impegno dialettico, come si è detto in premessa),
ma ne conserveremo comunque un aspetto, che già era stato notato nella
pratica di analisi: il fatto che il rebuttal si presenti spesso in forma concessiva,
introdotto da espressioni quali “sebbene”, “nonostante”, “anche considerato
che”… Per noi, l’individuazione e il conteggio dei rebuttals rappresenterà quindi
solo un aspetto preliminare dell’analisi, che dovrà essere completata mediante
la messa a punto di concetti quali la tolleranza dell’ambivalenza e la tolleranza
delle contraddizioni.
4. Il modello di Toulmin rivisitato
Terminata l’analisi dei singoli elementi del modello, conviene ora rammentare i
criteri mediante i quali esso è stato modificato e presentarne una rielaborazione
grafica. Come dovrebbe essere ormai chiaro, il principale criterio a cui ci siamo
attenuti – con un’unica, parziale eccezione relativa ai dati – per adattare il
modello di Toulmin ai fini delle nostre indagini è il rispetto della funzione che i
diversi elementi assolvono nel modello, funzione che può essere realizzata, in
molti, anche se non in tutti i casi, indipendentemente dalla posizione da essi
rivestita.
I tre elementi basilari – tesi, dati e garanzie – sono stati tutti specificati,
ma seguendo criteri differenti: le tesi in base al loro “riferimento” (mondo o
sé), le garanzie a partire dal loro carattere esplicito o implicito (e poi anche in
base al loro grado di “evidenza”), i dati, infine, sulla base della loro particolare
funzione (di specificazione o di supporto delle tesi e delle garanzie). Qualifier e
rebuttal sono stati disancorati dalla loro originaria posizione, a partire dalla
constatazione che la loro funzione possa essere svolta anche in associazione ad
altri elementi, oltre che in associazione alla tesi. Il backing è stato eliminato e
sostituito con il data warrant, trattandosi in entrambi i casi di asserzioni fattuali.
Di conseguenza, il modello – rivisitato – può essere graficamente rappresentato
come segue (tra parentesi quadre sono riportate le sigle indicanti i possibili tipi
di un certo elemento, tra parentesi graffe le sigle relative a diversi usi dei data;
entro ogni riquadro si elencano gli elementi che possono associarsi
eventualmente ai tre basilari):
Data {Dc} {Dw}
…………………
Q, R
Claim [M], [S], [N], [O]
………………..
{Dc}, Q, R
Warrant [Ee], [Ed], [Ie], [Id]
……………………………...
{Dw}, Q, R
14
15