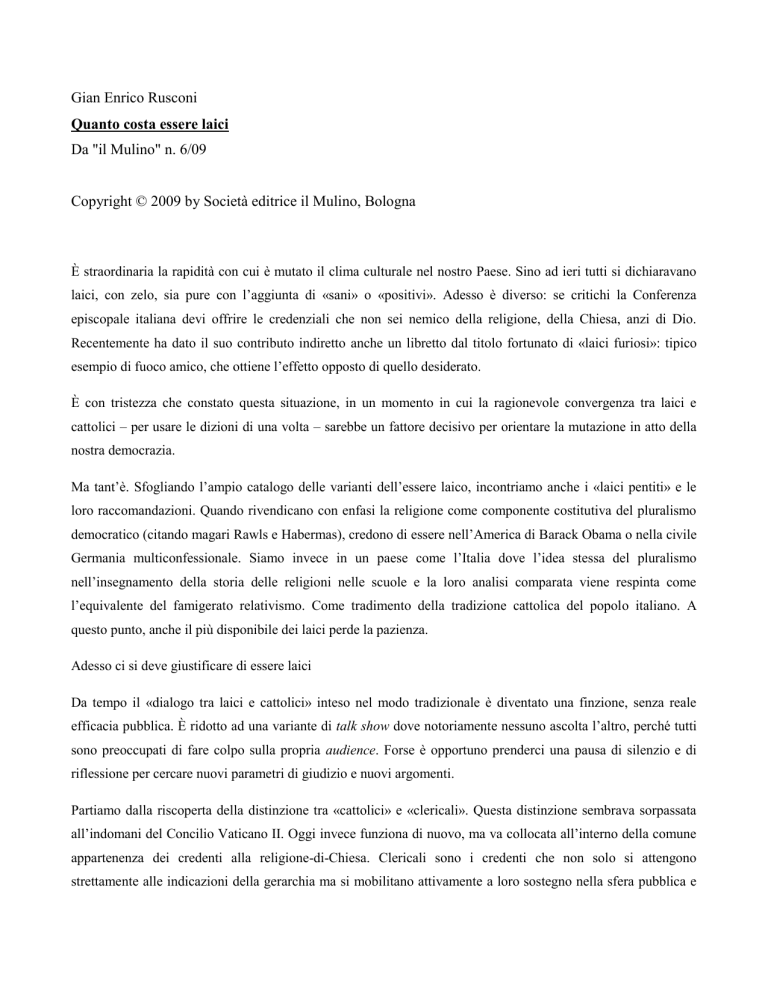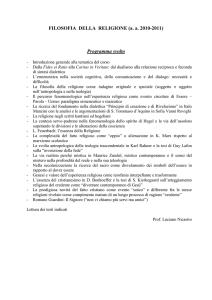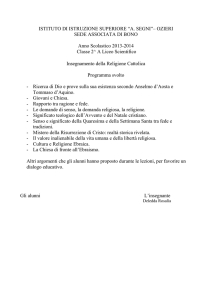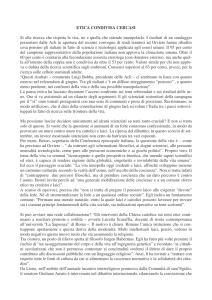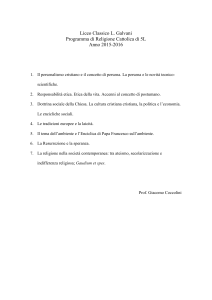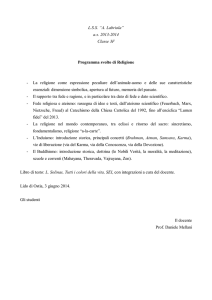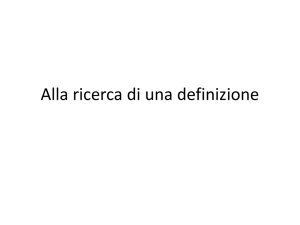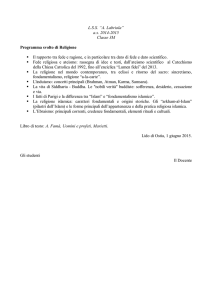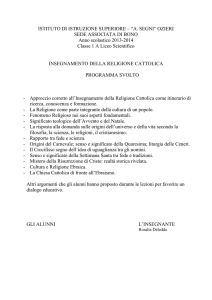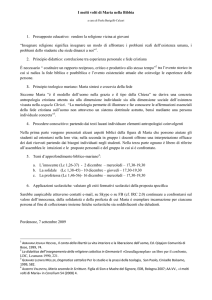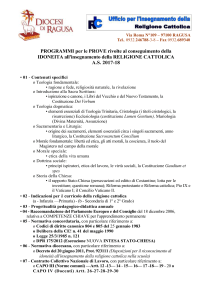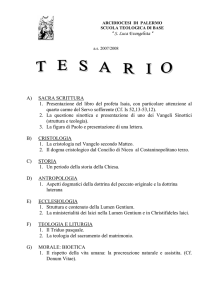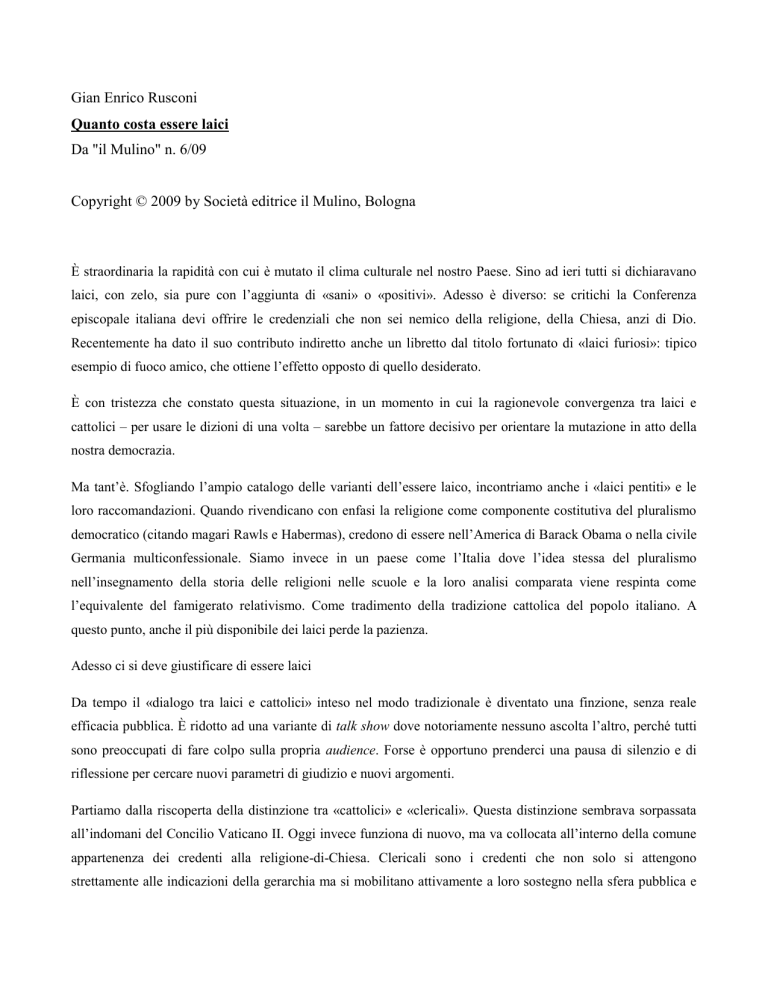
Gian Enrico Rusconi
Quanto costa essere laici
Da "il Mulino" n. 6/09
Copyright © 2009 by Società editrice il Mulino, Bologna
È straordinaria la rapidità con cui è mutato il clima culturale nel nostro Paese. Sino ad ieri tutti si dichiaravano
laici, con zelo, sia pure con l’aggiunta di «sani» o «positivi». Adesso è diverso: se critichi la Conferenza
episcopale italiana devi offrire le credenziali che non sei nemico della religione, della Chiesa, anzi di Dio.
Recentemente ha dato il suo contributo indiretto anche un libretto dal titolo fortunato di «laici furiosi»: tipico
esempio di fuoco amico, che ottiene l’effetto opposto di quello desiderato.
È con tristezza che constato questa situazione, in un momento in cui la ragionevole convergenza tra laici e
cattolici – per usare le dizioni di una volta – sarebbe un fattore decisivo per orientare la mutazione in atto della
nostra democrazia.
Ma tant’è. Sfogliando l’ampio catalogo delle varianti dell’essere laico, incontriamo anche i «laici pentiti» e le
loro raccomandazioni. Quando rivendicano con enfasi la religione come componente costitutiva del pluralismo
democratico (citando magari Rawls e Habermas), credono di essere nell’America di Barack Obama o nella civile
Germania multiconfessionale. Siamo invece in un paese come l’Italia dove l’idea stessa del pluralismo
nell’insegnamento della storia delle religioni nelle scuole e la loro analisi comparata viene respinta come
l’equivalente del famigerato relativismo. Come tradimento della tradizione cattolica del popolo italiano. A
questo punto, anche il più disponibile dei laici perde la pazienza.
Adesso ci si deve giustificare di essere laici
Da tempo il «dialogo tra laici e cattolici» inteso nel modo tradizionale è diventato una finzione, senza reale
efficacia pubblica. È ridotto ad una variante di talk show dove notoriamente nessuno ascolta l’altro, perché tutti
sono preoccupati di fare colpo sulla propria audience. Forse è opportuno prenderci una pausa di silenzio e di
riflessione per cercare nuovi parametri di giudizio e nuovi argomenti.
Partiamo dalla riscoperta della distinzione tra «cattolici» e «clericali». Questa distinzione sembrava sorpassata
all’indomani del Concilio Vaticano II. Oggi invece funziona di nuovo, ma va collocata all’interno della comune
appartenenza dei credenti alla religione-di-Chiesa. Clericali sono i credenti che non solo si attengono
strettamente alle indicazioni della gerarchia ma si mobilitano attivamente a loro sostegno nella sfera pubblica e
politica (dal boicottaggio della Ru 486 alla bocciatura della legge sulla omofobia). Accanto ad essi sono schierati
gli ex laici agnostici «compiacenti verso la Chiesa».
A proposito di distinzioni: gli insegnamenti del caso Boffo
Cattolici non clericali sono invece quei credenti che, pur facendo proprie le posizioni di principio della Chiesa,
non condividono la sua strategia politica e pubblica. Ma il punto è che questi cattolici – diciamo critici – sono
pubblicamente irrilevanti o zittiti e intimoriti. Parecchi di loro sono presenti sui giornali laici o scrivono libri di
successo, ma nei momenti cruciali del dibattito pubblico e politico si defilano sulle questioni più controverse per
evitare ritorsioni clericali che impedirebbero loro di continuare nella loro opera.
Le distinzioni sia nel campo laico che in quello religioso-di-Chiesa acquistano rilievo soprattutto in rapporto alla
sfera pubblica e politica. A questo proposito non può essere dimenticato quanto è accaduto mesi or sono nel caso
Boffo. Per un momento sembrò che minasse irreversibilmente nientemeno che l’equilibrio etico-politico
nazionale: invece è rientrato senza grosse conseguenze. Le massime gerarchie della Chiesa hanno superato senza
danni apparenti le ore di panico vissute in quella occasione. Adesso si accontentano di ribadire
retrospettivamente la condizione di vittima del loro giornale, «L’Avvenire», finito nel mirino di un sistema
informativo imbarbarito. Riaffermano la volontà di non rinunciare alla propria libertà di espressione, ma questa
rivendicazione non cancella la leggerezza con cui il responsabile dell’organo della Cei si è esposto ad un attacco
giornalistico per un fallo personale (non si sa quanto noto ai vertici) che si supponeva sarebbe rimasto privato
ovvero celato nel confessionale. È stato un errore di valutazione imperdonabile per chi si ritiene maestro di
comunicazione pubblica. Ma adesso tutto è finito. Anzi l’errore sarà ampiamente ripagato – in senso letterale.
Dispiace per i milioni di buoni credenti che sono rimasti male, senza capire che cosa è successo davvero.
Si ha l’impressione che alle gerarchie interessi innanzitutto ottenere dal governo risorse finanziarie e strumenti
legali per realizzare quella che ritengono la loro missione e la loro «battaglia per la verità» e «per la vita». I
convincimenti degli altri (dei laici in particolare) sono soltanto errori e traviamenti morali da contrastare anche
con gli strumenti che offre la democrazia. Che oggi in Italia questa democrazia abbia la faccia del berlusconismo
è soltanto un vantaggio da sfruttare prima che sia troppo tardi.
So bene che alcuni lettori troveranno questo quadro semplicistico. Ma per articolarlo meglio dovremmo fare
chiarezza sul potere intimidente che la gerarchia vaticana esercita nei confronti degli altri uomini di Chiesa che
hanno una sensibilità diversa e un diverso orientamento etico e politico.
Un confronto tra laici e religiosi-di-Chiesa
In attesa di questo chiarimento interno alla Chiesa, il confronto tra laici e religiosi-di-Chiesa va messo a fuoco
innanzitutto nello spazio pubblico e ci suggerisce alcune riflessioni.
La laicità non si definisce come un fatto privato, riconducibile alla categoria del «credente/non credente» – come
si pensa comunemente – ma è una dimensione pubblica che prescinde dalle credenze. È istituzionalizzazione del
principio del pluralismo dei convincimenti. È il fondamento dell’etica pubblica. La laicità è lo statuto della
cittadinanza.
Insisto: essere laici non è una dichiarazione di fede o di opinione etica personale. Tanto meno coincide con un
atteggiamento antireligioso o ateo (personalmente mi attengo al criterio etsi deus non daretur – che viene inteso
in modo semplicistico, quando viene ribaltato nella formula dell’uti deus daretur. Ma in questa sede non intendo
approfondire il punto).
La laicità è una dimensione pubblica che prescinde dalle credenze
L’essere laico è parte costitutiva dell’essere cittadino che ha il diritto e il dovere di decidere autonomamente la
propria condotta morale di vita. In questo senso tutti sono o dovrebbero essere laici. Ma allora si pone un grave
problema di coerenza per i clericali che si riservano di sottrarre la loro lealtà allo Stato democratico se legi fera
in modo contrario ai loro convincimenti. Si badi: non contro la loro libertà di fede e di comportamento, ma
contro la loro opinione su come gli altri cittadini devono comportarsi.
Qui nasce il contrasto con la dottrina e la strategia della gerarchia della Chiesa quando mira alla determinazione
autoritativa dell’etica pubblica del Paese, in particolare nelle «questioni che fanno riferimento all’area della
soggettività personale». Faccio notare che questa sintetica ed esplicita espressione è stata coniata dal cardinale
Camillo Ruini per qualificare il Progetto culturale cattolico da lui messo in moto. Detto questo, va chiarito un
punto molto importante. Il concetto di etica pubblica è ampio. Chi è laico, nel senso che stiamo illustrando, può
avere larghi spazi di convergenza con le posizioni della gerarchia ecclesiastica su altri temi sociali e culturali.
Penso alla difesa dei diritti degli immigrati, o all’azione di contrasto di ogni forma di razzismo. Su questi e altri
punti ci può e ci deve essere totale convergenza.
Facciamo un passo in avanti. Quella che a molti appare una illecita interferenza degli organi ecclesiastici nel
rapporto Stato-Chiesa, segnala un fenomeno assai più serio. In una situazione di disorientamento della società
civile, l’etica pubblica, anziché costruirsi sul pluralismo delle posizioni etiche dei cittadini senza che l’una
prevarichi sull’altra, viene delegata di fatto alla dottrina della Chiesa e alla sua strategia di controllo attraverso le
istituzioni, o sopra le istituzioni, se è necessario. In questa situazione il laico deve assumersi i seguenti compiti.
a) Sostenere con fermezza la legittimità del contrasto di visioni etiche e la illegittimità della prevaricazione
autoritativa, tramite norme di legge, da parte di una maggioranza che non riconosce la pari dignità etica di chi
non la pensa come lei. In questo modo si concretizza il principio della laicità come statuto della cittadinanza e
non come questione di convincimenti personali e di stili di vita, da regolamentare secondo i criteri delle
convinzioni della maggioranza.
b) Contestare gli equivoci che esistono a proposito dello «spazio e del discorso pubblico», distinguendo
nettamente tra l’accesso alla sfera pubblica, aperto e praticato senza restrizioni dalla Chiesa, e l’azione
strategicamente mirata ad influenzare con ogni mezzo la deliberazione politica.
c) Combattere le confusioni tra scienza e teologia a proposito dei concetti di natura e di vita che sono diventati
cruciali per l’etica pubblica. Da anni nel mondo cattolico si discute di biotecnologie, di testamento biologico, di
famiglia «naturale» mescolando in modo arbitrario argomenti che si pretendono razionali e scientifici,
«puramente umani», con assunti di fede. Il punto culminante è l’idea di vita (anzi di Vita), potente veicolo di una
visione religiosa che diventa ostinato rifiuto di altre visioni della vita umana, interpretata in modo diverso nella
sua concreta storicità, con quel che segue per i rapporti procreativi, sessuali, familiari – giù giù sino alla
contraccezione.
d) Aprire un dibattito culturale qualificato di carattere storico-critico sulla formazione della dottrina e della
dogmatica cristiano-cattolica (anche in risposta ai discorsi del Pontefice sulla razionalità della fede, sul logos,
l’illuminismo, l’ellenizzazione del cristianesimo ecc.). In questo senso parlo della necessità che i laici siano
competenti di teologia e della sua storia. Il disinteresse del pensiero laico per la riflessione teologica ha portato
alla clericalizzazione della teologia stessa diventata strumento per tenere in minorità intellettuale i credenti.
Naturalmente conosco le seccate repliche dei teologi professionali che mi accusano di ignorare la loro
produzione. Ma il punto non è il professionismo degli esperti bensì la «teologia pubblica», per così dire.
In questo contesto vorrei sollevare un paio di punti problematici.
L’approccio etico-religioso oggi dominante mantiene sfocati (o semplicemente non detti) i riferimenti ai grandi
dogmi teologici della colpa originale, della redenzione, della salvezza che storicamente sono (stati) tutt’uno con
la dottrina morale della Chiesa. Oggi questi temi teologici sono diventati incomunicabili ad un pubblico
religiosamente de-culturalizzato. La teologia morale è interamente assorbita dalla tematica della «vita» e della
«natura» con modalità che rischiano di farla cadere in forme di bio-teologismo o di risacralizzazione
naturalistica carica di risentimento verso le scienze biologiche e le teorie dell’evoluzione. La teologia diventa
sacra biologia.
In questo contesto l’unico riferimento teologico che resta è quello della creazione, presentato per altro con molta
cautela rispetto alla narrazione biblica. Su questo punto, anziché una «traduzione» del codice religioso in codice
naturale-razionale c’è una sottile fusione e confusione di elementi.
Ma i teologi morali, oggi, continuano a far finta di niente
Faccio un esempio. Quando nel dibattito bioetico si discute dell’inizio biologico della vita umana o meglio della
persona umana, oppure quando nell’esercizio del discorso pubblico-politico è sollevata l’opportunità di
correggere in modo restrittivo la legge sull’aborto, i credenti nelle loro dichiarazioni in Parlamento non
introducono argomenti manifestamente religiosi circa l’intangibilità dell’embrione in quanto creato da Dio.
Cercano di argomentare in termini razionali, etico-naturali oppure filosofico-metafisici, in qualche caso
addirittura scientifici.
Va da sé invece che gli uomini di Chiesa nei loro interventi pubblici si richiamino direttamente e del tutto
legittimamente alla creazione divina per sostenere le loro tesi. Il risultato complessivo tuttavia è che non appena
si esce dal discorso parlamentare-istituzionale in senso stretto e si accede alla sfera pubblica, i motivi razionali (o
presuntivamente scientifici) si fondono inestricabilmente con motivi religiosi. Tanto più che quello di creazione
è uno dei concetti più accessibili, intuitivi e umanamente comprensibili.
Nel frattempo si è verificata una straordinaria mutazione silenziosa: la Chiesa, nella sua comunicazione pubblica
odierna, trasmette un’idea tutta positiva di natura/naturalità originaria – rimuovendo d’un colpo tutti gli aspetti
tremendi che per secoli e secoli hanno prodotto e accompagnato l’idea della natura decaduta con il peccato
(natura lapsa). Rimane il dato di fatto che gran parte dell’etica sessuale cattolica è stata costruita sull’assunto
della natura corrotta. Ma i teologi morali, oggi, fanno finta di niente.
La centralità della dimensione pubblica della religione
Insistiamo sulla dimensione pubblica della religione, che è il motivo dominante e originale dell’età cosiddetta
post-secolare. Sappiamo con quanta enfasi le autorità della Chiesa insistono nel reclamare per la tesi religiosa
l’accesso senza restrizioni alla comunicazione pubblica – con l’implicito convincimento che basti la sua
semplice incontrastata diffusione perché venga accolta. Come se le idee esposte nella sfera pubblica diventassero
automaticamente «ragioni pubbliche», tali cioè da essere condivise da tutti i cittadini e da fondare l’etica
pubblica.
In questo equivoco cadono spesso gli uomini di Chiesa. Sono persuasi infatti che la resistenza o l’opposizione ai
loro argomenti (persino in Italia dove hanno incontrastato successo) sia imputabile ad una (presunta) restrizione
della comunicazione. L’equivoco diventa ancora più insidioso quando gli uomini di Chiesa avanzano la pretesa
di rappresentare l’opinione della «maggioranza» dei cittadini che ha il diritto di essere sostenuta da normative di
legge vincolanti per tutti, anche contro le pervicaci minoranze di laicisti e di cattolici traviati.
Per il laico l’ethos comune consiste nella comunanza delle regole condivise
Chi scrive non condivide l’utopia idealistica della possibilità del raggiungimento di un consenso etico comune
tramite «scambio di ragioni», «senza dominio». Nella concretezza sociale e politica di ogni confronto, in cui è
implicato un forte investimento identitario, permane l’inconciliabilità dei punti di vista, talvolta appesantita da
un sospetto morale diffamatorio nei confronti degli avversari. A partire da un certo momento, nella sfera
pubblica non c’è più ricerca di intesa ma dispiegamento di strategie tese a ottenere il riconoscimento delle
proprie convinzioni, delle proprie rivendicazioni materiali e immateriali o identitarie.
Ma questa constatazione non è altro che il riconoscimento della consistenza e inaggirabilità del pluralismo delle
visioni del mondo e della vita – pluralismo che è garantito dalle Costituzioni democratiche. L’ethos comune non
è sinonimo di omologazione di valori, bensì di convivenza di differenti punti di vista valoriali, di diversi ethos.
L’etica pubblica ricompone tramite norme accettate le differenti esperienze di vita dei cittadini. In questo modo
l’etica pubblica non è altro che l’espressione concreta della cittadinanza democratica.
Qui diventa insuperabile la differenza tra l’impostazione del magistero ecclesiastico e la visione laica. La Chiesa
riconosce come ethos comune soltanto quello promosso dalla sua dottrina morale. Diversamente – dice Papa
Ratzinger – «ethos e religione perdono la loro forza di creare comunità e scadono nell’ambito della
discrezionalità personale». Come si vede, ethos e religione sono qui di fatto identificati.
Il laico ha una visione diversa: l’ethos comune consiste nella comunanza delle regole condivise. Lo Stato è laico
proprio perché non pretende dai cittadini identità di credenze in campo etico-religioso ma reciproco rispetto e
considerazione dei differenti convincimenti, sempre aperti al confronto. Il laico accetta una certa disimmetria tra
moralità privata ed etica pubblica; ammette che i propri criteri morali e di giudizio non coincidono e non
esauriscono i criteri di moralità e di giudizio di altri, ed evita valutazioni che diffamano moralmente (quando
addirittura non criminalizzano) chi la pensa in modo diverso. La diffamazione morale di comportamenti
difformi, che non siano lesivi della libertà altrui, è virtualmente una minaccia alla democrazia.
Questa osservazione non contesta affatto al credente il diritto di far valere le sue convinzioni secondo la logica
della cittadinanza democratica cui partecipa. Ed in effetti constatiamo quotidianamente come il credente che si
attiene alle indicazioni della Chiesa avanzi la richiesta che la sua «verità» (sui temi della famiglia, ad esempio)
sia riconosciuta come momento costitutivo della sua stessa identità di cittadino sotto minaccia di sottrarre al
sistema politico la sua lealtà (o più banalmente il suo consenso elettorale). Ma agendo in questo modo il credente
cede ad una logica identitaria di tipo comunitarista, di riconoscimento cioè dei diritti di comunità (in questo caso
cattolica) che si muove ai limiti della democrazia. La situazione non cambia anche quando – come talvolta si
sente dire anche da noi – una «minoranza religiosa» rivendica di rappresentare, su determinati temi, la posizione
della «maggioranza morale» sentendosi così autorizzata a determinare l’etica pubblica.
La cultura laica rifugge da ogni omologazione culturale ma possiede una concezione della «natura umana»
ragionevole e scientificamente fondata, a fronte di visioni antropologiche strettamente intrecciate con culture
religiose storicamente debitrici a saperi pre-scientifici. Infine, contrastando ogni forma comunitarista che fa
appello a «tradizioni» o «radici» vincolanti, il laico fa valere il principio universalistico della cittadinanza
costituzionale.
Al di là dei luoghi comuni, della laicità e della religione
Tutto ciò è congruente con l’idea laica di democrazia intesa come lo spazio istituzionale entro cui tutti i cittadini,
credenti, non credenti e diversamente credenti confrontano i loro argomenti, affermano le loro identità e
rivendicano il diritto di orientare liberamente la loro vita – senza ledere l’analogo diritto degli altri. Questo
difficile equilibrio è garantito soltanto da un insieme di procedure consen suali di decisione che impediscono il
prevalere autoritativo di alcune pretese di verità o di comportamento su altre.
È importante sottolineare che l’intendersi e l’agire «tramite procedura» non è una formalità convenzionale,
artificiosa, opportunistica, revocabile a piacimento, ma è un agire performativo nel senso che impegna ad un
comportamento coerente e corrispondente. Impegna alla lealtà verso le norme legalmente definite, anche se non
sono gradite soggettivamente.
Questa è democrazia laica – nel senso che quando in essa si manifestano credenze e convinzioni incompatibili
tra loro, ai fini dell’etica pubblica e delle sue espressioni normative, non decidono «verità sull’uomo»
(implicitamente riferite ad una «parola di Dio» interpretata in modo autoritativo) ma le procedure che
minimizzano il dissenso tra i partecipanti al discorso pubblico. «La verità» – se vogliamo usare questo
impegnativo concetto – consiste nello scambio amichevole di argomenti e nella lealtà reciproca di
comportamento.
Detto questo, occorre energicamente combattere l’idea che la laicità sia soltanto un metodo o una regola
procedurale, mentre la religione offrirebbe contenuti di senso sostantivi. In subordine va fermamente respinto il
luogo comune secondo cui la percezione del mistero della vita e della contingenza del mondo, l’emozione
profonda davanti all’universo, il senso del limite dell’uomo siano prerogative del sentimento religioso. È sciocco
scambiare come indifferenza il senso di pudore che il laico prova dinanzi alla dignità della finitezza umana che
non ha bisogno di enfatiche retoriche enfasi sul senso della vita. Discorso analogo vale per i valori del
solidarismo sociale.
Vogliamo chiamare questi atteggiamenti espressione di «spiritualità» laica, un termine che recentemente ha
avuto una grande rivalutazione, sottraendosi apparentemente al monopolio degli uomini di religione o di Chiesa?
Personalmente ritengo inopportuno che il linguaggio dei laici debba mimare quello religioso – con espressioni
del tipo «fede laica» o «religione laica». Sia che queste espressioni segnalino convincimenti che vanno al di là
del materialismo otto-novecentesco o dei criteri di una razionalità dettata esclusivamente dalla metodologia
scientifica. O che indichino una «filosofia umanistica», comunque declinata, legata ad approcci ermeneutici.
Come se – in caso contrario – il laico fosse destinato da mattina a sera al dubbio metodico, al razionalismo
(«arido», naturalmente), all’edonismo e individualismo («egoistico», naturalmente), al famigerato relativismo
dei valori, alla mancanza di speranza. Queste sono caricature clericali.
Ma per correggere queste storture non è necessario rivendicare qualcosa che assomiglia alla «religione» o alla
«fede», etichettata ora, appunto, come laica. Il laico è l’uomo/la donna che si riconoscono nella ragionevolezza,
cioè nella razionalità temperata da forme di esperienze vitali la cui decifrazione non è riconducibile
esclusivamente a quella della strumentazione scientifica. Ma che con ciò la risposta «ultima» sia
automaticamente da lasciare alla fede, intesa nel senso dottrinale e tradizionale del termine, è un cortocircuito
che non regge.
Ma c’è di più. Il revival della spiritualità sulla bocca di alcuni religiosi è privo di un solido discorso teologico o
si affida a una teologia evocata solo come insieme di metafore. È un problema molto serio oggi conciliare la
tradizionale teologia sistematica con quella che si definisce «teologia narrativa». La Bibbia è una «narrazione»
che solleva questioni cognitive ed epistemologiche che sono rimaste irrisolte nella classica teologia sistematica.
Ma non sono questioni risolvibili con gli approcci di una «spiritualità» che attinge fondamentalmente ad
esperienze ed emozioni soggettive, personali e alle loro proiezioni. Il significato della Croce non è risolvibile
nella empatia per l’umanità sofferente o nel sentimento di solidarietà per tutte le vittime innocenti di questo
mondo. C’è un dato teologico «duro» da decifrare nel senso di un Figlio di Dio che si immola per la redenzione
dell’uomo da un peccato d’origine che ha scatenato la più terribile ira di Dio. Su questo argomento le metafore
edificanti o pietose non servono. E la teologia tradizionale si trova priva di capacità comunicativa rispetto ad
altre epoche storiche.
Questo è forse il motivo che spiega quella sorta di silenziosa rivoluzione teologica per cui dall’idea millenaria
della natura umana decaduta per il peccato originario si è arrivati oggi ad un discorso pubblico tutto positivo
sulla natura umana, insidiata nella sua integrità originaria dalle biotecnologie o dalle famiglie «irregolari». È una
profonda mutazione concettuale che attende ancora una convincente spiegazione, anche per le implicazioni che
dovrebbe portare con sé nell’idea di «famiglia naturale», di sviluppo biogenetico e di morte ecc. E le battaglie
etiche connesse. Ma di questa mutazione né i teologi ufficiali né gli spirituali amano (o sanno) parlare.
Le peculiarità del caso italiano
È difficile dire se quanto sto scrivendo rispecchia una situazione peculiare della cultura del nostro Paese o non
declini invece una problematica generale internazionale affrontata da importanti studiosi del revival religioso,
del secolarismo e del post-secolarismo. Nei ristretti limiti di questo intervento vorrei riprendere criticamente – a
mo’ di excursus finale – alcuni spunti di Charles Taylor e di Jürgen Habermas.
Taylor, filosofo canadese, credente, cattolico ma per niente clericale, è l’autore di un grosso volume su L’età
secolare recentemente uscito anche in italiano (Feltrinelli, 2009). Decisiva e ben illustrata è la sua tesi che la
secolarizzazione non è stata un fenomeno che ha colpito proditoriamente la religione dal di fuori, alle spalle. Ma
è un processo endogeno al cristianesimo occidentale stesso, che nella modernità (passando attraverso il deismo
provvidenzialistico e il primo illuminismo ancora religioso) si è distaccato e contrapposto alla religione. Nasce
così l’umanesimo autosufficiente o esclusivo. O l’ateismo nella forma contemporanea. Paradossalmente, è
culmine del processo di razionalizzazione messo in moto dal cristianesimo.
Ma con la secolarizzazione è nata la concezione moderna di immanenza e trascendenza. È nato un nuovo modo
di pensare la religione. Soprattutto tra le acquisizioni irreversibili della secolarizzazione c’è la piena legittimità
etica del non credere, oltre che la legittimità e la plausibilità intellettuale del non credere.
È difficile non apprezzare l’onestà intellettuale del filosofo che, come credente, non presume di possedere un
«qualcosa in più» che lo differenzierebbe dal non credente. Per entrambi infatti la posta in gioco è la «pienezza»
del vivere in vista della quale credente e non credente adottano strategie legittimamente diverse. È una tesi
importante. Non a caso in Taylor non c’è il lamento e la polemica contro il «relativismo», che è il cavallo di
battaglia della pubblicistica cattolica.
La «trascendenza» è per Taylor la caratteristica essenziale della fede, ma essa non viene disconosciuta neppure
ad un certo tipo di umanesimo non credente sotto la forma paradossale di «trascendenza interna».
Queste affermazioni, che da noi sarebbero derubricate a variante del «relativismo», portano invece a chiedersi
come sia possibile credere in un mondo irreversibilmente e legittimamente pluralista in cui le molte forme di
credenza e di non credenza «sgomitano l’una contro l’altra». «La caratteristica saliente delle società occidentali
non è tanto il declino della fede e della pratica religiosa quanto piuttosto la reciproca fragilizzazione (sic) delle
diverse posizioni religiose e delle prospettive contrapposte del credere e del non credere».
Sui grandi temi dogmatici Taylor si muove con cautela. Talvolta con incertezza. Denuncia la «cornice giuridicopenale iperagostiniana», che ha storicamente fissato i concetti teologici di peccato originale, di espiazione e di
punizione eterna quali sono giunti sino a noi. Ma non rinuncia all’idea del mistero che quei concetti a loro modo
hanno tentato di decifrare e di codificare. «La tensione, l’imbarazzo, talvolta persino la dilemmaticità della
coscienza cristiana odierna dipendono dal fatto che essa stacca le verità centrali della fede riguardo al peccato e
all’espiazione, dal loro sfondo storico cristiano-latino, dalla lettura giuridico-penale iperagostiniana e
dall’ermeneutica della violenza divina che interpreta la sofferenza come punizione o pedagogia».
Non è chiaro che cosa Taylor intenda. Non sa o non vuole sciogliere la tensione tra dato dogmatico tradizionale e
sensibilità morale del nostro tempo. Gli va bene così. È diffidente verso approcci alla problematica religiosa che
considera troppo filosofici. Cita con simpatia i grandi intellettuali cattolici francesi (Péguy, Mounier, Maritain)
ma non porta affatto avanti il loro pensiero filosofico. Il suo cuore batte per gli uomini e le donne di preghiera e
di testimonianza come Charles de Foucauld e Teresa di Lisieux. Quasi marginalmente osserva che tutti costoro
sono stati impeccabilmente rigorosi nella loro ortodossia cattolica.
Ma il filosofo non dà una risposta a quello che personalmente ritengo il dilemma cruciale del revival religioso
odierno: l’assenza di un nesso tra il discorso teologico tradizionale e il vissuto esistenziale.
Habermas e i «potenziali semantici» della religione
In un quadro teorico diversissimo si muove Jürgen Habermas, un autore troppo noto in Italia perché qui mi
dilunghi a presentarlo. Parecchi cattolici nostrani, fraintendendo e addomesticando alcune sue posizioni, lo
prendono come esempio di laicità positiva contrapposta al «laicismo» imperante a loro avviso in Italia. È una
interpretazione superficiale che confonde le buone intenzioni e lo stile del discorso habermasiano con la sua
sostanza di fondo. Il filosofo francofortese infatti non insiste semplicemente sull’apertura dello spazio pubblico
alla religione ma altrettanto significativamente parla della necessità della reciproca «traduzione» del linguaggio
religioso e di quello secolare/laico per rilanciare il dialogo tra «fede e sapere» (con la ripresa di un topos
classico). Il tutto sulla base dell’assunto che «l’ethos della cittadinanza liberale esige la presa di coscienza
riflessiva dei limiti sia della fede che del sapere». Che cosa è questa tesi se non una elegante e ragionevole
dichiarazione di relativismo?
Mentre i nostri clericali si limitano a citare strumentalmente Habermas, alcuni teologi tedeschi lo hanno
sottoposto ad uno stringente scambio di idee in un simposio in suo onore. Ecco in modo sintetico alcuni passaggi
(cfr. Habermas im Religionsdiskurs, Replik auf Einwände, Reaktion auf Anregungen, in Glauben und Wissen.
Ein Symposium mit Jürgen Habermas, a cura di R. Langthaler e H. Nagl-Docekal, Oldenbourg Verlag, 2008).
Habermas parla di «potenziali semantici» della religione, di «contenuti di verità delle espressioni di fede» che i
cittadini laici devono riconoscere «nascosti o addirittura repressi» nelle loro stesse «intuizioni morali». La base
del reciproco riconoscimento tra credenti e non credenti sta dunque in alcune «intuizioni» comuni, che hanno
radici religiose ma che ora vanno trasformate in «argomenti» razionali.
Benissimo. Ma come? Il teologo capisce subito che dietro all’invito habermasiano ad argomentare razionalmente
a partire dalle «intuizioni religiose» c’è la classica operazione di secolarizzazione dei contenuti teologici stessi.
Ovvero, il riconoscimento del valore etico-sociale della religione ma anche la sua riduzione/riconduzione a
dottrina morale deprivata di specificità teologica. Questa operazione è fatta da Habermas, con intensi richiami a
Kant, in nome della «ragione/Vernunft». Già questo era stato il motivo della simpatetica (e celebrata)
conversazione tra Habermas e l’allora cardinale Ratzinger. Ma l’idea di Vernunft del filosofo e quella dell’uomo
di Chiesa sono radicalmente diverse. I cattolici nostrani non se ne sono accorti. E di conseguenza non hanno
preso nota delle ferme critiche che Habermas ha avanzato alla famosa prolusione di Benedetto XVI a Ratisbona.
Certo: Habermas respinge il pre-giudizio illuministico che considera la fede un «relitto dell’età assiale», un fatto
irrazionale se non addirittura ostile alla ragione. A suo avviso la filosofia non può né surrogare né rimuovere la
religione. Ma «la razionalità della fede», quale è sviluppata in molti interventi di Ratzinger, ha poco in comune
con i criteri ispiratori della razionalità habermasiana che rimane immanente e rigorosamente agnostica nei
confronti dei dogmi religiosi. Il filosofo che nel suo discorso introduce (a mio avviso in modo non convincente)
il concetto di «contenuti di verità» non può accogliere l’idea stessa di «verità della rivelazione». La «verità»
della religione (cristiana) va ricercata piuttosto nella intuizione morale del valore delle «vite fallite»,
dell’esperienza del dolore, ma è una intuizione interamente de-teologizzata.
Analogamente la grande «intuizione fondamentale della dottrina cristiana della creazione» ha valore in quanto
congruente con la convinzione laica della non liceità di ogni intervento manipolatorio sul materiale genetico
della vita umana non nata. È noto che Habermas sostiene posizioni piuttosto restrittive a proposito delle
biotecnologie. In questa ottica apprezza molto come «garanzia semantica» il concetto cristiano di creazione,
anche se in quanto filosofo secolarizzato mantiene il suo agnosticismo.
Ma nella disponibilità habermasiana verso la religione e i suoi «potenziali semantici», il teologo intravvede uno
spazio per la sua controffensiva. Se la possibilità dell’esistenza di Dio non può essere teoreticamente esclusa –
dice il teologo – perché non rischiare la scommessa di Pascal? Se è legittimo tenere aperta l’opzione di Dio,
l’ipotesi di un «Dio che salva» non potrebbe giustificare «il salto nella fede» anche agli occhi della ragione
secolare? Che ne pensa Habermas?
Il filosofo risponde in modo cauto, in fondo lusingato di essere preso in tanta considerazione sul terreno
teologico dove si dichiara incompetente. Ma davanti alla pretesa/esigenza del teologo di poter almeno falsificare
filosoficamente l’ipotesi della non esistenza di Dio, si chiede se su questo punto teologi e filosofi parlino della
stessa cosa. Qui vale l’ammonimento di Wittgenstein a prestare attenzione alle differenze dei giochi linguistici.
L’interpretazione ontologica di ciò che esiste o non esiste muta profondamente a seconda del suo ambito di
applicazione. Se l’esistenza di Dio è attestata sostanzialmente da quel tipo di fiducia che si nutre dell’amore per
gli uomini; e se è questa fiducia che orienta verso l’affermazione di una Esistenza che trascende ogni
accadimento terreno, non è ragionevole – si chiede Habermas – nutrire una certa perplessità (eine gewisse
Ratlosigkeit) verso l’affermazione di una tale Esistenza, che si rende presente soltanto nella dimensione della
dedizione e della promessa?
Mi pare che, al di là del suo stile espressivo, la posizione habermasiana non si discosti qui nella sostanza
dall’impostazione kantiana secondo la quale l’affermazione dell’esistenza di Dio è sottratta alla ragione pura e
affidata alla ragion pratica. Ciò non toglie che al filosofo stiano a cuore i contatti tra fede e ragione, per
valorizzare il «deposito semantico della tradizione religiosa» ai fini di un lavoro comune per una società più
umana e più giusta.
È difficile non aderire a queste intenzioni e a questo invito. Ma di fronte all’Habermas «agnostico e disposto
all’apprendimento» tornano ancora più pressanti gli interrogativi che ci siamo posti di fronte al credente Taylor:
con il benefico ritorno della «esperienza vitale religiosa individuale» e dei suoi «potenziali semantici» che ne è
dei contenuti teologici forti della tradizione cristiana? Forse più che ad un’età neo-religiosa post-secolare
assistiamo alla compiuta secolarizzazione di verità dogmatiche che hanno costituito l’ossatura della religione
così come è stata intesa nei due millenni che abbiamo alle spalle.