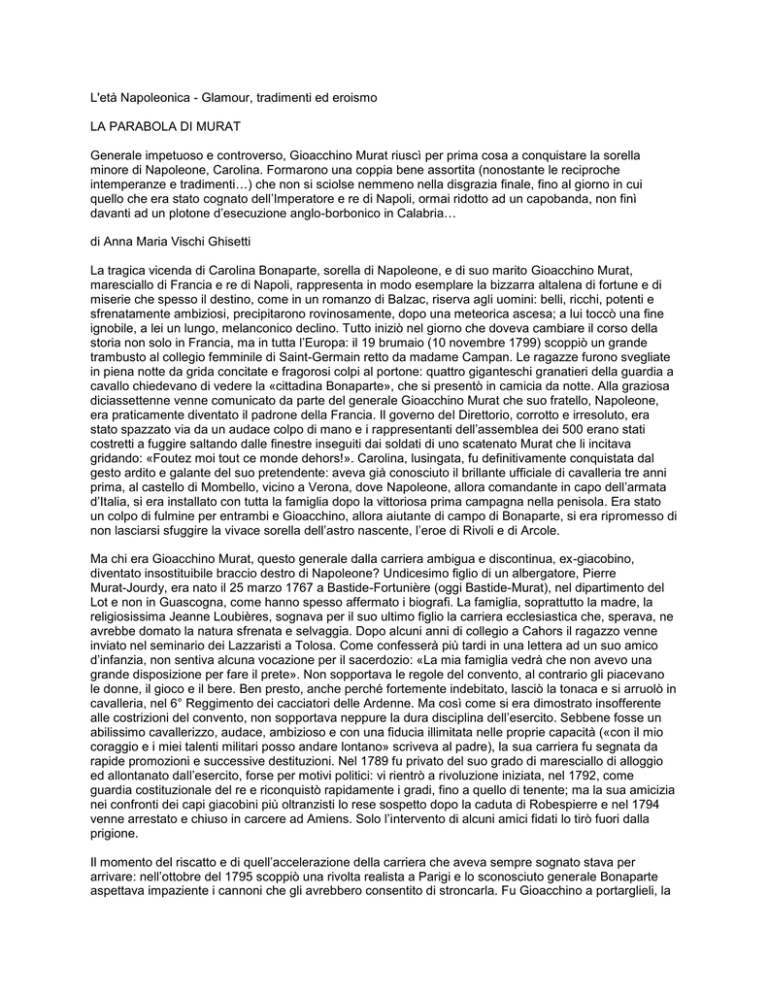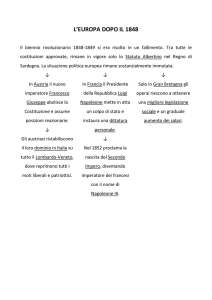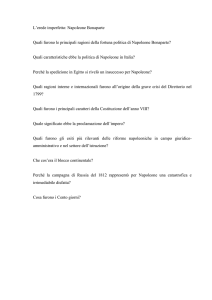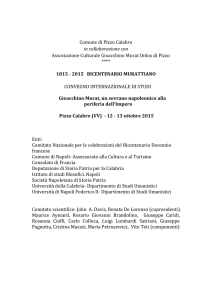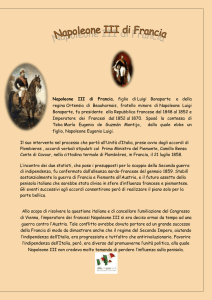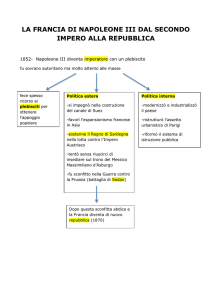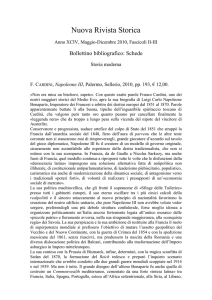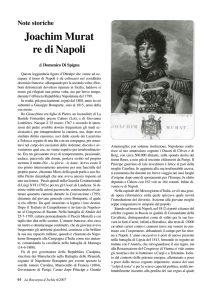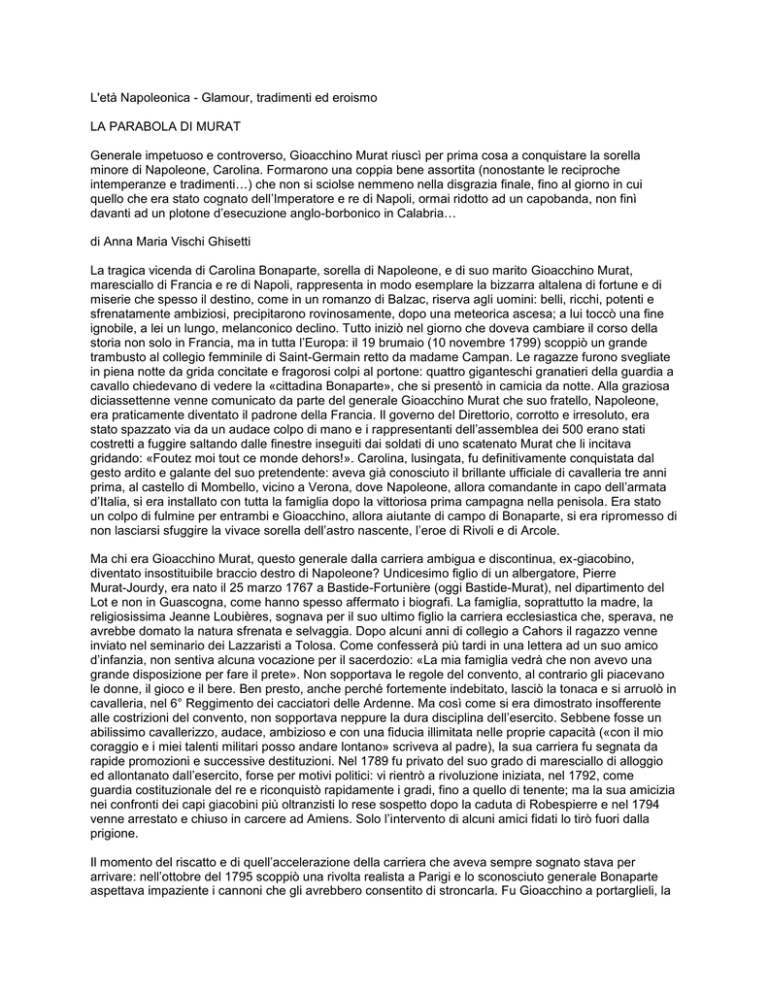
L'età Napoleonica - Glamour, tradimenti ed eroismo
LA PARABOLA DI MURAT
Generale impetuoso e controverso, Gioacchino Murat riuscì per prima cosa a conquistare la sorella
minore di Napoleone, Carolina. Formarono una coppia bene assortita (nonostante le reciproche
intemperanze e tradimenti…) che non si sciolse nemmeno nella disgrazia finale, fino al giorno in cui
quello che era stato cognato dell’Imperatore e re di Napoli, ormai ridotto ad un capobanda, non finì
davanti ad un plotone d’esecuzione anglo-borbonico in Calabria…
di Anna Maria Vischi Ghisetti
La tragica vicenda di Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone, e di suo marito Gioacchino Murat,
maresciallo di Francia e re di Napoli, rappresenta in modo esemplare la bizzarra altalena di fortune e di
miserie che spesso il destino, come in un romanzo di Balzac, riserva agli uomini: belli, ricchi, potenti e
sfrenatamente ambiziosi, precipitarono rovinosamente, dopo una meteorica ascesa; a lui toccò una fine
ignobile, a lei un lungo, melanconico declino. Tutto iniziò nel giorno che doveva cambiare il corso della
storia non solo in Francia, ma in tutta l’Europa: il 19 brumaio (10 novembre 1799) scoppiò un grande
trambusto al collegio femminile di Saint-Germain retto da madame Campan. Le ragazze furono svegliate
in piena notte da grida concitate e fragorosi colpi al portone: quattro giganteschi granatieri della guardia a
cavallo chiedevano di vedere la «cittadina Bonaparte», che si presentò in camicia da notte. Alla graziosa
diciassettenne venne comunicato da parte del generale Gioacchino Murat che suo fratello, Napoleone,
era praticamente diventato il padrone della Francia. Il governo del Direttorio, corrotto e irresoluto, era
stato spazzato via da un audace colpo di mano e i rappresentanti dell’assemblea dei 500 erano stati
costretti a fuggire saltando dalle finestre inseguiti dai soldati di uno scatenato Murat che li incitava
gridando: «Foutez moi tout ce monde dehors!». Carolina, lusingata, fu definitivamente conquistata dal
gesto ardito e galante del suo pretendente: aveva già conosciuto il brillante ufficiale di cavalleria tre anni
prima, al castello di Mombello, vicino a Verona, dove Napoleone, allora comandante in capo dell’armata
d’Italia, si era installato con tutta la famiglia dopo la vittoriosa prima campagna nella penisola. Era stato
un colpo di fulmine per entrambi e Gioacchino, allora aiutante di campo di Bonaparte, si era ripromesso di
non lasciarsi sfuggire la vivace sorella dell’astro nascente, l’eroe di Rivoli e di Arcole.
Ma chi era Gioacchino Murat, questo generale dalla carriera ambigua e discontinua, ex-giacobino,
diventato insostituibile braccio destro di Napoleone? Undicesimo figlio di un albergatore, Pierre
Murat-Jourdy, era nato il 25 marzo 1767 a Bastide-Fortunière (oggi Bastide-Murat), nel dipartimento del
Lot e non in Guascogna, come hanno spesso affermato i biografi. La famiglia, soprattutto la madre, la
religiosissima Jeanne Loubières, sognava per il suo ultimo figlio la carriera ecclesiastica che, sperava, ne
avrebbe domato la natura sfrenata e selvaggia. Dopo alcuni anni di collegio a Cahors il ragazzo venne
inviato nel seminario dei Lazzaristi a Tolosa. Come confesserà più tardi in una lettera ad un suo amico
d’infanzia, non sentiva alcuna vocazione per il sacerdozio: «La mia famiglia vedrà che non avevo una
grande disposizione per fare il prete». Non sopportava le regole del convento, al contrario gli piacevano
le donne, il gioco e il bere. Ben presto, anche perché fortemente indebitato, lasciò la tonaca e si arruolò in
cavalleria, nel 6° Reggimento dei cacciatori delle Ardenne. Ma così come si era dimostrato insofferente
alle costrizioni del convento, non sopportava neppure la dura disciplina dell’esercito. Sebbene fosse un
abilissimo cavallerizzo, audace, ambizioso e con una fiducia illimitata nelle proprie capacità («con il mio
coraggio e i miei talenti militari posso andare lontano» scriveva al padre), la sua carriera fu segnata da
rapide promozioni e successive destituzioni. Nel 1789 fu privato del suo grado di maresciallo di alloggio
ed allontanato dall’esercito, forse per motivi politici: vi rientrò a rivoluzione iniziata, nel 1792, come
guardia costituzionale del re e riconquistò rapidamente i gradi, fino a quello di tenente; ma la sua amicizia
nei confronti dei capi giacobini più oltranzisti lo rese sospetto dopo la caduta di Robespierre e nel 1794
venne arrestato e chiuso in carcere ad Amiens. Solo l’intervento di alcuni amici fidati lo tirò fuori dalla
prigione.
Il momento del riscatto e di quell’accelerazione della carriera che aveva sempre sognato stava per
arrivare: nell’ottobre del 1795 scoppiò una rivolta realista a Parigi e lo sconosciuto generale Bonaparte
aspettava impaziente i cannoni che gli avrebbero consentito di stroncarla. Fu Gioacchino a portarglieli, la
sommossa fu soffocata nel sangue e il Direttorio salvato da colui che allora venne ribattezzato «il
generale vendemmiaio». Conquistata così la fiducia del supremo potere esecutivo e del suo massimo
esponente, il potentissimo Paul Barras, Napoleone ricevette nel 1796 il comando della spedizione in Italia
contro l’Austria, l’acerrima nemica della Francia repubblicana, e Murat colse al volo l’occasione. Con
perfetto tempismo e grande spirito di iniziativa, si offrì al generale come aiutante di campo. Da allora la
sua ascesa fu inarrestabile, anche se il rapporto personale con Napoleone, all’inizio segnato da una fede
e da una sottomissione assolute, divenne sempre più problematico e conflittuale, fino a sfociare nella
rivolta e nel tradimento. Compagno dell’onnipotente generale corso negli anni che precedettero la
conquista del vertice del potere, combatté eroicamente in Italia e in Egitto, raggiungendo rapidamente i
gradi di generale di brigata nel 1796 e di generale di divisione nel 1799, dopo la battaglia di Abukir. Ma
nel gennaio del 1800 ottenne il premio più ambito: riuscì a vincere le resistenze di Napoleone, diventato
primo console, e a sposarne la sorella più giovane, l’avvenente e capricciosa Carolina. Bonaparte era
contrario al matrimonio, che considerava una mesalliance: «Verranno tempi, profetizzava, in cui forse ci
saranno dei sovrani a disputarsi la sua mano». Inoltre considerava Murat un immorale e un libertino: «Ha
sempre bisogno di donne, ne cambia una al giorno!» Avrebbe preferito per sua sorella un altro tra i suoi
fedelissimi, il futuro maresciallo Jean Lannes, o il generale Victor Moreau, suo avversario politico, ma
quest’ultimo rifiutò sprezzantemente facendo sapere che avrebbe piuttosto sposato la ravadeuse du coin
(una rammendatrice). Alla fine fu costretto a cedere di fronte alla testardaggine dei due giovani, sempre
più infatuati l’uno dell’altra.
Gioacchino, secondo la testimonianza di Constant Wairy, il valletto di camera di Napoleone, era «un
uomo di statura gigantesca, con begli occhi blu che roteavano nelle orbite, enormi favoriti e lunghi capelli
neri che gli ricadevano sul colletto». Proverbiale era la sua eleganza e il gusto per gli abiti stravaganti,
generalmente un’uniforme polonaise ricamata vistosamente in oro, con ampi pantaloni color amaranto e
un cappello a larghe falde con quattro grandi piume di struzzo alla sommità, in mezzo alle quali svettava
una magnifica egretta di airone. La maligna duchessa di Abrantès racconta invece che, tolti i ricami e i
vestiti sgargianti, era quasi brutto, con labbra troppo grosse e il colorito scuro. Celebre era l’irridente
soprannome di Re Franconi (un cavallerizzo del circo di Parigi), che gli aveva affibbiato il potente
cognato. Carolina, il cui vero nome era Maria Annunziata, era nata il 24 marzo 1782 ad Ajaccio: meno
bella della sorella Paolina, immortalata come principessa Borghese nel candido marmo del Canova, era
una seducente fanciulla piccola e bionda, con uno splendido incarnato («seta bianca cosparsa di rose»),
che sapeva mettere in risalto indossando delicati abiti color pastello. Le spalle tonde e le belle braccia
erano di un candore abbagliante e le mani e i piedi piccolissimi. In compenso «era di un ignoranza che
non avrebbe potuto essere maggiore». Il 20 gennaio 1800 finalmente l’aitante cavaliere e la sua piccola
dama convolarono a nozze, con una dote piuttosto modesta e il dono, da parte del primo console, di una
collana di perle prelevata dallo scrigno dei gioielli della moglie Giuseppina. La vita che conducevano nella
loro prima abitazione, l’hotel de Brienne, era sfarzosa, densa di ricevimenti, balli e feste, perché
l’ambiziosa Carolina era perennemente in competizione con l’odiata cognata Giuseppina Beauharnais:
considerata in Corsica come la Cenerentola della famiglia, arrivata all’improvviso alla ricchezza dopo che
le era mancato tutto, insieme al marito non meno avido, iniziò ad approfittare con frenesia dei beni
materiali e del potere; entrambi sembravano voler mordere la vita. I biografi non sono teneri con lei: la
considerano un diabolico incrocio tra Machiavelli e Messalina e la fonte principale delle disgrazie di
Gioacchino. Dotata come il fratello di una forte volontà unita a una smodata ambizione, costretta ad agire
in un tempo in cui le donne avevano più doveri che diritti, usava le sole armi a sua disposizione, la
seduzione e l’intrigo.
I primi anni del matrimonio furono comunque segnati da un amore sincero e appassionato tra i due
coniugi, che misero al mondo in rapida successione i loro quattro figli, Achille, Letizia, Luciano e Luisa.
Gioacchino fu probabilmente miglior padre che buon marito: le sue lettere alla sua beniamina, la
secondogenita Letizia, traboccavano di affetto e tenerezza. Dopo la seconda vittoriosa campagna d’Italia,
che riconsegnò la Lombardia ai francesi, Murat ebbe il prestigioso incarico di comandante in capo
dell’armata francese nella penisola, e si trasferì a Milano con la famiglia. Il periodo milanese fu però
contrassegnato dai continui dissidi tra lui e il vicepresidente della neonata Repubblica Italiana,
ex-Cisalpina, il nobile monarchico Francesco Melzi d’Eril, con il quale invece Carolina, più diplomatica
dell’irruente consorte, seppe stabilire un’ottima intesa: «Madame Murat si è comportata con grande
giudizio, saggezza e prudenza», riferiva Melzi a Napoleone, assai infastidito dalle incessanti lamentele
del cognato. L’insoddisfazione di Murat dipendeva principalmente dalla sensazione di essere relegato in
secondo piano e in realtà, mentre accusava d’Eril di scarsa fedeltà verso la Francia, covava il segreto
desiderio di prenderne il posto. A Milano Murat si era scandalosamente arricchito: quando infine nel 1803
tornò in patria e venne nominato governatore di Parigi, acquistò un magnifico palazzo di 35 stanze, l’hotel
Thélusson, un castello a Neuilly, e numerosi terreni, per un totale di quasi un milione e mezzo di franchi.
Il suo stato maggiore era il più ricco di tutto l’esercito e costava una fortuna ai suoi membri: bisognava
possedere almeno tre cavalli e quattro tenute, per l’estate, per l’inverno, una di parata e una di società.
Come governatore di Parigi Murat dovette affrontare un’emergenza di inaudita gravità: il fallito complotto
per assassinare Napoleone da parte dei generali filomonarchici George Cadoudal e Charles Pichegru,
ispirato dal governo inglese, e l’affaire del duca d’Enghien che tanto scandalizzò tutta l’Europa. Luigi
Enrico di Borbone, figlio del principe di Condé, fu ritenuto da Bonaparte complice dei cospiratori, rapito in
Germania dove si trovava in esilio, imprigionato e fucilato dopo un giudizio sommario. Si dice che Murat e
Carolina fossero stati tenacemente contrari all’esecuzione, ma la testimonianza del generale Savary,
futuro capo della polizia, smentisce questa versione: «Coulaincourt ha fatto rapire il duca, ma è stato
Murat a farlo giudicare e io a fare eseguire la sentenza». Napoleone, già sfuggito nel dicembre del 1800
alla bomba di rue Saint Nicaise, quando una violenta esplosione aveva ucciso numerosi civili mancando
per un pelo la sua carrozza mentre si recava all’Opéra, aveva deciso di usare il pugno di ferro contro i
monarchici al servizio dei Borboni e al soldo degli inglesi: «Sono dunque un cane che si può ammazzare
per la strada! Li farò tremare e gli insegnerò a stare tranquilli!». Come ulteriore dimostrazione di forza, nel
maggio dello stesso anno si fece proclamare per senatoconsulto Imperatore dei Francesi; George
Cadoudal, prima di salire sul patibolo, aveva commentato con caustica amarezza: «Volevamo dare un re
alla Francia, abbiamo fatto molto di più, le abbiamo dato un Imperatore!».
La pace tra la Francia e le potenze europee stava per finire: ma la serie di guerre interminabili che
insanguinò il continente per dieci anni non fu, come spesso si crede, il nefasto prodotto della volontà di
uno solo, ma la continuazione di uno scontro secolare, con cause economiche e sociali, tra due
superpotenze, la Gran Bretagna e la Francia, dove le rispettive borghesie commerciali e industriali
lottavano per l’egemonia mondiale. Alla fine fu il nascente impero finanziario mercantile e oceanico
inglese a prevalere sull’impero militare amministrativo e continentale francese. Per Murat iniziò un lungo
periodo di trionfi, culminato nella nomina a re di Napoli, l’apice della sua carriera: ad Austerlitz, Jena,
Eylau, Friedland, come comandante della riserva di cavalleria, guidò grandiose cariche e vittoriosi
inseguimenti. Gli altri marescialli, dotati di qualità militari infinitamente più solide, non potevano credere
che quel vanitoso coq empanaché (gallo impennacchiato) si accaparrasse tutta la gloria nei bollettini
dell’Armée solo perché era il cognato di Napoleone. I suoi contrasti con gli altri capi erano frequenti: ad
Ulm lui e Ney, entrambi facili alla collera, per un pelo non vennero alle mani per una differenza di vedute
sulla strategia da adottare contro gli austriaci. Di fronte alle argomentazioni e alle carte geografiche
dispiegate sul tavolo da Ney, Gioacchino aveva risposto irridente: «Signor maresciallo, non mi
interessano i vostri piani. Io sono abituato a fare i miei di fronte al nemico!» Il lorenese era furioso e solo
l’intervento del suo segretario privato, il prudente e compassato Charles Cassaing, aveva evitato un
duello alla sciabola tra i due. Napoleone d’altra parte era abilissimo a sfruttare le invidie e le gelosie dei
suoi luogotenenti, per accrescerne la combattività e lo spirito di emulazione. Come osservò un’acuta
memorialista, madame de Rémusat, a proposito dei marescialli: «Il modo in cui l’Imperatore conteneva,
soddisfaceva e irritava impunemente uomini così alteri, così fieri della loro gloria, era notevole; con quale
abilità seppe servirsene nell’esercito e come trasse da essi nuovi raggi per la sua gloria impadronendosi
della loro!». Con il vanagloriso cognato alternava i favori alle critiche brucianti. Però, cedendo anche alle
incessanti insistenze di Carolina, lo copriva di onori e di incarichi prestigiosi: maresciallo di Francia,
principe e granduca di Berg e di Clèves, grand’ammiraglio… «Con i miei parenti - confessò in esilio l’ex
Imperatore - sono sempre stato un poule mouillé» (pulcino bagnato). Mentre il marito e il fratello
combattevano nel fango della Polonia, la mente operosa e calcolatrice di Carolina non rimaneva inattiva.
Napoleone non aveva eredi, poteva morire improvvisamente durante una delle sue campagne e la
successione al trono era aperta. Intrigando con le due eminenze grigie del governo, Fouché e Talleyrand,
mirava ad assicurarsi il potere supremo cercando soprattutto di estromettere i detestati Beauharnais;
Murat aveva inoltre un grande vantaggio su Eugenio, figlio dell’Imperatrice Giuseppina e viceré d’Italia:
aveva carisma e si era creato un vero e proprio partito nell’esercito. Come ulteriore garanzia, Carolina era
diventata l’amante del generale Andoche Junot che, come governatore di Parigi, era il più idoneo a
gestire una crisi, se l’Imperatore fosse morto in battaglia. Naturalmente la relazione giunse alle orecchie
del malcapitato Gioacchino, scoppiò uno scandalo tremendo e Junot venne spedito in Portogallo. Ma
poco dopo anche Murat fu inviato nella penisola iberica, dove il 2 e il 3 maggio 1808 dovette reprimere
con crudele ferocia la ribellione del popolo di Madrid contrario all’abdicazione dei Borboni e alla nomina di
Giuseppe Bonaparte quale re di Spagna. L’apertura del fronte spagnolo si rivelò fatale per l’Impero:
inoltre la Spagna fu economicamente ridotta a una colonia e sfruttata a beneficio della Francia, che
operava in condizioni di assoluto monopolio nel paese, politica che suscitò una serie di interminabili
sommosse da parte di giunte ribelli capeggiate dal clero e dall’aristocrazia e assistite dall’Inghilterra,
finché nel 1813 il re Giuseppe fu costretto a fuggire e a restituire il trono ai Borboni.
Gioacchino lasciò dunque la Spagna con la sinistra fama di massacratore, ma nella lotteria dei troni lui e
Carolina vinsero il reame di Napoli, lasciato vacante da Giuseppe. La moglie da tempo gli ripeteva:
«Lasciami fare, grande bete! Fra poco, grazie a me, sarai re!». Il 25 settembre 1808 fece una trionfale
entrata nella città, con l’altisonante titolo di «Joachim-Napoleon par la grace de Dieu et la Constitution de
l’Etat, roi des Deux Siciles, grand amiral de l’Empire». Nonostante i continui ammonimenti e i rimbrotti
dell’augusto cognato, che pretendeva dagli stati vassalli retti dai suoi «proconsoli» una totale
sottomissione agli interessi economici francesi, l’azione di Murat a Napoli fu sostanzialmente positiva:
introdusse il codice napoleonico, iniziò grandi opere pubbliche, costruì strade, cercò di modernizzare le
città, prosciugò le zone paludose e insalubri, represse il banditismo in Calabria. Ma Napoleone,
spregiatore di ogni merito, continuava a soprannominarlo lazzarone e Pantalone italiano.
Quando Murat tentò di aggirare il blocco continentale, cioè il divieto di commercio con l’Inghilterra
imposto a tutta l’Europa, una vera mostruosità che stava portando alla rovina l’intero continente,
Napoleone lo convocò a Parigi e lo minacciò: «Signor maresciallo, vi farò tagliare la testa!». Il blocco
continentale, pilastro della politica napoleonica per annientare l’Inghilterra, iniziato con la firma del trattato
di Berlino nel 1806, si stava rivelando rovinoso per le forze produttrici europee e causò una grande crisi
economica all’inizio del 1811. Nelle piazze ardevano enormi falò in cui venivano bruciate le merci
coloniali importate illegalmente, zucchero, caffè, indaco, cotone, tè, sotto gli occhi di popolazioni sempre
più esasperate verso una Francia non più liberatrice ma sfruttatrice e tiranna, che sopravviveva solo
grazie ai sussidi ricavati dalle esose contribuzioni estorte ai paesi vassalli. I giornali inglesi scrivevano
«Cesare ha perso la testa». In effetti, anche senza Lipsia, anche senza Waterloo, la barbarie del blocco
continentale avrebbe portato alla rovina la mastodontica costruzione imperiale: l’invio di crudeli satrapi
come il maresciallo Nicolas Davout, che ad Amburgo minacciava di punire i trasgressori delle leggi
francesi con cinquanta colpi di bastone, non contribuiva a pacificare gli animi. Quando lo Zar Alessandro
infranse il blocco, permettendo alle navi inglesi di raggiungere i suoi porti, fu la guerra e Napoleone
invase la Russia. Anche il re di Napoli vi partecipò, alla testa di un’unità di cavalleria che all’inizio contava
50 mila uomini e che alla fine si ridusse a non più di 1.200. Memorabili furono i suoi litigi con Davout, che
gli rimproverava di ingaggiare la cavalleria senza riconoscere il terreno e di far massacrare uomini e
cavalli inutilmente. Murat gli aveva risposto per le rime: «Quando si portano gli occhiali, signor
maresciallo (Davout era molto miope), non si fanno più campagne militari».
Pieno di ardore quando c’era da sferrare il coup de sabre decisivo, era però incostante e privo di spirito di
sacrificio durante le lunghe marce strategiche. In Russia Murat perse definitivamente la sua fede, già
vacillante, in Napoleone, che lo aveva nominato comandante in capo dell’armata durante la ritirata,
quando nel dicembre 1812 era stato costretto a rientrare frettolosamente a Parigi in seguito al tentativo di
colpo di Stato del generale Malet. Davanti ai marescialli allibiti, Gioacchino dichiarò che l’Imperatore era
ormai un fou, un insensé al quale nessun governante in Europa poteva più credere. Il capo di Stato
Maggiore Alexandre Berthier così scrisse, allarmato, al ministro della Guerra: «Il re di Napoli è il primo
uomo sul campo di battaglia, ma il più incapace come comandante in capo; bisogna sostituirlo subito con
il viceré (Eugenio Beauharnais) che è pieno di salute e di forza e ha la totale fiducia da parte del duca di
Elchingen (Ney) e del maresciallo Gouvion Saint Cyr». Carolina da Napoli lo scongiurava di restare al suo
posto: «Mon ami, calmati, non perdere il frutto di una campagna così pericolosa e brillante. Capisco le tue
sofferenze, ma ti scongiuro, abbi ancora un po’ di pazienza!» L’Imperatore tempestava: «Vostro marito
non ha coraggio morale, un capitano dei volteggiatori avrebbe comandato meglio di lui». Murat intanto si
dichiarava malato e alle quattro del mattino del 17 gennaio 1813 lasciava il quartiere generale dell’armata
a Vilna e si dirigeva verso Napoli sbraitando: «Non mi farò prendere in questo pot de chambre!». Tornato
nel suo regno, iniziò una frenetica politica del doppio gioco, sostenuto dalla regina, per conservare ad
ogni costo il trono negli anni di agonia dell’Impero. Già sul punto di firmare un accordo con gli austriaci,
combatté nella campagna di Germania, ma dopo la sconfitta di Lipsia nell’ottobre del 1813, lasciò
l’esercito e l’Imperatore, che non doveva più rivedere. Nel gennaio dell’anno successivo firmò un trattato
segreto con Austria e Gran Bretagna e intervenne con i suoi 30 mila uomini a fianco delle potenze alleate
marciando contro l’esercito franco-italiano di Eugenio e affrontandolo sul Taro, presso Reggio. Napoleone
giudicò la sua condotta infame e lo bollò con l’appellativo di traitre extraordinaire. In realtà Murat aveva le
mani legate: aveva agito con l’unico scopo di evitare l’invasione del suo regno e la restaurazione dei
Borboni.
Ma dopo la prima abdicazione di Napoleone, nell’aprile del 1814, lo aspettava un’amara sorpresa: gli
alleati e soprattutto l’Inghilterra si rifiutarono di riconoscerlo e preparavano un ritorno di re Ferdinando,
esiliato dal 1806 in Sicilia. A questo punto l’unica carta che gli restava da giocare era quella, azzardata
ma nobile, dell’unità italiana: «Un re che non sa conservare la sua corona - sosteneva - deve almeno
morire da soldato». Incoraggiato dall’incredibile sbarco a Cannes di un redivivo Bonaparte, che in pochi
giorni riconquistò la Francia, con un ulteriore rovesciamento di alleanze, nel marzo del 1815, alla testa di
circa 36 mila napoletani, si mosse verso il nord Italia per affrontare gli austriaci, con il sogno di
conquistare la penisola e dichiararne l’indipendenza, come aveva enunciato nel proclama indirizzato agli
italiani e firmato a Rimini il 30 marzo. Il suo esercito, dopo alcuni parziali successi, venne però sconfitto a
Tolentino il 2 e il 3 maggio, battaglia che alcuni storici considerano la prima del Risorgimento italiano. Il
20 maggio, in seguito al trattato di Casalanza, il re Ferdinando IV di Borbone veniva richiamato a Napoli,
Carolina si consegnava agli inglesi e Murat era costretto a rifugiarsi in Provenza. Napoleone rifiutò di
impiegare il traitre extraordinaire a Waterloo e dopo la catastrofe in Belgio, Gioacchino, braccato, fuggì in
Corsica. Da quest’isola partì per la sua ultima tragica, fatale avventura.
Qui comincia il mistero: possibile che abbia veramente creduto di potere riconquistare Napoli sbarcando
in Calabria con trenta disperati còrsi? Appare molto più plausibile la tesi secondo la quale sia caduto in
una trappola abilmente ordita da agenti segreti borbonici e inglesi. Dichiarato ormai hors la loi (fuorilegge)
era stato avvicinato a Bastia da un suo ex-aiutante di campo, l’ambiguo colonnello inglese Francis
Macirone, che gli aveva consegnato i passaporti, preparati dal principe Metternich, per raggiungere in
esilio Carolina a Trieste, dove si era rifugiata sotto il falso nome di contessa di Lipona (anagramma di
Napoli). Contemporaneamente venne avvicinato da due agenti borbonici, inviati dal ministro di re
Ferdinado IV, Luigi de Medici, che aveva giurato la sua rovina, e da questi attirato in Calabria facendogli
credere che i napoletani erano scontenti e pronti a sollevarsi a suo favore. Esaltato da questa falsa
informazione e arruolati circa 250 uomini e cinque battelli, Gioacchino tentò la sorte; l’8 ottobre 1815
sbarcò a Pizzo Calabro: le sue schiere si erano molto assottigliate perché un’improvvisa burrasca aveva
disperso quattro delle sue navi, che erano scomparse. Sembra che a questo punto Murat avesse
considerato fallito il suo tentativo e volesse proseguire per Trieste per raggiungere sano e salvo la
famiglia. Ma per un malinteso, o forse per il tradimento del comandante della sua nave, il maltese
Barbara, fu costretto a sbarcare con un pugno di uomini: a Pizzo era domenica, giorno di mercato, la
piazza era gremita; in poco tempo si svuotò, mentre Gioacchino invano tentava di farsi riconoscere.
All’improvviso arrivò un drappello di gendarmi che iniziò a sparare sul gruppo, uccidendo tre uomini.
Murat tentò di fuggire verso la spiaggia, ma venne inseguito, arrestato e portato, coi vestiti a brandelli e
coperto di graffi, nella tetra cella detta «del coccodrillo» presso il castello di Pizzo. Il suo funereo destino
era segnato. Alla corte di Napoli ci si congratulava per il successo dell’operazione, l’unico dubbio
riguardava l’esito del processo: si temeva, con una condanna a morte, di offendere l’Austria, poiché
Gioacchino era cognato dell’Imperatrice Maria Luisa, e per i legami che univano Carolina a Metternich,
suo ex-amante. Ma l’ambasciatore inglese, William A’Court, esclamò implacabile: «Ammazzatelo, me ne
assumo la totale responsabilità». Fu istituita una commissione militare, giudicata illegale dall’ex-sovrano,
che rifiutò sia l’avvocato, il capitano Starace, sia di comparire di fronte al tribunale. L’ordine era di
«emettere la sentenza e di procedere all’esecuzione del generale Murat con un quarto d’ora per i conforti
religiosi». Nel tardo pomeriggio del 13 ottobre venne fucilato. Le sue ultime parole furono: «Soldati,
mirate al cuore, ma risparmiate il viso!». La sua ultima vanità, ma non venne ascoltato, poiché fu
necessario finirlo con due colpi di grazia alla testa. Con il consueto glaciale cinismo Napoleone
commentò da Sant’Elena: «Ha avuto quello che si meritava, è morto come un vulgaire chef de bande…
Con me era il mio braccio destro, lasciato a se stesso era un imbécile senza giudizio… I calabresi,
fucilandolo, si sono mostrati più pietosi di chi mi ha imprigionato qui». Carolina Murat si ritrovava così
vedova a soli trentasette anni, esiliata, con quattro figli, e scarse risorse economiche. Da Trieste fu
trasferita a Praga e quindi in Austria: era molto ingrassata, l’eterno sorriso si era trasformato in una
smorfia sprezzante «che non le donava affatto», ma aveva trovato un nuovo spasimante, il generale
Francesco Macdonald, suo ex ministro della guerra, con il quale forse si sposò segretamente. Nel 1830 e
nel 1838 fece due brevi soggiorni a Parigi, dove il governo le aveva finalmente concesso un vitalizio
annuale di centomila franchi. Non ne usufruì mai, poiché morì il 18 maggio 1839 a Firenze, dove fu
sepolta, nella chiesa di Ognissanti. Il corpo dello sfortunato re giacobino era stato invece gettato in una
fossa comune e sebbene non sia mai stato identificato, si suppone riposi sotto la lapide posta nella
navata centrale della chiesa di San Giorgio a Pizzo, con la semplice iscrizione: «Qui è sepolto Re
Gioacchino Murat». Il grande poeta George Byron aveva così commentato, commosso, la scomparsa di
un tale magnifico cavaliere: «Povero, caro Murat, che brutta fine! Sono certo che le sue piume bianche
fossero un punto di riferimento in battaglia, come quelle di Enrico IV».
Anna Maria Vischi Ghisetti