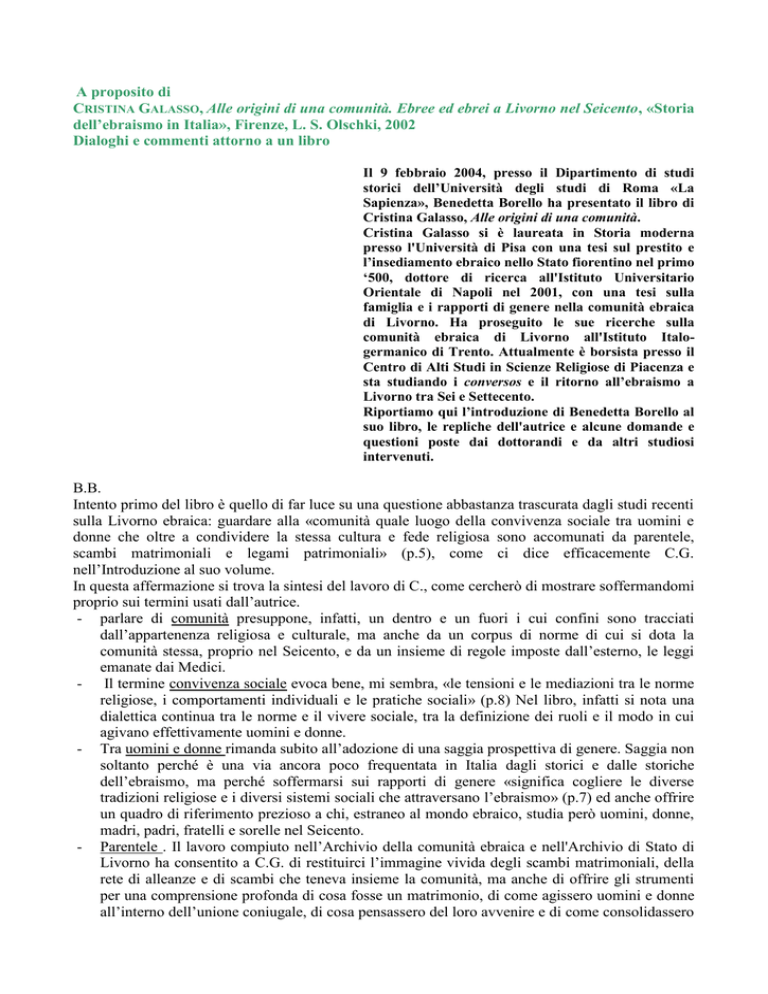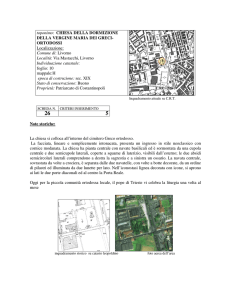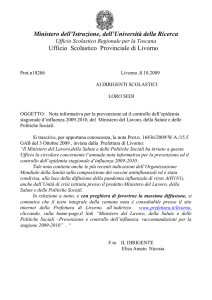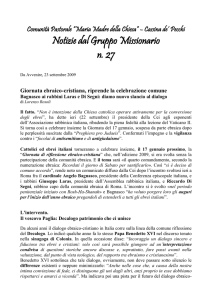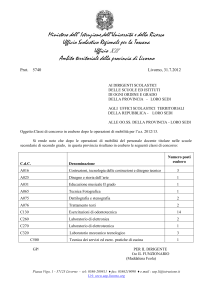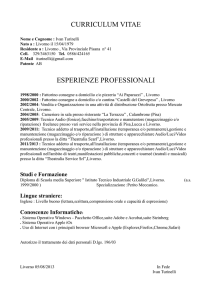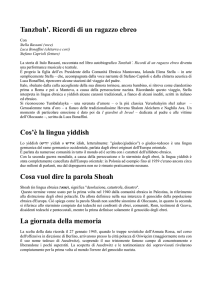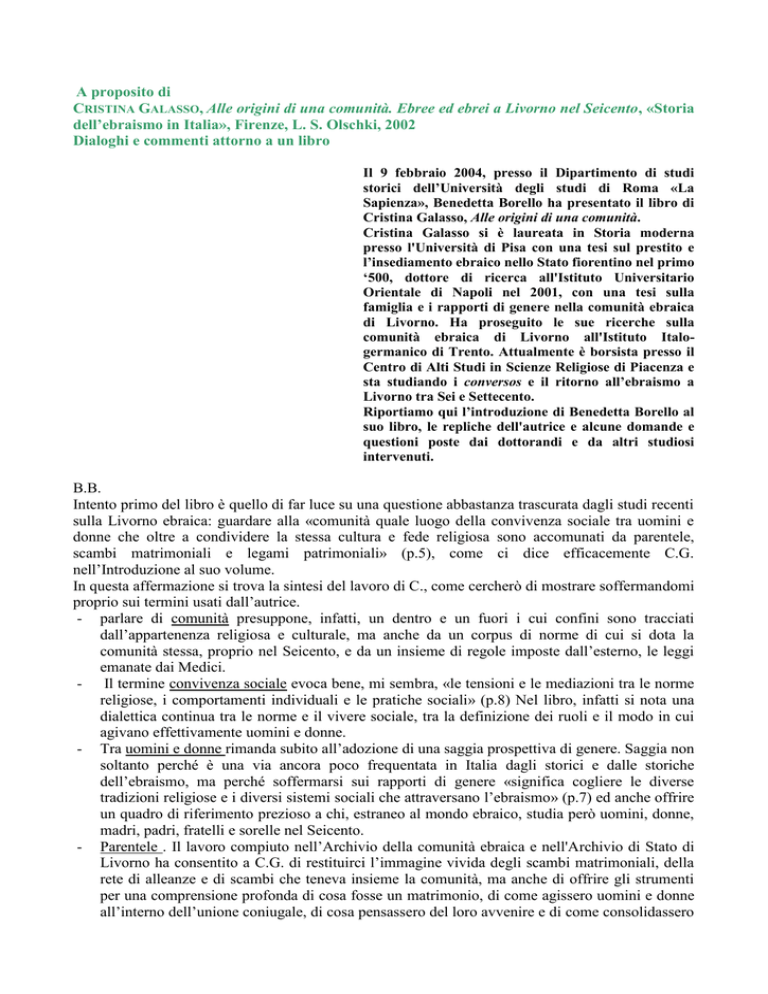
A proposito di
CRISTINA GALASSO, Alle origini di una comunità. Ebree ed ebrei a Livorno nel Seicento, «Storia
dell’ebraismo in Italia», Firenze, L. S. Olschki, 2002
Dialoghi e commenti attorno a un libro
Il 9 febbraio 2004, presso il Dipartimento di studi
storici dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza», Benedetta Borello ha presentato il libro di
Cristina Galasso, Alle origini di una comunità.
Cristina Galasso si è laureata in Storia moderna
presso l'Università di Pisa con una tesi sul prestito e
l’insediamento ebraico nello Stato fiorentino nel primo
‘500, dottore di ricerca all'Istituto Universitario
Orientale di Napoli nel 2001, con una tesi sulla
famiglia e i rapporti di genere nella comunità ebraica
di Livorno. Ha proseguito le sue ricerche sulla
comunità ebraica di Livorno all'Istituto Italogermanico di Trento. Attualmente è borsista presso il
Centro di Alti Studi in Scienze Religiose di Piacenza e
sta studiando i conversos e il ritorno all’ebraismo a
Livorno tra Sei e Settecento.
Riportiamo qui l’introduzione di Benedetta Borello al
suo libro, le repliche dell'autrice e alcune domande e
questioni poste dai dottorandi e da altri studiosi
intervenuti.
B.B.
Intento primo del libro è quello di far luce su una questione abbastanza trascurata dagli studi recenti
sulla Livorno ebraica: guardare alla «comunità quale luogo della convivenza sociale tra uomini e
donne che oltre a condividere la stessa cultura e fede religiosa sono accomunati da parentele,
scambi matrimoniali e legami patrimoniali» (p.5), come ci dice efficacemente C.G.
nell’Introduzione al suo volume.
In questa affermazione si trova la sintesi del lavoro di C., come cercherò di mostrare soffermandomi
proprio sui termini usati dall’autrice.
- parlare di comunità presuppone, infatti, un dentro e un fuori i cui confini sono tracciati
dall’appartenenza religiosa e culturale, ma anche da un corpus di norme di cui si dota la
comunità stessa, proprio nel Seicento, e da un insieme di regole imposte dall’esterno, le leggi
emanate dai Medici.
- Il termine convivenza sociale evoca bene, mi sembra, «le tensioni e le mediazioni tra le norme
religiose, i comportamenti individuali e le pratiche sociali» (p.8) Nel libro, infatti si nota una
dialettica continua tra le norme e il vivere sociale, tra la definizione dei ruoli e il modo in cui
agivano effettivamente uomini e donne.
- Tra uomini e donne rimanda subito all’adozione di una saggia prospettiva di genere. Saggia non
soltanto perché è una via ancora poco frequentata in Italia dagli storici e dalle storiche
dell’ebraismo, ma perché soffermarsi sui rapporti di genere «significa cogliere le diverse
tradizioni religiose e i diversi sistemi sociali che attraversano l’ebraismo» (p.7) ed anche offrire
un quadro di riferimento prezioso a chi, estraneo al mondo ebraico, studia però uomini, donne,
madri, padri, fratelli e sorelle nel Seicento.
- Parentele . Il lavoro compiuto nell’Archivio della comunità ebraica e nell'Archivio di Stato di
Livorno ha consentito a C.G. di restituirci l’immagine vivida degli scambi matrimoniali, della
rete di alleanze e di scambi che teneva insieme la comunità, ma anche di offrire gli strumenti
per una comprensione profonda di cosa fosse un matrimonio, di come agissero uomini e donne
all’interno dell’unione coniugale, di cosa pensassero del loro avvenire e di come consolidassero
i legami, patrimoniali e di affetto, con i loro discendenti. Non è un caso mi sembra che la parte
più corposa del libro sia proprio il secondo capitolo dedicato alle famiglie.
Ma come è strutturato questo lavoro?
Il libro si articola in quattro capitoli.
Nel primo l’autrice spiega perché Livorno è una “città di nazioni” e perché gli ebrei vengono
considerati nel Seicento una "nazione", al pari degli alemanni a Roma per esempio.
Interrogarsi all’inizio del libro sulle caratteristiche del flusso migratorio aiuta a comprendere la
configurazione della comunità e a delineare le sue caratteristiche.
A Livorno arrivano intere famiglie ma anche donne sole dalla Toscana e dall’Italia Centro
Settentrionale. Permettere agli ebrei di entrare a far parte di una nazione è coerente con una parte
degli obiettivi medicei cioè con l’idea di privilegiare i forestieri e «dare vita ad una città che
proprio nei forestieri possa trovare le ragioni del suo sviluppo» (p.19). Questo stesso progetto è
invece in antitesi con la politica antiebraica perseguita dagli stessi Granduchi a Firenze e a Siena e
con la costruzione dei ghetti. Livorno, al contrario «è una città senza ghetto, perché innanzitutto è
una città di nazioni, dove cioè si privilegia lo status di forestiero e immigrato e non solo quello di
ebreo» (p.25)
Il secondo e, più corposo capitolo, è quello dedicato alla famiglia. La famiglia è infatti «il nucleo
centrale della società ebraica, attorno a cui ruotano gran parte delle relazioni, delle ricchezze, delle
solidarietà degli individui e del gruppo». (p. 27)
Il matrimonio è l’istituzione fondante di questo nucleo chiave. Non ci sono dubbi in proposito: la
ricerca compiuta da C.G. le consente senza troppa fatica di concludere che «la legislazione, i
testamenti, gli atti civili e criminali mostrano quanto la famiglia e il matrimonio costituiscano il
principale scenario dell’azione e del pensiero degli ebrei e delle ebree di Livorno» (p.27)
A differenza di quello cristiano il matrimonio ebraico «non è un patto sacro e indissolubile, ma un
contratto tra individui»(p.8) che si scambiano dote e controdote.
Il mercato matrimoniale è caratterizzato
- da una forte endogamia
- scambi e trasmissioni patrimoniali che non seguono soltanto una logica patrilineare
- spazi di contrattazione tra i generi (alle donne ebree viene concesso un certo grado di
autonomia e libertà, maggiore di quello delle cristiane e soprattutto è maggiore la capacità di
gestione di sé e dei propri beni).
- Rispetto di particolari pratiche matrimoniali, come levirato e bigamia.
Per far capire quanto ho detto vorrei ricorrere ad esempio concreto, un caso presentato nel libro che
ci consente di riflettere su alcuni elementi chiave della famiglia, in particolare di quella sefardita,
cioè di origine iberica, dell’alleanza matrimoniale e della trasmissione patrilineare nella comunità
ebraica di Livorno. La storia è un po’ complicata e ricorrerò a una rappresentazione grafica.
Matrimonio tra Jacob Fernandes Nunes e Judica de Almeida
Jacob
Fernandes Nunes
Judica
De Almeida
Nel 1663 viene celebrato il matrimonio tra Jacob e Judica. Al momento delle nozze, Jacob è già
sposato con una donna da cui ha avuto dei figli.
Jacob, inoltre, è lo zio di Judica. L’uomo, al quale la famiglia di Judica aveva affidato la dote,
avrebbe dovuto trovarle un marito, in realtà ha rapporti con lei e Judica rimane incinta. Jacob, però,
non può e non vuole divorziare, perché non può restituire la dote alla sua prima moglie.
In difficoltà, l’uomo prova ad allontanare Judica da Livorno, mandandola ad Alessandria dal
fratello. I Massari di Livorno, consultati i rabbini, stabiliscono però che Judica abbia diritto al
legame coniugale con Jacob, che i due abbiano un «congiungimento usuale e cotidiano», e che
Jacob provveda al mantenimento della seconda moglie e della figlia nata da quell’unione.
Judica ha l’appoggio della sorella Sara, sposata con Abramo de Campos. Jacob temporeggia e le
due sorelle decidono di rivolgersi al Tribunale del Governatore di Livorno, perché temono che tra i
Massari ci possano essere persone troppo vicine a Jacob. Alla fine il Governatore, in accordo con il
Granduca stabilisce che la causa debba essere giudicata dai Massari con il voto di 3 rabbini.
Il base a quest’ultima sentenza, Jacob deve rimanere sposato a Judica, provvedere al suo
mantenimento e a quello della bambina e persino pagare una balia perché la donna è malata e non
può allattare.
Famiglia di Judica De Almeida
Judica
Jacob
Sara
Abramo
de Campos
Questa vicenda consente di delineare almeno sei elementi chiave.
1) Bigamia : è considerata dal tribunale ebraico l’unica soluzione possibile, benché contraria alla
legge che generalmente prevede che un uomo possa prendere una seconda moglie senza
divorziare dalla prima se è senza figli o in rispetto del levirato (l’obbligo cioè di sposare la
2)
3)
4)
5)
6)
cognata, rimasta vedova e senza figli). Non è questo il caso perché Jacob ha dei figli dal primo
matrimonio né può divorziare dalla prima moglie perché non può restituirle la dote. «Qui la
legge viene piegata di fronte alla rottura di un vincolo e di una fiducia familiare che nessun
uomo può riparare se non chi l’ha provocata» (p.31), ci suggerisce bene C.G.
Onore e destino matrimoniale di Judica: è un elemento forte, mi sembra una sorta di principio
costituzionale che riesce a modificare la legge. Non è chiaro se questa causa diventa una sorta
di giurisprudenza, ma nel 1671 il governo della comunità inserisce nei propri statuti un capitolo
in cui obbliga il marito che prende una seconda moglie a depositare la dote della prima presso i
Depositari della Scuola i quali amministreranno gli utili «per alimenti e onore della 1° moglie».
Dote La dote conferisce un tal potere alle donne ebree che, addirittura, in un altro caso bigamia
presentato da C.G. è previsto dalla ketubà (contratto di nozze) che essa debba «restare in potere
della sposa, la quale ne disporrà come meglio crede, senza che lo sposo abbia su quel denaro
nessun potere e facoltà.» (p.34). Quello ebraico è un sistema di scambi matrimoniali scanditi da
doti e controdoti, sistema non del tutto antitetico a quello cristiano. Non sono rari neanche qui i
casi in cui le donne ricorrono ai tribunali, di prima o di seconda istanza perché il marito
sperpera la dote che deve servire per sostenere gli onera matrimonii. Maggiori sono i vincoli
alla gestione femminile del patrimonio. La comunità ebraica sembra far propria una «logica di
totale scambio e reciprocità» (p.41). «Impedire che le donne partecipino alla costruzione e al
mantenimento di questa area di scambi significherebbe congelare e mettere a rischio un intero
sistema sociale: sono infatti le donne a garantirne il funzionamento in quanto soggetti mobili e
intestatarie di doti, attraverso cui i beni si spostano da una famiglia all’altra» (pp.45-46). La
stessa preoccupazione di far circolare i beni femminili si avverte in ambito cristiano per i
cosiddetti stradotali (che possono confluire in nuove doti o servire a incrementare il patrimonio
dei cadetti). E’ certo comunque che nella comunità ebraica l’assenza di primogeniture e di
celibato imprime maggiore velocità alla circolazione di questi beni.
Inopia dell’uomo Dato tutto questo e dato soprattutto che il matrimonio è uno scambio
«reciproco e paritario di risorse», si comprende bene come altro elemento chiave del sistema
matrimoniale ebraico sia proprio la necessità di colpire l’inopia del marito. Con la delibera del
1671 sopra citata, che tutela la dote della prima moglie e che imponene il mantenimento della
seconda mi sembra che si eviti che la bigamia «diventi un mero espediente da parte maschile
per accedere a nuove risorse economiche» (p.32). In questo e in altri casi di fallimento del
marito C.G. fa vedere bene come « le donne conoscano bene i propri diritti e quanto sappiano
esercitarli in virtù dei propri diritti dotali, ma più in generale in virtù dell’idea di scambio e di
reciprocità del matrimonio, anzi addirittura di “parità coniugale”, come esse stesse dichiarano
di fronte ai giudici» (p.54) Proprio quest’idea della parità e della reciprocità è la caratteristica
del mondo ebraico. Come già dicevo se le carte dei tribunali cristiani e della Rota romana sono
piene di controversie sulla dote e sulla cattiva amministrazione maritale, non mi è parso di
vedere nella logica che ispirava l’azione delle proponenti lo stesso principio di parità. Rese
incapaci di amministrare, le cristiane adottano strategie diverse a difesa del loro patrimonio, più
giocate sugli alimenti e sul fatto di essere creditrici. Questo è un punto che vorrei sviluppare
nella discussione.
Solidarietà femminile Come Judica che gode dell’appoggio della sorella Sara, le donne quando
portano le loro ragioni davanti ai tribunali «possono trovare l’aiuto di altre donne e con queste
condividere gli sforzi e le strategie legali». (p.57) In caso di fallimento di un'impresa
commerciale, in cui le donne hanno investito la loro dote non è raro trovare la figura delle
«consorti in lite». Non di rado questo accade anche nel mondo cristiano, soprattutto quando
parenti e sorelle diventano una riserva di appoggi legali o di sostegni politici.
Capacità di rivolgersi all’istituzione più idonea a far rispettare i propri interessi:
preoccupazione di Judica e Sara che temono il giudizio viziato del Tribunale dei Massari e si
rivolgono al Tribunale del Governatore, ma abilità comune anche agli altri ebrei. Come si vede
più ampiamente nel terzo capitolo, la ricerca di C.G. sembra confermare il dato già emerso
dagli studi di Simona Feci su Roma [Tra il tribunale e il ghetto: le magistrature, la comunità e
gli individui di fronte ai reati degli ebrei romani nel Seicento, in "Quaderni Storici", 99 (1998)
Ebrei sotto processo], quando si rivolgono alla giustizia granducale ebrei e ebree dimostrano
grande «padronanza nell’uso degli strumenti che il giudizio consente e capacità di criticare i
singoli atti processuali» (Feci cit. p.101). Sotto questo profilo mi pare emergere una
caratteristica più generale di Antico Regime: l’attore sociale che si sottopone al giudizio o che,
anche senza giudizio, porta le sue ragioni in tribunale ha l’abilità di presentasi sotto la luce più
favorevole o gradita all’istituzione. L’appartenenza allora può non essere più netta, ma sfumata
nella complicità che ebrei e cristiani dimostrano in particolari circostanze. Livorno, d’altro
canto, è una città senza ghetto e le relazioni ebraico-cristiane «sono continue e profonde e
quindi difficili da controllare e da reprimere» (p.108)
Torno ora per un momento ad altro argomenti affrontati nel secondo capitolo per porre altrettante
questioni relative al parallelismo con il mondo cristiano
I testamenti da cui «emergono i meccanismi di trasmissione dei beni, le tensioni familiari e le
negoziazioni tra uomini e donne che attraverso lo strumento testamentario possono fare deroghe e
modifiche al sistema di devoluzione patrimoniale» (pp.72-73), presentano singolari somiglianze
con il sistema cristiano di trasmissione patrimoniale, fatte salve sempre le differenze
macroscopiche legate all'assenza di primogenitura.
Una perfetta coincidenza tra spose cristiane ed ebree mi sembra che ci sia, per esempio, per la
libera disposizione degli stradotali. Anche le donne ebree, inoltre, avevano maggiore libertà di
testare rispetto agli uomini, privilegiando, inoltre, figli e nipoti. Come in ambito cristiano, inoltre,
«nei testamenti femminili gli affetti sono protagonisti … traspaiono più facilmente legami affettivi
[laddove gli uomini fanno un elenco di quello che hanno] … testimonianza più forte dei vissuti e
delle relazioni [legami affettivi dunque, ma anche rancori]» (p.84)
Una curiosità inoltre: il senso delle lacrime e della disperazione e il rituale del dolore.
Daniel Ribero Enriques fa scrivere nelle sue ultime volontà che moglie e figlie, durante la sua
veglia funebre, avrebbero dovuto pagare due uomini per vegliarlo, mentre esse sarebbero dovute
rimanere in un’altra stanza «senza pianti e considerazioni» (p.82).
L'altra questione sulla quale mi vorrei soffermare riguarda la tutela pupillare.
Le donne ebree sono effettivamente più libere delle cristiane di occuparsi dei figli e una
spiegazione va ricercata nel «rapporto materno [che], a differenza di quello paterno è un legame
naturale incondizionato e irreversibile» e nella «diversa concezione di mater e paterfamilias, grazie
alla quale intercorrono rapporti meno asimmetrici tra i generi» (p.92)
Le madri ebree possono aver voce nella nomina del tutore. Ma cosa succede effettivamente in caso
di divorzio?
Il libro si chiude con la solidarietà, cioè con un quadro del “welfare” ebraico di Livorno. L’analisi
del funzionamento della confraternita per maritare le donzelle, del sistema dei sussidi di viaggio,
dei sussidi per gli ebrei indigenti e degli strumenti messi in atto per riscattare gli ebrei in schiavitù,
ci riporta un po’ all’inizio, alla costituzione e alla vita della comunità vera e propria, alle origini di
una comunità, insomma, per riprendere il titolo del libro. E’ un peccato che il cerchio si chiuda
senza poter dare un quadro, probabilmente per mancanza o povertà del materiale archivistico,
altrettanto vivido di questi strumenti. Mentre la famiglia spicca, queste forme di solidarietà su cui
sarei curiosissima di sapere di più restano in secondo piano, riflettendo, probabilmente il peso che
la comunità annetteva all’una e alle altre.
Credo di aver sollevato abbastanza questioni, avendone volutamente taciute altre, che per ragioni di
tempo e di spazio ho tralasciato. Lascio quindi la parola a C.G. per le repliche.
C.G.
Ti ringrazio moltissimo Benedetta per aver così sinteticamente e, allo stesso tempo, chiaramente
esposto gli aspetti principali del mio lavoro che, come hai osservato, si è soprattutto concentrato
sullo studio del sistema familiare e dei rapporti tra i generi all’interno della comunità ebraica di
Livorno. Prima di rispondere alle tue sollecitazioni, vorrei sottolineare che la comunità livornese è
una comunità sefardita, di origine cioè iberica, composta, soprattutto nel Seicento, da ex-conversos.
Ciò influenza profondamente la struttura familiare e comunitaria, il rispetto di pratiche
matrimoniali e religiose (vedi appunto la bigamia e il levirato che, invece, nelle comunità
ashkenazite erano scomparse fin dal Medioevo). D’altra parte l’autonomia che la comunità di
Livorno gode a livello politico, economico e religioso è proprio dovuta al fatto che i Medici
intendevano favorire l’insediamento di ebrei iberici e con loro lo sviluppo di una grande economia
mercantile aperta sul Mediterraneo.
Venendo a quanto mi chiedevi sul divorzio e sul destino dei figli. Le leggi ebraiche che normano la
tutela dei pupilli in caso di morte paterna derivano da quanto prevede la halachà (legge ebraica) in
caso di divorzio. Il principio che i giudici sono tenuti a rispettare quando affidano ad uno o all’altro
genitore la custodia dei figli è lo stesso di quando sono chiamati a decidere se i pupilli debbano
stare con la madre o con gli zii, ovvero quello del miglior interesse dei bambini. Non esiste cioè,
secondo la legge ebraica, un diritto superiore dei genitori (in particolare del padre) o dei familiari
(in particolare gli zii) ma esiste innanzittuto il diritto dei figli a vivere con il genitore o il tutore che
sappia garantire al meglio il loro interesse. Ciò apre, in caso di divorzio o di morte paterna, un
confronto talvolta molto accesso tra il genitore, i giudici e i familiari il cui esito non è scontato,
anche quando la madre passa a nuove nozze, perché ciò che conta è l’interesse dei figli e questo
principio offre alle madri ebree dei margini di manovra sconosciuti alle cristiane.
Altro punto che sollevavi: la “parità” rivendicata dalle mogli di falliti. Questo è un concetto
estraneo alla società cristiana. La moglie ebrea in caso di fallimento del marito rivendica la
restituzione della dote non soltanto perché ‘creditrice’ e perché così può mantenere la famiglia ma
soprattutto perché il marito, avendo perso tutti i suoi beni, non è più pari suo (e nei documenti
troviamo proprio il termine di “pari”), non può cioè più garantire alla moglie quella parità e
reciprocità di status e di risorse che è alla base dell’unione matrimoniale, della ‘società’ che con le
nozze si viene a creare tra moglie e marito. Il fallimento finanziario del marito provoca cioè un
mutamento nelle condizioni originarie del matrimonio, quando egli «stava bene e da pari suo,
attendeva alla Piazza et alimentava se et sua famiglia convenientemente». Il fallimento creando una
disparità all’interno della coppia, di fatto vede il marito delegittimato a rappresentare la moglie, ad
amministrare i beni dotali e quelli familiari.
Infine, è vero, come tu dicevi, che la parte del libro dedicata all’organizzazione comunitaria è
meno ‘vivida’ di quella dedicata alla famiglia. Ciò è in parte dovuto alla scarsità di fonti che invece
per quanto riguarda il sistema familiare sono abbondanti (testamenti, atti nuziali, atti civili, delibere,
responsa rabbinici), ma forse è anche dovuto alla prospettiva e all’interesse che ha guidato il mio
lavoro. Mi spiego meglio: più o meno consapevolmente, ho privilegiato lo studio della famiglia e
dei suoi meccanismi, lasciando più in ombra il tema della vita comunitaria, non solo perché questo
era il mio principale e originario oggetto di studio ma perché avevo l’impressione (o forse la
presunzione di pensare) che non avrei potuto capire davvero la vita comunitaria, l’organizzazione e
le istituzioni della comunità, se non avessi studiato a fondo il sistema familiare e i rapporti di
genere, se non avessi ricostruito quel tessuto sociale, relazionale, patrimoniale dal quale poi la
comunità traeva risorse ed energie per svilupparsi nel suo insieme. Così mi sono concentrata
soprattutto su questo aspetto e poi, chissà, il resto lo farò in un altro libro. In fondo, ogni lettura e
scrittura della storia è parziale e incompleta.
Ringrazio C.G. per le spiegazioni che credo che abbiano sollevato abbastanza curiosità, quindi
invito a porre domande o questioni.
Domenico Rizzo: Quanto una città con il ghetto o senza ghetto incide al livello delle relazioni con
la giustizia ?
C.G. Nel rapporto con la giustizia, a mio avviso, l’assenza di ghetto di per sé non significa molto,
se ad essa non si aggiunono tutta una serie di diritti e riconoscimenti. A Livorno credo che nel
rapporto tra ebrei e giustizia più che l’assenza del ghetto incidesse l’esistenza delle Livornine, dei
privilegi granducali che garantivano agli ebrei, oltre alla tolleranza religiosa, l’autonomia politica e
giurisdizionale, l’esistenza di un tribunale rabbinico a cui spettavano tutte le cause tra ebrei. Tutto
ciò favoriva lo sviluppo di una giustizia ebraica che normava e disciplinava la vita individuale e
comunitaria sulla base di leggi e necessità proprie e che, allo stesso tempo, si confrontava con
quella cristiana senza subirla o subendola molto poco rispetto ad altre realtà, dove gli ebrei non
potevano amministrarsi e giudicarsi autonomamente. Il Governatore di Livorno e il Granduca
fungevano da corti di appello ma quasi sempre le autorità giudiziarie cristiane rimandavano le
cause ai Massari e ai rabbini della comunità perché, come più volte scrive il Granduca al
Governatore, bisognava salvaguardare l’autonomia del tribunale ebraico e non irritare una
‘nazione’ così importante dal punto di vista economico. D’altra parte questo rapporto privilegiato
tra gli ebrei di Livorno e il Granduca spingeva gli ebrei a rivolgersi non di rado alla giustizia
granducale. Così non era tanto il Granduca a voler entrare negli affari interni della nazione ebraica
ma erano piuttosto gli ebrei, spesso in conflitto con il governo della propria comunità, a usare
strumentalmente le autorità granducali per influenzare e modificare la giustizia ebraica.
Marina D'Amelia: Chiederei a C.G. di soffermarsi sull'aspetto dei matrimoni misti.
C.G. Se per matrimoni misti intendi quelli tra ebrei e cristiani, questi non c’erano né a Livorno né
altrove perché proibiti da una e dall’altra religione. Vi erano però matrimoni tra cristiani/e e
convertiti/e. I convertiti a Livorno, almeno nel Seicento, non erano moltissimi perché la comunità
era molto coesa e le Livornine garantivano agli ebrei alcuni diritti che andavano proprio a
contenere, se non addirittura, a vanificare le pressioni conversionistiche della Chiesa. Come già
Luciano Allegra ha osservato per Torino, uomini e donne si convertivano in modo e misura
diversa, anche se entrambi tendono a convertirsi soprattutto in età nuziale (la conversione, dunque,
era anche un modo per allargare il mercato matrimoniale). Anche a Livorno erano soprattutto gli
uomini a convertirsi e lo facevano in virtù di una scelta che era non di rado individuale e che quasi
sempre nasceva dalla necessità di aprirsi nuove opportunità di vita, di fuggire da un contesto
familiare e sociale in cui non riuscivano ad integrarsi. Le donne, invece, si convertivano poco e
sono molti i casi di donne che preferiscono non seguire il marito nella scelta conversionistica
incorrendo in problemi di ordine sociale e giuridico che puoi immaginare. Le donne, d’altra parte,
quando si convertivano lo facevano preferibilmente insieme al proprio gruppo familiare, raramente
si convertivano da sole e quando ciò accadeva, alla conversione seguiva quasi automaticamente
anche il matrimonio con un cristiano.
Lea Nocera: Mentre in ambito cristiano i rapporti con il clero sono molto stretti, questo manca
totalmente nel mondo ebraico, la forza di coesione sembra essere la famiglia.
C.G. La famiglia è un forte elemento di coesione in tutte le società di antico regime e, dunque,
anche in ambito cristiano ma è vero che la mancanza di un clero e, soprattutto, di un celibato e
nubilato religioso fanno sì che in ambito ebraico il matrimonio sia, per così dire, una scelta
obbligata e, quindi, che la famiglia e il rapporto coniugale, sul quale essa si basa, diventi un nodo
cruciale dell’organizzazione sociale. Avere un rabbino in famiglia non è la stessa cosa che avere un
prete, non produce gli stessi effetti a livello sociale e simbolico proprio perché anche i rabbini si
sposano e fanno figli e vivono dunque come e con gli altri uomini.
Stefano Chianese: Livorno nel Seicento è una città in espansione, questo influisce sulla vita della
comunità e nel coinvolgimento delle donne nella mercatura ?
C.G. I destini della comunità ebraica e della città di Livorno saranno per lungo tempo strettamente
legati uno all’altro. La nascita della città coincide con quella della comunità ebraica, anzi senza
quest'ultima la città non avrebbe potuto conoscere quello sviluppo straordinario che ebbe
soprattutto a livello economico. La mercatura era l’attività a cui la comunità ebraica livornese
doveva la sua prosperità e la forza dei suoi privilegi. Da essa le donne non era escluse tout court. In
tutte le società a forte impronta mercantile le donne hanno più spazi di manovra e di azione a
livello economico, valga per tutti l’esempio di Venezia. Così anche a Livorno vi erano delle ebree
impegnate in attività mercantili, soprattuto vedove, moglie e figlie di mercanti che gestivano
l’attività che era stata del marito, spesso coadiuvate da soci e/o da familiari. Ma gran parte del
potere economico e sociale delle ebree livornesi non veniva da questo ma, più in generale,
dall’essere intestatarie di doti, ovvero di capitali che rappresentavano parti importanti del
patrimonio della famiglia di origine e che, dopo le nozze, venivano investiti in attività da cui
dipendevano le sorti economiche di intere famiglie. Il loro cioè non era un potere diretto che veniva
dal gestire attività economiche e patrimoni ma piuttosto un potere indiretto, ma non per questo
meno forte, che conferiva loro grande forza contrattuale rispetto all’autorità maritale e maschile.
Ovviamente ciò vale anche per le cristiane ma le ebree hanno capitali dotali tendenzialmente più
alti (anche se per Livorno non è possibile fare un confronto perché non esistono studi sulle doti
cristiane o di altre comunità) e vivono anche in un diverso contesto sociale e giuridico. Inoltre,
credo che vivere in comunità di minoranza favorisca un rapporto meno asimmetrico tra i generi
perché per sopravvivere alle pressioni della società dominante è necessario il contributo di tutti e,
dunque, anche delle donne.
Simona Feci: Gli studi di storia sociale su comunità ebraiche sono molto rari. Mi sembra quindi da
apprezzare questo lavoro di smontamento e di decostruzione della comunità. Nell’ebraismo ci sono
differenze sociali, culturali e religiose, non è una realtà monolitica.
C.G. E’ vero l’ebraismo non è così omogeneo e uguale attraverso il tempo e lo spazio come spesso
siamo portati a pensare e non soltanto in virtù delle grandi differenze tra ebraismo sefardita e
ashkenazita (e italiano). Ogni comunità ebraica si doveva confrontare con la società nella quale
viveva e, allo stesso tempo, con le differenze che la percorrevano al suo interno. Attraverso lo
studio della famiglia e dei rapporti tra i generi si possono cogliere aspetti, differenze, mutamenti
che altrimenti passerebbero sotto silenzio perché meno visibili sulla scena pubblica, politica e
religiosa. Ciò vale per la società ebraica così come per altre società. La storia della famiglia e la
storia di genere devono molto alla storia sociale e viceversa. Anche la storiografia ebraica sta
conoscendo ormai da tempo una stagione nuova di studi, meno concentrati sugli aspetti economici
e istituzionali (penso ad esempio agli studi sul prestito ebraico, dai quali io stessa provengo) e più
attenta alla vita sociale e materiale, al rapporto tra individuo e comunità, ai conflitti interni sia
religiosi che sociali, alle relazioni di genere.
Emanuele Galante: Quale è il peso politico della comunità?
C.G. A Livorno la comunità ha certamente un peso politico che gli viene dal suo peso economico e
dal rapporto privilegiato che ha con il Granduca grazie alle Livornine. Ma quel peso le verrà
formalmente riconosciuto a livello politico soltato sul finire del ‘700 quando finalmente avrà diritto
ad avere un suo rappresentate nel consiglio municipale. Nel 1779, infatti, anche un ebreo otterrà il
diritto a sedere nel consiglio municipale della città e credo che questa sia una data importante e
significativa per la storia non soltanto toscana e italiana. Gli ebrei di Amsterdam, infatti, otterranno
lo stesso diritto soltanto qualche anno dopo.
Alessandra Gissi: Mi piacerebbe sapere di più sulla tutela dei pupilli, giacché l'importanza dei
bambini si accresce con la diminuzione del loro numero. Non si tratta soltanto di una questione
materiale, ma anche sentimentale.
C.G. La tutela dei pupilli, come dici tu, non è soltanto una questione materiale e giuridica ma
ovviamente è strettamente connessa a come si considera l’infanzia, il rapporto tra genitori e figli e i
figli stessi. Il fatto che la loro tutela, in caso di divorzio o di morte del genitore, debba innanzitutto
garantire il loro interesse, il loro bene, mi sembra fornisca un punto importante di riflessione e di
confronto rispetto alla cultura cristiana. Agire secondo il miglior interesse dei bambini significa
sottrarli al potere assoluto e incondizionato dei genitori, in particolare del padre, significa
riconoscere un interesse dei bambini che può non coincidere con quello dei genitori, significa
riconoscere ai giudici (perché sono loro a decidere della custodia dei minori) il potere di interferire
nei rapporti familiari e di modificare il concetto stesso di patria potestà. Inoltre in ambito ebraico
mi sembra sia cruciale la distinzione tra custodia e tutela che spesso sono appunto disgiunte e
affidate a persone diverse. Questa distinzione permette alle madri di vivere più facilmente con i
propri figli, anche dopo che questi hanno raggiunto il sesto anno di età (nel caso dei maschi, le
femmine invece possono vivere con le madri anche più a lungo), senza però avere l’obbligo del
loro mantenimento e la responsabilità del loro patrimonio. Infine, la legge ebraica non vieta ad una
donna, soprattutto se vedova, di nominare il tutore dei propri figli e io ho trovato almeno 3 casi di
donne che nominano in sede testamentaria coloro che si occuperanno dei figli (una donna ha il
marito ancora in vita, seppure lontano), un potere sconosciuto alle cristiane. In questi casi le donne
sembrano distinguere più degli uomini tra custodia e tutela, forse perché più attente alla vita dei
figli, al loro benessere emotivo oltre che economico. La tutela, infatti, attiene soprattutto alla
gestione e all’amministrazione del patrimonio pupillare e quindi non è detto che chi è nominato
tutore dei pupilli ne abbia anche la custodia, che cioè possa o voglia vivere con loro e offrirli le
migliori condizioni di vita e di cura.
B.B.
A questo punto non mi resta che ringraziare Cristina per aver chiarito, anche con dovizia di
particolari, le questioni che le abbiamo sollevato rispetto al suo libro.
Azzardo una conclusione. Come ho già detto ho trascurato di affrontare alcuni aspetti del suo libro,
che poi, in parte almeno, sono emersi al livello della discussione. Ho però tenuto il centro del
discorso sulla famiglia e il matrimonio, per ragioni anche di formazione - non potendomi definire
certo una storica dell'ebraismo. Eppure se si assume questa prospettiva "gamocentrica" mi sembra
proprio che si vada alle origini di quella comunità di cui ci ha parlato C.G. nel suo libro e che,
"smontata e decostruita" si presenta come una lettura di grande interesse anche per chi non
appartiene al gruppo di storici che si occupano di ebrei.