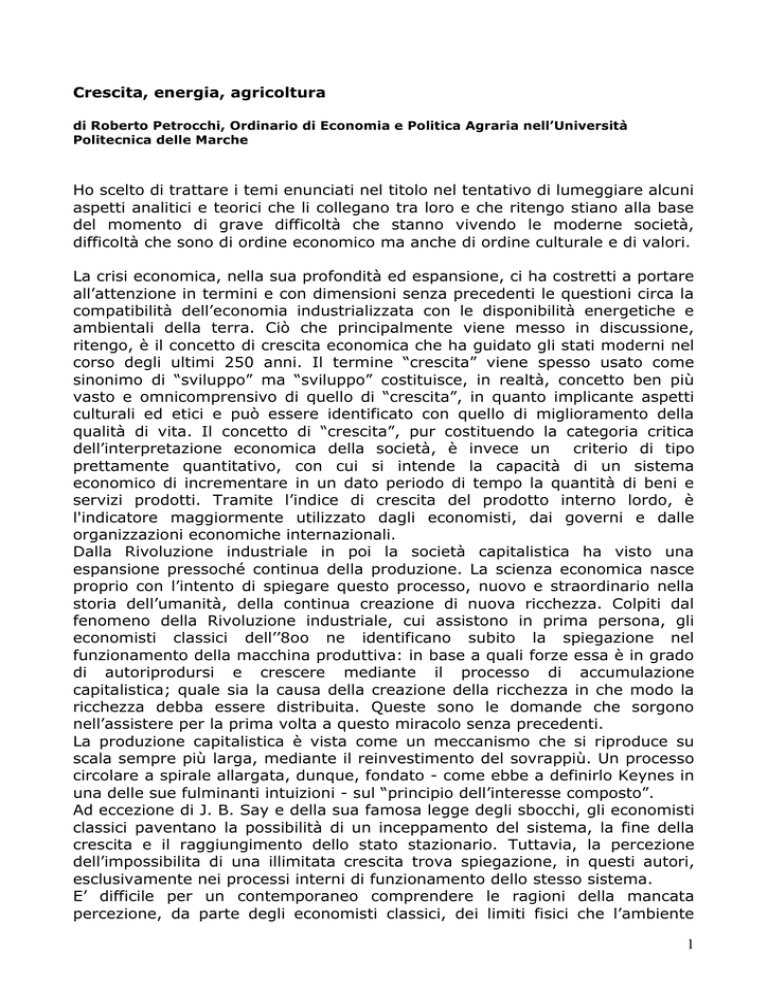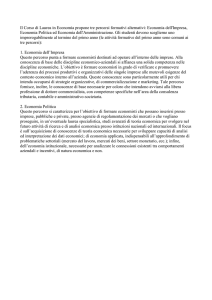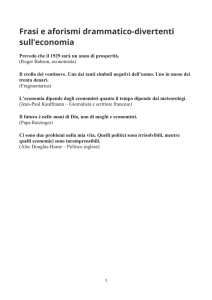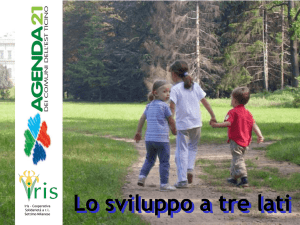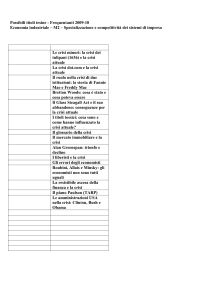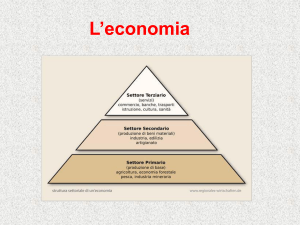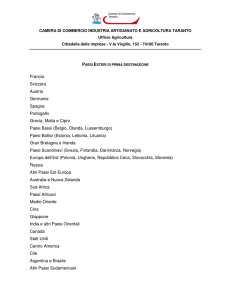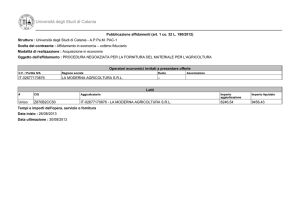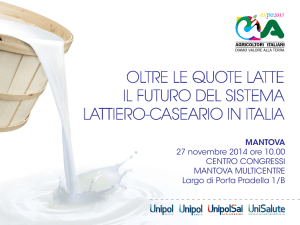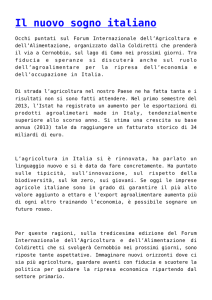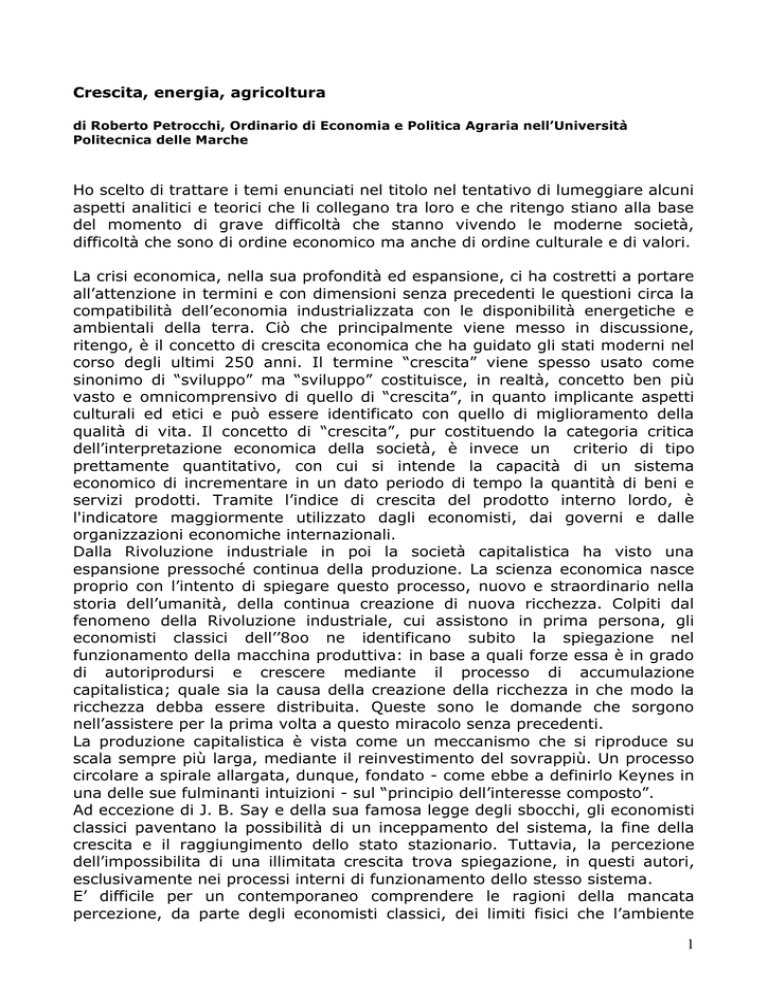
Crescita, energia, agricoltura
di Roberto Petrocchi, Ordinario di Economia e Politica Agraria nell’Università
Politecnica delle Marche
Ho scelto di trattare i temi enunciati nel titolo nel tentativo di lumeggiare alcuni
aspetti analitici e teorici che li collegano tra loro e che ritengo stiano alla base
del momento di grave difficoltà che stanno vivendo le moderne società,
difficoltà che sono di ordine economico ma anche di ordine culturale e di valori.
La crisi economica, nella sua profondità ed espansione, ci ha costretti a portare
all’attenzione in termini e con dimensioni senza precedenti le questioni circa la
compatibilità dell’economia industrializzata con le disponibilità energetiche e
ambientali della terra. Ciò che principalmente viene messo in discussione,
ritengo, è il concetto di crescita economica che ha guidato gli stati moderni nel
corso degli ultimi 250 anni. Il termine “crescita” viene spesso usato come
sinonimo di “sviluppo” ma “sviluppo” costituisce, in realtà, concetto ben più
vasto e omnicomprensivo di quello di “crescita”, in quanto implicante aspetti
culturali ed etici e può essere identificato con quello di miglioramento della
qualità di vita. Il concetto di “crescita”, pur costituendo la categoria critica
dell’interpretazione economica della società, è invece un
criterio di tipo
prettamente quantitativo, con cui si intende la capacità di un sistema
economico di incrementare in un dato periodo di tempo la quantità di beni e
servizi prodotti. Tramite l’indice di crescita del prodotto interno lordo, è
l'indicatore maggiormente utilizzato dagli economisti, dai governi e dalle
organizzazioni economiche internazionali.
Dalla Rivoluzione industriale in poi la società capitalistica ha visto una
espansione pressoché continua della produzione. La scienza economica nasce
proprio con l’intento di spiegare questo processo, nuovo e straordinario nella
storia dell’umanità, della continua creazione di nuova ricchezza. Colpiti dal
fenomeno della Rivoluzione industriale, cui assistono in prima persona, gli
economisti classici dell’’8oo ne identificano subito la spiegazione nel
funzionamento della macchina produttiva: in base a quali forze essa è in grado
di autoriprodursi e crescere mediante il processo di accumulazione
capitalistica; quale sia la causa della creazione della ricchezza in che modo la
ricchezza debba essere distribuita. Queste sono le domande che sorgono
nell’assistere per la prima volta a questo miracolo senza precedenti.
La produzione capitalistica è vista come un meccanismo che si riproduce su
scala sempre più larga, mediante il reinvestimento del sovrappiù. Un processo
circolare a spirale allargata, dunque, fondato - come ebbe a definirlo Keynes in
una delle sue fulminanti intuizioni - sul “principio dell’interesse composto”.
Ad eccezione di J. B. Say e della sua famosa legge degli sbocchi, gli economisti
classici paventano la possibilità di un inceppamento del sistema, la fine della
crescita e il raggiungimento dello stato stazionario. Tuttavia, la percezione
dell’impossibilita di una illimitata crescita trova spiegazione, in questi autori,
esclusivamente nei processi interni di funzionamento dello stesso sistema.
E’ difficile per un contemporaneo comprendere le ragioni della mancata
percezione, da parte degli economisti classici, dei limiti fisici che l’ambiente
1
naturale - limitato nello spazio e nella dotazione di risorse disponibili - pone
inevitabilmente alle possibilità di indefinita espansione di un sistema. Cause di
questo limite del pensiero classico furono la disponibilità di uno stock ancora
intatto e apparentemente illimitato di risorse energetiche e materiali,
l’esistenza di un potenziale apparentemente inesauribile di bisogni umani da
appagare nonché, come vedremo, l’impostazione culturale dell’epoca ancorata
ad una concezione epistemologica meccanicistica derivata dalla fisica classica.
L'avvento, nella seconda metà del XIX° secolo, dell'economia neoclassica e il
concentrarsi dell'attenzione analitica non più sulla produzione bensì sui
processi di scambio e della ripartizione delle risorse, portarono la questione
“crescita” in secondo piano. Assumono ora rilievo cose come la concezione del
risparmio quale motore primo della formazione della ricchezza, il mercato
concorrenziale quale ottimizzatore sovrano dell’allocazione delle risorse e
l’equilibrio di piena occupazione costantemente garantito dalle forze della libera
concorrenza lasciate al loro libero e spontaneo dispiegarsi. Alla base di questo
paradigma sta, come è noto, una rappresentazione dell’individuo mosso, in
quanto soggetto economico, dal proprio esclusivo interesse, da un egoismo
acquisitivo a cui non devono essere posti freni. Questo uomo egoista, rivestito
con una patina di virtù “sociali” come la parsimonia, l’operosità, la sobrietà, la
pietà verso i poveri diviene il centro di quell’equilibrio tra egoismo utilitarista
economico e moralità sociale noto come “compromesso vittoriano”.
Su questo scenario culturale irruppe, devastante, la grande crisi degli anni
Trenta del Novecento. In essa J. M. Keynes vide dimostrata la fallacia della
legge di Say - che escludeva crisi di sovrapproduzione -, nonché il fallimento
della “mano invisibile” a garanzia di ricchezza sociale e piena occupazione. I
comportamenti dell’uomo cosiddetto “virtuoso” e la “mano invisibile” avevano
in realtà condotto le economie capitalistiche nel più profondo baratro della loro
storia. E le cure proposte sul modello ideologico dominante, lungi dal
contribuire a risolvere la crisi, la aggravavano.
Contro la visione del libero dispiegarsi degli egoismi individuali quale
condizione per il perseguimento del pubblico bene, Keynes, in sintonia con il
pensiero di Edmond Burke, sostenne con decisione la concezione di uno stato
moderno capace di orientare con l’attività politica le scelte dei soggetti
economici verso obiettivi di felicità collettiva. Come è stato detto, la “politica
economica” keynesiana “venne concepita come un tassello di quel grande
mosaico che è l’arte o la scienza di governo”.
La “politica economica” così intesa, con le misure di sostegno alla domanda
effettiva, consentì non soltanto la ripresa dell’espansione del capitalismo ma
una sua straordinaria accelerazione in tutto il mondo occidentale.
Eppure, nemmeno Keynes, nonostante l’esperienza diretta di una crisi del
capitalismo come quella degli anni Trenta e con tutta l’imponente mobilitazione
intellettuale – sua ma anche di molti altri radunati intorno a lui – che si
dimostrò capace di attivare, riuscì, così come tutti i grandi economisti prima di
lui, ad individuare altre cause di instabilità della crescita che non fossero di
ordine interno al sistema economico. Mai ebbe modo di rilevare l’esistenza di
influenze e connessioni reciproche tra espansione economica e limiti ambientali
e quindi di poter individuare tali limiti come ostacoli per la crescita economica.
Anzi, alcune sue proiezioni sull’andamento futuro della condizione umana sono
2
di un tale ottimismo da apparire oggi perfino ingenue. Ebbe infatti a lanciarsi
in un’ardita profezia che - avvertiva egli stesso - avrebbe sconcertato i lettori.
Secondo il generoso vaticinio il problema futuro dell’umanità sarebbe stato
cosa fare della propria acquisita libertà dai bisogni economici, una volta che
l’uomo si fosse affrancato da essi in virtù dello sviluppo economico. “Giungo
alla conclusione – affermava - che, […] il problema economico può essere
risolto (…)nel giro di un secolo”. A quel punto l’umanità privata “del suo scopo
tradizionale”, guadagnarsi da vivere, sarebbe andata incontro a un generale
“esaurimento nervoso” non sapendo più “come impiegare il tempo libero che la
scienza e l'interesse composto gli avranno guadagnato” .(ibidem).
Il secolo profetizzato dal grande economista è ormai arrivato e, ammettiamolo,
almeno per quanto riguarda il generale “esaurimento nervoso” dell’uomo
contemporaneo, egli fu veramente profeta. Ma la realtà è che non sappiamo
più che fare di una economia che ha consumato la quasi totalità delle risorse
disponibili e sta compromettendo le condizioni di vita sul pianeta, mentre la
liberazione dell’umanità dai bisogni economici è ancora lontana da vedersi.
Sappiamo invero, in questo addivenuto secolo, che la rivoluzione keynesiana,
se ha salvato il capitalismo, ha anche posto le premesse teoriche per la
trasformazione del capitalismo medesimo in un implacabile meccanismo di
“produzione per la produzione” al cui interno il consumo stesso viene
continuamente prodotto dalla produzione. Il consumo, cioè, ha finito per
divenire il momento centrale ed essenziale della riproduzione sociale delle
stesse condizioni della produzione. Contrariamente a quanto affermato dalla
profezia, non c’è stata una liberazione dell’uomo dal problema economico:
compito principale del sistema è diventato proprio quello di creare
continuamente nuovi scopi economici e, quindi, di vita per l’umanità. La
rivoluzione keynesiana indicò la via per il passaggio all’età del consumismo.
Negli anni successivi alla rivoluzione keynesiana la teoria economica della
crescita ha continuato a non vedere i limiti ad essa posti dalla esauribilità delle
risorse naturali che la alimentano. Anche quando le risorse naturali sono state
considerate oggetto di specifica trattazione economica ciò è avvenuto
all’interno di un assunto generale circa la capacità dei meccanismi equilibratori
del mercato di garantirne l’ottimale utilizzo. Ne è valido esempio quel noto
“principio dello sconto del futuro” che è servito da base, negli anni trenta, per
il famoso studio di Harold Hotelling dell’economia delle risorse esauribili. Ma
nessun principio dello sconto del futuro sarà in grado di tenere in conto la
domanda delle generazioni future, dato che esse non possono partecipare alla
contrattazione per la determinazione di un tasso temporale di sconto che tenga
conto anche delle loro esigenze. Mezzo secolo dopo, J. M. Hartwick – per citare
uno dei più noti di questa classe di fantasiosi economisti – arriverà ad affidare
al sistema di accumulazione un ruolo quasi metafisico di creazione di una
entità riproducibile, il capitale, investito della capacità di sostituire i beni
materiali in esaurimento. Al fine di
ovviare al riconosciuto problema
dell’esaurimento delle risorse irriproducibili per via del loro utilizzo, è
sufficiente investire in capitale riproducibile tutte le rendite derivanti dallo
sfruttamento delle risorse. Personalmente, consentitemi, credo che nel mito o
nella letteratura fantastica sia forse possibile trovare analoghi riscontri di
ottimismo nei poteri dell’uomo posto ormai capace di sostituirsi al Dio creatore.
3
Per arrivare alla prima analisi, tuttora insuperata, di una economia
esplicitamente inquadrata all’interno di un ambiente limitato, bisognerà
attendere gli anni Sessanta del Novecento e l’opera di Nicholas Georgescu
Roegen. Egli definisce lo studio dell’attività economica “Bioeconomia” per
sottolineare che si tratta di una attività che si svolge – e, quindi, può essere
studiata - soltanto in stretta connessione con le forze fisiche e biologiche che
governano la natura e con cui essa interagisce.
Georgescu Roegen intuisce che anche i processi economici di produzione e
consumo soggiacciono ai principi della termodinamica che possono essere così
sintetizzati: “La quantità di energia totale dell’universo è costante e l’entropia è
in continuo aumento”. Essi stabiliscono in maniera inoppugnabile che ogni
trasformazione energetica comporta una perdita irreversibile, nel senso che
una parte dell’energia trasformata non sarà più utilizzabile. Georgescu Roegen
dimostra che il principio vale non solo per l’energia ma anche per la materia
per cui le trasformazioni sia di energia che di materia soggiacciono allo stesso
ineludibile principio della dissipazione.
L’economista rumeno, avendo individuato il processo economico come
artificiale acceleratore dell’universale principio di degrado entropico di materiaenergia, introduce all’interno del discorso economico il concetto di entropia.
Nella visione bioeconomica di Georgescu Roegen le risorse naturali ed i servizi
ambientali vengono interpretati come “patrimonio di bassa entropia”. Dette
risorse (energetiche e materiali) a disposizione dell’umanità possono essere o
rinnovabili solo in tempi geologici, oppure si tratta di flussi continuamente
rinnovati secondo ritmi misurabili ma non controllabili dall’uomo, come
l’energia solare. Nei fatti, le risorse energetiche e i materiali realmente
utilizzati dalla produzione economica sono costituiti, in pressoché totale
misura, da stock disponibili sulla terra in misura finita.
A differenza delle tradizionali impostazioni di derivazione meccanicistica,
soprattutto quella marginalista, che vedono il processo economico in termini di
circolarità, nell’interpretazione termodinamica i fatti economici vengono
correttamene individuati in quanto processi unidirezionali e irreversibili. Il
tempo storico, inteso come succedersi irrevocabile di eventi, diviene elemento
essenziale dell’osservazione economica e ogni trasformazione produttiva viene
finalmente vista quale inesorabile degradazione del capitale naturale utilizzato.
La dimensione temporale consente di reinterpretare il tradizionale concetto di
scarsità delle risorse: le fonti energetiche sono scarse perché sono non
riproducibili e fisicamente limitate e, soprattutto, perché il loro utilizzo nel
tempo ne causa l’inevitabile esaurimento. Ciò introduce per la prima volta
all’interno dell’economia il concetto di scarsità assoluta delle risorse, le quali
cessano di essere categorie quasi metafisiche capaci di alimentare
indefinitamente il mito prometeico dell’uomo creatore, ma divengono elementi
concreti che definiscono le reali possibilità produttive. In tal modo, gli orizzonti
dell’analisi economica vengono allargati a una prospettiva intergenerazionale.
Da tutto ciò discendono con immediatezza nuovi criteri di ricchezza e di valore,
non più determinati esclusivamente, come si riteneva in passato, dal lavoro
contenuto, dall’utilità marginale o dal livello della domanda ma, in primo luogo,
dal contenuto energetico dei beni. Il meccanismo dei prezzi, rispondente alle
4
dinamiche fluttuanti della domanda e dell’offerta, risulta in questa ottica
inadeguato per assegnare il reale valore delle cose e i meccanismi di mercato
non sono in grado di garantire un’efficiente allocazione delle risorse nei
termini intertemporali e di efficienza entropica. Anche il concetto di produttività
assume, alla luce della termodinamica, una connotazione del tutto nuova non
essendo più la quantità prodotta per unità di tempo o per unità di lavoro
impiegata che stabilisce l’efficienza di un processo, bensì il contenuto di
entropia per unità di produzione.
Non è il caso, in questa sede, di entrare oltre nel merito dell’opera di G.
Roegen. Possiamo solo aggiungere che il suo contributo forse più rilevante è
stato aver posto le premesse per un possibile risveglio dell’economia
dall’illusione di poter indefinitamente sostituire il capitale prodotto dall’uomo al
capitale naturale consumato nei processi economici. E questo avviene a
distanza di ben un secolo e mezzo dalla enunciazione del secondo principio
della termodinamica e dalle rivoluzionarie conseguenze che esso impose
all’impostazione epistemologica di stampo meccanicistico in tutte le discipline
scientifiche a partire dalla fisica. Solo la scienza economica, pur definita la
“triste scienza” (R. Carlyle) ha continuato a muoversi nella continua illusione
“delle magnifiche sorti e progressive dell’umana gente” (G. Leopardi, La
ginestra, 1836) da cui il poeta aveva messo in guardia il nostro tempo
“superbo e sciocco”.
E ancora oggi, a quasi mezzo secolo dal contributo di G. Roegen,
l’impostazione dominante della scienza economica continua a muoversi
nell’indifferenza circa i limiti che alla crescita economica vengono posti dalla
disponibilità energetica a monte e dalla capacità di assorbimento degli scarti
indesiderati a valle. E ciò, nonostante sia ormai ben evidente l’inadeguatezza
dei modelli rappresentativi e delle analisi tradizionali alla luce di tali limiti
ambientali.
E’ ormai all’ordine del giorno l’urgenza di una presa d’atto generale della
impossibilità di continuare in una crescita senza limiti e della necessità di
abbandonare la cieca fiducia che ha sorretto gli intelletti durante gli ultimi
secoli e per cui “qualunque cosa accada la tecnologia ci aprirà una strada”.
Oggi sappiamo che questo mito tecnologico porta con sé molti possibili e
terribili pericoli e che l’applicazione delle tecniche esistenti - basate sulla
disponibilità limitata di risorse inquinanti utilizzate però come se si trattasse di
risorse illimitate e pulite - può portare anche a risultati disastrosi.
3. Il caso in questo senso paradigmatico è quello della moderna agricoltura.
L’attività produttiva agricola tradizionale, fondata sulla conoscenza e il governo
dei cicli naturali, costituiva un’attività in armonia con i ritmi e le
complementarità tecniche e temporali derivanti dalla natura organica dei
processi naturali di trasformazione. Essa si affidava per la coltivazione al lavoro
degli uomini e degli animali, per la fertilizzazione e la conservazione del suolo
ai concimi naturali e alla rotazione delle colture, per la difesa delle piante ai
nemici naturali degli insetti. L’esercizio dell’attività agricola nel rispetto di tali
vincoli faceva dell’agricoltura un’”arte” con le sue regole ben definite e
temporalmente scandite e gli “agri-cultori” dovevano essere profondi e
rispettosi conoscitori delle regole dell’arte agricola. Le modalità di esercizio
5
dell’agricoltura tradizionale configuravano un’attività multifunzionale che oltre
alla produzione di beni agricolo-alimentari sicuri e di alto valore nutritivo,
rendeva altri importanti servizi alla collettività come il presidio territoriale, la
tutela dell'ambiente, la cura del paesaggio.
La modernizzazione ha sostituito le macchine al lavoro dell’uomo e degli
animali, i prodotti chimici alla fertilizzazione organica, alle rotazioni, al diserbo
manuale e al controllo naturale degli agenti patogeni. Con l’industrializzazione
– ovvero, la trasformazione dell’agricoltura tradizionale in un “sottoprodotto
della rivoluzione industriale” – l’agricoltura non solo ha perduto quelle
multifunzioni virtuose cui abbiamo fatto cenno ma è divenuta all’opposto la più
grande sperperatrice di energia non riproducibile, fonte di inquinamento
ambientale, causa di dissesto del territorio e produttrice di beni agroalimentari
spesso di dubbia qualità e sicurezza.
Per quanto si vogliano celebrare i mirabolanti risultati quantitativi della
moderna agricoltura, per quel che riguarda i suoi effetti entropici è fuor di
dubbio essa si è mostrata tanto “viziosa” quanto “virtuosa” fu l’agricoltura
tradizionale. Le moderne tecniche agricole sostituiscono energia solare,
praticamente illimitata e gratuita, con la più scarsa delle risorse, l’energia
fossile. Ciò è in evidente contrasto con il criterio di efficienza entropica, il quale
implica che i flussi di energia e materia in entrata debbano essere inferiori a
quelli in uscita. L’agricoltura è per sua natura fondata sullo sfruttamento del
vantaggio entropico legato all’attività fotosintetizzante delle piante; a
differenza degli altri settori produttivi dovrebbe dunque presentare un bilancio
positivo dei flussi di energia e materia. La fotosintesi infatti, utilizza la fonte
energetica più abbondante e rinnovabile attualmente a disposizione – il sole –
per strutturare materia organica e per la formazione di energia libera: essa è
dunque l’unico processo in grado di contrastare il degrado entropico associato
a tutte le attività vitali. Viceversa la modernizzazione agricola, sostituendo
l’energia fossile a quella solare, ha puntato tutto in direzione di un aumento
della produttività economica ma, diminuendo l’efficienza entropica, ha
rinunciato al vantaggio derivante dal processo fotosintetizzante.
A fronte di queste considerazioni sulla dannosità della moderna agricoltura, la
risposta pressoché unanime fa riferimento alla crescente pressione
demografica e alla necessità primaria di ottenere quantità crescenti di beni
agricolo-alimentari al fine di affrontare il problema della sottonutrizione e della
fame. Si sostiene – evocando talvolta perfino Malthus –, che tale obiettivo può
essere perseguito soltanto attraverso una intensificazione del rendimento della
terra coltivata a mezzo di una sempre maggiore meccanizzazione, maggior uso
di fertilizzanti e pesticidi chimici, nonché, sulla base delle più recenti
innovazioni tecniche, maggior coltivazione dei cerali ad alta resa. Tuttavia,
come sostiene Georgescu Roegen, la realtà è che, contrariamente a quanto
generalmente sostenuto, “questa tecnica agricola moderna costituisce nel
lungo periodo, un’azione contraria ai più elementari interessi bioeconomici
della specie umana”.
E’ da tempo e abbondantemente provato che i nuovi elementi con cui la tecnica
moderna rimpiazza l’energia solare sono caratterizzati da una resa fortemente
decrescente. All’aumento dell’utilizzo del macchinario, dei fertilizzanti chimici e
dei pesticidi fa riscontro un aumento notevolmente meno che proporzionale
6
delle rese per via del fatto che l’intensificazione di attività fotosintetica
consentita dalle nuove tecniche su di una data superficie di terra coltivata
viene ottenuto a scapito di un ancor più intensivo consumo di bassa entropia
di origine terrestre, la sola risorsa criticamente scarsa. Si tratta di una
diseconomia - osserva Georgescu Roegen - “particolarmente pesante nel caso
delle varietà a resa elevata che hanno fatto vincere al loro realizzatore,
Norman E. Borlaug, il premio Nobel”.
In definitiva, quindi, se per un verso l’utilizzo delle moderne tecniche sembra
fornire risposta nell’immediato al problema delle necessità alimentari di una
popolazione crescente, per altro verso, a motivo della intensificazione del
consumo delle risorse esauribili, crea le premesse per compromettere le stesse
possibilità di vita delle generazioni future. Questo fatto, unitamente alla
progressiva perdita di biodiversità causata dall’applicazione delle moderne
tecniche agricole potrebbe condurre “il genere umano in un vicolo cieco
ecologico senza possibilità di ritorno”.
4. Ecco, questo è, credo, nei suoi termini essenziali, lo scenario generale della
situazione delle società umane allo stato attuale. Tuttavia, se questo è il
quadro, per quanto foschi possano apparire i suoi colori, ritengo che il più
grave errore sarebbe abbandonarsi alle suggestioni di un cupio dissolvi legato
a senso di ineluttabilità circa il drammatico destino di una umanità impotente
rispetto al suo futuro.
A fronte di questo desolante panorama è sterile e dannoso l’atteggiamento
catastrofistico e rassegnato di molti, quasi quanto quello degli ottimisti
tecnologici ad oltranza. Potremmo assistere, in un prossimo futuro che forse è
già iniziato, a ripensamenti di portata rivoluzionaria circa le modalità
organizzative delle società degli uomini, ma anche di ordine culturale ed
esistenziale, che riguarderanno il senso stesso della vita, attraverso radicali
rivisitazioni delle concezioni degli stili di vita e dei rapporti degli individui con il
mondo umano e naturale intorno ad essi.
Capovolgimenti di pensiero e di approcci politici che sembravano impensabili
fino a poco tempo fa si affacciano già oggi in termini dominanti sulla scena
mondiale e accendono di nuovo le speranze di una umanità che sembrava
destinata a non avere più sogni.
Non spetta a me in questa sede provare ad immaginare in che termini e
quando esattamente tutto ciò avverrà.
Il mio compito, il nostro compito come uomini di cultura, ricercatori di scienza,
costruttori di sapere, è quello di smetterla, infine, di coltivare ad oltranza e
acriticamente i graziosi giardinetti del nostro sapere accademico, talvolta
troppo isolati dal mondo, dalle sue contraddizioni e dalle sue storture; avere il
coraggio di abbandonare, quando necessario, i percorsi di ricerca ben
collaudati e per noi assai rassicuranti, ma talvolta – e mi rivolgo soprattutto ai
colleghi economisti - avvitati nella asettica autoreferenzialità di una sterile
ricerca di perfezione formale, senza più avere chiaro dove si stia andando.
Dobbiamo uscire, credo, dalle nostre mura, prendere atto e affrontare con gli
strumenti a disposizione una realtà che può anche non piacere ma che non si
può non vedere. E questa realtà è quella di un mondo viziato dalla convinzione
che le disponibilità materiali degli uomini debbano sempre e continuamente
7
crescere – il mito della crescita –; un mondo che ormai non può più
permettersi di coltivare questo mito, mentre la gran parte dell’umanità, quella
che sino ad ora ne era stata esclusa, preme per poter sedere anch’essa al
banchetto dell’abbondanza; un mondo esausto svuotato delle sue preziose
risorse esauribili e ormai troppo saturo delle deiezioni del oro irragionevole
utilizzo; un mondo densamente popolato che annaspa alla ricerca di nuove
fonti energetiche capaci di garantire uno “sviluppo” che possa dare risposta alle
necessità vitali di questa popolazione ma che non potrà essere la replica della
crescita incontrollata che ci ha guidato finora: dovrà essere un vero “sviluppo”,
ispirato da criteri guida radicalmente nuovi rispetto ad essa.
Questo è il mondo che dovremo saper vedere e con cui dovremo saperci
confrontare per tentare di offrire il nostro indispensabile contributo.
Spetta a noi lavorare con senso di concretezza sulla ricerca di fonti energetiche
veramente pulite, alternative a quelle fossili – compresa quella nucleare,
anch’essa in via di esaurimento e pericolosissima per noi e per le generazioni
future –; per fare ciò dovremo abbandonare l’illusione del moto perpetuo e che
sia ancora ipotizzabile un mondo di uomini-dio dotati di risorse illimitate e
inesauribili. E dovremo saper dire ai popoli che il nostro pianeta non è in grado
di mantenere ancora a lungo una pressione demografica come quella attuale,
con gli attuali consumi, e che in prospettiva la popolazione dovrà
necessariamente decrescere.
Spetta a noi essere capaci di elaborare modelli di riferimento filosofico,
culturale ed economico fondati su cognizioni affatto nuove dei concetti di
ricchezza e di valore; per fare ciò dovremo abbandonare l’illusione che
l’esercizio della libertà degli uomini possa essere indifferente rispetto alle
necessità di giustizia e di equità tra individui, popoli e generazioni.
Spetta a noi, ancora, saper costruire obiettivi e paradigmi politici capaci di dare
senso di appartenenza, compartecipazione, condivisione e di indirizzare
l’attività degli uomini verso mete comuni da cui possa discendere, reale
benessere per i singoli individui; per fare ciò dovremo abbandonare l’illusione
tipicamente moderna degli stati di equilibrio e di benessere collettivo emananti
come per incanto - per metafisica “mano invisibile” - dal libero agire delle forze
primitive, dagli egoismi della natura umana.
Infine, per noi economisti che ci occupiamo del settore agricolo, si pone,
credo, anche un compito più preciso, strettamente legato al ruolo
fondamentale che in un futuro eco-sostenibile dovrà avere la coltura della
terra. Dovremo lavorare nel senso di una nuova agricoltura che,
contrariamente a quanto avvenuto in passato, si conformi ad un uso misurato
e giudizioso della tecnologia, tale cioè da rendere le produzioni agricole
compatibili sia con la conservazione dei caratteri originali delle forze biologiche
su cui si fondano, che con l’ambiente naturale nonché con le necessità di una
alimentazione di qualità e sicura. Una agricoltura che dovrà saper recuperare
modalità tradizionali di sapere agricolo attraverso il formarsi di nuovi mestieri
colturali fondati, come lo erano gli antichi mestieri agricoli, sulla conoscenza
8
delle leggi, dei ritmi della natura e del loro rispetto: attraverso essi soltanto,
diverrà possibile ricostruire una rinnovata fiducia tra agricoltori e consumatori
nel quadro di una nuova alleanza tra agricoltura, tecnologia e natura.
9