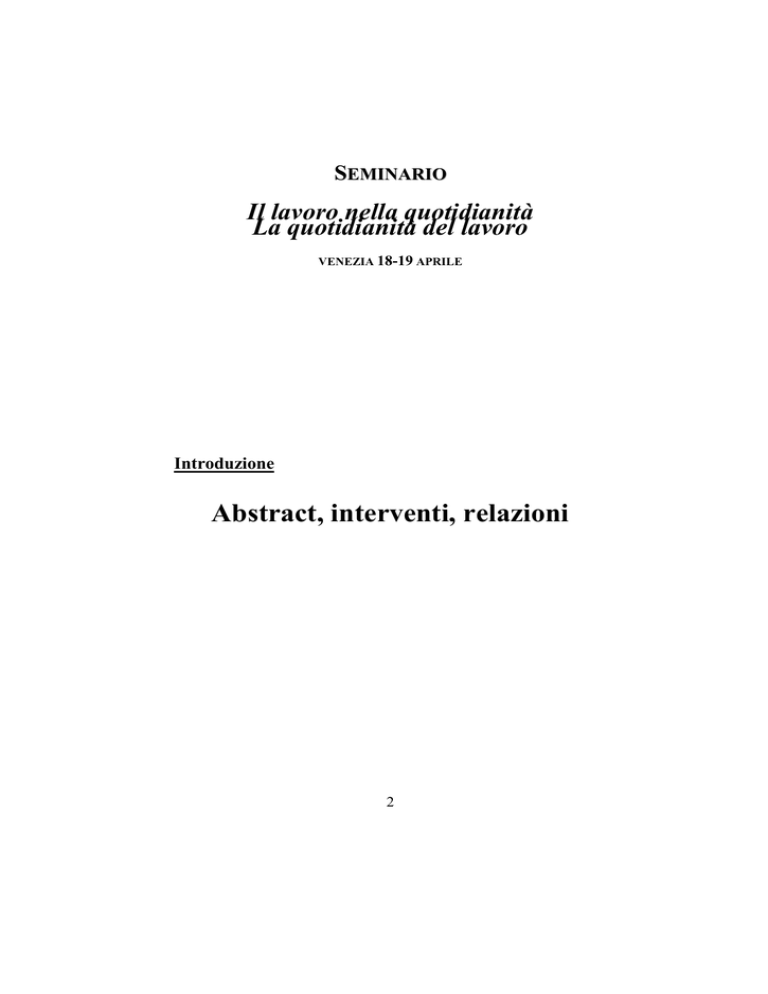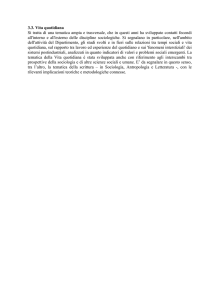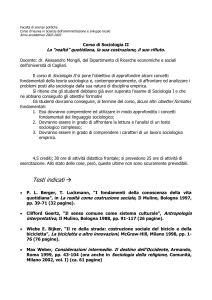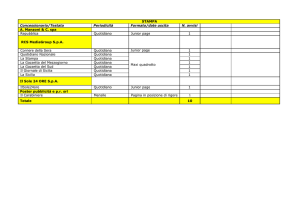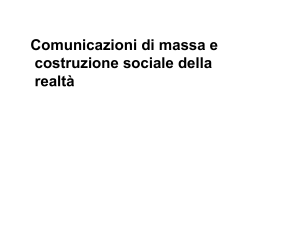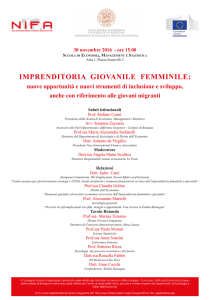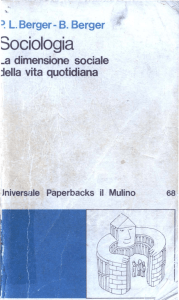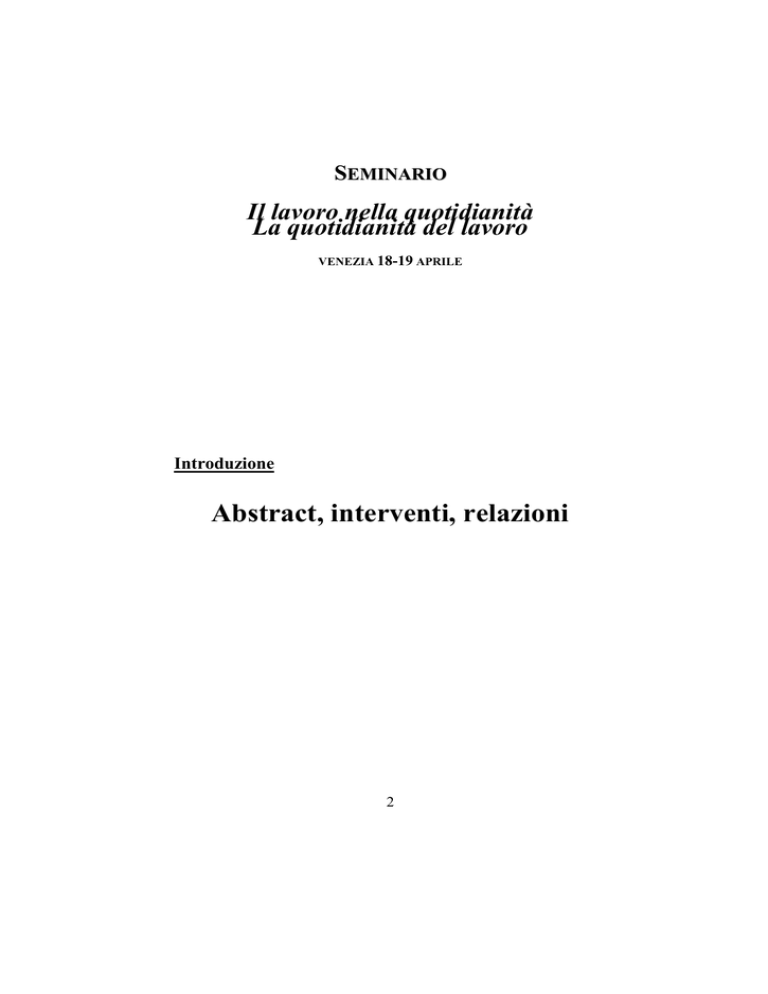
SEMINARIO
Il lavoro nella quotidianità
La quotidianità del lavoro
VENEZIA 18-19 APRILE
Introduzione
Abstract, interventi, relazioni
2
LA QUOTIDIANITA’ DEL LAVORO: QUALI
CATEGORIE ANALITICHE?
Silvia Gherardi
Università di Trento
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Research Unit on Cognition, Organizational Learning, and
Aesthetics
via Verdi 26, I-38100 Trento.
Tel. +39 0461-881311; Fax +49 0461-881348,
e-mail: [email protected]
Paper preparato per il convegno Lavoro e vita quotidiana, Venezia
18-19 aprile 2005.
Si prega di non citare senza autorizzazione.
3
Introduzione
Molte sono le etichette che nelle scienze sociali sono attualmente in
uso per definire le caratteristiche della società contemporanea e
coglierne il nucleo centrale di senso. Tra queste il termine società
della conoscenza ben si presta, a mio avviso, a fissare e descrivere il
lavoro nel mondo occidentale contemporaneo. L’accento sulla
conoscenza simbolizza la de-materializzazione del lavoro, il
principale e più prezioso prodotto del lavoro, nonché l’attività
centrale che viene compiuta nel mentre che si lavora, cioè conoscere
e mettere in pratica la conoscenza posseduta o creata nel corso
dell’attività lavorativa.
La società occidentale contemporanea mostra una crescita costante
del contenuto di conoscenza dei lavori, di autonomizzazione dei
saperi esperti (Beck, 1994, 2000; Luhman, 1984) e del valore
economico delle risorse cosiddette “intangibili” come la conoscenza,
il capitale sociale e intellettuale, il servizio, la fiducia o l’immagine.
Tutto ciò pone una sfida agli scienziati sociali che cercano di
comprendere e descrivere i mutamenti del lavoro con le categorie
tradizionali ereditate dallo studio del lavoro industriale o aggiornate
con lo studio del lavoro nella società dei servizi.
In particolare la sociologia del lavoro, tradizionalmente, ha costituito
il suo oggetto di studio mettendo a fuoco il lavoro come fatto
“macrosociale” che si manifesta prevalentemente in relazione al
mercato del lavoro (Reyneri, 2005), alle sue forme aggregate in
professioni (Chiesi, 1995), alla sua regolazione contrattuale nelle
forme del lavoro atipico e nella sua negoziazione sindacale (Magatti
e Fullin, 2002; Borghi, 2000). L’analisi del lavoro in un’ottica
“microsociale” non ha, soprattutto in Italia, una altrettanto radicata
tradizione. Non mancano certamente gli esempi importanti e
metodologicamente rilevanti come il tema della qualità del lavoro
(Gallino) o nella creatività del lavoro (DeMasi).
Tuttavia è proprio sul terreno dell’analisi “micro” che la sfida della
“società della conoscenza” diviene più evidente.
Infatti se
assumiamo che il passaggio fondamentale nell’analisi e nella
gestione del lavoro dipendente possa essere riassunto nella formula
“dall’analisi delle mansioni all’analisi delle competenze” possiamo
intuire come le tradizionali categorie di analisi delle mansioni non si
applichino all’analisi degli skills in pratica. E’ su questo terreno che
4
le categorie di analisi della vita quotidiana possono dare un
contributo significativo. Un confronto quindi tra chi studia il lavoro
come attività situata e chi studia la quotidianità può arricchire la
comprensione della quotidianità del lavoro.
Nei paragrafi che seguono prenderò in considerazione gli aspetti
metodologici connessi alla concettualizzazione del lavoro come
attività situata proponendo ai colleghi che studiano la vita quotidiana
un terreno di comune approfondimento.
Il lavoro come attività situata
Alcuni autori francesi definiscono l’azione situata come nuovo
paradigma (De Fornel e Quéré, 1999) in relazione al contesto ed in
contrapposizione alla razionalità oggettiva (o decontestualizzata).
Questo filone di studi si inserisce nell’alveo della critica alla
razionalità e dell’indebolimento dei modelli razionali per
l’interpretazione dell’azione sociale. In questo senso si può dire che
lo scopo dello studio del lavoro come attività situata sia costituito dal
sostituire la razionalità oggettiva – rappresentata sotto forma di un
insieme di compiti da eseguire in regime di “logica ottimizzante” –
con la logica della situazione e quindi in regime di “razionalità
contestuale”. In questa prospettiva il contesto nel quale il lavoro
viene espletato non è “dato”, bensì attivamente “costruito” in tanti
“quadri situazionali” che interpretano le situazioni ritagliandole
dall’ambiente.
Il lavoro è allora “situato” nel senso che è
contestualizzato entro situazioni e che in tali contesti “agire”
significa trattare una situazione .
Il punto di partenza del cambiamento di paradigma consiste dunque
nel considerare il lavoro non più come un insieme di compiti
strutturati oggettivamente, bensì come un processo di definizione
delle situazioni (Schutz, 1971; Berger e Luckmann, 1966) attraverso
momenti di attenzione selettiva che attivamente incorniciano porzioni
di realtà in funzione di un tema e che selezionano le conoscenze
pertinenti alle situazioni.
Definire il lavoro come attività situata significa focalizzare l’analisi
sociologica del lavoro sulle pratiche lavorative quali modalità di
azione e conoscenza emergenti in situ dalla dinamica delle interazioni
(Gherardi 2005). Questa definizione affonda le sue radici teoriche
nella
fenomenologia
sociale,
nell’etnometodologia,
nell’interazionismo simbolico, nella cognizione distribuita, nella
5
psicologia cognitiva culturale. La tabella 1 tratta da Conein e Jacopin
(1994:500) riassume graficamente le radici teoriche del paradigma
dell’azione situata e consente anche di delineare una distinzione in
merito al significato di “situato” in relazione alla natura delle
interazioni considerate (Conein e Jacopin, 1994:476):
a) una prima concezione, che si ritrova in Goffman (1959;
1967), nell’etnometodologia e in Suchman (1987), mette
l’accento sulla comunicazione e sulla capacità dell’attore di
comprendere ed essere orientato all’azione altrui (all’incontro,
nei termini di Goffman, orientato e dipendente dall’azione del
destinatario)
b) una seconda concezione, che si ritrova nei lavori di Lave
(1988), mette l’accento su come negli ambienti popolati da
artefatti e da oggetti, questi possano divenire delle guide che
facilitano ed indirizzano l’esecuzione del lavoro.
Per gli autori citati queste due concezioni hanno dato luogo a due
programmi di ricerca diversi a seconda che venisse privilegiato il
ruolo degli attori nel processo di “sense –making” delle situazioni e
della comunicazione nel processo di cooperazione interattiva, o
viceversa il ruolo delle tecnologie e degli oggetti nell’interpellare
attivamente gli attori e suggerire loro risorse per l’interazione. A mio
avviso tale distinzione è fuorviante se viene operata quale criterio per
ribadire la preminenza dell’attore “umano” sul mondo materiale (non
– umano nei termini di Latour), mentre acquisisce un senso più
complesso se ridefinisce la natura delle interazioni sociali in contesti
sociali abitati parimenti da umani e non umani o detto con i termini di
Knorr – Cetina (1999) in situazioni di post socialità o entro sistemi
sociotecnici (Law, 1987).
Nel paradigma dell’azione situata è centrale la rivisitazione del
concetto di contesto: non più contenitore dell’azione, ma situazione
in cui gli interessi degli attori e le opportunità dell’ambiente si
incontrano e si definiscono reciprocamente. Entro questo contesto
teorico si situa la mia proposta di considerare l’attività lavorativa
come attività situata in contesti di interazione umana e non umana ed
informata dalla logica della situazione. In questa proposta la
conoscenza pratica non è attività cognitiva che ha luogo nella testa
delle persone che lavorano né solamente cognizione distribuita entro
persone che cooperano allo svolgimento di un compito, bensì è
un’attività sociale che non distingue tra il pensare ed il fare, che ha
6
luogo entro pratiche lavorative contestualizzate, che risente della
specificità delle situazioni che cambiano a seconda degli altri presenti
e che sono mutevoli (o polisemiche) anche per lo stesso attore in
tempi diversi.
L’attività lavorativa è dunque conoscenza-in-pratica (knowing-inpractice, Gherardi, 2005) e per analizzarla abbiamo bisogno di
concetti e modelli interpretativi che si allontanino dalla visione del
lavoro come attività di esecuzione e puntino invece al contenuto della
progettazione, di ideazione e di mobilitazione di risorse in relazione
al contesto e a strategie di flessibilità ed equifinalità.
Il lavoro come pratica material-discorsiva
Il concetto di pratica – che pur ha una lunga tradizione sia
filosofica che sociologica – ha ripreso vigore nel dibattito
contemporaneo (Gherardi; 2000; Schatzki et al, 2000; Strati, 2003).
A mio avviso tale riscoperta è connessa alle potenzialità che questo
concetto di poter contenere tanto gli elementi legati alla
abitualizzazione (pratica come modalità abituale e ripetuta del fare e
come conoscenza perfezionata nel fare) quanto gli elementi connessi
all’azione intenzionale (pratica come modalità istituzionalizzata e
considerata appropriata del fare) e tuttavia la pratica non coincide né
con l’abitudine, né con l’azione orientata allo scopo. La logica della
pratica è la logica dell’azione situata con l’aggiunta che nel concetto
di pratica ritroviamo tanto la riproduzione quotidiana delle azioni che
la compongono sostenute da un senso di normatività, quanto
l’istituzionalizzazione di una modalità dell’agire. Partecipare ad una
pratica è conseguentemente un modo di acquisire conoscenza in
azione, ma anche di cambiare o perpetuare tale conoscenza e di
produrre o riprodurre la società. Mente, cultura e società sono
costantemente riprodotti in sistemi di attività che possono essere
anche descritti nei termini di pratica come lavoro (per quel che
riguarda la trasformazione di un dato processo di lavoro), pratica
come linguaggio (per quanto riguarda il linguaggio professionale e
l’interazione all’interno di un certo processo di lavoro) e pratica
come moralità (per quanto riguarda la politica ed il potere dei
differenti gruppi o classi sociali che sono coinvolti in un dato
processo di lavoro).
7
L’ambito degli studi basati sulla pratica (i cosiddetti practic-based
studies) è un filone di studi emergenti nel quale stanno confluendo
una pluralità di programmi di ricerca che vanno dagli studi che
nascono nell’alveo dell’apprendimento e della conoscenza nelle
organizzazioni nella tradizione dell’activity theory (Engenstrom,
1987; Blackler, 1999), ai workplace studies (Heath e Button, 2002)
che focalizzano l’interazione, agli studi sulla tecnologia come pratica
sociale (Suchman et al, 1999) o agli studi sulla costruzione sociale e
relazionale di reti sociotecniche nel filone dell’actor–network theory
(Law e Hassard, 1999). Ciò che accomuna questi filoni è la non
distinzione tra lavorare e organizzare e quindi l’essere a cavallo tra
gli studi micro sia del lavoro che dell’organizzazione. Sebbene sia
difficile dare un volto preciso ad un programma di studio emergente
possiamo tuttavia contribuire ad identificarlo sia per ciò a cui esso si
contrappone, sia per la centralità di alcuni temi, variamente presenti.
Possiamo dire che gli studi basati sulla pratica nascono in polemica
con le discipline dell’interazione uomo/macchina e dell’intelligenza
artificiale (Human Information Processing e Human Computer
Interaction) per via dell’influenza predominante in esse delle scienze
cognitive e dei suoi modelli che si basano sull’elaborazione simbolica
e computazionale di un insieme di informazioni ‘date’ (Carassa,
2000). Da questa polemica nasce la centralità della conoscenza come
attività pratica e situata in contesti ‘tecnologicamente densi’ (Bruni,
2004). Possiamo infatti dire che una caratteristica che accomuna
questi studi è la scelta di studiare contesti nei quali la tecnologia è
una presenza importante, come nei centri di coordinamento, nel
lavoro supportato dalle tecnologie della comunicazione e
dell’informazione. Più precisamente dobbiamo dire che è la
tecnologia-in-uso ciò che accomuna questi studi, cioè un modo di
vedere la tecnologia come pratica sociale e non come artefatto
tecnologico.
Non si tratta infatti di porre attenzione a come la tecnologia possa
essere progettata in modo facile da usare o quali siano le conseguenze
dell’adozione di particolari tecnologie, ma come comprensione e
l’uso delle tecnologie costituisca ‘un problema’ e diventi esso stesso
una pratica sociale attraverso le modalità d’interazione di coloro che
le usano e le interpretano nella quotidianità delle pratiche lavorative.
Il fuoco dell’attenzione si sposta così dalle potenzialità della
tecnologia in sé stessa o nel momento della sua progettazione al
momento in cui gli artefatti tecnologici entrano in relazione con i suoi
8
utilizzatori in contesti lavorativi situati e prendono forma entro
interazioni discorsive e materiali.
Il lavoro che la tecnologia-in-uso compie è quello di allineare mondi
sociali (del progettista, degli utilizzatori, dei non utilizzatori ecc.) e
mondi materiali (la configurazione che l’artefatto assume attraverso il
modo in cui viene usato ed i discorsi entro cui prende forma). Ad
esempio quando Lucy Suchman (1987) studia la relazione tra una
fotocopiatrice “interattiva” (sempre più sono le macchine che “ci
parlano” avendo incorporato tecnologia informatica) e due suoi
utilizzatori novizi ella osserva e descrive la cooperazione e la
comunicazione tra i due novizi come modello d’interazione faccia a
faccia, ma contemporaneamente tratta il sistema di aiuto incorporato
nella fotocopiatrice come un insieme di domande poste
all’utilizzatore e le sue risposte. In questo modo si giustifica il
modello di interpretazione di una macchina in dialogo con il suo
interlocutore e la ricerca in termini di etnometodologia sulla
comunicazione verbale in quanto la cooperazione è una condizione
essenziale per la comprensione dell’interazione con la macchina.
Questo esempio ci è utile per sottolineare en passant come il parlare
nel corso delle attività lavorative (ma non solo!) sostituisca una
pratica situata e giustifichi quindi un approccio contestuale
all’azione. Non basta infatti che i due novizi siano compresenti, ma è
il fatto di entrare in comunicazione che fa sì che il contesto sia il
risultato dell’interazione. Questa osservazione richiama i due
concetti cardine dell’etnometodologia: indessicalità e riflessività.
Le parole prendono significato nel loro uso contestualizzato e si ha
riflessività allorché l’attività del parlare non è solamente ancorata alla
situazione, bensì costituisce il contesto stesso del suo impiego. La
situazione pertanto non circoscrive soltanto le circostanze
dell’azione, ma le produce al tempo stesso per mezzo delle pratiche
discorsive.
Una analisi situata del lavoro mette in evidenza non solo come
parlare sia lavorare, ma anche come il presupposto del parlare-inpratica e del parlare-sulla-pratica sia costituito dalla presenza di altri
sul luogo di lavoro e quindi come il lavorare sia una attività
cooperativa/conflittuale che coinvolge sia la relazione con altri umani
che con il mondo materiale. Ad esempio quando Heath e Luff (1996)
studiano la sala di controllo di una stazione della metropolitana
londinese o Joseph (1994) studia quella della RER di Parigi o la
Suchman (1996) studia il centro di controllo aereo di un aeroporto
9
metropolitano della West Coast mettono al centro dell’analisi la
relazione tra l’ambiente lavorativo e la strutturazione delle attività.
La cooperazione tra singoli operatori mostra come esista un
continuum tra compiti individuali e collettivi e come mentre un
operatore è assorbito in un compito con la coda dell’occhio o con un
‘orecchio distratto’ segua contemporaneamente ciò che gli altri fanno
in una sorta di ‘equilibrio sempre instabile della partecipazione’ dove
forme varie di coordinamento tendono alla cooperazione, mentre gli
operatori sono impegnati in forme individuali di partecipazione. La
distribuzione della conoscenza nella sala è prodotta anche attraverso
il parlare ad alta voce, cosa che consente nei lavoratori di essere
consapevoli degli eventi che possono essere rilevanti anche per il loro
lavoro.
La sala di controllo rappresenta il punto fisso verso cui i partecipanti
distribuiti nello spazio si orientano, ma allo stesso tempo le persone
all’interno della sala sono in relazione con i loro colleghi dislocati in
altri luoghi. In questa situazione gli oggetti e le tecnologie che
compongono l’ambiente assumono molteplici identità a seconda della
loro rilevanza per la pratica. Gli spazi lavorativi, l’arredamento, le
tecnologie e gli antefatti sono esperiti come più o meno focali o
contestuali, negoziabili o fissi, che permettono o ostacolano il lavoro
che deve essere fatto. In questi tipi di analisi del lavoro si vede molto
chiaramente come le pratiche lavorative siano material-discorsive,
come il lavoro sia contestualmente individuale(ogni operatore ha
responsabilità formale per la comunicazione con altri luoghi
rilevanti) e collettiva in quanto debbono coordinarsi per portare a
termine in modo ordinato le operazioni di imbarco e sbarco e questo
viene ottenuto tramite il mantenimento di un forte orientamento
reciproco.
Al contempo queste osservazioni consentono di ridefinire il
significato di spazio lavorativo, visto non più come ambiente
oggettivo o meramente fisico, bensì come ‘territorio situazionale’
(Goffman, 1959, Suchman, 1996) cioè campo di percezione ed
interazione, attivamente costruito e continuamente mantenuto nel
corso del lavoro quotidiano. Si pensi a come le ICT medino lo spazio
in termini di coordinamento del lavoro a distanza e contribuiscano
alla de-materializzazione del concetto di ‘posto di lavoro’ e quindi in
scenari simili siano le relazioni sociali del lavoro che definiscono i
confini visibili ed invisibili del luogo di lavoro e quindi come la
costruzione di spazi (e tempi) di lavoro condivisi sia un processo di
10
convergenze, divergenze e allineamenti di molteplici linee di attività.
Gli spazi di lavoro non solo sono un territorio situazionale, ma sono
anche una materializzazione della memoria. Ad esempio Lave et al
(1984) mostra come l’organizzazione spaziale dei supermercati
configuri un’arena che mette in scena una situazione in cui l’ordine
degli elementi sugli scaffali riproduca l’ordine con cui vengono messi
nel carrello. Analoghe strategie spaziali sono descritte dalla Scribner
(1984) in relazione ai librai che debbono trovare i libri o da Beach
(1988) in relazione ai barman che utilizzano la forma e il posto dei
bicchieri, nonché i colori dei liquori per aiutarsi a ricordare la
preparazione di cocktails. In particolare David Kirsh (1999) ha
studiato come l’organizzazione spaziale del luogo di lavoro venga
predisposta in modo da facilitare il controllo dell’attività, da ridurre il
carico di lavoro mnemonico o la quantità di calcoli richiesto, che
semplifichino la ricerca visuale o la categorizzazione necessaria nel
compito. Quando gli oggetti vengono dislocati secondo modalità
opportune, essi ci interpellano attivamente: ci fanno ricordare di
qualcosa, attirano la nostra attenzione, ci impediscono di pensare ad
alternative non pertinenti come quando ci vietano qualcosa.
Nuove categorie di analisi:coreografia, performance,
estetica
Mentre l’analisi tradizionale dell’attività lavorativa si è basata
prevalentemente sulla divisione del lavoro in attività e compiti e
quindi ha assunto prevalentemente l’ottica della progettazione delle
mansioni e della loro valutazione, il portare l’attenzione sulle attività
di esecuzione, sullo svolgimento di queste in ambienti
tecnologicamente densi e che richiedono la manipolazione di oggetti
e di simboli, consente di problematizzare le categorie di analisi
tradizionali e di proporne di nuove. Abbiamo visto come il luogo di
lavoro in quanto territorio situazionale venga disegnato dalle
relazioni sociali, come lo spazio costituisca una struttura spaziale
attrezzata per contenere/restituire informazioni, come le tecnologie
siano sempre più in interazione con gli umani e come gli oggetti
costituiscano degli scenari e dei supporti informativi per l’attività.
Ebbene questi elementi ci consentono di pensare ed analizzare il
lavoro come se fosse una coreografia e non una routine di compiti
che formano un programma d’azione. L’analisi di un call centre
(Whalen et al, 2002) di una grande azienda produttrice di macchine
11
per ufficio descrive come le azioni dei venditori richiedano che per
mostrare la loro competenza essi debbano avere padronanza delle
tecnologie e degli artefatti ed i loro metodi di condotta (per non
lasciare tempi morti nella conversazione e per proporsi come
professionalmente competenti) richiedano una coreografia
improvvisata di varie azioni.
Gli elementi coinvolti nella coreografia sono: un software di
consultazione (elemento strutturato), carta e penna (elementi più
flessibili), attività di conversazione e movimenti del corpo. Gli
autori, analizzando il lavoro dell’operatore come una coreografia
meccanica ne descrivono quattro forme:
1. la disposizione degli oggetti nello spazio di lavoro e del corpo
in relazione a questi posizionamenti. Ad esempio sulla destra
del monitor c’è la lista di tutti i clienti del venditore, a destra
del desktop ci sono carta e penna, mentre i documenti cartacei
sono a sinistra e tra questi c’è la guida in formato cartaceo che
viene usata più frequentemente di quella on line perché
l’operatore
la
può
consultare
senza
modificare
significativamente la propria posizione fisica. Il corpo infatti
e la sua posizione sono parte integrante di questa condotta
nello spazio e l’operatore ha imparato ad usare il mouse con la
sinistra per avere la destra libera per immettere codici nel
computer o per scrivere;
2. l’aggiramento dei problemi generati dall’inflessibilità del
software. Ad esempio esso non prevede uno spazio dove
inserire il nome di chi sta chiamando e quindi l’operatore
deve scriverlo su carta perché questo è una risorsa importante
nel gestire una conversazione,
3. l’anticipazione degli eventi, come ad esempio la richiesta dei
clienti.
E’ la conoscenza pratica che l’operatore ha
accumulato la risorsa principale per questa operazione,
4. il coordinamento di molteplici strumenti e mezzi. Nel mentre
che parla l’operatore deve usare il software sul PC e la guida
cartacea senza interrompere la conversazione e quindi deve
coordinare l’attività di ricercare le informazioni da dare
facendo in modo di aver già trovato le risposte alle richieste
successive prima di aver finito di rispondere alle precedenti,
dando così l’impressione di padronanza dell’argomento.
Gli autori concludono che ciò che sembrava una routine fatta di
compiti da svolgere in successione è meglio interpretata come una
12
coreografia improvvisata, cioè un set di metodi pratici condivisi dai
membri di questa comunità di lavoro e che richiede una notevole
abilità in quanto la qualità del lavoro non è predeterminata, ma
coinvolge il giudizio, la destrezza e la cura con cui l’operatore svolge
il suo compito e la qualità del risultato è sempre a rischio durante il
processo.
Si noti anche come la tecnologia, che è pensata per ridurre
l’incertezza, durante il singolo incontro è organizzata localmente ed è
dunque contingente.
L’idea della coreografia è illustrata bene anche dallo studio di
Schmidt e Wagner (2005) sul lavoro degli architetti e sul come essi
assemblano i materiali per un compito e lì ridistribuiscono
rapidamente per quello successivo (coreografie effimere) e come in
queste riconfigurazioni alcuni oggetti abbiano un forte carattere
narrativo che li distingue da altri.
Il concetto di coreografia può essere considerato interno ad un più
ampio set di concetti raggruppabile nel termine “lavoro come
performance”.
La polisemia del termine performance comprende tanto l’oggetto
finito, portato a compimento, quanto il processo del portare a
termine. La performance, nel suo senso artistico, è poi effimera e
contingente:qualcosa che crea un effetto e poi scompare lasciando
una traccia dietro di sé. E’ quindi un concetto che richiama la
contingenza e l’interattività. In sociologia ha una tradizione
goffmaniana che non considera tanto la performance quanto la
“performativity” cioè l’insieme di quei processi espressivi di
“impression management” e di improvvisazione contingente con i
quali gli umani normalmente articolano i loro interventi, le situazioni
e le relazioni della vita quotidiana.
Ad esempio sviluppare una identità professionale e, al suo interno,
apprendere il relativo codice di comportamento di genere è stato
analizzato come abilità situata del mettere in scena e di allineare
elementi eterogenei, materiali e discorsivi (Bruni e Gherardi, 2001).
Infine un contributo nella ricerca di categorie per l’analisi del lavoro
come attività pratica viene dall’estetica e dal considerare sia la
conoscenza acquisita tramite i sensi, sia le categorie estetiche come
giudizio estetico condiviso e formantesi entro una comunità di
pratica.
Ad esempio Strati (2000: ??) definisce la conoscenza estetica come
‘quella forma di sapere che la persona umana consegue attivando
13
nella quotidianità organizzativa le capacità specifiche delle proprie
facoltà percettivo-sensoriali e di giudizio estetico’. La dimensione
estetica nelle organizzazioni, cioè, non è limitata al giudizio estetico,
non è riferita solo a ciò che è bellezza, o che è brutto, grottesco o
kitsch;, ma è pure, al tempo stesso, quello che i cinque sensi della
vista, dell’udito, dell’odorato, del gusto e del tatto fanno conoscere.
Caratteristica, quest’ultima, che anche Michael Polanyi (1962) ha
considerato proponendo la distinzione tra conoscenza esplicita, vale a
dire il sapere formalizzato, e conoscenza tacita, ossia il sapere di
saper fare senza essere in grado di fornirne una adeguata descrizione
analitica. Nel descrivere un gruppo di carpentieri che lavorano al
disfacimento di un tetto e nel descrivere la conoscenza tacita da essi
posseduta ed attivata in situazione, Strati argomenta che le categorie
dell’estetica ci consentono di:
a) contrapporci alla spiegazione razionale cartesiana, grazie al
valorizzare il mythos, l’immaginazione mitologica, il ragionare
per metafore, ossia il pensare mitico degli individui ed il legame
stretto e continuativo tra questo loro pensare ed il loro sentire
basato sulle facoltà sensoriali e percettive dei loro corpi;
b) considerare il giudizio sensitivo a cui si deve la facoltà di
giudicare cose sulle quali il giudizio intellettuale, invece, non ha
facoltà di comprensione. Si tratta di ciò che giunge ai nostri sensi
e che fa parte della nostra esperienza sensoriale, ovvero del
complesso delle rappresentazioni sussistenti al di sotto delle
distinzioni analitiche che costituiscono la scienza;
c) considerare il giudizio estetico che verte sulla perfezione o
imperfezione di quella particolare cosa. Si tratta di un giudizio
sensibile che non dà concetti, bensì formula un apprezzamento
sulla perfezione o sulla imperfezione che viene percepita ed ha il
carattere di sentimento e di gusto, ossia un giudicare in armonia
con il sentire invece che con i concetti.
Questi esempi di utilizzo di categorie non tradizionali per lo studio
del lavoro ci consentono di osservare un tratto comune ad esse e cioè
come s’inscrivano in una più generale rivalutazione del sapere
narrativo in contrapposizione al sapere paradigmatico o analitico.
Bruner (1986) scrive di due modalità cognitive, diverse e
complementari: la comprensione paradigmatica e la comprensione
narrativa e definisce la modalità paradigmatica della cognizione
come finalizzata a puntualizzare il flusso dell'esperienza, a separare,
ad individualizzare, a comparare, a calcolare e a dare valutazioni
14
comparative. Mentre la modalità paradigmatica consente solo una
rappresentazione della realtà alla volta in quanto è tesa alla
validazione secondo il criterio di verità (vero/falso), la modalità
narrativa consente una pluralità di ricostruzioni/rappresentazioni
contemporanee del mondo in quanto il suo criterio di validazione è la
plausibilità (Poggio, 2004). Infatti è attraverso la narrazione che una
situazione acquisisce senso per sé e per gli altri perché è attraverso il
narrare che vengono costruite le categorie che danno un nome e un
significato agli eventi narrati (Jedlowski, ). Lo straordinario potere
della conoscenza narrativa risiede infatti nel legame che, attraverso le
narrazioni, le persone stabiliscono tra l’eccezionale e l’ordinario
quando tentano di stabilire delle spiegazioni, giustificazioni e
interpretazioni dei comuni fatti quotidiani.
La ricerca di categorie interpretative “alternative” è appena iniziata e
le analogie con le attività artistiche può essere una via interessante da
percorrere perché mette a fuoco sia la natura processuale di ciò che pur nella continua ri-produzione - è sempre una opera unica, sia la
sua natura di esperienza compiuta e conclusa.
In questa ricerca le categorie della quotidianità possono offrire un
contributo rilevante?
Un frame analitico per studiare il lavoro come
quotidianità
Così come il lavoro può essere definito ed analizzato in modi diversi
a seconda dell’orientamento teorico del ricercatore, così il quotidiano
è soggetto ad una pluralità di concezioni teoriche (Jedlowski,
1986;2003, Ghisleni, 2004) e non è questo il luogo di una accurata
disamina degli approcci. Per trovare un ambito comune ai due
termini propongo di considerarli entrambi entro un approccio
fenomenologico e di definire ciò che li accomuna nei termini di una
tensione tra opposti.
Infatti se il lavoro viene considerato come esperienza soggettivamente e collettivamente significativa - e come pratica
sociale situata nella quotidianità, allora il campo semantico entro il
quale la quotidianità del lavoro può essere interpretata può essere
delimitato dalla tensione tra le seguenti coppie di termini:
produzione/riproduzione
habitus/azione
ripetizione/innovazione
15
tipico/unico
convenzione/innovazione
dato per scontato/riflessività
Preferisco parlare di tensione e non di concetti che si definiscono per
differenza ed opposizione per sottolineare come entrambi i termini
siano necessari per descrivere le attività situate in un contesto spaziotemporale di interazioni significative.
Un frame interpretativo che consenta di analizzare e progettare il
lavoro come una pratica quotidiana potrebbe quindi essere basato sui
seguenti presupposti:
l’oggetto del lavoro, nel senso del suo prodotto e dell’attività
compiuta (opus operatum), è emergente e prodotto
collettivamente nel corso di interazioni situate e sostenute dal
mantenimento di un orientamento comune e reciproco;
il posto di lavoro (workplace e work space) è un territorio
situazionale, costituito e ricostituito attivamente attraverso le
pratiche lavorative quotidiane,
il “fare” lavorativo non è attività separata dal conoscere,
apprendere, organizzare ed innovare. Attraverso il “conoscere in
pratica” si può cogliere analiticamente la complessità
dell’intreccio tra le attività compresenti.
L’insieme di questi presupposti delinea uno spazio interpretativo in
cui è centrale il concetto di interazione situata e questa è mediata da:
il corpo, sia come presenza fisica (co-presente o differita e
mediata da tecnologie ICT) che come strumenti di lavoro, che
come fonte di conoscenza sensibile, che come contenitore di
conoscenza tacita incorporata negli schemi corporei per l’azione e
per la memoria,
le tecnologie, gli oggetti e la materialità del mondo circostante o
del mondo virtuale intrecciato ad esso (mixed spaces, mixed
objects). Il mondo materiale non è passivo, ma ci interpella
costantemente, è “attante” (Latour, 1986) entro una ecologia di
umani e non umani, è “protesi” tecnologica (Norman, 1990) delle
capacità umane limitative, è “progetto che ha preso corpo”
(Mantovani, 1995).
Il linguaggio, sia esso nella forma del vocabolario tecnico che
della semantica e pragmatica del suo uso, sai esso il medium di
pratiche discorsive, cioè di un “fare” e “conoscere” che ha luogo
nel discorso e per mezzo di esso,
16
-
Le relazioni sociali, che si manifestano ed assumono forma
tramite “l’ordine dell’interazione” (Goffman, 1956), sia esso dato
dalla reciproca compresenza (faccia a faccia o differita) o da
relazioni inscritte nella divisione del lavoro o nel sistema
normativo (regolazione sociale del lavoro) o nel sistema sociale.
Conclusioni
Studiare il lavoro come attività situata assume particolare rilevanza
nella società della conoscenza poiché in questo periodo storico si
guarda alla conoscenza come ad una speciale risorsa produttiva.
Lo studio dell’attività situata non è del tutto nuovo in quanto la
tradizione etnometodologica aveva già etichettato questo ambito
d’indagine del lavoro nei termini del “missing what” (Fele, 2002) per
sottolineare come nello studio del lavoro mancasse proprio una
focalizzazione sulle attività.
Tuttavia rispetto alle ricerche
etnometodologiche di ………… oggi sono cambiati gli elementi di
particolare attenzione e, a mio avviso, la maggiore sfida è costituita
dalla complessità dei contesti lavorativi tecnologicamente densi, nei
quali le nuove tecnologie ICT hanno dissolto i confini spazio
temporali tra la realtà on line e off line e le forme dell’interazione
non sono limitate agli esseri umani ma anche agli umani e le
macchine “intelligenti”.
La conoscenza dettagliata del lavoro situato in questi contesti ha una
immediata rilevanza pratica per la progettazione delle nuove
tecnologie che dovrebbero essere di supporto alle attività lavorative,
ma che nel supportarle vanno a cambiare le relazioni socio tecniche
pre esistenti e quindi richiedono al progettista una capacità di
conoscere l’oggi per disegnare il domani ed una capacità di
coinvolgere gli utilizzatori nella progettazione perché i sistemi
tecnologici incorporano gli script delle relazioni sociali e gli
utilizzatori spesso possiedono la conoscenza necessaria allo sviluppo
della tecnologia mentre i produttori non l’hanno. Un esempio di
questo è il campo della bioinformatica o dello sviluppo delle
tecnologie medicali. La nascita di un filone di studi che va sotto il
nome di “participatory design” (Schuler, Namioka, 1993) si è
sviluppato entro le discipline informatiche e spesso ha coinvolto
sociologi con un background etnografico, tuttavia il mainstream della
sociologia del lavoro ancora non ha recepito la rilevanza del tema.
17
Bibliografia
Beach (1988)
Beck, U. (1994). 'Self-Dissolution and Self-Endangerment of
Industrial Society: What Does This Mean?' in U. Beck, A.
Giddens,
and
S.
Lash
(eds.),
Reflexive
Modernization.
Cambridge, Polity Press, 174–83. (trad. it. La modernizzazione
riflessiva, Il Mulino, Bologna, 1995).
Beck U., (2000) Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro. Tramonto
delle sicurezze e nuovo impegno civile, Einaudi, Torino, 2000
Berger, P.L. e T. Luckmann 1966 The Social Construction of Reality,
London, The Penguin Press.; trad. it. La realtà come costruzione
sociale, Bologna, Il Mulino, 1979.
Blackler F. (1999), “Il processo di conoscenza come prodotto delle
comunità”, Studi Organizzativi, 3: 5-18.
Borghi V., 2000, “Complessità versus flessibilità. Appunti per un
programma di ricerca sulle trasformazioni del lavoro”, in
Sociologia del lavoro, n. 80, pp. 89-110.
Bruner, J. S., (1986), Actual Minds, Possible Worlds, Cambridge,
MA: Harvard University Press.
Bruni, A. (2004), “Tecnologie, oggetti e pratiche di lavoro
quotidiane: il caso della cartella clinica informatizzata”. In
18
Gherardi, S. e Strati, A. (a cura di), Telemedicina: tra tecnologia
e organizzazione. Carocci, Roma
Bruni, A., Gherardi, S. (2001), ‘Omega’s story: the heterogeneous
engineering of a gendered professional self’, in Dent, Mike, and
Stephen Whitehead (eds), (2001), Managing Professional Identities:
Knowledge, Performativity And The ‘New’ Professional,
London:
Routledge,
Carassa, 2000
Chiesi, A. (1995), "Le trasformazioni dei contenuti del lavoro", in
Chiesi A., Regalia I., Regini M., Lavoro e Relazioni Industriali in
Europa, Milano: La Nuova Italia Scientifica.
Conein, B. and Jacopin, E. (1994) ‘Action située et cognition: le
savoir en place’, Sociologie du Travail, 94(4) :475-500.
Engestrom Y. (1987), Learning by Expanding: An Activity
Theoretical Approach to Developmental Research. Helsinki,
Orienta Konsultit.
Fele G., (2002), Etnometodologia, Roma, Carocci.
Fornel, M. de, and Quéré, L. (1999) Presentation. In Fornel, M. de,
and Quéré, L. (eds) La logique des situations, Paris: Editions de
l’Ecole des Hautes Etudies en Sciences Sociales, 7-32.
Gherardi, S., “La pratica quale concetto fondante di un rinnovamento
nello
studio
dell’apprendimento
organizzativi, 2000, 1, 55-71.
19
organizzativo”,
Studi
Gherardi, S. (2005), Organizational Knowledge: The Texture of
Workplace Learning, Blackwell, Oxford, (in corso di stampa)
Ghisleni, 2004)
(Goffman, 1956
Goffman, E. 1959 The Presentation of Self in Everyday Life, Garden
City, NY, Doubleday; trad. it. La vita quotdiana come
rappresentazione, Bologna, Il Mulino, 1979.
Goffman, E. (1967). Interaction Ritual. Garden City, NJ: Doubleday.
Heath, C. and Button, G. (2002) ‘Special issue on workplace studies:
editorial introduction’, The British Journal of Sociology, 53(2):
157-161.
Heath, C. and Luff, P. (1996) Convergent activities: line control and
passenger information on the London Underground, in Cognition
and Communication at Work, Engestrom, Y. and Middleton, D.
(eds). Cambridge: Cambridge University Press.
Jedlowski
Jedlowski, 1986;2003,
Kirsh, D. (1995) ‘The intelligent use of space’, Artificial Intelligence,
73: 36-68.
20
Knorr-Cetina, K. (1997) ‘Sociality with objects: social relations in
post-social knowledge societies’, Theory, Culture and Society,
14(4): 1-30.
Latour, B. (1987), Science in Action. Open University Press.
Lave, J. (1988) Cognition in Practice, Cambridge: Cambridge
University Press.
Lave et al (1984)
Law, J. (1987) 'Technology and heterogeneus engineering: the case
of the portuguese expansion'. In W.E. Bijker, T. P. Hughes, T.J.
Pinch (eds), The social construction of technical systems: new
directions in the sociology and history of technology. 111-134,
Cambridge, MA: MIT Press.
Law, J. e J. Hassard 1999 Actor Network Theory and After, Oxford,
Blackwell.
Luhmann, N. (1984). Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen
Theorie. Frankfurt on the Main: Suhrkamp.
Magatti M., Fullin G. (a cura di), 2002, Percorsi di lavoro flessibile,
Carocci, Roma.
Mantovani, G., (2005), Ergonomia, Bologna, Il Mulino
Norman, D. (1990) The Design of Everyday Things. New York:
Doubleday/Currency.
Poggio, B. (2004), Mi racconti una storia?
21
Polanyi, M. (1962). Personal Knowledge. London: Routledge and
Kegan Paul.
Reyneri, E. (2005)…..IL Mulino
Schatzki, T. R., Knorr Cetina, K., von Savigny, E. (eds) (2001), The
Practice Turn in Contemporary Theory, London and New York:
Routledge
Schutz, A. (1971). Collected Papers. The Hague: Nijhoff.
Schuler, D., Namioka, A. (1993), Participatory Design: principles
and Practices, Hillsdale: Erbaum.
Schmidt e Wagner (2005)
Strati, A., (2000), Estetica, conoscenza tacita e apprendimento
organizzativo, Studi Organizzativi, 2.
Strati,
A.,
(2003)
Centralità
della
pratica
nello
studio
dell’organizzazione e conoscenza sensibile, Sociologia del
Lavoro, 92.
Suchman, L. (1987) Plans and situated action: the problem of
human-machine
communication.
Cambridge:
Cambridge
University Press.
Suchman, L. (1996), Constituting Shared Workspaces. In Engestrom,
Y. & Middleton, D. Cognition and communication at work.
Cambridge: Cambridge University Press, , 35-60.
22
Suchman, L., Blomberg, J. Orr, J.E., Trigg, R. (1999) Reconstructing
technologies as social practice, in American behavioural scientist,
43(3): 392-408.
Paper preparato per il convegno Lavoro e vita quotidiana, Venezia
18-19 aprile 2005. Si prega di non citare senza autorizzazione.
23
Lavoro, organizzazione e vita quotidiana tra
separatezza e scambio.
Giovanni Gasparini
Università Cattolica
1. Una premessa
L’idea alla base del Seminario nel suo complesso è quella di mettere
insieme e a confronto e di far interagire due diverse prospettive e
tradizioni di studio sociologiche - quella della Sociologia del lavoro e
dell’organizzazione da un lato, quella della Sociologia della vita
quotidiana d’altro lato – che sembrano essere state finora non solo
distinte ma scarsamente comunicanti tra loro.
L’ipotesi generale sulla quale si articola l’intervento riguarda il
passaggio da una situazione di separatezza di studio e ricerca (dagli
anni 70-80 in poi) ad una nuova realtà, quella attuale, in cui diversi
fattori sollecitano uno scambio attivo e proficuo tra le due tradizioni
subdisciplinari.
2. Uno sguardo retrospettivo alla tradizione della Sociologia del
lavoro e della Sociologia dell’organizzazione
Si individuano gli ambiti prevalenti di sviluppo della Sociologia del
lavoro e dell’organizzazione, alla luce di alcune opere-chiave su cui
si sono formati e a cui hanno collaborato gli studiosi italiani del
settore nel dopoguerra, a partire dagli anni 60-70. Ne emerge una
forte centratura sulle tematiche tipiche dell’azienda e di riflesso del
sindacato, con un’attenzione solo marginale e indiretta a
problematiche caratteristiche della vita quotidiana.
3. Cenni alle tematiche della Sociologia della vita quotidiana
Vengono richiamate, con riferimento anche ad altri interventi previsti
nel Seminario, le tematiche principali oggetto della Sociologia vita
quotidiana. I punti di incontro più evidenti con la Sociologia del
lavoro, negli anni 80-90, sembrano essere due: il lavoro delle donne,
con la problematica della doppia presenza e del lavoro di cura; il
tempo di vita rispetto al tempo di lavoro, con riferimento ancora alla
condizione femminile e con una proiezione più ampia sui servizi
della città.
4.La situazione oggi: dalla separatezza alla convivenza e allo
scambio
24
Una serie di trasformazioni in atto a cavallo del nuovo secolo e
millennio nelle società postindustriali contemporanee sembrano
spingere verso una convivenza mutuamente consapevole e uno
scambio intellettuale tra le due subdiscipline sociologiche in
questione.
Tra tali fattori trasformativi si possono indicare in sintesi:
- nuove tecnologie e strumenti della comunicazione (in
particolare, con riferimento ai processi di disembedding,
delocalizzazione,
istantaneizzazione),
che
incidono
fortemente sulle problematiche precedenti riguardanti il
tempo di lavoro e il luogo di lavoro;
- la molto maggiore esposizione del lavoro e delle
organizzazioni produttive nei riguardi di fattori, fenomeni e
variabili trasversali, esterne all’azienda e riconducibili –
almeno in parte - alla vita quotidiana;
- l’inserimento delle nuove realtà e prospettive del lavoro nel
quadro di analisi sociologiche generali, globali;
- la tendenza scientifica in atto a uscire dalle specializzazioni
eccessive, ad allargare i confini tra subdiscipline e discipline,
a lavorare e ricercare creativamente sulle intersezioni, gli
interstizi disciplinari, le aree grigie.
In conclusione, il binomio hardware/software viene utilizzato come
possibile metafora della situazione e dei rapporti tra le due tradizioni
subdisciplinari in questione.
25
Giuliana Chiaretti (Università di Venezia),
Disagi giorno per giorno: resistenze, adattamenti, routine.
26
La narrabilità del lavoro e della quotidianità.
Paolo Jedlowski
Università “L’Orientale” di Napoli
1. "Fra le dimensioni dell'identità adulta, il profilo del Sè legato al
lavoro professionale è fra i più significativi. In primo luogo perchè il
tempo giornalmente dedicato all'attività professionale è quello più
ampio. E in secondo luogo perchè, per una persona media, le chance
di vita dipendono dall'attività professionale svolta". Scrive così
Maurizio Ghisleni in un recente studio sulla Sociologia della
quotidianità. Considerazioni come queste suggeriscono che il lavoro
dovrebbe essere al centro dell’attenzione di chi studia la quotidianità.
Per motivi che appartengono meno alla teoria che alla pratica della
“divisione dei compiti” all’interno della comunità accademica, i
sociologi che si sono occupati della vita quotidiana non si sono mossi
spesso, però, in questa direzione. Piuttosto, se si sono occupati del
lavoro, lo hanno fatto riconoscendo che la riduzione del termine
“lavoro” al significato di “occupazione professionale”, che ha per
contropartita un reddito, è a sua volta un portato specifico della
modernità, e che una delle conseguenze di tale riduzione è che non
vengono considerate “lavoro” le attività che non rientrano nella
contabilità economica ufficiale, e soprattutto non vi rientrano le
attività domestiche, di servizio e di cura, svolte prevalentemente dalle
donne.
Non mi occuperò qui, però, della storia di queste ricerche. Nel
contribuire a costruire il quadro delle domande intorno a cui
vorremmo che ruotasse questo incontro, proverò a mettere in gioco
alcune nozioni della sociologia della vita quotidiana per affrontare la
questione della “narrabilità” del lavoro e della quotidianità: della
possibilità cioè di raccontare ciò che avviene nel corso di attività che,
in una certa parte almeno, vengono date per scontate dai soggetti
coinvolti.
2. Tanto la vita quotidiana quanto le modalità del lavoro sono
costantemente mutate nel corso della storia dell'uomo. Ma la
modernità, come già Benjamin notava agli inizi del Novecento, ha
reso le abitudini sempre più brevi. Negli ultimi decenni questo è
diventato ancora più vero, a tal punto che la percezione del
mutamento sembra essere diventata il segno più caratteristico della
27
quotidianità stessa. La nostra è una quotidianità mobile e incerta: per
quanto possa apparire un ossimoro, siamo immersi in quella che
potremmo chiamare una quotidianizzazione del mutamento.
Ma, per quanto possa mutare, la vita quotidiana ha un rapporto
consustanziale con la routinizzazione. Il pensiero quotidiano tende
incessantemente a "naturalizzare" le condizioni della nostra esistenza,
cioè a considerarle sotto la specie dell'eternità. Una falsa eternità,
un'eternità presunta, certamente, ma una presunzione che serve a
sostenere quella che chiamiamo la nostra "sicurezza ontologica". Una
presunzione che è del resto connessa alla nostra necessità di tipizzare
le situazioni più ricorrenti e di rendere parzialmente automatici
almeno i comportamenti che dobbiamo attuare più frequentemente
con altri. Il pensiero quotidiano tende incessantemente a dare per
scontato qualcosa. E non può farne a meno.
3. Ciò implica una tensione fra quotidianità e racconto. Questa
consiste nel fatto che nella vita quotidiana, per definizione, non
prestiamo e non possiamo prestare attenzione ad ogni cosa. Gran
parte degli ambienti, delle relazioni, delle pratiche e degli universi di
senso entro cui siamo immersi sono dati per scontati. Ma se non vi
prestiamo attenzione, come possiamo narrarli?
La risposta è che possiamo narrarli nella misura in cui mutano. Come
spiega ogni narratologo, il racconto è una forma del discorso che ha
essenzialmente a che fare con il mutamento, e la vita quotidiana ne
può essere oggetto esattamente per il fatto che muta. Certo, il
quotidiano ha una dimensione routinaria. Ma la routine non è
ripetizione: è ripresa. Le stesse cose non sono mai fatte
identicamente. Ed esistono d’altra parte imprevisti, eventi critici,
processi di addomesticamento di oggetti o di situazioni nuove che,
inserendosi nel quotidiano, illuminano per riflesso anche tutto ciò che
non muta, poiché lo costituiscono come lo sfondo che permette di
riconoscerli. Infine, ogni fase della vita di una persona corrisponde a
una diversa organizzazione della sua quotidianità, ed il confronto tra
queste diverse organizzazioni si presta a essere ordinato narrando.
Certo, sappiamo che la caratteristica della situazione contemporanea
è che la successione delle fasi biografiche tende a destrutturarsi: le
fasi sono diverse per ognuno, possono allungarsi, comprimersi,
differenziarsi ulteriormente, persino comportare ritorni all'indietro.
Ciò comporta una sorta di crisi permanente. Ma non intacca la
possibilità di raccontare e di raccontarsi: se mai, anzi, ne rende più
28
avvertito il bisogno, nello stesso momento in cui ne rende più
difficile la realizzazione.
4. Al di qua di ogni riflessione sul quotidiano, sappiamo che
raccontare e raccontarsi è reso difficile nel mondo contemporaneo
dalla frammentazione delle esperienze e delle identità, che toglie
plausibilità alla linearità di un racconto. La molteplicità delle
appartenenze e delle possibili definizioni di sè apre ogni racconto alla
critica di tutti gli altri racconti che, anche a proposito delle medesime
cose, potrebbero essere svolti in linguaggi o da punti di vista diversi.
Questa difficoltà ha un'importanza da non sottovalutare. Il punto è
infatti che riconoscere una trama nella nostra esistenza è uno dei
modi principali di cui disponiamo per attribuire a quest'ultima un
senso e l'incapacità di narrare e di narrarsi, quando si manifesti
davvero, è una seria minaccia alla nostra presa sulla realtà.
L’esperienza e il racconto hanno un rapporto circolare. Senza
qualcosa che si stagli come un’esperienza - un apprendimento, un
incontro, una situazione di cambiamento o di rischio - la narrazione si
attiva difficilmente. Ma il racconto a sua volta è ciò che rende
un’esperienza propriamente tale: è un modo di appropriarsi degli
eventi e dei vissuti, di attribuirvi significato ordinandoli. Come
spiegava Walter Benjamin, l’atrofia dell’esperienza e quella della
narrazione sono solidali.
Benjamin pensava che la tendenza all’atrofia dell’esperienza e della
narrazione fosse caratteristiche della condizione moderna. Ma le
tendenze si accompagnano sempre a controtendenze. E i soggetti
hanno più risorse di quante a volte non gliene attribuiamo.
Il punto qui è riconoscere che la narrazione ha un posto di tutto
rilievo nella quotidianità anche oggi. Ciascuno racconta qualcosa
mentre vive ogni giorno. Lo fa spesso. Narrare è un aspetto ordinario
delle pratiche di cui la vita quotidiana è intessuta.
Un’infinità di conversazioni comprende passaggi in cui l’uno degli
interlocutori mette l’altro a parte di avvenimenti occorsi a lui stesso,
ad altri o a personaggi più o meno di fantasia (quelli di cui apprende
dai media, ad esempio): in cui cioè viene raccontata una storia. Come
ha scritto una studiosa americana, “quasi ogni espressione verbale, in
realtà, è legata a una dose più o meno piccola di narrazione, che può
andare dal resoconto frammentario e dall'aneddoto appena accennato
fino a quei discorsi più definiti e contrassegnati da alcune
29
convenzioni linguistiche che tendiamo a chiamare propriamente
‘racconti’”.
Si può raccontare con arte maggiore o minore (c’è chi è un buon
narratore e chi non lo è). In ogni caso, la narrazione è un’azione che
coinvolge almeno due attori. Si dispiega in una relazione sociale. E’
la pratica grazie a cui un narratore e un destinatario mettono in
comune una storia. Quali storie, come e perchè vengano messe in
comune dipende dalla relazione, la quale a sua volta può essere
rafforzata o, in certi casi, modificata dalle storie che ospita.
Non a tutti infatti si raccontano le medesime cose, e le funzioni della
narrazione, nella vita quotidiana, possono essere tanto varie quanto
sono varie le relazioni in cui ci troviamo implicati.
Anche le complesse organizzazioni del lavoro di oggi prevedono
spazi in cui i lavoratori più vecchi raccontano storie ai nuovi arrivati,
narrazioni aziendali in cui ci si dispensa consigli su come
comportarsi, ci si introduce alle dimensioni informali delle relazioni,
si costruisce la "morale" del gruppo e si produce e riproduce la
memoria del gruppo stesso. Ogni comunità di pratiche è anche una
comunità di racconti.
La narrazione è una parte di quelle pratiche di conversazione che
hanno comunque, in ogni cultura, un ruolo decisivo nella costruzione
di uno spazio di socialità. Narrare e scambiarci informazioni è un
modo per coordinare le nostre attività ed orientarci praticamente nel
mondo, per costruire e ricostruire incessantemente un’interpretazione
della realtà condivisa. I sociologi hanno imparato da tempo che la
costruzione sociale della realtà è un’operazione in gran parte
linguistica, o più propriamente discorsiva: nei discorsi mediante i
quali si definiscono i contorni della realtà e i nessi possibili fra gli
avvenimenti, le narrazioni giocano un ruolo cruciale.
5. Se la questione è dunque la narrabilità del quotidiano, un primo
elemento della risposta è questo: la narrazione è parte del quotidiano.
E in parte ha il quotidiano come suo oggetto: un fatto, questo,
probabilmente oggi vero più che mai, data la particolare attenzione
che diverse agenzie prestano alla quotidianità e data l’accresciuta
necessità di atteggiamenti autoriflessivi da parte di tutti i soggetti.
Ma resta un problema. Non tutto, nella vita quotidiana, si presta
facilmente all’autoriflessività. Ciò deriva in primo luogo dal ruolo
che nel quotidiano giocano i saperi pratici. Come sa bene chi ha
provato, ad esempio a cimentarsi con manuali di istruzioni per l’uso
30
di un macchinario, o per apprendere un’arte come la cucina il
giardinaggio, i saperi pratici non si lasciano facilmente riprodurre in
parole. Il sapere pratico si acquista con la pratica. Si possono
raccontare storie esemplari, ma nessuna istruzione può mai risultare
esaustiva. In secondo luogo, deriva da fatto che ogni discorso, per
poter essere formulato e per venire compreso, deve appoggiarsi
necessariamente su un insieme di presupposti di senso che non sono
esplicitati. Come ha ben mostrato Garfinkel, il tentativo di rendere
esplicito ogni presupposto conduce a una regressione infinita.
Tutto ciò significa che non possiamo aspettarci che le narrazioni che
si svolgono nella quotidianità, fra i soggetti che vi sono coinvolti,
dicano tutto a proposito della quotidianità.
D’altra parte, è lecito aspettarsi che proprio in ciò che gli attori danno
per scontato nel corso delle proprie pratiche e dei loro discorsi si
nascondano elementi importanti (se non gli elementi più importanti)
per comprendere che cosa avviene di fatto.
La dimensione quotidiana di ogni attività lavorativa comporta
l’esistenza di routine e di “sensi comuni locali” che difficilmente
possono essere esplicitati da chi vi è coinvolto, e non sono facili da
percepire per chi ne è all’esterno. Per questo raccontarla è difficile.
Ma senza la comprensione di questa dimensione non si comprendono
neanche gli esiti concreti a cui il lavoro conduce, e non si comprende
l’insieme dei significati che il lavoro riveste.
6. E’ all’altezza di questo problema che si situa a mio avviso il
compito di chi fa sociologia. Questo non può limitarsi alla raccolta di
narrazioni locali. Consiste piuttosto nel ricostruire l’universo di senso
entro cui queste narrazioni si collocano, ma che non sono in grado di
dire.
Ricordando alcune ricerche recenti, Barbara Poggio ha notato che “le
organizzazioni non possono essere rappresentate da una singola
storia, ma contengono e si esprimono attraverso una pluralità di storie
e di interpretazioni di storie, spesso in conflitto tra loro”. Ciò
significa - scrive - che le narrazioni sono in fin dei conti
“micropratiche di potere”, e che la storia cui la stessa indagine
sociologica mette capo è una storia fra le altre. Sul piano del metodo,
queste osservazioni sospingono verso una costruzione “riflessiva” dei
materiali, in cui le voci dei soggetti narrati siano affiancate, senza
venire negate, alla voce del ricercatore, in un “mettersi alla prova”
reciproco. Penso sia giusto. Ma potremmo aggiungere che il compito
31
del ricercatore si spinge al di là della costruzione di una “propria”
storia da affiancare alle altre: il suo compito consiste nel ricostruire
gli universi di senso entro cui ogni singola storia proposta dagli attori
coinvolti si situa. Svolgendo tale compito, il sociologo offre di fatto
un “di più” di conoscenza: contribuisce cioè a rendere edotti gli stessi
soggetti di ciò che sanno senza, per così dire, saper di saperlo.
Per questo compito, disponiamo di diversi metodi. Si va dall’esame
ermeneutico del testo delle interviste che realizziamo, finalizzato a
scoprire nel testo le tracce di ciò che dà per scontato, fino al
resoconto etnografico; si possono inventare metodi speciali come il
shadowing o le “interviste al sosia”. Di questi metodi spero che in
questo incontro si parlerà.
La loro importanza è notevole. Non sono metodi che mettano capo a
misurazioni della realtà sociale. Ma contribuiscono a permettere a
ciascun soggetto studiato di trasformare ciò che vive in esperienza
propriamente tale, cioè in vissuto compreso, e dunque passibile di
valorizzazione o di critica.
Sarà inoltre interessante mettere questi metodi a confronto con chi, da
narratore, si è impegnato a raccontare il lavoro e la sua quotidianità.
Il problema qui mi sembra sia quello di introdurre il lettore al gergo
locale, alle prospettive implicite, al senso complessivo di cui il lavoro
è investito, non potendo contare su una precomprensione di tutto ciò
da parte del lettore.
7. La chiave della sociologia della vita quotidiana sta nella frase di
Henri Lefebvre: "ciò che è familiare non è per questo conosciuto".
Quello che è noto - che è saputo cioè in relazione agli scopi pratici
della vita di ogni giorno, che diamo per scontato, che ci è familiare non è per ciò conosciuto, cioè compreso o fatto proprio nella sua
logica e nelle sue conseguenze.
Ciascuno di noi sa di più e di meno di quello che sa quotidianamente.
Di più, perchè a molte delle cose che sappiamo non prestiamo
attenzione e a molte altre non attribuiamo valore, e tuttavia senza di
queste non saremmo in grado di vivere. Di meno, perchè di ciò che
sperimentiamo restiamo in parte ignoranti.
Vivendo, non possiamo che fare esperienze. E tuttavia possiamo non
avere esperienza. Possiamo rimanere all'oscuro, o tacitare, o
camuffare quello che sperimentiamo.
Ma prendere atto di ciò che viviamo è riconoscere la situazione in cui
stiamo, e solo questo apre uno spazio di libertà. E' quotidianamente
32
che produciamo e riproduciamo la nostra realtà, ed è da qui che si
può modificarla.
La vita quotidiana non è del resto soltanto la forma che assume ogni
giorno la soddisfazione dei bisogni materiali dell'esistenza.
Corrisponde sempre implicitamente anche a un'estetica e a un'etica: è
il modo in cui ogni individuo (in relazione alle opportunità che gli
offre la sua società, alle sue risorse, alla storia) articola le proprie
risposte alla domanda di senso che la vita gli pone. Può darsi che solo
negli spazi dell'"estraneità al domestico" possa sorgere una coscienza
non mistificata, ma in questi spazi abitiamo di rado.
Quotidianizziamo il mondo - per quanto la quotidianizzazione oggi
possa farsi precaria - e nei modi in cui lo facciamo si esprimono le
nostre preferenze concrete e la scelta dei fini ai quali, in fin dei conti,
ci votiamo. Ai fini rispetto ai quali è organizzata la nostra esistenza
pensiamo di rado nella vita ordinaria; ma non sono nascosti: si
esprimono in ciò che facciamo quotidianamente. Lo stesso vale per le
collettività: la forma della vita in cui si esprimono quotidianamente
mostra i valori e le credenze fondamentali cui si riferiscono.
La "vita quotidiana" è un'espressione linguistica che serve a rendere
conto di certi aspetti della nostra esistenza. Gli aspetti che permette di
illuminare consistono in ciò che nella nostra vita ci è prossimo e
ricorre con maggiore frequenza, ma ciò che ricorre (ciò che facciamo
e rifacciamo, gli ambienti a cui siamo più esposti, i pensieri e i
sentimenti che ci abitano più di frequente, tutto ciò che diamo per
scontato) costituisce il nostro essere molto più di quanto non lo
costituiscano le esperienze eccezionali, i momenti straordinari o, per
altri versi, le fantasie cui indulgiamo. Prendere atto della vita
quotidiana è così avvicinarci quanto più è possibile alla
determinazione della nostra esistenza e a riconoscerne “il senso”.
33
Relazioni
Giorgio Vasta (Scuola Holden di Torino)
Messe in scena del lavoro nella narrativa italiana
contemporanea
Pietro Basso (Università Ca’ Foscari di Venezia)
L’ orario giornaliero: è questo quello che conta
34
Martedì 19 aprile,
RICERCHE E TEORIE
I Workshop (ore 9-16)
Coordinano:
Laura Balbo (Università di Ferrara)
Marina Piazza (Gender, Milano)
Bruna Bianchi (Università Ca’ Foscari di Venezia)
La vita quotidiana, familiare e lavorativa, della
gioventù operaia in Europa dal 1880 al 1933
L’intervento vuole mettere a fuoco i mutamenti intervenuti nella vita
della gioventù operaia tra la seconda metà dell’Ottocento e la Grande
crisi. Tra le classi popolari la gioventù è un gruppo relativamente
facile da identificare: i giovani non vanno più a scuola, lavorano,
non sono ancora sposati, vivono con i genitori e, in parte, sotto il loro
controllo. Tra l’infanzia e la gioventù lo stacco è netto, almeno nei
paesi come Francia, Germania e Gran Bretagna, in cui a partire dal
decennio ’70 e ’80 dell’800 la legislazione sull’obbligo scolastico è
in gran parte osservata. I conflitti generazionali sono rari; i ruoli
sociali della gioventù sono fissati e riconosciuti, accettati perché
transitori. I conflitti esplodono alla soglia della giovinezza, ad
esempio al momento del ritorno dal servizio militare, quando essi
esplicitamente rivendicano maggiore autonomia.
Il tema della gioventù operaia è stato fino ad ora assai trascurato dalla
storiografia. A differenza dei giovani di origine borghese infatti, i
giovani di estrazione operaia non sono stati considerati una presenza
storica significativa; quando essi fanno la loro apparizione negli studi
sulla storia della famiglia, dell’educazione o del lavoro, restano sullo
sfondo. Se infatti gli industriali consideravano i ragazzi una mano
d’opera docile e a basso costo, gli operai vedevano in loro degli
assistenti e degli aiutanti dai quali pretendevano rispetto, obbedienza
e paziente sopportazione della fatica, in definitiva, silenzio. Esclusi
dalla scuola, dominati dal sapere e dall’autorità degli adulti nei luoghi
di lavoro e nella famiglia, i giovani lavoratori raramente sono riusciti
a far sentire la propria voce.
35
Descrivere le condizioni di vita della gioventù lavoratrice inoltre si
scontra con problemi di fonti, spesso insormontabili. Le rilevazioni
statistiche rendono conto del lavoro infantile, mentre il lavoratore
nell’età dell’adolescenza e della prima giovinezza è assimilato
all’adulto e resta totalmente in ombra.
Le fonti ufficiali (dibattiti parlamentari, inchieste ministeriali,
rapporti consolari) spesso propongono rigidi stereotipi: l’immagine
della “vittima innocente” dell’egoismo familiare e dell’avidità
padronale nega a fanciulli e adolescenti la capacità di affrontare le
difficoltà della loro condizione, quella del ribelle indisciplinato e
irresponsabile occulta il suo desiderio di affermazione e autonomia.
Più che descritta, la gioventù operaia viene rappresentata e tuttavia
tali rappresentazioni, recando il segno dei timori collettivi, sono assai
eloquenti di una condizione sociale.
Mettere a fuoco le esperienze di vita e di lavoro dei giovani delle
classi popolari, ricomporre un quadro complessivo dalla
frammentarietà di informazioni richiede quindi l’analisi di un gran
numero di fonti e la capacità di leggerle in controluce. Si aggiunga
che raramente i giovani delle classi popolari raccontano o scrivono le
loro storie di vita o semplicemente annotano le loro esperienze, se
non in situazioni estreme (guerra, profuganza, persecuzione). Manca
loro la consuetudine con la scrittura e soprattutto quel senso del
passare del tempo che induce l’adulto a ripiegarsi su se stesso e
riflettere sul significato della propria esistenza. Preziose per
ricostruire la quotidianità della vita si sono rivelate le memorie e,
soprattutto, le testimonianze raccolte e pubblicate negli ultimi
decenni. L’intervento cercherà di ricostruire i mutamenti intervenuti
nella vita dei giovani delle classi popolari (rapporti famigliari e
lavorativi, forme della partecipazione politica e della protesta sociale)
alla luce dei mutamenti del mercato del lavoro giovanile e si
soffermerà più sui ragazzi che sulle ragazze, più su Gran Bretagna e
Germania, i paesi in cui fu più intenso il processo di
industrializzazione, che su Francia e Italia. Spero di poter fare un
quadro più articolato nel corso della discussione.
1880-1914 Il declino del lavoro minorile e l’aumento
dell’occupazione giovanile
Negli ultimi decenni dell’800 il diffondersi dei processi innovativi
nell’industria, la crescente specializzazione della produzione, lo
sviluppo di nuovi settori quali la chimica e la meccanica leggera,
36
modificarono profondamente il mercato del lavoro e favorirono
l’ingresso nelle fabbriche di un gran numero di adolescenti a cui
venivano attribuite mansioni non qualificate. Nel corso di pochi anni
mutarono sia le modalità di ingresso al lavoro, sia le tradizionali vie
di trasmissione delle conoscenze legate al mestiere. Un percorso
lavorativo sotto la guida morale dell’adulto venne gradatamente
sostituito dal lavoro industriale non qualificato, ripetitivo,
temporaneo.
Il declino dell’apprendistato suscitò ovunque crescenti apprensioni:
privi della guida morale dell’adulto – si affermò - i giovani lavoratori
dimostravano eccessiva indipendenza, mancanza di previdenza e
parsimonia e non nascondevano la propria insofferenza verso ogni
forma di autorità. La società industriale non appariva in grado di
garantire il controllo sulla moralità dei giovani lavoratori ed i loro
comportamenti irrispettosi divennero il simbolo della rapida
industrializzazione e del tumultuoso processo di urbanizzazione.
Se nei decenni precedenti era diminuito il numero dei fanciulli
lavoratori grazie alla legislazione sull’obbligo scolastico che ne
innalzava i limiti di età (a 13 anni in Francia e a 14 anni in Germania
e Gran Bretagna) e si erano quindi attenuate le forme più brutali di
sfruttamento, si stava ora profilando un modo nuovo di abusare degli
adolescenti: la drastica riduzione delle opportunità di un lavoro
stabile e qualificato.
Tuttavia per i giovani l’ingresso nel mondo del lavoro era un evento a
lungo atteso. Poiché i guadagni dei figli, per quanto miseri, erano
essenziali alla sopravvivenza famigliare, quando il ragazzo si poteva
porre all’interno della famiglia come portatore di reddito, veniva
trattato con maggior rispetto. La madre aveva per lui quelle attenzioni
che fino a quel momento aveva rivolto solo al padre o ai fratelli
maggiori, si allentavano i rapporti di autorità, poteva passare più
tempo fuori casa e, al contrario di quanto accadeva per le ragazze,
poteva trattenere una parte dei suoi guadagni. Una volta entrati nel
mondo del lavoro ai figli maschi non si chiedevano più quelle attività
domestiche che essi percepivano come servili e umilianti: caricare e
scaricare legna e carbone, attingere l’acqua, disfarsi della spazzatura,
scopare il cortile.
Il ragazzo, fin dall’età dell’adolescenza, aspirava ad uscire dalla sfera
del controllo materno ed essere assimilato ai maschi della famiglia, in
particolare al padre, dispensato dai lavori domestici.
37
Nei luoghi di lavoro invece, sia nelle fabbriche che nei laboratori, sia
per l’apprendista che per il non qualificato, i rapporti di
subordinazione all’operaio adulto restarono molto accentuati. La
dipendenza del giovane lavoratore nei luoghi di lavoro si rispecchia
nella scarsa considerazione che il suo lavoro riceveva all’interno
delle organizzazioni sindacali, tese a privilegiare l’operaio adulto e
qualificato ed a trascurare, se non ad ignorare, le condizioni di salario
e di lavoro della mano d’opera minorile e giovanile. Nel movimento
operaio i minorenni ebbero sempre scarso peso numerico e la
questione della gioventù operaia non entrò mai a far parte della
strategia sindacale; anche sul piano rivendicativo infatti dai giovani ci
si attendeva rispetto e ubbidienza.
La gerarchia professionale infatti riuscì a lungo a contenere
rivendicazioni autonome e quando queste si manifestarono in scioperi
promossi e diretti esclusivamente da minorenni, si trattò di scioperi di
breve durata che si svolsero nell’indifferenza e talvolta nell’ostilità
degli adulti e si conclusero negativamente. Nell’impossibilità di
identificarsi come gruppo all’interno delle organizzazioni sindacali, i
giovani operai spesso esprimevano il proprio malcontento per le
condizioni di lavoro e di salario con l’indisciplina o l’abbandono del
lavoro.
Ma è soprattutto alla strada, al mondo del gruppo e alle bande che i
giovani lavoratori si rivolsero per compensare le ristrettezze e le
umiliazioni della loro vita e trovare forme di autoaffermazione. Nel
gruppo i giovani condividevano un senso di appartenenza
generazionale, di classe e di quartiere e nelle testimonianze i ricordi
dei rapporti di vicinato tra i coetanei sono colmi di nostalgia.
Tuttavia, per quanto monotono e privo di gratificazioni personali, il
lavoro permeava a tal punto la vita quotidiana, che anche le
conversazioni all’interno del gruppo ruotavano attorno al lavoro.
La condizione delle ragazze lavoratrici era decisamente peggiore di
quella dei maschi: costrette al lavoro domestico e a quello domicilio
fin dalla più tenera età, le ragazze sono colpite dalla tubercolosi in
misura di gran lunga maggiore dei ragazzi. La loro situazione era
aggravata dal fatto che non potevano né ribellarsi né fuggire. Non c’è
un turn over femminile. “Le ragazze – ha scritto Michelle Perrot sono inchiodate al loro posto dal volere di tutti, in primo luogo dal
padre”.
38
1914-1918 Le nuove opportunità di lavoro nell’industria bellica
In tutti i paesi industrializzati coinvolti nel conflitto l’aumento
straordinario della produzione nel settore dell’armamento, la
diffusione della lavorazione in serie, la mobilitazione della gran parte
della classe operaia, ampliarono grandemente le opportunità
occupazionali per i giovani nell’età compresa dai 14 ai 21 anni.
Le retribuzioni a cottimo, la semplicità delle mansioni, la condizione
di debolezza della mano d’opera adulta maschile, costantemente sotto
il ricatto di perdere l’esonero e di essere rinviata al fronte, favorì nei
giovani lavoratori l’occasione per emanciparsi dal sapere e dal
rispetto dovuto all’adulto e il maturare di una coscienza nuova della
propria dignità e dei propri diritti. Nelle fabbriche, infatti, la protesta
dei ragazzi, che nel passato era stata tante volte soffocata o guidata
dagli adulti, acquista un rilievo nuovo. Furono i ragazzi che, insieme
alle donne, presero l’iniziativa degli scioperi e nel corso delle
manifestazioni si dimostrarono i più attivi e i più determinati.
Anche all’interno delle famiglie la guerra portò mutamenti di grande
rilievo: impose un continuo riadattamento delle modalità di
convivenza, alterò le relazioni di dipendenza, ridefinì responsabilità e
ruoli. In molti casi gli adolescenti divennero capifamiglia e il loro
salario non rappresentò più una semplice integrazione del reddito
famigliare complessivo, bensì divenne indispensabile alla
sopravvivenza. Alle nuove, accresciute responsabilità tuttavia non
venne conferita dignità, alle fatiche e alle privazioni non venne
attribuito alcun riconoscimento né morale né sociale. Ai giovani
inoltre fu negato il diritto allo svago e alla socializzazione al di fuori
delle forme ufficialmente previste dalla mobilitazione e dalla
propaganda ed essi reagirono valorizzando in modo ancora più
accentuato rispetto al passato forme di socializzazione spontanea. Nel
gruppo ricercarono sostegno morale e forme alternative di svago,
praticarono forme di opposizione quotidiane ai controlli autoritari,
ostentarono la propria estraneità al clima di lealismo patriottico e alla
pressione ideologica che investì il fronte interno. Il tempo libero dal
lavoro era trascorso per le strade dove si andarono moltiplicando le
condanne per alcuni reati: aggressione nei confronti delle guardie,
azioni irriverenti e ritorsioni violente nei confronti della classe media,
dei “signori” che dimostravano disprezzo e indifferenza per le
privazioni delle classi popolari. In ogni paese coinvolto nel conflitto
aumentarono le condanne per questo tipo di reati.
39
L’atteggiamento di rivalsa, il desiderio di sfida appare una reazione
esclusivamente maschile; il maggior controllo sulla vita e il lavoro
delle ragazze, i limiti posti alla loro socialità, l’impegno nella sfera
domestica, spiegano la minore presenza femminile tra gli imputati dei
tribunali. In Italia, ad esempio, la maggioranza delle ragazze che
comparvero di fronte ai giudici dovette rispondere di reati contro
l’ordine pubblico: nelle manifestazioni collettive di protesta le più
giovani sono alla testa dei cortei, urlano la loro rabbia contro la
guerra e il loro disprezzo per le forze dell’ordine.
1919-1933 La disoccupazione
Dopo il conflitto in tutti i paesi gran parte dei ragazzi impiegati nelle
industrie di guerra furono licenziati e solo pochi trovarono
occupazioni alternative in paesi investiti dalla crisi. Giovani che
avevano contribuito al bilancio familiare soffrirono di un senso di
umiliazione, anche rispetto ai fratelli più giovani (il lavoro minorile
non diminuì, ma aumentò in quasi tutti i paesi). La demoralizzazione
condusse ad un senso acuto di inutilità, alla noia, al fatalismo.
Le difficoltà erano accresciute dal fatto che ai giovani disoccupati
che continuavano a vivere in famiglia non spettava alcun sussidio.
Nel 1923 in Gran Bretagna furono censiti 150.000 disoccupati tra i
14 e i 18 anni, ma di essi solo 6.500 ricevevano un sussidio. Accadde
così che molti giovani si allontanassero dalla famiglia, andando a
vivere in camere in affitto sovraffollate e tornando in famiglia di
tanto in tanto, nei momenti di bisogno più acuto. E tuttavia
l’affermarsi delle misure previdenziali per i lavoratori adulti ebbe
ripercussioni favorevoli su un gran numero di adolescenti; in
particolare si attenuò quel senso di insicurezza che nei decenni
precedenti aveva condotto le famiglie ad esercitare un forte controllo
sui figli e sui loro salari. Nella nuova situazione anche il padre
disoccupato era disposto a rinunciare ad una piccola parte del suo
sussidio per i divertimenti dei figli, rappresentati negli anni Venti e
Trenta dal cinema e dal ballo. Soprattutto le ragazze si dimostrarono
decise a difendere i loro piccoli margini di libertà, pronte a sostituire
la cipria con la farina pur di andare a ballare, a cambiare con una
certa disinvoltura “boy friend” pur di non rinunciare al cinema.
Condizioni ben più drammatiche in Germania dove i giovani della
classe di età compresa tra i 18 e i 23 anni furono i più colpiti dalla
disoccupazione. Si trattava di giovani che avevano appena terminato
la poro preparazione professionale o che avevano raggiunto l’apice
40
delle loro possibilità di guadagno, ma che nelle nuove condizioni non
potevano fare alcun progetto per il futuro. Le inchieste condotte da
osservatori e assistenti sociali descrivono giovani irritabili, depressi e
instabili, dominati da un senso di fallimento personale. Il
disorientamento che derivava dalla perdita del lavoro conduceva in
primo luogo ad una dissoluzione dei ritmi della vita quotidiana, alla
perdita della disciplina del tempo.
In un primo momento essi si rinchiusero nella famiglia, nel mondo
del vicinato o del gruppo, ma in seguito furono attratti dalle
organizzazioni politiche più radicali: dal partito comunista, e
soprattutto dal partito nazionalsocialista. Ai giovani disoccupati i
nazionalsocialisti offrirono la possibilità di strutturare la propria vita
quotidiana, di dare un senso alla propria attività. Al senso di inutilità
contrapposero l’esaltazione della gioventù: solo i giovani avrebbero
potuto plasmare il mondo.
Si aggiunga che in Germania, in quegli anni cruciali, si era diffuso il
timore di una pericolosa inversione nei rapporti tra i generi. Le
ragazze infatti, tradizionalmente inserite in settori produttivi meno
colpiti dalla crisi, erano considerate pericolose concorrenti degli
uomini e le ansie collettive fissarono uno stereotipo di giovane
operaia frivola, immorale, resa troppo sicura di sé dalla recente
acquisizione del diritto al voto. In un paese in cui quasi 4 milioni di
uomini, per lo più giovani, avevano perso la vita nelle trincee, e che
presentava un grave squilibrio demografico, i comportamenti delle
giovani lavoratrici erano percepiti in maniera sempre più accentuata
come un grave problema sociale e morale.
Vando Borghi (Università di Bologna)
Lavoro e sfera pubblica. Appunti per una prospettiva di ricerca
Vorrei proporre due direzioni di lavoro e di analisi, tra loro
strettamente legate (e in parte sovrapposte) e tuttavia analiticamente
separabili. Si tratta di due assi di sviluppo relativi ad un unico tema di
fondo: il rapporto tra lavoro e sfera pubblica – cioè il rapporto tra una
dimensione della vita sociale estremamente necessitata, in cui è forte
la componente eterodiretta dell’azione, e la dimensione in cui
dovrebbe invece esprimersi l’accesso alla cittadinanza, materiale e
immateriale.
41
La prima direzione di riflessione riguarda il rapporto tra lavoro e
sfera pubblica, laddove quest’ultima è intesa in termini di ‘proprietà
sociale’ (Castel). Tale rapporto è quindi qui interpretato in modo da
indagare come le trasformazioni della proprietà sociale incidono su
lavoro. La profonda ristrutturazione del settore pubblico, in corso nel
nostro paese così come a livello internazionale, implica un
conseguente ridisegno dello statuto sociale del lavoro, storicamente
fondato, dalla modernità, sul suo stretto rapporto con la proprietà
sociale. Inoltre tali trasformazioni incidono anche sul lavoro (sulla
sua qualità, sul suo significato) indispensabile alla stessa
predisposizione e fruizione della proprietà sociale.
La seconda direzione di approfondimento concerne invece le
modalità attraverso le quali il lavoro istituisce sfera pubblica. I
fenomeni di rimodellamento della natura del lavoro, dei suoi tempi e
spazi, della sua conformazione istituzionale tendono a favorire
crescenti processi di privatizzazione dell’esperienza lavorativa.
L’individualizzazione del lavoro, che è in parte anche un processo di
emancipazione dalla monolitica standardizzazione del passato,
produce tuttavia anche frammentazione, impossibilità di narrazione
significativa delle proprie esperienze di lavoro, etc. In ogni caso,
queste trasformazioni impongono l’esigenza di un ripensamento delle
forme in cui, attraverso il lavoro, è possibile istituire sfera pubblica
(dentro e fuori i confini delle organizzazioni e dei luoghi di lavoro),
ripensando quelle tradizionali ed prendendo sul serio le lezioni che
vengono da esperienze di tipo deliberativo.
Attila Bruni (Università di Trento)
Piccole disuguaglianze quotidiane: uno studio
etnografico delle traiettorie di accesso ai servizi
sanitari nella città di Bologna
L’intervento si propone di presentare i risultati preliminari di una
ricerca avente ad oggetto i processi organizzativi che innescano (o
che possono innescare) disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari
a Bologna città. In particolare, ci si concentrerà sull’analisi della
quotidianità organizzativa di un luogo particolare (e nevralgico) per
le traiettorie di accesso a servizi sanitari: i Centri Unici di
Prenotazione (CUP), dove i soggetti devono recarsi al fine di
42
prenotare la prestazione clinica che è stata loro prescritta.
L’osservazione dell’attività quotidiana del CUP, infatti, permette di
iniziare a cogliere come quelle che in via preliminare possono essere
definite come “piccole disuguaglianze quotidiane” prendano forma
all’interno di interazioni situate e si ripercuotano sulle traiettorie di
accesso ai servizi. Banalmente, chi abita in alcune zone della città
risulta privilegiato; chi può gestire autonomamente i suoi impegni
lavorativi può avere più facilità nel far coincidere orari e
appuntamenti; chi ha la possibilità di condividere (con parenti e/o
amici) la gestione degli impegni quotidiani riesce a rendersi più
flessibile; chi ha un buon rapporto con il proprio medico di medicina
generale ha la possibilità di essere indirizzato meglio. Meno
banalmente, però, si cercherà di mostrare come tali “piccole
disuguaglianze” siano per l’appunto “quotidiane” e, quindi, non
dipendano da fattori strutturali (senza per questo negare la rilevanza
di variabili quali classe, genere, razza e livello di istruzione) ma siano
a loro volta frutto delle dinamiche e dei processi sociali in cui i
soggetti si trovano coinvolti all’interno della loro vita ordinaria.
Sulla scorta di alcuni concetti derivanti dalla sociologia di stampo
fenomenologico, interazionista ed etnometodologico (e, in
particolare, i concetti di ‘rapporti di vicinato’ di Park, di
‘determinismo locale’ di Goffman e di ‘fiducia’ nella sua versione
garfinkeliana) si mostrerà come i processi di disuguaglianza non solo
siano situati nell’interazione quotidiana, ma come (proprio in virtù di
ciò) quest’ultima si riveli una dimensione appropriata e ricca di
spunti per lo studio dei processi che ‘fanno’ disuguaglianza. In questo
senso, il presente contributo si prefigge di mantenere un doppio
binario di lettura e discussione: da un lato, l’individuazione dei
processi di disuguaglianza e del loro operare dinamico; dall’altro, una
riflessione metodologica a proposito del come studiare (‘dal basso’ e
sulla scorta di una metodologia etnografica) fenomeni sociali che si
caratterizzano per la loro multiformità e policromia.
Carla Facchini (Università Bicocca Milano)
La vita di coppia sulla soglia del pensionamento e
oltre
43
Manuela Naldini (Università di Torino)
Tempi di lavoro e tempi di vita. Strumenti di genere
per la conciliazione : alcuni dati e riflessioni a margine di uno studio
di caso
di alcuni spazi della casa in determinati momenti della
giornata, ecc…
Gli altri membri della famiglia entrano così a far parte del
“lavoro”: ciò a volte avviene in modo diretto come quando il partner
del telelavoratore si prende cura dei figli nei momenti di maggiore
impegno o svolge commissioni per suo conto, in modo indiretto, dal
momento che tutti debbono rispettare le nuove regole.
Del resto, un altro aspetto dell’attenuarsi dei confini tra vita
privata e vita lavorativa è la tendenza del tempo di lavoro a
colonizzare gli altri tempi sociali, come il tempo familiare o il tempo
libero. E, ancora, ciò che si produce è una perdita della
sincronizzazione collettiva dei ritmi familiari. Ciò significa che non
vi saranno più orari di punta in cui tutti vanno a lavorare o tornano
dal lavoro, non andremo al supermercato tutti lo stesso giorno, con
evidente sollievo per il traffico e per i trasporti pubblici. Nella pratica
quotidiana, però, la perdita di sincronizzazione collettiva rende molto
più difficile sincronizzare i tempi all'interno della famiglia: per
esempio, spesso il tempo libero del lavoratore non coincide con
quello degli altri membri della famiglia o viceversa.
Il telelavoro non costringe a modificare solo le routine pratiche
ma anche quelle cognitive, che abbiamo riassunto nel concetto di
“senso comune”, cioè “l’insieme di tutto ciò che ciascuno considera
ovvio all’interno di una data cultura o di una data società (e in un
certo momento della storia)”.
Orbene, utilizzando questo concetto abbiamo potuto costatare la
difficoltà dei lavoratori a staccarsi da routine e "ovvietà" sedimentate
nella formazione precedente all'esperienza del telelavoro: la necessità
di avere in casa uno spazio, seppur piccolo, che rappresenti il lavoro
esprime il tentativo di ricreare quella divisione spaziale e temporale
tra casa e lavoro che era caratteristica del lavoro tradizionale.
44
Questo dimostra che il senso comune è dotato di una sua forza
di inerzia. Per certi versi, esso è effettivamente una sorta di memoria
sociale, che tende a proiettarsi sul nuovo e, almeno in una prima fase,
a depotenziarne gli aspetti di rottura.
Nella ricerca, inoltre, viene messo in evidenza come le
caratteristiche strutturali del telelavoro, cioè la maggiore o minore
libertà dei telelavoratori di combinare spazio e tempo, e gli accordi
contrattuali a quali sono legati influenzano in modo decisivo il modo
in cui il telelavoratore combina vita lavorativa e vita extra-lavorativa,
cioè il modo in cui viene riorganizzata la vita quotidiana
dell’individuo.
Il telelavoro offre ai lavoratori un maggiore controllo su alcuni
elementi del processo lavorativo, come il luogo, il ritmo, il numero di
ore di lavoro. La possibilità di controllare questi elementi dovrebbe
permettere al lavoratore di conciliare meglio vita privata e vita
lavorativa.
In realtà, dalla nostra ricerca è emerso che questa opportunità
non si realizza, o si realizza solo in parte, perché entra in conflitto
con quelli che sono gli interessi del committente.
In concreto, uno dei principali fattori in cui si manifesta la
difficoltà a conciliare le mutevoli esigenze dei datori di lavoro con
quelle di autonomia del lavoratore è l’esistenza di scadenze per la
consegna dei lavori svolti, quasi sempre a breve termine.
Il committente, sia esso un privato o un’agenzia, attraverso i
termini di scadenza riesce ad esercitare una pressione sui tempi del
lavoratore, variando così secondo le proprie esigenze il confine tra
vita lavorativa e vita familiare che il lavoratore definisce. Ciò
capovolge la logica che vorrebbe il telelavoratore libero di pianificare
i propri tempi lavorativi, adattandoli anche alle esigenze familiari. E’
questa indeterminatezza dei tempi che crea quell’allentamento dei
confini tra vita privata e vita lavorativa cui si faceva cenno in
precedenza.
In definitiva possiamo dire che, al contrario delle promesse di
autonomia ed indipendenza presente in molta della letteratura, la vita
lavorativa del telelavoratore è sottoposta a pressioni ed è intensa forse
più di quella di chi lavora in modo tradizionale.
Resta vero che, come abbiamo costatato nelle interviste, i
telelavoratori affermano in genere di godere di maggiore autonomia
rispetto ai lavoratori tradizionali; ma in realtà l'autonomia di queste
persone si limita alla mancanza di una diretta supervisione e ad un
45
limitato controllo altrui sulle ore di lavoro svolto.
Questa contraddizione appare evidente agli occhi di un
osservatore esterno; nelle parole degli intervistati, appare a volte sotto
forma di una esplicita autocritica delle scelte e delle aspettative
iniziali, più spesso sotto la forma dell’ambivalenza di alcune
espressioni o della franca coesistenza di affermazioni contrapposte.
La sua presenza mette in gioco di nuovo la nozione di “senso
comune”. Il senso comune, oltre che come memoria sociale, opera
anche come ideologia. I discorsi veicolati dai datori di lavoro, dalle
imprese interessate alla diffusione del telelavoro e dai media
esprimono la tensione di questi attori a promuovere, esplicitamente o
meno, una rappresentazione sociale positiva del telelavoro: tendono
cioè a rendere “ovvio” che esso abbia essenzialmente una valenza
liberatoria, nascondendone gli aspetti problematici.
In definitiva, ci pare di poter affermare che quello che emerge
da questa ricerca è che le tecnologie informatiche e della
comunicazione e lo stesso telelavoro sono davvero potenzialmente in
grado di migliorare la qualità del lavoro e della vita quotidiana. Ma
alla prova dei fatti i risultati della loro applicazione, entro i quadri
contrattuali ed organizzativi che abbiamo esaminato, rischiano di
essere diversi. La soddisfazione dei singoli lavoratori può essere
varia, a seconda delle possibilità che essi hanno di venire a patti con
questi quadri.
Giuseppina Pellegrino (Università della Calabria)
Quotidianità mediatizzata, lavoro e artefatti
tecnologici tra innovazione e routine
I processi di appropriazione ed addomesticamento (Silverstone,
2000) di artefatti tecnologici costituiscono una parte sempre più
rilevante della vita quotidiana di individui ed organizzazioni. La vita
quotidiana (quella che si svolge nelle organizzazioni e nei luoghi di
lavoro, e quella che va oltre essi) è sempre più mediatizzata, ovvero
ha a che fare con processi di tipizzazione e di routinizzazione di
innovazioni sociotecniche.
Le categorie di innovazione e routine, “ponte” tra lavoro e
quotidianità, costituiscono chiavi di lettura per de-costruire i processi
di appropriazione della tecnologia in quanto artefatto organizzativo,
oggetto e strumento di apprendimento nello svolgimento del lavoro.
46
D’altro canto, queste stesse categorie appartengono alla teoria della
vita quotidiana e consentono di illuminare rotture e ricostituzioni del
senso comune (Jedlowski, 2003) in riferimento ai processi
comunicativi mediati dalle tecnologie, che accomunano lavoro e nonlavoro.
La sociologia della vita quotidiana (Jedlowski e Leccardi, 2003) è
sociologia di costruzione ed interpretazione della conoscenza, in
particolare di quella conoscenza quotidiana che sospende il dubbio e
che costituisce il “senso comune” (Schutz, 1979a). Il mutamento
sociale può essere tematizzato, tra l’altro, come una continua messa
in discussione di categorie, modi di pensiero e d’azione dati per
scontati. L’alternanza e la combinazione di innovazione e routine, di
fatto, è ciò che accomuna i processi di apprendimento e conoscenza
dentro e fuori il lavoro, il lavoro nella quotidianità e la quotidianità
del lavoro. Vi è tuttavia un terzo tipo di relazione tra lavoro e vita
quotidiana, ed è il “lavoro” (o, meglio, lavorio) proprio della vita
quotidiana, che gli individui compiono per dare senso al mondo
passando attraverso molteplici organizzazioni con cui sono chiamati
a confrontarsi e che da questo confronto emergono. Questo lavorio,
che è talvolta simile a quello compiuto dallo “straniero” (Schutz,
1979b), talaltra a quello del “reduce” (Schutz, 1979c) è sempre più
riferito ad una dimensione tecnologicamente mediata, che è da un
lato “addomesticata” e resa quotidiana, dall’altro costituisce
strumento dei modi in cui il mondo diviene dato per scontato.
La metafora del “tessuto organizzativo” radicata nella tradizione
della scuola socio-tecnica e portata alla ribalta da Emery e Trist
nell’analisi dei rapporti tra organizzazione e ambiente (Emery e Trist,
1965), verrà adoperata per rappresentare la vita organizzativa come
vita quotidiana in cui innovazione e routine si alternano.
L’espressione “tessere l’organizzazione” descrive l’insieme degli atti
interattivi posti in essere in un contesto organizzativo (Strati, 2004;
Gherardi e Strati, 1990). Ma “tessere l’organizzazione” è anche la
metafora di un lavoro (o, di nuovo, lavorio) quotidiano compiuto dai
soggetti all’interno dell’organizzazione. Si tratta di un meta-lavoro e
di un meta-livello costituito da “trame” più o meno fitte. Ipotizzando
che la routine sia la trama più fitta e l’innovazione quella più larga
del tessuto, si può cogliere il fatto che le trame “larghe”
(l’innovazione) allentano la rigidità del disegno principale della
trama del tessuto, in cui variazioni continue e minimali ricorrono,
come nel genere del serial televisivo (Czarniawska, 2000).
47
Lungi dall’essere contrapposta al lavoro, la vita quotidiana è dunque
un ambito unificante dell’esperienza: il tessuto è un continuum le cui
separazioni sono, talvolta, artificiali o ritagliate ad hoc.
Rispetto a questo tessuto, la (nuova) tecnologia può agire in
molteplici modi, di seguito sintetizzati sulla scorta dei risultati di una
ricerca comparata sulla costruzione sociale della tecnologia Intranet
in due aziende (Pellegrino, in corso di stampa), e delle ipotesi relative
ad un progetto di ricerca in corso di elaborazione.
Sul fronte della ricerca comparata riguardante Intranet, emergono le
seguenti relazioni tra tecnologia, vita quotidiana e routine nelle
organizzazioni:
- La (nuova) tecnologia è fonte di nuove routine: la quotidianità del
lavoro è costruita su routine che sono spesso “incorporate” in (e
rappresentate da) artefatti tecnologici;
- La tecnologia è parte della routinizzazione come ripetitività
della vita quotidiana lavorativa;
- La tecnologia è contenuto del lavoro e strumento di esso; è
oggetto di appropriazione ovvero di un processo di
quotidianizzazione che la rende data per scontata.
- La (nuova) tecnologia è rottura/interruzione della routine
lavorativa.
Per quanto concerne la ricerca in corso di elaborazione, essa si
propone di indagare ambiti e campi di continuità/discontinuità nella
vita quotidiana di individui ed organizzazioni, in quanto mediata da
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
L’esperienza della mediatizzazione (Schulz, 2004), e della
comunicazione mediata che la costituisce, rappresenta un elemento di
forte continuità nella vita quotidiana. Il luogo (di lavoro o di nonlavoro, pubblico o privato) è sempre più definito dalla (o contiguo
alla) comunicazione mediata e complessità semplificata di artefatti
tecnologici le cui dimensioni, funzionalità e potenzialità sono in
rapporto inverso: più piccolo è il dispositivo, più sofisticate le sue
funzioni.
La miniaturizzazione, mobilità, portabilità, semplicità d’uso di tali
artefatti rappresenta la materializzazione di tendenze di apertura (e
ridefinizione) dei confini tra lavoro e non lavoro.
L’enfasi sull’individualità e l’emergere dei cosiddetti “personal
media” (in particolare tecnologie mobili di ultima generazione, basate
sull’integrazione tra telefonia mobile e altri media) sono spie di una
tendenza verso forme di relazioni sociali non solo più mobili e più
48
flessibili, ma anche in grado di accelerare la comunicazione e
l’interscambio tra le “realtà multiple” (Schutz, 1979d) in quanto
veicolate e vissute attraverso una mediazione tecnologica e culturale.
Presupposto teorico-metodologico comune alla ricerca completata
relativa ad Intranet ed alla ricerca in corso su tecnologie mobili di
ultima generazione, è che la tecnologia costituisca un “punto di
accesso” ed un osservatorio privilegiato della vita quotidiana di
individui ed organizzazioni.
Riferimenti bibliografici
Czarniawska, B. (2000). Narrare l'organizzazione. La costruzione dell'identità
istituzionale, Edizioni di Comunità, Torino.
Emery, F.E. e Trist, E.L., (1965). "The Causal Texture of Organizational
Environments," Human Relations, 18, 21-32.
Gherardi, S. e Strati, A. (1990). “The Texture of Organizing in an Italian University
Department”, Journal of Management Studies, 27 (6), 605-618.
Jedlowski, P. (2003), Fogli nella valigia. Sociologia, cultura, vita quotidiana,
Intersezioni - il Mulino, Bologna.
Pellegrino, G. (in corso di stampa). Il cantiere e la bussola. Le reti Intranet fra
innovazione e routine, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli.
Schulz, E. (2004), Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept,
European Journal of Communication, 19 (1): 87-101.
Schutz, A. (1979a), Saggi sociologici, Utet, Torino.
Schutz, A. (1979b), “Lo straniero”, in Saggi sociologici, Utet, Torino, 375-389.
Schutz, A. (1979c), “Il reduce”, in Saggi sociologici, Utet, Torino, 390-403.
Schutz, A. (1979d), “Sulle realtà multiple”, in Saggi sociologici, Utet, Torino, 181232.
Silverstone, R. (2000). Televisione e vita quotidiana, il Mulino, Bologna.
Strati, A. (2004). L’analisi organizzativa. Paradigmi e metodi, Carocci, Roma.
Marita Rampazi (Università di Pavia)
Giovani, tempo, vita quotidiana
1. L’incertezza biografica è un tema centrale nella riflessione
sociologica contemporanea sul tempo dei giovani, stimolata dalla
trasformazione delle coordinate spazio-temporali prodottasi nel
passaggio dalla prima alla seconda modernità e dalla saldatura di
questo cambiamento con il processo di individualizzazione in atto.
Tale concetto è stato messo a tema negli anni ’80 in relazione alla
contestazione delle certezze tipiche della prima modernità,
emergente, come tratto trasgressivo, in talune frange giovanili. Oggi,
49
esso definisce una condizione che si va generalizzando al punto da
proporsi come un dato normale dell’esperienza dei giovani.
In estrema sintesi, gli aspetti costitutivi del concetto di
incertezza biografica sono rappresentati da: a) reversibilità delle
scelte e loro relativa de-connessione rispetto a forme consolidate di
modelli di ruolo e di radicamento spaziale, in una prospettiva di
crescente flessibilizzazione di percorsi e carriere, b) enfatizzazione
della dimensione del presente rispetto a un futuro sempre meno
prevedibile e ad un passato che sbiadisce sotto la spinta
dell’accelerazione dei tempi dell’agire, che provoca una sorta di
reificazione dell’atto in sé, entro una cultura dell’‘immediatezza’
potenzialmente distruttrice della cumulatività dell’esperienza; un
fenomeno sotteso all’idea di presentificazione; c) dilatazione dei
tempi
di
passaggio
entro
un
gioco
complesso
di
anticipazione/posticipazione delle esperienze che l’orizzonte
culturale moderno associava a specifiche fasi della vita; d)
progressiva centralità della dimensione biografica, associata allo
sbiadire di quella storico-istituzionale e del ‘tempo lungo’ posto a
fondamento delle identificazioni collettive ‘forti’ del passato; in tal
senso, si sottolinea oggi non solo la perdita di memoria storica, ma
anche l’affievolirsi dei confini fra pubblico e privato, che, per taluni,
si risolve nella privatizzazione dell’esperienza.
Per i giovani, questo insieme di fenomeni trae origine da e,
insieme, alimenta un processo nel quale “le traiettorie esistenziali
ricavano sempre meno luce (tendendo progressivamente ad
autonomizzarsi) dalle relazioni con il mondo istituzionale, non più
garante del loro ingresso nella sfera adulta”, come osserva Carmen
Leccardi 1, illustrando gli orientamenti verso il futuro emergenti da
una recente ricerca nazionale sul tempo dei giovani, dalla quale
traggono spunto le considerazioni che vorrei proporre con questo
intervento.
2. Il venir meno di garanzie istituzionali “certe” circa l’ingresso nella
sfera adulta è particolarmente evidente e sofferto nel caso della
progettualità connessa al lavoro.
Si tratta di una ricerca PRIN coordinata da Franco Crespi, nell’ambito della quale
chi scrive è stata responsabile dell’unità di ricerca pavese. Per quanto riguarda
l’impianto teorico-metodologico e i risultati, cfr: F. Crespi, a cura di, Tempo vola,
Il Mulino, Bologna, in corso di stampa
1
50
E’ quasi banale notare che, finché non si ha un lavoro che offra
concrete e stabili prospettive di autonomizzazione dalla famiglia e
qualche forma di riconoscimento sociale, non si può seriamente
pensare né ad uscire di casa, né a stabilizzare il rapporto di coppia, né
ad avere dei figli. Meno banale è il disagio identitario derivante dal
non sapere se e quando si potrà uscire dal limbo in cui si è confinati a
causa del protrarsi dei tempi di passaggio. Nel limbo, si può stare
anche bene: la famiglia garantisce la sopravvivenza, la sostanziale
de-responsabilizzazione tipica di questa condizione consente di
sperimentare la molteplicità di percorsi, relazioni, interessi, che
l’universo culturale contemporaneo propone come possibili. Tuttavia,
si è socialmente “invisibili” (Diamanti, 1999). A lungo andare, tale
invisibilità, che mette in dubbio il riconoscimento, può tradursi in un
senso di perdita angosciante: “il tempo vola e io sono sempre qui:
rischio di mancare all’appuntamento con tutte le tappe importanti
della vita”, dicono i nostri intervistati.
L’incertezza per il proprio futuro lavorativo e per il
riconoscimento sociale ad esso collegato, può tradursi in un vissuto
di precarietà, potenzialmente paralizzante ai fini della costruzione di
sé come durata, vale a dire, soggetti capaci di raccontarsi in una
prospettiva di divenire. In questo senso, ad esempio, Sennett (1999)
denuncia le conseguenze distruttive delle “parole d’ordine del
capitalismo moderno” – flessibilità, mobilità, rischio - sulla vita
personale. L’“uomo flessibile” di Sennett è prigioniero di una sorta di
paralisi temporale, appiattito su un quotidiano, talvolta caratterizzato
da un iperattivismo frenetico, ma privo di significato per la biografia.
Questa lettura, tuttavia, non è l’unica possibile. In alcuni casi,
anziché all’idea di precarietà sembra più corretto riferirsi al concetto
di provvisorietà (Rampazi, in corso di stampa) ed al suo statuto
ambivalente. Da un lato, evoca il fenomeno visto sopra di
sradicamento, disagio identitario, frammentarietà nella narrazione di
sé, fonte di potenziale neutralizzazione affettiva. D’altro lato, la nonfissazione, implicita nell’idea di provvisorietà, rimanda
all’autonomizzazione del soggetto favorita dal processo di
individualizzazione. Da questo punto di vista, balza allora in primo
piano ciò che Bauman (1999) definisce la «strategia post-moderna
generata dall’orrore di essere legati e fissati», attualizzando le
metafore del vagabondo, del turista, del flâneur e del giocatore. Fra
queste metafore, quella del vagabondo sembra coniugarsi
perfettamente con il senso di provvisorietà connesso alla de51
strutturazione delle carriere ed alla mobilità – spaziale e funzionale implicite nel modo con cui si tende a interpretare, oggi, la
flessibilizzazione del lavoro. “Il vagabondaggio – nota Bauman - non
ha alcun itinerario fissato – la sua traiettoria è messa assieme pezzo
per pezzo, un pezzo alla volta Per il vagabondo, ogni posto è un
luogo di sosta, ma egli non sa quanto a lungo rimarrà … Dovunque il
vagabondo vada, egli è un estraneo …Vivere il sogno di diventare un
nativo finisce solo per creare recriminazione reciproca e amarezza. E’
quindi meglio non ambientarsi troppo in un posto. E, dopo tutto, altri
posti si profilano, posti non ancora sperimentati, magari più ospitali,
sicuramente in grado di offrire nuove possibilità. Aver caro di «essere
fuori posto» è una strategia ragionevole … Permette di lasciare aperte
le opzioni. Permette di non ipotecare il futuro … Il primo vagabondo
moderno vagava attraverso luoghi «organizzati»; egli era un
vagabondo perché non riusciva a sistemarsi, come altra gente aveva
fatto, in alcun posto. Coloro che erano sistemati erano tanti, i
vagabondi pochi. La postmodernità ha invertito la situazione … Ora
il vagabondo è tale non per la sua riluttanza o difficoltà a sistemarsi,
ma per la scarsità di luoghi organizzati”.
3. Il vagabondare contemporaneo descritto da Bauman non riguarda
scelte o sfortune dei singoli, ma il progressivo sbriciolarsi della
strutturazione sociale dello spazio, l’assenza di luoghi «organizzati»
in cui potersi stabilizzare. Si tratta di una condizione oggettiva di
disancoraggio, che si coglie nei racconti di alcuni intervistati.
Tuttavia, i casi puri sono molto rari.
Più frequentemente, la provvisorietà si lega ad una situazione di
nomadismo: una mobilità, nel quotidiano e/o nella dimensione
biografica, caratterizzata da molteplici passaggi, e ritorni, entro
luoghi che, agli occhi degli intervistati, mantengono precisi caratteri
di «organizzazione». Nella ricerca in questione, il nomadismo
emerge come un tratto normale dell’esperienza possibile agli occhi
dei giovani, soprattutto in relazione alla necessità di saper cogliere,
ovunque si trovino, le opportunità formative e lavorative prospettate
dal mercato.
A differenza del vagabondo, il nomade non gira a caso. Egli
segue un percorso disegnato da una finalità precisa: trovare le risorse
che consentano di “crescere” ed, eventualmente, imbattersi nel “posto
giusto” dove potersi stanziare. Nella misura in cui gli scenari stessi
del quotidiano sono mutevoli e imprevedibili, la risposta alla
52
domanda “chi e che cosa posso diventare?” - alla base del dilemma
identitario – si può cercare solo per approssimazioni successive,
attraverso una continua negoziazione interpersonale dei significati
delle scelte. L’importante, dicono molti fra i nostri intervistati, è
“attrezzarsi” per saper gestire questa negoziazione, sfruttando le
opportunità che si presenteranno volta a volta, nell’immediatezza
della vita quotidiana.
4. I caratteri della mobilità contemporanea profilano, accanto al
vagabondaggio e al nomadismo, una terza modalità, che potremmo
definire, con Beck (1997), poligamia di luogo, di particolare
interesse, ai fini delle strategie di stabilizzazione di un’immagine di
sé coerente, indipendentemente dalla frammentarietà del contesto. Si
tratta di un fenomeno che sottintende una temporalità giostrata fra più
“tavoli” fortemente organizzati e connotati dal punto di vista
identitario: analoga, a ben vedere, a quella che caratterizza la doppia
presenza femminile. Il tratto distintivo della poligamia di luogo non è
tanto la provvisorietà, quanto la sovrapposizione di spezzoni di vita,
ciascuno dei quali ha una propria logica temporale e una specifica
valenza etica. Questo concetto è stato coniato da Beck in relazione
alla fine dell’esclusività delle identificazioni territorialmente fondate
– quella nazionale, in particolare. La non esclusività cui allude Beck
deriva dall’accresciuta mobilità geografica fra stati e continenti
diversi, innescata dalla globalizzazione economica, che ha spostato
sino ai limiti del globo i confini dell’agire professionale di numerose
categorie di soggetti e oggi produce i suoi effetti ben oltre la sfera
dell’economia e del lavoro. Gli individui sono così in condizione di
potersi costruire percorsi identitari che si alimentano di una pluralità
di identificazioni con contesti culturalmente assai diversificati.
Fra i nostri intervistati, abbiamo trovato alcuni casi di
poligamia di luogo à la Beck, tuttavia, la declinazione più
interessante e generalizzata di tale metafora riguarda il modo in cui si
organizza la vita quotidiana: un patchwork (Balbo, 1982) che si
compone e ricompone giorno per giorno, “tenendo insieme” la
pluralità di contesti, tutti egualmente importanti, nei quali si vivono
lo studio e/o il lavoro – spesso distribuito fra più “lavoretti” svolti
contemporaneamente -, l’intimità con il/la partner, lo “stare con” gli
amici e i familiari, l’andare in palestra – un appuntamento
importantissimo, da non mancare! -, il volontariato e così via. La
riduzione ad unità di questi frammenti è possibile, a condizione di
53
potersi ritagliare un po’ di tempo per sé, in cui “riannodare le fila”,
“ritrovarsi” come dicono alcuni, in un processo di costante
autoriflessione. Rieccheggiano, qui, i temi evidenziati da tempo dalle
indagini sulla temporalità femminile moderna. La novità è che essi si
stanno generalizzando.
5. Per concludere rapidamente, accanto ai noti fenomeni di
dispersione e disorientamento, si vede anche emergere una strategia
di governo dell’incertezza identitaria, che fa perno su un’immagine di
costante costruzione/ricostruzione di sé, innescata e sostenuta dal
farsi delle relazioni interpersonali. In questa prospettiva, non
scompare la capacità di raccontarsi; si delinea piuttosto, un nuovo
modo per farlo, che abbiamo definito strutturazione riflessiva della
biografia. Raccontandosi, il soggetto si “costruisce”, costruendo
contemporaneamente il contesto relazionale (Melucci, 2001) e
riconducendo all’esperienza di vita i cambiamenti affioranti
nell’orizzonte culturale del proprio ambiente sociale.
Nelle parole dei nostri giovani, c’è una sottolineatura continua
dei contenuti relazionali dell’esperienza, declinati prevalentemente in
termini di “comunicazione emozionale”, tipica delle relazioni “pure”
(Giddens, 2000), che vanno alimentate e coltivate nelle pratiche,
anche minute, del quotidiano. Concentrando l’attenzione
sull’intensità e la durata di queste relazioni, si può astrarre dagli
effetti disgreganti prodotti dallo sradicamento spaziale e
dall’istantaneità dell’agire funzionalmente orientato. In questo senso,
va letta, ad esempio, l’enfasi posta sull’importanza di ritagliarsi
quotidianamente un po’ di tempo “per stare con gli amici”; sul ruolo
di alcune figure-chiave nello stimolare la “crescita personale e
professionale” nel contesto di lavoro; sulla tendenza a collezionare
oggetti – dalle foto, ai libri, ai fogli su cui si trascrivono gli sms
ricevuti - legati al ricordo di persone significative per il proprio
percorso di vita; sul recupero della dimensione collettiva del passato
attraverso le memorie familiari.
Si tratta di una strategia di recupero della progettualità – e della
memoria – fondata sulla totale assunzione di responsabilità per le
proprie scelte: una responsabilità che non tutti, come si è notato,
riescono a maturare, o ad accettare, o per assumere la quale non vi
sono per tutti risorse adeguate. Molti ne sono sopraffatti, paralizzati.
Altri si danno al vagabondaggio, trasformando l’esplorazione del
54
presente nel progetto di vita, finalizzato a vivere compiutamente
l’intensità di ogni attimo, finito in sé.
Ciò che unisce le tre modalità di declinare l’incertezza
biografica tratteggiate sin qui è il rilievo assunto dalla dimensione
quotidiana. Per l’uomo flessibile di Sennett, il quotidiano è il
contesto in cui l’angoscia del vuoto può trovare sollievo in un
iperattivismo che non lascia spazio per pensare. Per il vagabondo di
Bauman, è il terreno nel quale “andare a caccia” di esperienze
(Jedlowski, 1989). Per chi persegue strategie di strutturazione
riflessiva, è la dimensione nella quale costruire e mettere alla prova le
proprie capacità di bricoleur, il luogo in cui si concretizzano le
potenzialità di “innovazione, di creatività, di differenza”, di cui già
parlava nel 1978 Laura Balbo a proposito della complessa gestione
della doppia presenza femminile.
Riferimenti bibliografici
L. Balbo, “Patchwork”: una prospettiva sulla società di capitalismo maturo, in L.
Balbo e M. Bianchi, Ricomposizioni. Il lavoro di servizio nella società della crisi,
Angeli, Milano, 1982
L. Balbo, La doppia presenza, in “Inchiesta, n. 32, 1978
Z. Bauman, La società dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999
U. Beck, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società
planetaria, Carocci, Roma, 1997
U. Beck, Il lavoro nell’epoca della fine del lavoro. Tramonto della sicurezza e
nuovo impegno civile, Einaudi, Torino, 2000
I. Diamanti, a cura di, La generazione invisibile, ed. Il Sole-24 Ore, Milano, 1999
A. Giddens, Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra
vita, Il Mulino, Bologna, 2000
P. Jedlowski, Memoria, esperienza e modernità, Angeli, Milano, 1989
C. Leccardi, I tempi di vita tra accelerazione e lentezza, in F. Crespi, a cura di,
Tempo vola, Il Mulino, Bologna, in corso di stampa
A. Melucci, Su raccontar storie e storie di storie, in G. Chiaretti, M. Rampazi, C.
Sebastiani, a cura di, Conversazioni, storie, discorsi. Interazioni comunicative tra
pubblico e privato, Carocci, Roma, 2001
M. Rampazi, La costruzione della durata negli spazi del quotidiano, in F. Crespi,
Tempo vola, cit.
R. Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita
personale, Feltrinelli, Milano, 1999
55
Luca Salmieri (Università La Sapienza Roma)
Lavori atipici, vita di coppia, tempi del quotidiano
Il contributo presenta alcuni dei risultati di una ricerca condotta
tra le coppie composte da lavoratori instabili della provincia di Napoli
ed accenna ad una serie di analisi che approfondiscono i legami tra le
forme del lavoro atipico ed i vari percorsi e aspetti della vita a due.
Oggetto della ricerca sono state le persone con un’età tra i 20 ed i 40
anni, sposate o che convivono e coloro che non coabitano stabilmente.
Nel campione rientrano diverse tipologie di lavoro atipico:
collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a tempo determinato,
lavoro part-time, tanto a tempo indeterminato che determinato. Il
lavoro interinale è stato scartato a causa dell’estrema brevità delle
missioni lavorative. La scelta delle coppie è stata effettuata prendendo
in considerazione un quadro composito: è stato infatti sviluppato un
raffronto tra le coppie in cui entrambi i partner svolgono un lavoro
atipico e flessibile, definite per comodità “totalmente flessibili” e quelle in
cui tale condizione riguardava soltanto uno dei partner, definite, invece,
coppie “parzialmente flessibili”. Tra queste l’altro partner poteva risultare
disoccupato oppure occupato con un lavoro “standard” (contratto a
tempo indeterminato e full-time).
L’ipotesi di fondo che ha mosso la ricerca è che la società
dell'incertezza alimenta nuove ed inesplorate forme di adattamento degli
individui alle dinamiche, ai vincoli e alle opportunità della flessibilità e
quindi delle strutturali condizioni di vita. Flessibilità del lavoro,
destabilizzazione della vita quotidiana, formazione e consolidamento
della coppia nella vita di tutti i giorni così come nella prospettiva di
lungo periodo hanno costituito i temi e gli interrogativi dell’analisi. In
particolare il contributo presentato si riferisce alle ricadute
dell’occupazione instabile e del lavoro flessibile su alcuni degli aspetti
della vita quotidiana, legati al rapporto e alla commistione tra tempi
lavorativi ed extralavorativi.
Non a caso questo tema è uno degli aspetti meno indagati
nell’ambito delle ricerche sociologiche. In che modo le nuove coppie
flessibili tentano di combinare i tempi del lavoro con il resto delle
attività della propria vita ? Come ci si barcamena tra attività e cura di
sé, lo stare insieme, le intimità, le attività comuni, gli impegni
professionali, i compiti ed i servizi domestici e familiari, la cura e
l’educazione dei figli ? Se più di un’analisi ha segnalato il venir
meno della netta distinzione tra tempo lavorativo e tempo non
56
lavorativo, riscontrando un sovrapporsi tra tempi dedicati alla
prestazione professionale e altri tempi di vita, poche ricerche hanno
affrontato questo aspetto in relazione alla formazione della coppia e
alla nascite delle nuove famiglie toccate dall’instabilità del lavoro e
dalla continua variazione degli orari.
I risultati della ricerca offrono alcuni primi spunti di
riflessione: l’erosione del confine tra tempi-luoghi di lavoro e di non
lavoro attiene al livello quotidiano della vita delle persone. Le
difficoltà di pianificazione, l’instabilità e l’imprevedibilità della
carriera professionale stravolgono le vita e ne distorcono la
percezione secondo un continuo ricorrere all’analisi di rischi ed
opportunità. La vita riuscita di una persona assomiglia sempre più al
successo di un’impresa: nel senso che le traiettorie della vita
sembrano dover rincorrere i tipici comportamenti delle imprese. In
una frase, “vivere è quasi un’impresa”: i soggetti, come le imprese, si
muovono tra le turbolenze delle richieste che emergono momento
dopo momento nell’arena della quotidianità lavorativa, ponendosi
spesso come minacce, a volte come opportunità tipiche delle
situazioni instabili, precarie e discontinue. Da qui l’ormai ricorrente
invito, quasi di carattere normativo, ad essere “imprenditori di se
stessi”. La necessità di interfaccia tra domanda e offerta di servizi e la
volatilità dei contenuti che sostanziano tali servizi presumono una
totale adattabilità del lavoratore a tempi, compiti, procedure,
informazioni e processi di lavoro. Un nuovo tipo di pressione della
“domanda”, proveniente dalla competizione globale, dalla riduzione
delle disponibilità economiche dei settori pubblici e dalla rivoluzione
informatica, si caratterizza esprimendo la necessità di erogare servizi
diversificati, mutevoli ed in tempo reale. Dato che le barriere che
separavano i luoghi del lavoro dai contesti di non lavoro si sgretolano
(si pensi all’influenza esercitata da internet, dalla telefonia mobile e
dal lavoro a distanza) e lo spazio relazionale si confonde con quello
produttivo, viene meno la tipica distinzione fordista tra spazio di
produzione (la fabbrica), spazio di riproduzione (il nucleo familiare)
e tempo libero (i luoghi dell’entertainment). L’era del post-fordismo
poggia sull’osmosi tra questi spazi. Tale osmosi è resa possibile
dall’economia della conoscenza, che ha disintegrato la fabbrica,
frammentandola nel territorio, e dalla comunicazione a distanza, che
ha trasformato la casa in ufficio, grazie all’impiego degli strumenti
tipici dell’ufficio, e l’ufficio in abitazione, grazie alla presenza dei
comfort tipici dell’abitazione
57
Un tempo istituzione monolitica nella quale si entrava per
tutta la vita, la coppia è divenuta anch’essa, per forza di cose, un
sistema flessibile, fatto di continui aggiustamenti. Non più scontata
nella sua struttura, nei suoi rapporti interni ed esterni, la convivenza a
due richiede una costante “manutenzione” e ricostruzione degli
equilibri che appaiono sempre più legati al divenire irregolare della
vita quotidiana dei singoli e all’importanza dei progetti e delle scelte
di fondo. Al di là del tipo di condizione coniugale (convivenza,
coabitazione, matrimonio, presenza di figli), la maggior parte delle
testimonianze raccolte mostrano soprattutto la presenza di relazioni
che, poco organizzate o stabili, appaiono imperniate su una
percezione della vita quotidiana e dell’avvenire in cui i partner hanno
accettato, chi deliberatamente e chi no, l’esistenza di una certa
flessibilità, anzi di un livello di confusione ed indeterminatezza, nel
sistema domestico, nello scambio reciproco e nelle attività comuni.
Le giovani coppie basano la loro esperienza su un sistema già di per
se flessibile, fatto di continui aggiustamenti. L’idea e la pratica dello
stare assieme non sono più qualcosa di scontato. Esse richiedono una
costante ricerca e ricostruzione degli equilibri. Mettersi assieme a
qualcuno ed impostare una vita di coppia è ormai una sorta di
impresa in progress e non solo in rapporto agli aspetti emotivi. Si
tratta di saper continuamente abbinare istanze lavorative e fabbisogni
della vita a due, verificando giorno per giorno che gli accordi su un
certo numero di cose comuni permetta un’intesa, e che questa venga
quotidianamente rispettata e alimentata.
Mara Tognetti ((Università Bicocca Milano)
Come cambia il lavoro di cura
Il sempre più diffuso ricorso al lavoro di cura prestato da persone
non appartenenti al nucleo familiare, ( fenomeno determinato fra
l’altro da un welfare sempre più monetario, da un’offerta di tale
lavoro a prezzi accessibili , dal persistere della permanenza del lavoro
di cura al domicilio, dalla scarsa o nulla ripartizione del lavoro
domestico fra i generi), oltre che produrre un welfare dai caratteri
inattesi, determina nuove relazioni all’interno della famiglia del
curato, ma anche una nuova idea dell’immigrazione al femminile.
58
Nel contributo oltre ad analizzare come e perché si diffonde
questo lavoro di cura, descriveremo le caratteristiche e i suoi aspetti
di “modernità”.
Analizzeremo altresì gli effetti che tale lavoro produce sul welfare
state per poi approfondire i cambiamenti che determina sia nella vita
quotidiana della famiglia del curato che in quella di chi cura.
Cambiamenti che riguardano lo stile relazionale fra i membri
della famiglia, ma anche la cultura del tradizionale lavoro di cura
svolto da qualche membro femminile della famiglia.
Bibliografia di riferimento
AA.VV, Servizio domestico, migrazioni e identità di genere in Italia dall’Ottocento
ad oggi, in “Polis”, n. 1, 2004
C. Gori, ( a cura di) Il welfare nascosto, Carocci, Roma, 2003
M. Tognetti Bordogna, Fra le mura domestiche :sfruttamento e crisi del welfare
nel lavoro di cura delle badanti, in M. A. Bernardotti, G.Mottura (a cura di)
“Immigrazione e sindacato. Lavori, discriminazione, rappresentanza”, Ediesse,
Roma, 2004
M. Tognetti Bordogna, Lavoro immigrazione femminile in Italia : una realtà in
mutamento, in U.Melotti, M.Delle Donne,( a cura di) “Immigrazioni in Europa.
Strategie di Inclusione - esclusione” , Ediesse, Roma, 2004
Rossana Trifiletti (Università di Firenze)
Famiglie a doppia carriera e organizzazione del
quotidiano
59
II Workshop (ore 9-16)
Coordinano:
Gabriella Paolucci (Università di Firenze)
Ida Regalia (Università di Milano)
Donatella Barazzetti (Università della Calabria)
Donne sull’orlo di una crisi di cura: spunti per
ripensare alcune categorie di genere
Nella mia comunicazione vorrei provare a ragionare su alcune
categorie (doppia presenza, lavoro di cura, conciliazione) che sono
state centrali in questi ultimi 30 nell’analisi di genere in Italia. Vorrei
riflettere su come esse vengano problematizzate dai processi di
trasformazione che stanno frantumando la tradizionale separazione
tra tempo di produzione e tempo di cura, tra spazio produttivo e
spazio riproduttivo. In particolare vorrei mettere in luce gli
interrogativi che pone il permanere della centralità della figura
femminile nelle dimensioni della cura. La categoria di doppia
presenza ha consentito di interpretare questa centralità come un
aspetto cruciale della capacità femminile di attraversare registri
temporali e culturali profondamente diversi:. Questa categoria
presupponeva e rinviava però a una dimensione sociale attraversata
da due sfere oppositive, quella pubblica e quella privata. E metteva in
discussione questa duplicità non negandola, ma assumendola come
frutto di una costruzione fondativa della modernità e delle
rappresentazioni del femminile che le erano proprie. Il reitersi della
centralità femminile nella cura si misura oggi con un processo di
“fluidificazione” dei confini tra tempo di vita e tempo di lavoro, con
la compenetrazione tra sfere e qualità temporali differenti, e con
messa in discussione delle attribuzioni simboliche e dei significati
stessi di tempo di cura, di tempo di non lavoro, di lavoro per il
mercato. Richiede dunque di ripensare a molte categorie consolidate,
e anche al senso e alle ragioni di questo permanere nei nuovi scenari
che oggi attraversiamo.
60
Carmen Belloni (Università di Torino)
L’Indagine Multiscopo sull’uso del tempo
L'Indagine Istat Multiscopo sulle famiglie: Uso del tempo, è ormai
giunta alla sua conclusione ed è quasi terminato il lavoro di pulizia
dei dati.
Facendo parte del ristretto gruppo di "esperti" (non necessariamente
sociologi) chiamati a proporre letture dei dati e a realizzare
elaborazioni degli stessi, in modo che questi abbiano una buona
utilizzabilità sul piano della ricerca (per quanto ci riguarda, sociale,
ma anche linguistica, psicologica ecc.), ho la possibilità di disporre
fin da ora di un ampio sottocampione del campione nazionale di
famiglie.
Come dicono loro (staff ISTAT), i dati non sono ancora "validati",
quindi sono per ora non divulgabili, ma sono a nostra disposizione
solo per cominciare a impostare elaborazioni e ad avviare percorsi di
analisi che rispondano a specifiche domande nei nostri rispettivi
campi di studio. Verso la fine seconda metà dell’anno potranno
essere immessi i dati corretti e i risultati potranno essere divulgati.
Come probabilmente si sa, questi dati hanno una struttura particolare
molto complessa, il cui trattamento comporta un lavoro non piccolo e
una formazione specifica, soprattutto se si vuole andare oltre alla
semplice fase descrittiva, che ha caratterizzato nei tempi passati
questo genere di indagini.
Aggiungo inoltre che, in quest'ultima rilevazione, si è verificato un
accordo europeo, secondo il quale lo stesso protocollo di rilevazione
è stato adottato da tutti i Paesi aderenti al Progetto (la gran parte dei
Paesi europei), quantomeno rispetto a un livello "base", sul quale i
singoli partecipanti - e l'Italia è tra questi - avevano la possibilità di
realizzare livelli più analitici di rilevazione.
Dal lavoro di censimento, che sto facendo, sulle indagini di questo
tipo recentemente realizzate nel mondo, emerge che questo tipo di
analisi (uso tempo), contrariamente a quanto si potesse dire alcuni
anni fa, è ormai molto diffuso e costituisce una fonte preziosa e di
riferimento per la comparazione internazionale.
Come ho detto, su mandato dell'ISTAT, ho già avviato il lavoro di
preparazione dei dati grezzi, su cui impostare poi analisi specifiche,
grazie anche a un gruppetto di lavoro che - faticosamente, date le
solite ristrettezze economiche in cui ci troviamo sempre, ma che per
61
fortuna sta raggiungendo un buon livello - comincia ad avere non
solo la formazione sociologica di base ma anche le capacità tecniche
per la gestione di questi dati. Il mio obiettivo è quello di arrivare in
breve tempo a mettere in circolazione la maggiore quantità possibile
di informazioni sulle caratteristiche della vita quotidiana degli italiani
e delle italiane, confrontandole anche con quelle di altri Paesi
europei.
Come si può immaginare, questi dati rappresentano una vera e
propria miniera di informazioni che il nostro campo di ricerca
potrebbe, dopo il lavoro che stiamo facendo, utilizzare, quantomeno
nell'ottica di avere una "fotografia" di partenza della struttura
quotidiana di vincoli esistente (che passa ancora soprattutto
attraverso la divisione dei ruoli domestici e attraverso il sistema degli
orari) e delle scelte organizzative attuate dai singoli e dalle famiglie.
Sulla base anche dei miei lavori precedenti su questo tipo di ricerche,
posso indicare una serie di temi di riflessione che potrebbero
interessare soprattutto la nostra sezione, ma penso che dai
partecipanti potrebbero venire suggerimenti utili per l'impostazione
del lavoro che mi accingo a fare.
A titolo di esempio, posso indicare i seguenti temi, che
meriterebbero, a parer mio, di essere ulteriormente sviluppati:
1. Quali sono le caratteristiche di questo metodo/strumento e quali
possibilità ci offre?
Queste considerazioni si basano sul fatto che spesso si è messa in
discussione la reale capacità, da parte di questi dati, di permettere la
comprensione dell'azione sociale, considerandoli utili solo a una
semplice descrizione dell'esistente. In realtà, ferma restando, a mio
parere, l'utilità della fase, naturalmente iniziale, della descrizione, il
lavoro che sto facendo mi convince sempre più del fatto che è
importante una seria riflessione metodologica e, ancor più,
epistemologica, su alcuni aspetti fondamentali:
a. come avviene la costruzione del dato su cui impiantiamo poi le
nostre analisi
b. come tenere sotto controllo l'operazione molto delicata della
traduzione delle informazioni in categorie su cui applicare
operazioni di data processing
c. è necessaria una utilizzazione "composita" e non frammentata del
dato, facendone una lettura non "puntiforme", ma "integrata"
delle informazioni fornite; in altri termini, contestualizzando le
62
attività svolte con i dati di relazione, localizzazione, inserimento
tra le altre attività
d. i dati così ottenuti necessitano di essere integrati da informazioni
di cornice e di essere confrontati con dati ottenuti attraverso altri
metodi
Detto questo, è possibile e necessario avviare procedure d’analisi di
una certa complessità, non tanto con la pretesa di fornire un quadro
generale, ma con lo scopo di rispondere a domande precise che
emergono dalla teoria sociologica
2. Quali sono i meccanismi attraverso cui si definiscono o
ridefiniscono i ruoli, soprattutto quelli legati al genere?
Nella riorganizzazione delle attività quotidiane, soprattutto in
relazione alle ridefinizioni degli orari o alla perdita di rigidità e/o di
stabilità, normatività ecc. degli orari, in particolare di quelli
lavorativi, come si ri-organizzano i soggetti: aumentano i gradi di
libertà (in termini semplificatori, inteso come aumento del tempo per
sé) o, contrariamente, aumentano i limiti, sotto forma di
autolimitazioni, sovraccarico ecc.? Le prime impressioni sulla
stabilità dei carichi lavorativi complessivi delle donne, insieme a una
preoccupante tendenza al loro ritiro dal mercato del lavoro, sembrano
indicare che l'allentamento della rigidità dell'orario tenderebbe a
rafforzare i ruoli di genere, con forte cristallizzazione dei ruoli
solitamente definiti “femminili” (naturalmente bisogna ancora andare
avanti con l'analisi). Che cosa sta succedendo negli altri Paesi
europei, in particolare in quelli del nord? Dobbiamo pensare che si
tratti di una dato riconducibile a un "modello mediterraneo", con
forte matrice culturale e legato a una carenza di politiche correttive?
Sia l'indagine nazionale, sia l'indagine da me compiuta su un
campione rappresentativo di bambini torinesi (su cui posso dare già
alcuni risultati, essendo una ricerca autonoma dalla rilevazione
ISTAT, pur rispettandone il protocollo e che quindi, a suo tempo,
sarà con essa confrontabile) mettono in luce la precoce costruzione
sociale del genere e dei ruoli ad esso correlati. I comportamenti
quotidiani delle bambine e dei bambini (attività di tempo libero, uso
degli spazi urbani, attività domestiche, uso delle nuove tecnologie
della comunicazione, socialità) sono veramente differenti! Non è
difficile pensare come.
Un altro aspetto che sta emergendo da alcune analisi straniere sui dati
di uso del tempo è la rilevanza delle attività multitasking (svolgere
63
più attività contemporaneamente). Spesso ciò si mette in relazione
con effetti di stress. Fermo restando che l'aumento di densità del
tempo è una tendenza generale delle nostre società, come si riflette
ciò nella organizzazione del tempo richiesta alle donne, in rapporto
anche alla fissità dei ruoli di genere?
3. Si può parlare di perdita dei confini tra tempi sociali o di
ridefinizione degli stessi?
Nelle nostre ricerche sulla vita quotidiana, bene o male continuiamo a
usare categorie concettuali come lavoro, tempo libero, tempo di
riproduzione. Tutto sommato, il seminario veneziano si fonda su
questo principio e, nello stesso tempo, fa propria la consapevolezza
di una sempre maggiore porosità di questi confini. I dati dei
comportamenti quotidiani (rilevabili attraverso l'uso del tempo)
mettono in luce la sempre crescente difficoltà a separare tra i vari
ambiti. L'aspetto dell'attribuzione di senso tocca indubbiamente il
cuore della questione e, in un certo modo, l'esito di una serie di
passaggi, trasposizioni di finalità che si sono affermati (si stanno
affermando) in primis nell'organizzazione sociale, con cui i soggetti
hanno a che fare nella organizzazione delle loro vite.
Un elemento di "confusione", e di scelta con finalità problem solving
, come abbiamo visto, è quella del multitasking, in cui non solo si
"sovrappongono" le attività, ma si mescolano gli ambiti di
significato, rendendo spesso difficile, per gli stessi soggetti, cogliere
il significato complessivo dei loro comportamenti.
Altri aspetti di porosità dei confini vengono messi in luce dai
comportamenti quotidiani, da pratiche diffuse, come ad esempio
quella della sempre più spinta frammentazione delle attività, dal non
tenere separati gli spazi temporali di pratiche destinate a tempi sociali
differenti, dal processo, ormai più che avviato, di perdita del ritmo
settimanale, dal mescolamento di pratiche festive e non festive ecc.
Come vivono questa diversa velocità di ridefinizione dei tempi
sociali le fasce di popolazione che solo indirettamente entrano in
relazione con le regole dettate dal tempo di lavoro (che costituisce
ancora un tempo centrale), come ad esempio i bambini?
Ciò significa che si stanno mescolando i tempi sociali, e che non ha
più senso far riferimento ad essi, oppure che se ne stanno creando
degli altri, oppure ancora che attualmente stanno convivendo diverse
concezioni degli stessi?
64
Inoltre, la presenza costante e crescente del viaggio (spostamento non
a piedi, ma che noi viviamo come trasportanti o trasportati) nella
nostra organizzazione quotidiana (tema che ritroviamo spesso in
questo gruppo di indagini, in altri Paesi) si può pensare come un
nuovo tempo sociale, o uno spazio di sospensione, o di
depauperamento, nella nostra vita?
Ho fatto solo un elenco di interrogativi e di temi che possono trovare
un riscontro (non ho detto una risposta) nei dati provenienti dall’uso
del tempo. Si tratta di partire da qualcuno di questi interrogativi e
muoversi con analisi un po’ più raffinate al fine di ricostruire la
struttura risultante dalle scelte (più o meno consapevoli) attuate dai
diversi attori. Naturalmente sarebbe importante mettere a confronto
questi dati con analisi più adatte a mettere in luce gli aspetti valoriali
che ci permettono di comprendere i meccanismi che sottostanno a
comportamenti collettivi che caratterizzano gruppi o società locali.
F. Bergamante, R. Cavarra, A. Fasano, P. Rella
(Università La Sapienza Roma)
Famiglia e carriere lavorative instabili: una
conciliazione sempre più difficile
In un contesto di destrutturazione delle attività lavorative e delle
traiettorie di vita, in cui l’incertezza e la paura connotano le biografie
delle persone, armonizzare lavoro e famiglia risulta impresa difficile,
oggi più di ieri in particolare per le donne.
Nella ricerca appena conclusa (Il genere della Radio. Carriera,
famiglia e pari opportunità, Franco Angeli 2004), ciò è apparso
chiaramente.
Allo stato attuale le differenze di genere sono apparentemente
riconosciute, grazie anche al contributo offerto da numerosi studi su
questo tema che vengono svolti da oltre trent’anni. Si direbbe che le
discriminazioni di genere siano ormai molto attenuate e comunque in
via di superamento.
All’inizio di questo percorso di ricerca ci siamo chiesti se il
superamento delle differenze di genere è stato reale o si parla solo in
modo diverso del problema senza una sostanziale modificazione dei
rapporti di potere. Possiamo rispondere che se sono state eliminate le
differenze di genere più plateali, come la netta caratterizzazione
65
maschile o femminile di alcuni tipi di lavoro rimangono molte piccole
differenze che si cumulano fra loro. Soprattutto emergono nuove
disparità legate alla crescente instabilità del lavoro, anche perché le
responsabilità familiari continuano ad essere mal divise.
Eravamo pertanto interessati a scoprire se e in che misura
permanesse una difficoltà femminile nel fare carriera, al di là dei
pregiudizi e delle discriminazioni più grezze. Cercavamo una
situazione d'eccellenza, un'azienda non pregiudizialmente ostile alle
donne, che avesse una Commissione Pari Opportunità. Abbiamo
scelto la radiofonia pubblica, un importante comparto della Rai. La
Rai è un'azienda quasi pubblica che ha addirittura due Cpo. Non ci
aspettavamo di doverci confrontare con il problema del lavoro
precario. La ricerca ha utilizzato metodologie sia quantitative
(questionari e analisi dei dati sulle carriere fornite dall’azienda) che
qualitative (interviste in profondità ai dirigenti, sindacalisti e
lavoratori). Negli uffici dove abbiamo somministrato i questionari
abbiamo trovato numerosi precari/e che lavoravano gomito a gomito
con i/le regolari e che abbiamo quindi deciso di intervistare. Non
siamo però riusciti a fare loro qualche intervista qualitativa dato che,
in seguito al cambio di governo, nessuno era più disponibile a
parlare.
D'altronde se si guarda ai mutamenti del mercato del lavoro sotto i
colpi della sedicente globalizzazione, non si può ignorare che anche
(e forse soprattutto) in settori molto valorizzati socialmente e
culturalmente, si sta sempre più affermando una logica del precariato
come funzionamento normale del mercato del lavoro.
Se la segregazione e le maggiori difficoltà femminili di carriera,
come mostrano altre ricerche, non sono un fenomeno peculiare della
Rai, come anche comportamenti della dirigenza di fatto
discriminatori, ciò che è specifico di tale azienda è il meccanismo di
carriera basato sulla cooptazione e sulle conoscenze politiche e ciò
danneggia di più le donne per la loro scarsa capacità di muoversi nel
mondo della politica.
Non si può certo mettere in dubbio che un nesso così stretto tra
politica e carriera sia una specificità della Rai, ma non si può neanche
ignorare che, specie laddove la carriera la si fa per cooptazione, la
difficoltà delle donne di muoversi in ambito politico costituisca un
handicap, in particolare a livello di alta dirigenza, dove comunque far
carriera significa utilizzare reticoli sociali per entrare in una ristretta
elite, di cui spesso fanno parte anche i vertici politici.
66
Un altro risultato della nostra ricerca, che conferma quanto emerge
anche da altri studi è il ruolo che gioca la classe sociale d'origine sia
sull'ingresso nel lavoro che nella carriera. Gli svantaggi di provenire da
un ceto sociale medio basso si cumulano per le donne con le
differenze di genere: l'entrata, specie nel lavoro regolare, avviene in età
più avanzata e i percorsi di carriera risultano più difficoltosi.
Altro aspetto comune ad altri contesti di lavoro è la difficoltà
femminile di sfondare il soffitto di cristallo: d'altro lato un numero
non irrilevante di intervistate svolge funzioni dirigenziali, in parte
senza che ciò sia ufficialmente loro riconosciuto, e riceve una
positiva valutazione da entrambi i generi. Ciò ci ha permesso di
cogliere gli aspetti positivi delle differenze di genere, quelli meno
scontati. In particolare il leader ideale viene dipinto da entrambi i
generi con caratteristiche spesso ritenute femminili: la capacità di
comunicare e soprattutto quella di cooperare con i suoi sottoposti.
Inoltre uomini e donne, pur avendo (o quanto meno dichiarando)
minor fiducia in capi del loro stesso sesso, riconoscono che la
mancanza di solidarietà tra donne è tra le principali cause di una
scarsa presenza femminile ai vertici aziendali.
Il fatto di lavorare alla Rai è apprezzato dalla maggior parte delle e
degli intervistati, perché si tratta di un lavoro interessante e che
permette di realizzarsi dal punto di vista professionale. Significati ed
atteggiamenti verso il lavoro sono però differenziati per genere: le
donne vivono il lavoro come affermazione sociale, specie se si tratta
di un lavoro prestigioso come quello di giornalista o appassionate
come quello di programmista e affermano di porre molta attenzione
(in particolare se impiegate) nello svolgere correttamente il proprio
lavoro. Inoltre, a parità di qualifica, le intervistate hanno un più
spiccato senso di responsabilità rispetto agli intervistati. Passione per
il lavoro, peggiori condizioni retributive e di carico di lavoro e
maggiori difficoltà di carriera determinano una più alta
insoddisfazione femminile, che è conseguenza anche delle difficoltà
di conciliare lavoro e famiglia, problema di cui continuano a farsi
carico soprattutto le donne.
Tra le più giovani generazioni, dove la segregazione è più
attenuata, stanno peggiorando le condizioni di lavoro, con
l'incremento dei rapporti di lavoro precari. La crescita della precarietà
ha effetti diversi per i due generi sulla possibilità di farsi una propria
famiglia, dato che il lavoro di cura è ancora mal diviso tra uomini e
donne.
67
L'aumento della precarizzazione dei rapporti di lavoro è un
fenomeno non specifico dell'azienda da noi analizzata, tuttavia il fatto
che si presenti per lavoratori e lavoratrici che fanno un lavoro
“appassionante” (quello di giornalista e di programmista regista) ha
negativi risvolti in ambito familiare: la strategia della doppia
presenza diventa sempre più impossibile da praticare.
Le difficoltà di essere assunti in pianta stabile sembrano colpire sia
gli uomini, sia le donne, ma queste ultime subiscono maggiori
contraccolpi in ambito familiare che si percepiscono nell’alta
presenza di nubili in età avanzata, di separate e divorziate, o
quantomeno nella quasi impossibilità di trovare un equilibrio tra
ambito domestico e lavorativo che non sia a sfavore dell’uno o
dell’altro aspetto.
Giovanna Fullin (Università Bicocca Milano)
Instabilità del lavoro e processi di definizione
dell’identità
Gli studi condotti in Italia sulla diffusione delle occupazioni instabili
hanno generalmente dedicato scarsa attenzione all’analisi delle sue
conseguenze sulla vita dei lavoratori. Il tema dell’identità, in
particolare, è stato spesso trascurato, a differenza di quanto accade ad
esempio nella letteratura francese sulla flessibilità del lavoro.
Questo contributo intende prendere in considerazione i modi in cui
l’instabilità dei rapporti di lavoro incide sui processi di definizione
dell’identità professionale e sociale degli individui e, di conseguenza,
sui modi in cui essi progettano i loro percorsi nel mercato.
Il dibattito su questo tema si articola lungo linee contrapposte. Da un
lato c’è chi sostiene che la diffusione di forme di lavoro instabili
ostacola la costruzione dell’identità perché determina una
frammentazione delle esperienze lavorative e rende difficile la loro
ricomposizione in un percorso professionale e identitario coerente
(cfr. ad esempio Sennett 1998). Dall’altra parte, visioni meno
pessimistiche sottolineano il carattere di crescente “fluidità” delle
identità individuali (cfr. ad esempio Bauman, 2000), che si
adatterebbero alla mutevolezza del contesto divenendo a loro volta
mobili. In questa prospettiva, l’instabilità lavorativa non è vista come
un ostacolo al processo di costruzione dell’identità ma, al contrario, è
considerata come una risorsa per i soggetti, che devono essere sempre
68
pronti a modificare i propri piani per inseguire le nuove opportunità
che si possono presentare loro.
La ricerca - condotta in Lombardia attraverso interviste in profondità
a lavoratori interinali e collaboratori - mostra, da un lato, che non è
possibile valutare in modo univoco le conseguenze della diffusione
delle occupazioni instabili sui processi di definizione delle identità e,
dall’altro, che tali processi sono strettamente interrelati con quelli
relativi alla definizione dei percorsi lavorativi (che possono portare i
soggetti a raggiungere posizioni di forza sul mercato o intrappolarli
in condizioni di estrema vulnerabilità).
Le situazioni dei lavoratori instabili, infatti, non si differenziano tanto
sul piano oggettivo delle condizioni contrattuali e lavorative, ma
piuttosto su quello soggettivo relativo al grado di soddisfazione che
gli individui traggono dal loro lavoro e alle loro aspettative riguardo
al futuro (il genere e l’età costituiscono a questo riguardo dimensioni
cruciali dell’analisi). In particolare, si rileva una sostanziale
differenza tra coloro che svolgono un’attività corrispondente alle loro
aspettative e coloro che invece hanno un impiego instabile in attesa di
trovare un lavoro migliore. I primi, infatti, riescono generalmente a
costruire la propria identità professionale a prescindere
dall’instabilità della posizione occupazionale, mentre i secondi, al
contrario, vorrebbero evitare di identificarsi nell’attività svolta e
spesso riescono ad usare l’instabilità dell’occupazione per mantenere
su due diversi piani la concezione di sé e l’immagine di sé verso
l’esterno. Le “strategie di attesa” di questi ultimi, tuttavia, paiono
avere un senso se sono basate su un progetto chiaro di transizione ad
un lavoro migliore mentre divengono più problematiche se le
prospettive per il futuro sono vaghe. Inoltre, vi è il rischio che il
protrarsi dell’attesa riduca le capacità strategiche degli individui e
renda sempre più difficile ricomporre le esperienze di lavoro in un
percorso coerente che abbia un senso, con evidenti conseguenze in
termini di vulnerabilità sul mercato del lavoro.
Il presente contributo costituisce una rielaborazione di alcuni risultati di una
ricerca da me condotta tra il 2001 e il 2004, che ha portato alla pubblicazione
presso Il Mulino del volume “Vivere l’instabilità del lavoro” (2004).
Salvatore La Mendola (Università di Padova)
Retroscena e paura della contaminazione: l’esperienza
dello spazio nel lavoro quotidiano
69
Laura Parolin (Università di Trento)
Le pratiche discorsive come pratiche di lavoro. Il caso
del teleconsulto cardiologico
Negli ultimi anni è emerso un corpus di letteratura che si è
preoccupato di studiare il lavoro in setting tecnologicamente densi
quali le sale controllo di aeroporti o delle metropolitane di grandi
città. L´interesse di ricerca è focalizzato sulla natura contingente e
situazionale dell’agire organizzativo preoccupandosi di fornire
resoconti dettagliati delle attività che si svolgono nel work setting.
Questo filone di studi, cosiddetti Workpalce Studies per l’attenzione
allo spazio di lavoro come spazio ecologico dove sono in atti
dinamiche collettive e sociali e relazioni con gli artefatti utilizzati, si
concentrano sullo studio naturalistico delle pratiche di lavoro.
Attraverso strumenti di registrazione e di video ripresa analizzano le
pratiche di interazione dei soggetti presenti nel setting mettendo in
evidenza il carattere sociale della conoscenza presente nel workplace.
Vi è quindi un’attenzione al lavoro come attività sociale situata in un
particolare setting composto da attori umani e tecnologie. I wokplace
studies sono influenzanti dai filoni di studio che si richiamano alla
scuola di Chicago valorizzando il carattere emergente delle azioni
collettivo come prodotto del coodinamento reciproco.
Anche il caso del teleconsulto cardiologico che presentiamo può
essere letto attraverso gli strumenti che la letteratura dei Workpalce
studies ci mette a disposizione. Nel caso che presentiamo l´attività
lavorativa è svolta attraverso la mediazione di un infrastruttura
tecnologica che mette in contatto il medico di medicina generale che
invia il tracciato ECG e il cardiologo che lo riceve. Il contatto è poi
stabilito telefonicamente tra i due medici attraverso la mediazione di
un call centre.
Attraverso l’analisi situata delle pratiche lavorative degli attori che
lavorano al sistema di teleconsulto cardiologico possiamo vedere la
produzione pratica del coordinamento e la creazione contestuale di
senso che nell’interazione gli attori producono.
Questo modo di osservare il lavoro ci permette di porre dei quesiti
sulla applicazione nella pratica del sapere medico cercando di gettare
luce su quel´area grigia esistente tra il sapere formalizzato nelle
procedure organizzative quali i protocolli medici e la conoscenza
tacita che permette la performance della pratica medica.
70
A. Maria Ponzellini (Università di Bergamo)
Work life balance e relazioni industriali
Di recente, molte indagini hanno messo in evidenza le esperienze
positive realizzate in alcune aziende per migliorare la conciliazione
tra lavoro e famiglia: asili-nido aziendali, flessibilità degli orari,
supporti per la maternità e la paternità, etc.. Tuttavia, quando
abbandoniamo il (consolante) approccio descrittivo delle “buone
prassi”, il panorama che, soprattutto in Italia, ci offre la rilevazione
quantitativa di tali esperienze appare estremamente preoccupante.
Sono infatti pochissime - non oltre il 3%, secondo una stima avanzata
da una indagine sulla contrattazione aziendale degli ultimi anni - le
aziende dove sono state introdotte norme sul lavoro classificabili,
anche in senso lato, come misure favorevoli alla conciliazione.
Questo paper si propone di trovare spiegazioni al mancato, o
comunque insufficiente, riscontro nella esperienza contrattuale – e,
più in generale, nella esperienza delle relazioni tra organizzazioni
sindacali ed imprese – di un bisogno sociale che pure, dal momento
dell’ingresso di massa delle donne nel mercato del lavoro, è diventato
evidente ed urgente. Una carenza che potrebbe addirittura costituire
la ragione della scarsa propensione delle lavoratrici italiane – in
controtendenza rispetto al resto d’Europa – ad iscriversi al sindacato.
Per fare questo, il paper fa un’analisi delle oggettive difficoltà delle
parti sociali a regolare contrattualmente e estendere all’insieme del
mondo del lavoro esigenze differenziate, mutevoli nel tempo e
“costose”, come quelle di cui sono portatori e portatrici i dipendenti
con responsabilità familiari e di cura. Ipotizza però anche la
possibilità che le relazioni industriali che conosciamo siano - per
tradizione, cultura e struttura - inadatte a recepire e a tradurre in
regole contrattuali questi nuovi bisogni, al di fuori di un percorso di
reale innovazione.
71
Lorenzo Speranza e Angela Palmieri
(Università della Calabria)
Forme di costruzione dell’identità professionale:
gli stili di vita dei medici di Ancona, Cosenza e Torino
È possibile studiare l’identità di un gruppo professionale
partendo da pratiche che attengono alla sfera del non-lavoro?
Nelle società contemporanee, secondo molti autori, questo
non solo è possibile, ma è anche auspicabile: al centro della vita degli
individui contemporanei, infatti, non c’è più solo il lavoro (come
avveniva nelle società industriali) e, conseguentemente, l’identità
sociale si può strutturare anche su altre sfere. Ovviamente, i
condizionamenti esercitati dalle appartenenze tradizionali (che
attengono principalmente alla dimensione economica) non sono
scomparsi dalle nostre società. Se l’obiettivo, però, è analizzare i
processi (più che i prodotti) della formazione dell’identità sociale, gli
aspetti economici devono essere affiancati da altri che hanno a che
vedere con la cultura, con lo status.
In una simile ottica, quindi, gli stili di vita (intesi come
specifiche combinazioni di pratiche, o consumi, materiali e culturali,
che hanno una certa coerenza fra di loro) rappresentano un’utile
direzione cui guardare per capire come un gruppo professionale
segni, metaforicamente, i confini di un determinato spazio sociale,
attraverso scelte stilistiche che esplica nel quotidiano: in breve, come
costruisca la sua identità nella sfera del non-lavoro.
Il paper è basato su una ricerca COFIN condotta su circa mille
medici di tre zone scelte a rappresentare le “tre Italie”: la provincia di
Torino (Nord-Ovest), quella di Ancona (Centro-Nordest) e, infine,
quella di Cosenza (Mezzogiorno).
Maurizio Teli (Università di Trento)
La presentazione di sé degli addetti alla vendita come
resistenza quotidiana alla McDonaldizzazione
I riferimenti teorici a Erving Goffman e a George Ritzer sono
evidenti già nel titolo di questo intervento, con il quale vorrei
mostrare come, da una ricerca sul campo condotta nell'estate 2003 in
un supermercato della provincia novarese, emerga vividamente come
la quotidianità lavorativa costituisca una forma di resistenza a
72
processi di razionalizzazione della contemporaneità che sembrano
caratterizzare gli ultimi anni.
Il contributo di Goffman è stato considerato precipuamente in
riferimento al concetto di presentazione di sé, collegato all'idea che
tale comportamento quotidiano influisca sui frame con i quali gli
individui organizzano la propria esperienza e, in un meccanismo
circolare che lega individuo e cultura, si colleghi con il più ampio
framework di frameworks culturale.
Ho guardato al concetto di McDonaldizzazione introdotto da Ritzer
per cogliere elementi che ben rappresentassero le dinamiche presenti
nei luoghi di lavoro, quelli del consumo, che mi accingevo ad
analizzare. Ai fini di questa esposizione è utile scomporre il concetto
nelle quattro dimensioni che l'americano ha individuato: efficienza,
calcolabilità, prevedibilità e controllo. Soprattutto quest'ultima, nei
suoi elementi di spinta al controllo della clientela, risulta
maggiormente messa in discussione dall'interazione quotidiana tra
lavoratore e cliente, in un modo che discuterò in conclusione.
La ricerca è stata condotta su un punto vendita Coop che, nel periodo
considerato, annoverava 35 dipendenti, operanti su una superficie di
vendita di 1500 mq. Il punto vendita oggetto di studio attraversava un
periodo di crisi economica, culminato con il trasferimento ad altri
punti vendita di sei dipendenti, legato all'apertura, a pochi chilometri
di distanza, di un centro commerciale contenente un ipermercato.
All'interno di un quadro metodologico di natura qualitativa, la tecnica
che ho prevalentemente utilizzato è stata l'intervista non strutturata,
orientata a approfondire due aree tematiche: il rapporto del singolo
lavoratore con la clientela e l'immagine che l'azienda intendesse
fornire di sé. La scelta dei soggetti è stata effettuata seguendo una
metodologia di campionamento a scelta ragionata.
Per approcciare l'analisi dei dati, in particolar modo per comprendere
come si conformasse il rapporto tra quotidianità lavorativa e processi
di razionalizzazione, ho utilizzato i concetti di idioma di servizio
(centrato sul cliente) e idioma commerciale (con al centro gli aumenti
di produttività oraria).
Tutte le interviste, anche se con toni diversi, hanno evidenziato un
conflitto tra i due idiomi precedentemente descritti, soprattutto nei
termini di una diversa visione dell'aumento della produttività. Se dal
lato aziendale si è constatata una preferenza per la riduzione del costo
del lavoro, tramite la già menzionata riduzione delle ore di lavoro
straordinario richieste, dal lato della forza lavoro si è notato un
73
maggiore accento sulla necessità di garantire un ottimo livello di
servizio, precondizione per l'aumento degli incassi e
conseguentemente della produttività oraria.
Nella prospettiva teorica goffmaniana, ben applicabile ai risultati
delle interviste, l'accento posto dai lavoratori sull'idioma di servizio
trova fondamento nella presentazione di sé che il momento
interazionale implica, presentazione mirante a soddisfare le esigenze
della clientela, orientata all'ottenimento del servizio stesso.
Contemporaneamente questa interazione condiziona il frame con il
quale i lavoratori stessi concettualizzano la propria esperienza
quotidiana, frame che, nel caso di una apertura a processi di
partecipazione degli stessi alla gestione aziendale, con una effettiva
comunicazione bottom – up, potrebbe esercitare un ruolo decisivo
nell'orientare le politiche di vendita.
Per quanto riguarda le dimensioni della McDonaldizzazione, per
quanto le strutture fisiche dei punti vendita siano mirati ad aumentare
il controllo ottenibile sulla clientela, il frame di servizio tipico dei
lavoratori lascia pienamente spazio a una riduzione di tale spinta,
evidenziando in tal modo il ruolo della quotidianità come elemento di
resistenza verso le visioni totalizzanti dei processi contemporanei.
1 Questo intervento si basa sui risultati della mia tesi di laurea, “I lavoratori del
consumo: un'analisi del consumo dal punto di vista degli addetti alla vendita”,
discussa il 26 marzo 2004 presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli
Studi di Milano, con relatore la prof.ssa Luisa Leonini e correlatore il prof.
Giampietro Gobo.
2 Dottorando in Sociologia e Ricerca Sociale – Information Systems and
Organizations – Università di Trento
Giovanna Vingelli (Università della Calabria)
Intellettuali precarie. Donne e tempi di vita in un
dipartimento universitario
L’intervento in oggetto è parte di una più ampia ricerca, attualmente
in corso, sul lavoro intellettuale precario all’interno dell’Università
della Calabria. Nello specifico, oggetto del paper è l’analisi degli usi
e delle rappresentazioni del tempo delle dottorande di ricerca/borsiste
all'interno del Dipartimento di Sociologia e Scienze Politiche
dell'Università della Calabria. La ricerca è stata condotta attraverso
74
una serie di interviste in profondità, la cui analisi intende
problematizzare la relazione fra lavoro intellettuale e dimensione di
genere in un contesto organizzativo in continua evoluzione, che si
caratterizza per un’elevata esperienza e prospettiva di precarietà.
Utilizzando gli approcci della sociologia del tempo, della vita
quotidiana e degli studi di genere, la ricerca vuole analizzare come si
intersecano prospettive temporali sempre più flessibili e frantumate
con il contemporaneo perdurare della centralità della cura nella vita
delle donne intervistate. L’ambivalenza nella strutturazione del
tempo delle donne (difficoltà nell’organizzazione temporale
quotidiana e nella proiezione biografica nel futuro) si coniuga,
nell’analisi, alle contraddizioni del “lavoro intellettuale”
contemporaneo.
Il progetto di vita delle donne intervistate non si presenta coincidente
con l'adesione a sequenze prevedibili e socialmente accettate di
eventi; allo stesso tempo, tuttavia, emergono strategie temporali
legate alla ricomposizione e alla continuità: il lavoro intellettuale si
manifesta, in questo caso, come scelta di conciliazione per
eccellenza, modalità-cerniera fra la realizzazione individuale nel
lavoro per il mercato e la centralità sociale e culturale dell’istituzione
familiare. Allo stesso tempo, il lavoro intellettuale è vissuto in
maniera ambivalente: da un lato, la qualità stessa del tempo dedicato
alla “professione” intellettuale assume le scansioni e le logiche di un
tempo produttivo, collocato in un presente che si dilata
nell’incertezza del futuro; d’altro lato diventa una dimensione
interiore, creata dal soggetto, al di là e al di fuori del tempo
istituzionale: un tempo generato, in contrapposizione al tempo
normato dello spazio pubblico.
Riferimenti bibliografici
Balbo L., Bianchi M. (a cura di) (1982), Ricomposizioni. Il lavoro di servizio nella
società della crisi, Franco Angeli, Milano.
Balbo, L. (1987), «Crazy Quilts: rethinking the welfare state debate from a
women’s point of view», in A. Showstack Sasson (Ed.), Women and the State,
Hutchinson, London.
Bimbi F. (1986), «Lavoro domestico, economia informale, comunità», Inchiesta, n.
74.
Bimbi F. (1991), «Doppia presenza» in L. Balbo (a cura di), Tempi di vita. Studi e
proposte per cambiarli, Feltrinelli, Milano.
75
Calabrò A.R., (1996), Una giornata qualsiasi. Il tempo libero delle donne: tempo
per sé o tempo per gli altri?, Ripostes, Roma.
Chiaretti G. (a cura di) (1980) Lavoro intellettuale, lavoro per sè: doppia presenza,
FrancoAngeli, Milano.
Leccardi C, (1996a), Futuro breve, Rosenberg & Sellier, Torino.
Leccardi C. (1996b), «Re-thinking Social Time: Feminist Perspectives», Time &
Society, 5(2).
Paolucci G. (1993), Tempi postmoderni. Per una sociologia del tempo nelle società
industriali avanzate, FrancoAngeli, Milano.
Paolucci G. (1998) (a cura di.), La città, macchina del tempo. Territorio e politiche
del tempo urbano in Italia, FrancoAngeli, Milano.
Vantaggiato I. (1997), «Quel che resta del tempo», in Buttarelli A., Longobardi G.,
Muraro L., Tommasi W., e I.. Vantaggiato, La rivoluzione inattesa. Donne al
mercato del lavoro, Pratiche Editrice, Milano.
Lorenza Zanuso (Studio L.Z., Milano)
Il lavoro diviso, trent’anni dopo
Retoriche neutre
Il discorso pubblico sul lavoro e le sue modificazioni è oggi dominato
dalla retorica della competitività globale: nel nuovo mondo
globalizzato le economie occidentali potranno continuare a
svilupparsi – potranno sopravvivere - se sapranno mantenere il
primato sulla principale forza produttiva dell’era postmoderna: la
conoscenza, il “sapere” incorporato non tanto o solo nelle macchine,
ma nel lavoro vivo, cioè nelle persone che lavorano e nelle loro
interazioni cooperative.
Il sapere scientifico in primo luogo, ma anche le generali abilità
linguistiche, di apprendimento, memoria e astrazione; di
immaginazione e creatività; di relazione e comunicazione degli
individui - si avviano a diventare la risorsa produttiva principale del
modo di produzione post-fordista, quella su cui si gioca la sfida della
competitività tra diversi paesi e aree del mondo.
General intellect e intellettualità di massa nella versione di sinistra,
capitale umano e risorse di eccellenza nella versione dominante sono
i modi correnti di nominare le competenze cognitive e comunicative
che sono e saranno sempre piu’ necessarie alle società della
76
conoscenza per competere, alle imprese per produrre, agli individui
per lavorare.
Nei nuovi mercati del lavoro piu’ flessibili e insicuri, ma anche piu’
mobili e aperti di un tempo, la nuova classe media postfordista è
invitata a investire in capitale umano, ad assumere su di sé il
desiderio e il rischio e del proprio progetto e percorso lavorativo, a
cogliere le opportunità dentro e fuori le imprese di appartenenza. In
cambio delle sicurezze perdute, nuovi ammortizzatori sociali e nuove
opportunità di life-long learning dovranno essere messi in campo per
proteggere gli individui
dagli episodi di inoccupazione o
sottoccupazione, scelta o subita.
A questo livello di astrazione, il lavoratore è una figura sessualmete
neutra, senza specificazioni di genere; lo scenario è quello della
società del lavoro, con l’obiettivo dichiarato dell’aumento dei tassi di
partecipazione e del pieno impiego di uomini e donne, impegnati a
competere in un orizzonte lavorativo piu’ selettivo e incerto, ma
anche piu’ ricco di possibilità di scelta, e in particolare di una
maggiore possibilità modulazione dell’impegno lavorativo lungo il
corso di vita.
Ma qual è, in questo scenario, il posto delle donne?
I lavori delle donne
L’aumento della partecipazione e dell’occupazione femminile al
lavoro retribuito è la tendenza piu’ importante di tutti i mercati del
lavoro europei negli ultimi trent’anni.
In Italia, tra il 1971 eil 2001 sono scomparse dai territori domestici
centinaia di migliaia di casalinghe full-time, e centinaia di migliaia di
nuove occupate hanno popolato i territori del lavoro retribuito (oltre
un milione in piu’ negli ultimi 10 anni).
Questa dislocazione di massa ha interessato donne di tutte le età, ha
profondamente scompaginato l’ordine fordista del mercato del lavoro
e delle forme familiari, si è accompagnata a un imponente
cambiamento dei comportamenti demografici e dei rapporti tra
generazioni. E ha suscitato - in Italia in modo prevalentemente
discorsivo - nuove domande e proposte di riforma delle politiche
sociali e del lavoro, in una prospettiva di pari opportunità tra donne e
uomini e di migliore conciliazione, per donne e uomini, tra sfera
lavorativa e sfera familiare.
77
Oggi, a trent’anni di distanza dall’inizio di questi processi, colpisce
sia la difficoltà da parte istituzionale di immaginare, coordinare e
finanziare interventi e misure concrete per sostenere gli obiettivi
dichiarati, sia il permanere di una divisione del lavoro – familiare e
non - asimmetrica lungo linee di genere.
E colpisce, in senso piu’ generale, lo scarto crescente tra la retorica
pubblica sulle pari opportunità e la promozione del lavoro femminile
– a sua volta parte della piu’ recente retorica sulla valorizzazione del
capitale umano bisex - e i processi reali di adattamento che sia i
sistemi istituzionali che gli individui stanno mettendo in atto per far
fronte al cambiamento.
Al centro di queste strategie di adattamento – questa è l’ ipotesi – si
intravvede negli anni recenti una nuova, massiccia e silenziosa
“valorizzazione” e incentivazione del lavoro di cura, informale o
sottopagato, svolto da donne autoctone e immigrate.
Una valorizzazione implicita, sottaciuta nel discorso pubblico e priva
di riconoscimento economico e culturale, ma che si sta ri-affermando
di fatto nelle pratiche e nelle scelte quotidiane dei singoli, e nelle
logiche di ristrutturazione dei sistemi di welfare.
In una società che invecchia e in cui crescono tutti gli indici di
dipendenza, la crescente incertezza e discontinuità dei percorsi
lavorativi e biografici della popolazione giovane e adulta non riduce
infatti, ma semmai aumenta il bisogno di un retroterra di lavoro di
cura che sostenga e ricomponga il tessuto della vita quotidiana di
individui e famiglie. Non solo per far fronte alle condizioni di
routine, ma anche per fronteggiare i sempre piu’ “normali” episodi
di precarietà e discontinuità lavorativa e familiare, o ancora i rischi
di catastrofe esistenziale nel caso di inoccupazione protratta o
presenza di disabilità croniche.
In un quadro di sostanziale stabilità o contrazione dei servizi
pubblici, sono e saranno ancora e soprattutto le donne a farsi carico di
questo “backstage” del lavoro retribuito, con effetti già oggi ben
visibili sui livelli di partecipazione, sulla distribuzione occupazionale
e sulla differenziazione dei percorsi lavorativi di donne di diversa
generazione e età, provenienza etnica e origine sociale.
Le principali tendenze in corso in Italia, con diversa intensità a
seconda dei diversi contesti territoriali ( cfr. ricerche Lombardia e
Alto-Adige) sembrano essere:
78
Il rallentamento o l’ arresto dell’aumento di partecipazione
femminile al lavoro per il mercato: l’offerta di lavoro
femminile si sta esaurendo.
La polarizzazione interna all’universo femminile in termini
di redditi, continuità, tempi del lavoro retribuito, e di
collocazione nella struttura professionale: aumentano le
differenze tra donne, in particolare tra chi puo’ e vuole
perseguire percorsi di carriera e chi non.
La perdurante segregazione orizzontale nel lavoro retribuito,
correlata con la concentrazione femminile nelle nuove forme
di lavoro atipico, e in particolare nel lavoro a tempo ridotto: i
mestieri, i tempi e i percorsi di lavoro della grandissima
maggioranza delle donne continuano ad essere molto diversi
da quelli degli uomini.
La tacita redistribuzione tra donne, infine, del lavoro di cura
non coperto dai servizi pubblici, giocata anch’essa tra donne
di diversa generazione, provenienza e classe sociale: il lavoro
informale di cura delle piu’ mature e/o meno istruite sostiene
strutturalmente il lavoro per il mercato delle piu’ giovani e/o
piu’ istruite; il lavoro sottopagato delle immigrate sostiene la
doppia presenza e/o il caregiving a pieno tempo delle
autoctone.
Il lavoro diviso: disuguaglianza e resistenza
In sintesi, anche se in condizioni molto mutate rispetto a
trent’anni fa, sembra che la divisione del lavoro sociale lungo linee di
genere ritorni ad essere un potente dispositivo di adattamento e
compensazione, sia per i singoli che per la collettività, di fronte ai
nuovi assetti demografici e ai nuovi rischi e incertezze dell’era postfordista.
E’ vero che, nel frattempo, è anche aumentata la differenziazione
tra donne: per molte sono cresciuti i margini di libertà, di decisione
e di movimento nel mercato del lavoro. Ma è anche vero che il
silenzio e la sordità sociale sull’esistenza del lavoro di cura, sulla sua
natura e sulle sue modificazioni continua e continuerà a comportare
una profonda diversità nelle opportunità, nelle scelte professionali e
nelle biografie lavorative della grande maggioranza della popolazione
femminile. Sia che lo si denunci come fenomeno di disuguaglianza e
discriminazione subìta, sia che lo si interpreti come forma di
79
resistenza anche femminile di fronte all’incubo totalitario di una
società –senza-cura, la responsabilizzazione delle sole donne verso i
bisogni quotidiani “degli altri” continuerà a essere un inciampo
imbarazzante per tutte le retoriche della parità femminile nel lavoro
retribuito. Compresa la piu’ recente e piu’ accattivante, sul pieno
impiego del capitale umano di entrambi i sessi nella “società della
conoscenza”.
80