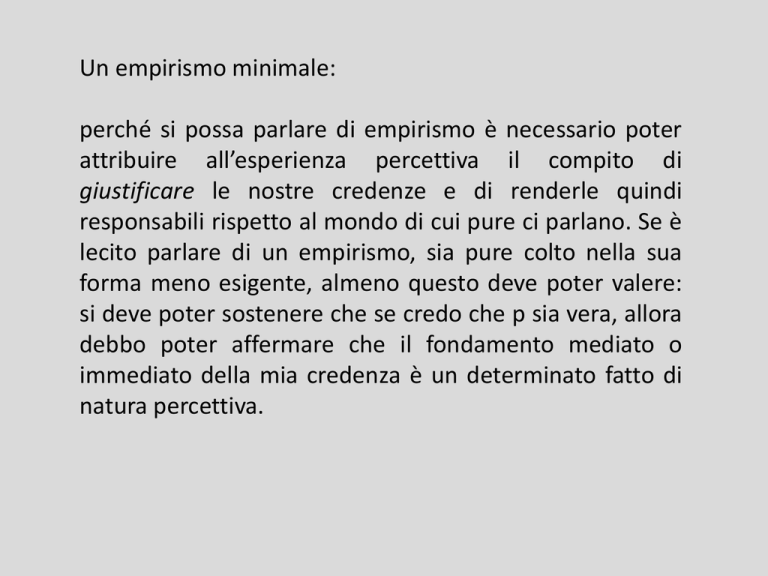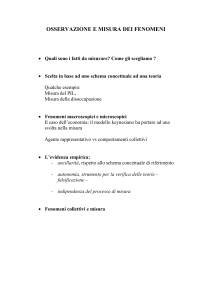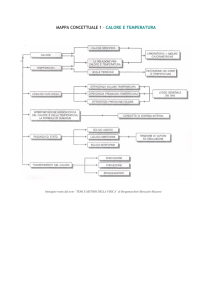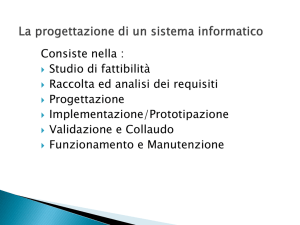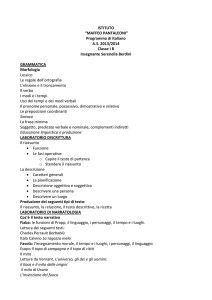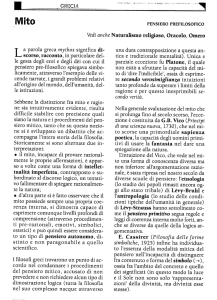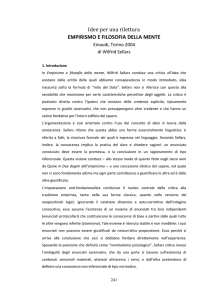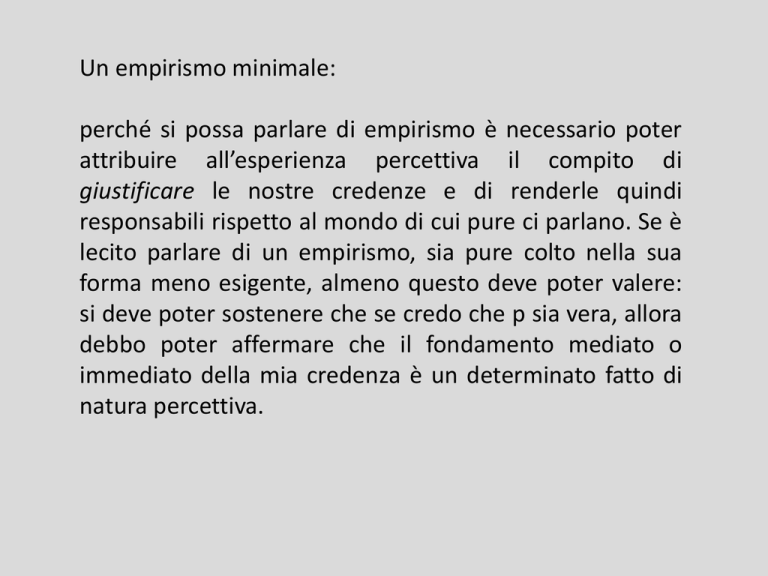
Un empirismo minimale:
perché si possa parlare di empirismo è necessario poter
attribuire all’esperienza percettiva il compito di
giustificare le nostre credenze e di renderle quindi
responsabili rispetto al mondo di cui pure ci parlano. Se è
lecito parlare di un empirismo, sia pure colto nella sua
forma meno esigente, almeno questo deve poter valere:
si deve poter sostenere che se credo che p sia vera, allora
debbo poter affermare che il fondamento mediato o
immediato della mia credenza è un determinato fatto di
natura percettiva.
“Nihil nisi punctum petebat Archimedes, quod esset firmum
et immobile, ut integram terram loco dimoveret; magna
quoque speranda sunt, si vel minimum quid invenero quod
certum sit et inconcussum”.
Il mito del dato
Alla constatazione secondo la quale è lecito distinguere le
conoscenze inferenziali da quelle che ci riconducono alla
dimensione osservativa sembra essere possibile affiancare una
tesi più impegnativa che ci invita a sostenere che le
conoscenze non inferenziali sono direttamente fondate
sull’esperienza e poggiano soltanto su essa. Non è una
differenza da poco: ora non ci limitiamo più a sostenere che vi
sono alcuni fatti che ci sembra di poter constatare muovendo
da ciò che la percezione ci porge, ma vogliamo invece
affermare che la percezione che ora abbiamo nella sua
immediatezza e nella sua natura di dato antecedente ad ogni
interpretazione concettuale è in grado di fondare la nostra
credenza e racchiude in sé tutto ciò che è necessario per
giustificarla.
Una constatazione importante: per Sellars, il
dato è un mito non in se stesso, ma se
cerchiamo di avvalercene in una funzione
fondazionale.
Ciò che è incomprensibile non è il fatto che vi
siano percezioni immediate, ma che esse
possano fungere come fondamento di credenze.
Il dato è un mito dunque solo nella sua funzione
fondazionale – questo è quanto Sellars sostiene.
Due argomenti. La critica del principio empiristico dell’astrazione.
È davvero possibile intendere i concetti come se fossero un
particolare genere di vissuti che sorgono dalle sensazioni grazie ad
una qualche modificazione del loro contenuto psichico? No: è solo
frutto di illusione credere che un concetto sia un’immagine, sia pur
priva di un confine ben definito. Le cose non stanno così, i concetti
non sono immagini, sia pure vaghe, ma un certo modo di impiegarle
che può essere determinato solo se ci si dispone sul terreno
intersoggettivo dei giochi linguistici. Di per sé un’immagine vaga non
ci permette di individuare l’oggetto cui si riferisce e questo può far
sorgere l’idea che quell’immagine abbia la valenza generale che è
propria delle nozioni; le cose non stanno così: un concetto non è
qualcosa che alluda in modo vago al suo referente e che, proprio per
questo, possa equivocamente essere usato per indicare ora questo,
ora quell’oggetto, ma è il veicolo di una determinazione ripetibile, di
un senso che può essere applicato secondo una regola che svincola
dall’occasione del suo occorrere la paradigmaticità dell’esempio.
Il maestro fa così: traccia alla lavagna un triangolo e poi
insegna al bambino ad avvalersene in un certo modo:
propone un disegno e insieme un modo di avvalersene –
una regola, appunto – che fa di ciò che è di fronte ai nostri
occhi un paradigma della triangolarità. Propone un esempio
e insegna un modo di avvalersene, e nel gioco delle
approvazioni e delle riprovazioni sorge una regola d’uso che
trasforma lo spazio dell’accordo in un concetto, in un certo
modo di comportarsi che ha nella sua ripetibilità e nella sua
intersoggettività i suoi contrassegni. Che cosa sia un
triangolo non ce lo dice dunque un disegno fatto alla
lavagna, ma un modo di impiegarlo che è sancito da un
accordo intersoggettivo. Si muove, certo, da ciò che alla
lavagna si mostra, ma l’immagine si fa modello solo in virtù
di una procedura condivisa che le attribuisce una
normatività.
Due argomenti. L’impossibilità di una definizione ostensiva
prelinguistica
Si può definire ostensivamente il nome di una persona, il nome di un
colore, di una sostanza, di un numero, il nome di un punto cardinale,
ecc. La definizione del numero due: «Questo si chiama ‘due’» – e così
dicendo si indicano due noci – è perfettamente esatta. – Ma come è
possibile definire il due in questo modo? Colui al quale si dà la
definizione non sa che cosa si voglia denominare con «due»; supporrà
che tu denomini questo gruppo di noci! – Può supporlo; ma forse non
lo suppone. Al contrario, se voglio attribuire un nome a questo gruppo
di noci, l’altro potrebbe anche scambiarlo per un numerale. E allo
stesso modo colui al quale do una definizione ostensiva del nome di
una persona potrebbe interpretarlo come il nome di un colore, come la
designazione di una razza o addirittura come il nome di un punto
cardinale. Ciò vuol dire che la definizione ostensiva può in ogni caso
essere interpretata in questo e in altri modi (L. Wittgenstein, Ricerche
filosofiche, op. cit., § 28).
La triade incorente di Sellars
«X esperisce il contenuto sensoriale rosso»
implica «X conosce in modo non
inferenziale che s è rosso». B. La capacità
di esperire dati sensoriali non è acquisita.
C. La capacità di conoscere fatti dalla
forma x è φ è acquisita. A e B insieme
implicano non C; B e C implicano non A; A
e C implicano non B (ivi, p. 9).
La soluzione di Sellars: se si abbandona A, l’esperire contenuti sensoriali diventa un
fatto non cognitivo, un fatto che può anche costituire, in realtà una condizione
necessaria, persino logicamente necessaria, della conoscenza non inferenziale, ma
che rimane pur sempre un fatto che non può costituire questa conoscenza . La tesi A
è per Sellars la tesi che esprime il mito del dato. Negarla vuol dire allora negare che
sia lecito muovere dai dati sensoriali per leggerli alla luce della loro controparte
conoscitiva e questo significa insieme distinguere nel concetto di dato sensoriale
due piani interamente diversi – da un lato il piano della percezione come
accadimento naturale che si situa nello spazio logico delle cause, dall’altro il piano
dei giudizi di esperienza che si situano sul terreno dello spazio logico delle ragioni.
Il concetto di dato sensoriale ci appare così come il frutto di un nothos logos da cui
occorre prendere apertamente le distanze: “1. L’idea che certi episodi interiori – ad
esempio sensazioni di rosso o di do # – si presentano negli esseri umani (e nei bruti)
senza presupporre alcun processo di apprendimento o di formazione di concetti, e
che questi episodi siano tali che, in loro assenza, sarebbe in un certo senso
impossibile vedere ad esempio che la superficie esterna di un oggetto fisico è rossa
e triangolare, o udire ad esempio che un certo suono fisico è un do #. 2. L’idea che
certi episodi interiori siano le conoscenze non inferenziali del fatto che certi
elementi sono, ad esempio, rossi o do #, insieme all’idea che essi rappresentino le
condizioni necessarie della conoscenza empirica per il fatto di fornire la base
evidenziale a tutte le altre proposizioni empiriche” (ivi, p. 10).
Al fallimento del mito del dato fa eco l’ipotesi del coerentismo, come posizione
che ci invita a prendere definitivamente commiato dall’empirismo e a sostenere
che non è possibile alcuna giustificazione razionale dei nostri giochi linguistici. Il
linguaggio come insieme dei giochi linguistici è coerente e ogni singola mossa è
giustificata, come in una partita a scacchi, da altre mosse, ma non c’è un
ancoramento razionale che ci consenta di dire che il nostro pensiero parla del
mondo.
Si parla di coerentismo per alludere a quella posizione filosofica che ritiene che il
problema della verità non possa che giocarsi sul terreno della coerenza interna
delle nostre opinioni, che non possono essere giustificate dall’essere così del
mondo. Disponiamo le nostre proposizioni e le raccordiamo al mondo solo in un
senso minimale – nel senso che i nostri pensieri ci servono per muoverci in
questo nostro mondo; che ne parlino davvero, tuttavia, è qualcosa che non
sembra possibile affermare. E ciò è quanto dire che nell’ipotesi del coerentismo il
pensiero è davvero molto simile ad una partita a scacchi in cui ogni mossa ha una
giustificazione interna alla scacchiera e una finalità esterna ad essa – vincere la
partita.
Di qui il problema di McDowell:
“le ragioni […] per l’abbandono dell’empirismo consistono, schematicamente,
nella tesi che non possiamo assumere una rilevanza epistemologica
dell’esperienza senza cadere nel Mito del Dato, nel quale si suppone che
l’esperienza, concepita in modo da non poter valere come tribunale, si ponga
nondimeno come giudice nei confronti del pensiero empirico. Certamente,
questo argomento ha la forma adatta per mostrare che dobbiamo rinunciare
all’empirismo. Il guaio è che non mostra come possiamo farlo. Non fa nulla per
rendere ragione della plausibilità della concezione empirista, secondo la quale
possiamo dare un senso alla direzionalità verso il mondo del pensiero empirico
solo se lo concepiamo come responsabile della sua correttezza nei confronti del
mondo empirico, e possiamo comprendere la responsabilità nei confronti del
mondo empirico solo in quanto mediata dalla responsabilità nei confronti del
tribunale dell’esperienza, concepita nei termini degli impatti diretti del mondo
sugli esseri che possiedono capacità percettive. Se ci limitiamo alle posizioni
prese in esame […] le attrattive dell’empirismo non portano che all’incoerenza
del Mito del Dato. Ma finché non viene data una ragione delle attrattive
dell’empirismo, questo fatto è solo fonte di un perdurante disagio filosofico, non
una ragione che ci alletti ad abbandonare l’empirismo” (ivi, p. XVIII).
Una soluzione kantiana: il duplice fungere della ragione. La
nostra esperienza percettiva è già permeata dalla
dimensione del concetto e la presenza della spontaneità
nell’esperienza è tale da non essere separabile dalla
sensazione stessa. Il contributo che la sensibilità dà alla
conoscenza non può essere nemmeno astrattamente
disgiungibile dalla dimensione concettuale – dice McDowell
e ciò equivale a sostenere che l’esperienza è attraversata da
parte a parte dai concetti.
Questa richiesta non è avanzata dal rifiuto del mito del dato,
ma dalla necessità di pensare all’esperienza percettiva come
una voce nello spazio logico delle ragioni. Non come un
accadimento, ma come una ragione che può giustificare il
nostro credere così.
Una domanda importante:
se il contributo che la sensibilità dà alla conoscenza non può essere
nemmeno astrattamente disgiungibile dalla dimensione concettuale , se
ogni esperienza percettiva è già subordinata alla norma del concetto, non
stiamo forse cancellando semplicemente la differenza tra spontaneità e
recettività? Che cosa differenzia l’esperienza sensibile nella sua apparente
passività dalla libertà che caratterizza la spontaneità del pensiero?
A questa domanda si deve cercare di dare una risposta perché la sensatezza
delle considerazioni che abbiamo proposto poggia comunque sul fatto che
spontaneità e recettività non siano la stessa cosa e operino anzi in modi
differenti. La sensibilità ci ancora al dato, la dimensione concettuale lo
illumina: il nodo che li stringe deve essere indissolubile, ma non può
cancellare la specificità delle loro funzioni
La soluzione che McDowell ci propone: il duplice fungere del
concetto e la passività dell’esperienza concettualmente intesa.
“Ho detto che, quando godiamo di un’esperienza, le capacità concettuali sono
già utilizzate nella ricettività, non esercitate su materiali della ricettività che si
suppongono antecedenti. E con ciò non voglio dire che vengano esercitate su
qualcos’altro. Suona del tutto stonato, in questo caso, parlare di esercizio
delle capacità concettuali. Farebbe pensare a un’attività, laddove l’esperienza
è passiva. Nell’esperienza ci si ritrova gravati di un contenuto. Le proprie
capacità concettuali sono già state messe in gioco, nel rendersi disponibile del
contenuto, prima che si abbia una qualunque scelta in materia. Il contenuto
non è qualcosa che si costruisce di propria iniziativa, come quando si decide
che cosa dire a proposito di qualcosa. In effetti è proprio perché l’esperienza è
passiva, un caso di ricettività in atto, che la concezione dell’esperienza che sto
suggerendo può soddisfare il desiderio di un limite alla libertà – di quel limite
che è all’origine del Mito del Dato” (ivi, p. 11).
Una soluzione, in senso ampio, kantiano
“la stessa funzione, che dà unità alle diverse rappresentazioni in un
giudizio, dà dunque unità anche alla semplice sintesi delle diverse
rappresentazioni in un’intuizione” (I. Kant, Critica della ragion pura,
op. cit., p. 95)
Kant ritiene che si possa parlare di un duplice fungere della ragione
e distingue per questo una logica formale da una logica
trascendentale, anche se poi ci invita a dedurre l’una dall’altra,
dimostrando così implicitamente che ciò che agisce sul terreno
del’esperienza, formandola nella modalità del giudizio, non è un
pregiudizio oscuro e infondato, ma è la razionalità stessa.
Il problema di Kant e la sua eco in Mente e mondo: come
possiamo dire che l’esperienza è formata da concetti se i concetti
non sono applicati all’esperienza?
Cogliamo il carattere concettuale dell’esperienza solo perché
possiamo disporla sullo sfondo del suo interagire con il pensiero
come libero esercizio delle nostre capacità intellettuali:
“In maniera del tutto generale, le capacità coinvolte
nell’esperienza sono riconoscibili come concettuali solo sullo
sfondo del fatto che chi le possiede è sensibile alle relazioni
razionali che collegano i contenuti dei giudizi d’esperienza con
altri contenuti giudicabili. Questi collegamenti danno ai concetti il
loro posto come elementi di possibili visioni del mondo”
(J. McDowell, Mente e mondo, op. cit., p. 12).
“Le capacità concettuali poste passivamente in gioco nell’esperienza
appartengono a una rete di capacità volte al pensiero attivo, una rete che
governa razionalmente le reazioni agli impatti del mondo sulla sensibilità tese
alla comprensione. Ed è parte dell’idea che l’intelletto è una facoltà della
spontaneità – che le capacità concettuali sono capacità il cui esercizio avviene
nel dominio della libertà responsabile – quella che la rete, nella forma in cui
determina a un certo momento il pensiero del singolo soggetto, non è
intangibile. Il pensiero empirico attivo si svolge sotto l’obbligo costante di
riflettere sulle credenziali dei collegamenti, presunti razionali, che lo governano.
Deve esserci una determinazione costante a rimodellare concetti e concezioni,
quando la riflessione ce lo richiede. Certo, non esiste davvero la prospettiva che
ci si possa trovare a dover rimodellare i concetti ai bordi estremi del sistema, i
concetti più immediatamente osservativi, in risposta a pressioni provenienti
dall’interno del sistema. Ma questa prospettiva, indubbiamente irreale, serve a
evidenziare quello che è il punto rilevante per il mio scopo attuale. Il punto è
questo: benché l’esperienza di per sé non si adatti bene all’idea di spontaneità,
anche i concetti più immediatamente osservativi sono parzialmente costituiti dal
loro ruolo in qualcosa che è, esso sì, appropriatamente concepito in termini di
spontaneità” (ivi, p. 13).
Insomma: il carattere concettuale dell’esperienza si manifesta nel
fatto che l’esperienza funga da un lato come una voce che sembra
fondare le nostre credenze, dall’altro come un parere che sembra
possibile rivedere e discutere alla luce di altre voci. L’esperienza
percettiva dice la sua nello spazio logico delle ragioni e se così
stanno le cose, allora deve avere forma concettuale. Il fondamento
della tesi secondo la quale il concettuale è senza confini è dunque
nella constatazione che vi è un’appartenenza della dimensione
percettiva allo spazio logico delle ragioni – quell’appartenenza che
è chiamata in causa sia dal concetto stesso di un tribunale
dell’esperienza, sia dalla possibilità del sapere di retroagire, sia
pure in misura minimale, sul come della nostra esperienza
percettiva.
Si può, in altri termini, imparare a vedere e imparare a vedere
meglio.
Alcune domande rimaste aperte:
1. La posizione di McDowell implica l’idealismo
2. L’affermazione secondo la quale il concettuale è senza
confini è fenomenologicamente proponibile?
3. Che dire del concetto di seconda natura di cui McDowell ci
parla?
4. Si può sostenere che vi è una cesura così netta tra gli
animali e l’uomo o questa tesi è semplicemente l’eco di un
specismo teoricamente dubbio ed eticamente discutibile?