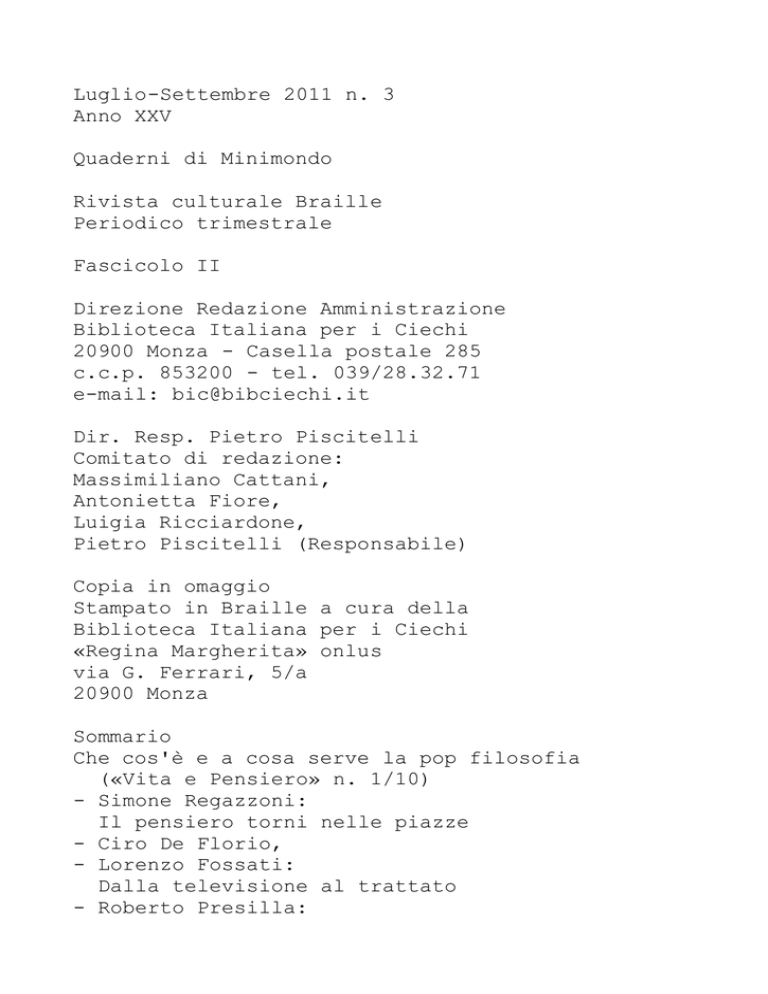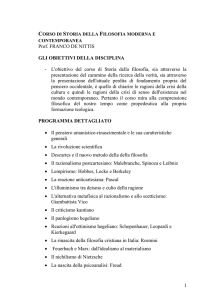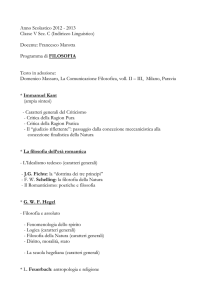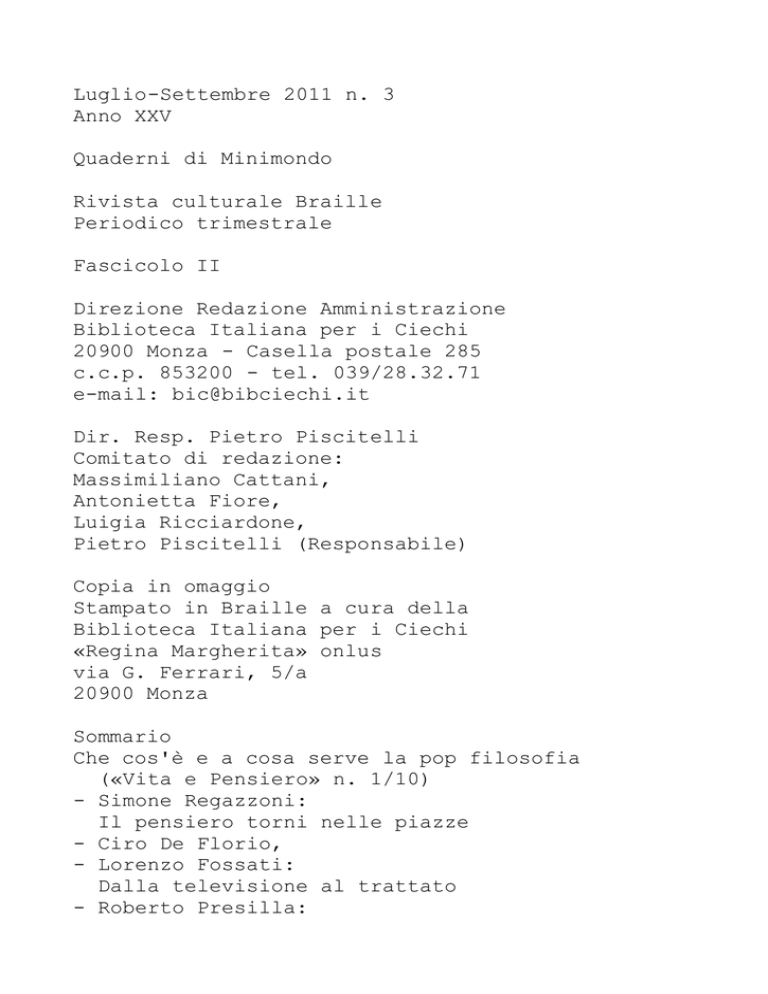
Luglio-Settembre 2011 n. 3
Anno XXV
Quaderni di Minimondo
Rivista culturale Braille
Periodico trimestrale
Fascicolo II
Direzione Redazione Amministrazione
Biblioteca Italiana per i Ciechi
20900 Monza - Casella postale 285
c.c.p. 853200 - tel. 039/28.32.71
e-mail: [email protected]
Dir. Resp. Pietro Piscitelli
Comitato di redazione:
Massimiliano Cattani,
Antonietta Fiore,
Luigia Ricciardone,
Pietro Piscitelli (Responsabile)
Copia in omaggio
Stampato in Braille a cura della
Biblioteca Italiana per i Ciechi
«Regina Margherita» onlus
via G. Ferrari, 5/a
20900 Monza
Sommario
Che cos'è e a cosa serve la pop filosofia
(«Vita e Pensiero» n. 1/10)
- Simone Regazzoni:
Il pensiero torni nelle piazze
- Ciro De Florio,
- Lorenzo Fossati:
Dalla televisione al trattato
- Roberto Presilla:
Filosofia e cultura popolare
Ignacio Provencio:
La funzione nascosta della retina
(«Le Scienze» n. 515/11)
David M. Nicol:
Se l'hacker spegne la luce
(«Le Scienze» n. 517/11)
Jolanda Stevani:
Addio principe azzurro?
(«Psicologia contemporanea» n. 214/09)
Che cos'è e a cosa serve la «pop filosofia»
- Recentemente emerso anche in Italia, un nuovo
approccio teorico rielabora il rapporto tra
filosofia e cultura di massa. Da Aristotele a
Lost, da Hegel a Matrix, opportunità (e azzardi)
di una prospettiva accademicamente «eccentrica». Il pensiero torni nelle piazze
Negli ultimi anni, si è diffusa anche in Italia
una forma di filosofia che, sulla scia della
definizione anglo-americana e di una suggestione
deleuziana, è stata ribattezzata pop filosofia.
Difficile, se non impossibile, tentare di darne
una rigorosa definizione. Il fenomeno della pop
filosofia, in costante crescita, non ha articolato
fino a oggi, nelle sue diverse e spesso disparate
forme, una seria riflessione attorno al proprio
statuto filosofico - se si escludono prefazioni ad
alcuni testi di pop filosofia, interviste agli
autori sul tema e pochi altri momenti in cui si è
cominciato a tracciare il profilo di un discorso
teorico circa un nuovo e auspicabile rapporto tra
filosofia e popular culture.
E tuttavia, visto l'interesse sempre più ampio
suscitato dalla pop filosofia in Italia, i tempi
sembrano maturi per tracciare una mappa
provvisoria del fenomeno e tentare di articolare
alcune considerazioni preliminarissime che possano
fornire un contributo a un dibattito ormai aperto,
fuori e dentro l'accademia, attorno alla pop
filosofia. Un dibattito che non è né marginale né
secondario per la filosofia stessa: riflettere
oggi sulla pop filosofia significa infatti, più in
generale, riflettere su che cosa significhi fare
filosofia nel XXI secolo.
È doveroso, prima di entrare nel merito della
questione, precisare che chi scrive non è
semplicemente un osservatore esterno del fenomeno
della pop filosofia. Ho scritto in questi anni,
accanto a testi accademici, testi filosofici
dedicati a fenomeni della pop culture; ho preso
parte al dibattito attorno alla pop filosofia su
quotidiani, riviste e siti come Rescogitans; ho
inoltre partecipato a incontri pubblici sul tema
insieme ad altri filosofi italiani. Da ultimo,
poiché credo vi sia l'esigenza di ancorare questo
significante vuoto, «pop filosofia», a un preciso
significato filosofico, ho curato un volume di
contributi internazionali di giovani filosofi e
scrittori che si intitola precisamente Pop
filosofia. Il mio sguardo e le mie osservazioni
sono dunque quelle di un osservatore partecipe con
un'idea ben precisa di pop filosofia.
Proviamo, in sintesi, a ripercorrere l'avventura
editoriale italiana della pop filosofia.
Tra il 2005 e il 2006 vengono tradotti Pillole
rosse. Matrix e la filosofia (curato,
nell'edizione italiana, da Vincenzo Cicero) e I
Simpson e la filosofia. Si tratta di volumi che
raccolgono saggi di differenti autori,
principalmente di indirizzo analitico, che
affrontano con rigore, ma in forma divulgativa, i
vari aspetti (estetici, etici, politici,
epistemologici) di due grandi fenomeni della
cultura pop: Matrix, il film dei fratelli
Wachowski, e la sitcom animata I Simpson. Nel 2006
Umberto Curi pubblica il volume Un filosofo al
cinema in cui, accanto a film considerati
«d'autore», vengono analizzati, in forma non
accademica, film come Minority Report (nel 2000 lo
stesso Curi aveva pubblicato un libro su cinema e
filosofia, Lo schermo del pensiero, in cui
venivano prese in esame in modo originale opere
come Titanic o Nove settimane e mezzo). Nel 2007
un gruppo di giovani filosofi, tra cui il
sottoscritto, pubblica La filosofia del Dr. House,
testo che affronta gli aspetti etici, logici ed
epistemologici di una serie tv di successo, Dr.
House, mescolando assieme prospettive analitiche e
continentali. Sempre nel 2007 viene tradotto Woody
Allen e la filosofia. Tra il 2008 e il 2009
vengono pubblicati: Harry Potter e la filosofia.
Fenomenologia di un mito pop; Metallica e la
filosofia. Libertà, autenticità, etica; La
filosofia di Lost. Philosophy fiction; South Park
e la filosofia; Cinefilosofia. I grandi filosofi
spiegati attraverso il cinema; Piangere e ridere
davvero. Feuilleton; Tormentoni! La filosofia nel
juke-box; da ultimo, Stramaledettamente logico.
Esercizi di filosofia su pellicola.
Il catalogo provvisorio è questo. Si possono
forse aggiungere alcuni testi (ad esempio, alcune
opere di Slavoj Zizek, da molti definito «pop
filosofo») o escluderne altri. Ma il quadro di
insieme non risulterebbe mutato nell'essenziale.
Che cos'hanno in comune tutte queste opere che
spesso, guardate più da vicino, si rivelano
diversissime per impostazione, metodo e intenti (e
anche qualità)? Almeno due caratteristiche: tutte
chiamano in causa, in qualche modo, la popular
culture; tutte si rivolgono a un pubblico di
massa. Detto altrimenti: pop filosofia si dice in
molti modi, ma questi molteplici modi condividono
due esigenze strettamente legate. La prima è
quella di intraprendere un confronto critico con
la cultura di massa o pop. La seconda è quella di
uscire dallo spazio accademico per rivolgersi a un
pubblico di massa. Il termine «pop», in «pop
filosofia», indica dunque sia l'oggetto cui questa
forma di filosofia si applica, sia, per una sorta
di contaminazione, la forma stessa di questa
filosofia che sarà quindi popular.
La pop filosofia, in questo senso, non è antiaccademica ma extraaccademica: si prefigge, per
usare una formula gramsciana, di socializzare
delle verità. Questo non significa tuttavia che
essa non possa o non debba trovare spazio anche
nell'accademia, dove per altro circola già in
differenti forme. Benché la filosofia della
cultura di massa o pop non esista ancora come
disciplina accademica, si può dire che esiste
anche nell'accademia italiana una filosofia
attenta alla cultura di massa o pop. È indubbio
che la pop filosofia, almeno in alcune sue
declinazioni, esprima le esigenze condensate nel
termine «pop» - occuparsi di cultura di massa e
rivolgersi a un pubblico di massa - in modo ancora
filosoficamente informe e, a tratti, ingenuo.
Tuttavia, il fatto stesso che vi siano opere di
pop filosofia e che si sia cominciato a riflettere
su di esse è il sintomo che una certa chiusura
filosofica di fronte alla cultura di massa e al
pubblico di massa comincia a essere forzata, e che
quella che Stanley Cavell chiamava
«democratizzazione della filosofia» è in corso.
Qualcuno potrebbe obiettare che la qualità
filosofica delle opere di pop filosofia non sempre
è altissima - e che dunque la pop filosofia
rischia di essere una banalizzazione della
filosofia. In realtà quest'obiezione non tiene
conto di un dato essenziale: e cioè che un
giudizio analogo potrebbe essere formulato anche
per la produzione accademica. La qualità o meno
dei testi filosofici che si occupano di cultura
pop è una questione che deve essere discussa nel
merito, caso per caso, e non attraverso
generalizzazioni che rischiano solo di essere
semplificazioni e che, al fondo, esprimono
semplicemente un vecchio pregiudizio verso la
cultura di massa considerata «cultura bassa»,
oggetto indegno di attenzione filosofica. La pop
filosofia opera precisamente a partire dalla
critica radicale di questo pregiudizio. Non si
tratta di dire, per riprendere le parole di
Fredric Jameson, «che sarebbe preferibile avere a
che fare con i programmi della televisione, Il
padrino o Lo squalo, piuttosto che con Wallace
Stevens o Henry James» - posizione teoricamente
debole, giustamente criticata da Jameson come
forma populista di anti-intellettualismo di cui
non si sente certo il bisogno. Si tratta, invece,
di aprire un nuovo fronte filosofico in grado di
misurarsi anche con le opere di cultura pop, che
spesso non hanno nulla da invidiare alle presunte
opere di «cultura alta».
Oggi, se un filosofo scrive, ad esempio, su Jeff
Koons, Damien Hirst o altri personaggi che calcano
la scena dell'arte contemporanea, non vengono
sollevate obiezioni. Ma si storce il naso e si
evoca il rischio di una banalizzazione della
filosofia se un filosofo scrive saggi sulle nuove
serie tv americane. Nessuno naturalmente - né i
filosofi né tantomeno i critici che si occupano di
arte contemporanea - può dimostrare che la qualità
estetica dell'arte contemporanea sia superiore a
quella delle serie tv americane, mentre il
contrario non sarebbe difficile. Ora, se c'è un
merito che deve essere riconosciuto alla pop
filosofia, è proprio quello di aver contribuito a
decostruire tutta una serie di pregiudizi estetici
e di aver cercato, nello spazio vasto e
ricchissimo della cultura pop, nuovi oggetti con
cui confrontarsi; abbandonando, ad esempio, le
suggestioni dei critici d'arte contemporanea per
seguire le preziose indicazioni che venivano da
discipline snobbate dalla filosofia accademica. È
il caso della critica televisiva: per quanto mi
riguarda, posso dire che la mia attenzione verso
le serie tv americane e la decisione di scrivere
su di esse (prima Dr. House e poi Lost) è stata
influenzata da studiosi della tv come Aldo Grasso,
che hanno rappresentato un ottimo antidoto ai
pregiudizi filosofici contro la cattiva maestra
televisione.
All'interno di questo quadro generale, tentare
di definire in modo più preciso che cosa sia la
pop filosofia significa inevitabilmente proporre
una propria definizione di pop filosofia. Ed è
quel che farò. Per parte mia, concepisco la pop
filosofia non solo come una forma di filosofia che
si occupa di cultura di massa, ma, più
precisamente, come una forma inedita di
decostruzione inscritta nel campo della cultura
pop. Su questo punto penso infatti che abbia
ragione Mark C. Taylor quando rimprovera a
Foucault e Derrida di aver trascurato la cultura
di massa. Non confrontarsi, oggi, con la cultura
di massa, lasciando che siano altre discipline a
occuparsene, significa, per la filosofia,
trascurare un fattore fondamentale non tanto della
costituzione dell'immaginario collettivo, bensì di
quel sistema ad alta complessità che è la realtà
stessa, nella misura in cui la fiction della
cultura pop è oggi parte essenziale di questo
sistema. Non esiste un solo mondo, una sola realtà
in cui la cultura di massa circolerebbe. Esiste
una molteplicità aperta di mondi interconnessi
alla cui produzione, e al cui conflitto - ecco in
che cosa consiste la guerra dei mondi partecipano, essenzialmente, i fantasmi della
cultura di massa. La filosofia si trova immersa in
questi mondi in cui realtà e fiction sono
indissolubilmente intrecciate. E deve prendere
parte alla loro trasformazione. La pop filosofia è
un'agente di questa trasformazione.
Ciò non significa semplicemente applicare un
qualche metodo filosofico - nel mio caso la
decostruzione - alla cultura di massa, bensì
inscrivere in modo inedito, e usando tutte le
risorse filosofiche, la decostruzione nello spazio
della cultura di massa. Ma che cosa significa
«usare tutte le risorse filosofiche»? Significa
ricordarsi che non appena si esce dallo spazio
dell'accademia (in cui la forma di scrittura
privilegiata e accettata resta il saggio) la
filosofia può far ricorso - come ha sempre fatto
nella sua storia, fin dall'origine - a differenti
generi di scrittura.
Pop filosofia, dunque, come decostruzione
immersa nel campo della cultura di massa che,
utilizzando tutte le risorse filosofiche, si
protende verso il fuori. Nulla a che vedere con il
«pensiero del di fuori» di cui parlava Foucault.
Qui il fuori è quello che per Aristotele era
l'essoterico: ciò che è fuori inteso come ciò che
è pubblico. Ripresa e trasformazione di una
strategia vecchia quanto la filosofia stessa: la
pop filosofia è anche un ripensamento del momento
essoterico della filosofia.
Come ricordava recentemente Sloterdijk: «Non
dobbiamo essere titubanti nel pensare oltre i
confini dell'attività accademica. La crisi
complessiva dei nostri giorni dovrebbe spingere la
filosofia che si è rinchiusa nel grembo delle
università ad abbandonare il suo nascondiglio.
Dobbiamo tornare nelle piazze e nelle strade,
dobbiamo ricomparire sulle pages littéraires e
sugli schermi, nelle scuole e nei festival
popolari per restituire al nostro mestiere, il più
gaio e il più malinconico del mondo, l'importanza
che gli è dovuta anche nella vita non accademica.
Gli uomini chiedono in modo così pressante che
cos'è la vita buona e cosciente. Chi crede di
sapere la risposta o vuole rispondere con un'altra
domanda deve ora farsi avanti e parlare».
Simone Regazzoni
Dalla televisione al trattato
Cosa c'entrano con la filosofia un cantante come
Johnny Cash, una band come i Metallica, una moto
come l'Harley Davidson, un fenomeno sociale come
Facebook, un regista pulp come Quentin Tarantino,
un inseparabile «compagno di strada» come l'iPod,
un gioco d'azzardo come il poker, uno sport come
il baseball, un serial di culto come I Soprano o
la grande saga de Il Signore degli anelli... solo
per citare alla rinfusa dal catalogo della serie
«Popular Culture and Philosophy» della prestigiosa
Open Court Publishing Company di Chicago,
Illinois?
Semplificando e radicalizzando, le possibili
risposte sono due: da un lato quella del
famigerato «cattedratico», che disdegna ogni
apparentamento con ambiti dell'umano estrinseci
alla sua titolarità, men che meno con forme
considerate basse o deteriori della cultura
(celebre in tal senso l'intervento di John Searle
che, in Occidente e multiculturalismo,
sottolineava con veemenza come non sia la stessa
cosa lo studio di Shakespeare e quello dei
fumetti); dall'altro il sincretico e democratico
«pasticcione», che ritiene al contrario che si dia
autentica cultura solo nella commistione e nella
contaminazione di discorsi disparati, in un ideale
melting pot di idee, concetti e pratiche. Al di là
della drammatizzazione del contrasto, il punto
interessante resta il fatto di un'esigenza o di un
interesse filosofico diffuso, che si esprime nei
titoli della collana citata e nelle altre
pubblicazioni di quella variegata costellazione
nota come pop philosophy.
Il nocciolo della questione sembra essere
l'alternativa tra due differenti idee di
filosofia: per la prima queste occasioni (Lost,
Star Trek o Woody Allen) si colgono per divulgare
dei contenuti, e quindi si assume che la filosofia
sia una disciplina specifica, con propri problemi
e soprattutto con un proprio metodo; per la
seconda la filosofia è una delle narrazioni
possibili, ed è posta sullo stesso piano di altre
narrazioni come loro estensione, prolungamento o
sottoinsieme (semplicemente un po') più
sofisticato. Del resto già Platone utilizzava i
miti e le narrazioni sia per esemplificare le sue
tesi, sia per prospettare quelle soluzioni cui la
sola ragione non avrebbe altrimenti attinto, e
privilegiare un movimento a scapito dell'altro
pregiudicherebbe la comprensione dei suoi intenti.
Oggi, tuttavia, mentre è chiaro quando il medico
o lo scienziato fanno divulgazione, cercando di
spiegare ai non specialisti i risultati della loro
ricerca o i termini di un problema specifico, è
meno chiaro quello che il filosofo sta facendo,
forse perché non è sempre chiaro neppure a lui: il
film, la fiction, il pubblico dibattito sono
l'occasione e il pretesto per comunicare, per
avviare «la filosofia» vera e propria, oppure
coincidono effettivamente con essa? In
quest'ultimo caso, infatti, «filosofica» sarebbe
una pratica o una narrazione più o meno
caratterizzata, ma comunque indistinguibile
dall'occasione in cui appunto viene esercitata e
non comunicata. Mentre è insomma chiaro ne La
fisica di Star Trek o ne La fisica dei supereroi
quale sia la parte narrativa e quale quella
scientifica (il Dottor Spock non è il Professor
Bohr, Clark Kent non è Ludwig Boltzmann), nei vari
titoli su La filosofia e... il confine è sempre
tracciato o addirittura tracciabile?
A ben vedere, non tracciare tale confine non
significa lasciare impregiudicato il discorso, ma
al contrario evidenzia una scelta teorica precisa
(ancorché non sempre consapevole) da parte
dell'autore, che tende appunto a concepire la
filosofia non come una scienza rigorosa, ma come
l'espressione di una visione del mondo, secondo
una versione rinnovata del contrasto tra Husserl e
Dilthey.
Dopo l'immortale scena di Io e Annie, in cui
Woody Allen in fila al cinema sbugiarda un
fanfarone che strologa su McLuhan chiamando a
testimone proprio lui, che stava appostato dietro
un cartellone pubblicitario, è sempre difficile
citare (o ancor più criticare) lo slogan per cui
il mezzo è il messaggio; tuttavia sembra a questo
punto indispensabile distinguere tra l'approccio
a, il discorso su o il rapporto con qualcosa dal
qualcosa stesso, cioè dall'oggetto cui ci stiamo
riferendo. Nel caso della filosofia, essa si
occupa di tutto, sia nel senso che si occupa
tradizionalmente della totalità (dei principi
supremi o dei fondamenti ultimi della realtà o del
pensiero), sia nel senso che può occuparsi di ogni
cosa, cioè ogni cosa è passibile di un'indagine
filosofica (dalla religione all'arte, dalla
scienza ai supereroi). Certamente ogni uomo si
interroga sulla vita, l'universo e tutto quanto, e
se qualcuno cerca od offre la sua soluzione con la
filosofia, altri lo fanno scrivendo poesie o
romanzi, o ancora girando fiction: magari riescono
anzi più efficacemente nell'impresa, ma non per
questo stanno tutti facendo la stessa cosa (e in
ogni caso, come sa chi ha letto Douglas Adams, la
risposta è 42).
Quale sarebbe allora lo specifico della
filosofia, che sembra negato o assai
ridimensionato da alcuni «pop» filosofi? La
filosofia guarda al mondo da una prospettiva
universale, cercando di coglierne gli aspetti
strutturali al di là delle differenze specifiche,
che sono al contrario essenziali
nell'articolazione dei vari saperi umani. Nel caso
di Lost, per esempio, il filosofo non si concentra
sul personaggio di Sayid per come è interpretato
dall'attore, per l'efficacia delle battute che gli
sono assegnate, per la complessità
dell'introspezione psicologica, per la sua
funzione nella vicenda; in una parola, non lo
considera narrativamente, ma come archetipo o
ideal-tipo, per quanto cioè incarna di universale,
nella misura in cui ci permette come mezzo di
considerare l'idea che rappresenta. Evidentemente
tutte le questioni non considerate dalla filosofia
sono tutt'altro che secondarie, e sono anzi quelle
più pertinenti a una narrazione televisiva, ma in
quanto tali non sono filosofiche, perché sono
appunto particolari, legate a un ambito specifico,
mentre la vocazione intrinseca della filosofia è
precisamente quella di prescindere da ogni
caratterizzazione individuale (seguendo la linea
tracciata da Aristotele nel primo libro della
Metafisica): proprio della filosofia sarebbe
dunque tener conto della ricchezza delle
dimensioni della realtà, dei vari mondi possibili
descritti, colti in quella loro essenza che vale
in quanto irriducibile a un'altra. Sarebbe insomma
probabilmente un pessimo film quello che
pretendesse d'essere «filosofico» e rischierebbe
di rivelarsi pessima filosofia quella che si
volesse «cinematografica».
Se quanto detto finora riguarda quello che
Husserl avrebbe rubricato come relativo all'«atto»
intenzionale, si tratta ora di considerare appunto
l'«oggetto»: posto che si sia distinto, come prima
si diceva, tra il discorso su qualcosa dal
qualcosa stesso, e posto che la filosofia in
quanto tale non abbia un oggetto specifico,
occorre vedere quale sia l'oggetto della pop
philosophy. Ammesso e niente affatto concesso che
resti al giorno d'oggi valida la distinzione tra
cultura alta e cultura bassa, solo apparentemente
la pop philosophy si occupa di cultura pop: essa
la utilizza in realtà come mezzo, come strumento,
per cogliere i temi affrontati dalla cultura pop.
La usa insomma come lente di ingrandimento, come
periscopio o torcia per cogliere indirettamente
quelle realtà che la tradizione filosofica ha
invece tematizzato direttamente. Viceversa, la
narrazione in quanto tale è oggetto di altre,
differenti indagini, quali la teoria della
narrazione, la critica letteraria, musicale,
cinematografica, teatrale, televisiva... che
presuppongono competenze tecniche specifiche che
il filosofo può solo malamente e
approssimativamente imitare. La pop philosophy non
guarderà, per esempio, all'evoluzione di Batman
dalla «Golden Age» al Dark Knight di Frank Miller,
alla diffusione della pubblicazione o all'impatto
del personaggio sull'immaginario collettivo
statunitense, quanto piuttosto all'abisso
interiore che provoca vertigine in lui e nel
lettore, alle conseguenze del trauma che lo ha
generato, alle implicazioni morali del desiderio
di vendetta e riscatto, al tema della sua doppia
personalità; punterà cioè lo sguardo su quanto di
universale e - appunto - filosofico la sua lettura
ci permette di cogliere.
Con questo abbiamo concesso quel che andava
concesso al «parruccone» menzionato in apertura;
ma non è necessario concedergli altro, perché
forse è lui stesso una delle cause del presunto
male che condanna. Ci si potrebbe infatti
soffermare più attentamente sull'intrinseca
difficoltà dei filosofi di oggi a condividere il
proprio sapere con il non specialista, in base a
idiosincrasie caratteristiche e speculari: quelli
di impronta «analitica» sembrano quasi vittime di
un tecnicismo che rende incomunicabile (se non
francamente trascurabile) il loro lavoro per
l'uomo comune, quelli «ermeneutici» o
«postmoderni» peccherebbero di una gergalità non
meno ostica, di primo acchito forse più seducente
ed evocativa, ma certo non in grado di presentare
la filosofia come qualcosa di utile o
significativo. In entrambi i casi la filosofia si
presenta come qualcosa di «esoterico» o
«iniziatico», ma sempre e comunque in modo diverso
da come potrebbero farlo le altre scienze: mentre
di queste, infatti, si percepisce l'utilità e la
consistenza, e la propria incomprensione è vissuta
come un'inadeguatezza (più o meno colpevole), la
filosofia rischia invece di confermare un'immagine
di sé come inutile fumisteria, incompresa perché
incomprensibile.
Se insomma nei confronti della filosofia si
nutrono aspettative che la filosofia attuale, in
modi diversi, finisce con il deludere, e se è pur
vero che l'unico rimedio alle delusioni è il non
nutrire aspettative, è anche vero che le
aspettative nei confronti della filosofia
potrebbero essere legittime e, dunque, che
disattenderle potrebbe essere la colpa della
filosofia attuale. Mentre la cultura pop,
americana ma non solo, dai fumetti alle serie tv,
ha l'innegabile merito di riuscire a esprimere
concetti e contenuti rilevanti in modo adeguato
alla sensibilità contemporanea, forse ci troviamo
in una fase della filosofia che Franz Brentano
chiamerebbe «decadente», essendo venuto meno un
interesse vivo e puramente teorico. Andando allora
alla ricerca di precedenti, potremmo trovarne nel
Settecento tedesco in cui fiorì una
Popularphilosophie (che a causa della finitezza
del proprio contenuto, secondo Hegel, sarebbe
stata costretta a cercare all'esterno i propri
motivi), o nel periodo tra la fine dell'Ottocento
e la Prima guerra mondiale in cui operò Georg
Simmel (che filosoficamente si occupò della moda,
del denaro, della metropoli e della cultura in
genere). Se queste analogie sono pertinenti, ci
troveremmo allora in un periodo di trasformazione
e di passaggio, perché è in questi casi che la
filosofia si è spesso, se non sempre, fatta «pop».
Da questo punto di vista la pop philosophy
risponde a un'esigenza e a un bisogno condivisi e
oggettivi: smarcandosi tanto dagli strali di
Searle quanto da superficiali e postmoderni
cultural studies, il suo specifico potrebbe essere
una sorta di terza via che aiuti a comprendere
quella ricchezza e quell'abbondanza dell'essere
che, grazie a una lettura un po' eterodossa di
Paul Feyerabend, va conquistata con ogni strumento
e ogni arma disponibili, dalla televisione al
trattato.
Ciro De Florio
Lorenzo Fossati
Filosofia e cultura popolare
Il fenomeno della pop filosofia - dell'incrocio
tra filosofia e cultura popolare - non è nuovo: la
produzione essoterica di Aristotele era famosa,
così come lo erano altri testi e autori. Lo stesso
si può dire per altri periodi e altre figure,
quando a una tradizione più o meno dotta, più o
meno accademica, se ne è affiancata una popolare:
anche se il fenomeno si è ripetuto più volte nella
storia della cultura occidentale, esso non ha
comunque una storia uniforme. Anzi, la filosofia
popolare ha avuto forme assai diverse nel corso
dei secoli, il che presenta una difficoltà: mentre
è relativamente facile stabilire che cosa
appartenga alla tradizione filosofica (i canoni
dei manuali di filosofia sono piuttosto coerenti,
per esempio) non è altrettanto semplice indicare
una tradizione comune per la filosofia diffusa.
Figure e testi della filosofia popolare non sono
ben conservati, non sono passati alla storia come
è successo per testi ovviamente difficili e
sicuramente meno aperti al pubblico.
Persone diverse per estrazione e cultura hanno
nei secoli selezionato dei testi, trasmettendoli
alle generazioni future: lo stesso non è accaduto
per opere che miravano a una diffusione più ampia,
capaci di intercettare motivi e figure della
cultura del momento. Forse chi è innamorato della
tradizione rifiuta, quasi per definizione, la
cultura popolare: la cultura «alta» porta a essere
fuori sincronia con un mondo il cui cuore batte
per le serie tv, per i fumetti o per la musica.
Per non parlare dei videogiochi o dello sport:
sono passioni che sembrano fare a pugni con la
capacità di riflettere sugli umani destini,
sull'esistenza di Dio, sulle domande ultime alle
quali il filosofo dovrebbe dare una risposta per
non perdere la sua presunta utilità sociale. Un
tempo sarà accaduto lo stesso per il gioco del
lotto, la caccia o i giochi del circo: passioni
capaci di accendere l'interesse di molti, e anche
di suscitare riflessioni sulla loro dimensione di
«senso».
Nonostante il loro indubbio interesse per molti,
le opere dedicate a questi aspetti della vita
hanno avuto un successo meno duraturo. Nella
tradizione sono stati invece conservati testi
magari difficili, su cui hanno lavorato diverse
generazioni di studiosi. Leggere la Metafisica di
Aristotele obbliga a confrontarsi con un testo
oggetto di riflessioni sedimentate in una lunga
storia di commenti: anche per questo è un punto di
riferimento per la nostra cultura. Emerge qui
un'ulteriore articolazione della differenza tra i
testi della tradizione «alta» e quelli della
cultura popolare: non solo i primi sono
conservati, ma sono anche oggetto di studio
ripetuto e accurato.
La tradizione «alta» non è insomma tale per un
pregiudizio intellettualistico: anche se
indubbiamente non manca chi ne fa uso in quel
modo, essa è frutto di scelte ripetute, che
riconoscono in essa i vertici di un certo modo di
pensare. Per rendersi conto del perché un testo
sia un «classico», a volte non c'è modo migliore
che leggere i testi coevi che non godono dello
stesso status. Anche se variabile e discutibile,
l'appartenenza alla tradizione parte dalla
percezione di trovarsi di fronte a qualcosa di
eccelso: vale lo stesso per l'arte, quando si
prende in esame la pittura di Michelangelo o la
musica di Bach. Così avviene anche per molte opere
contemporanee: anche alcuni film, dischi di jazz,
fumetti e così via sono considerati dei classici,
mentre altri sono (abbastanza) universalmente
riconosciuti come meno «belli».
Non è detto, insomma, che la tradizione sia in
quanto tale qualcosa di «chiuso»: se Adorno, forte
della sua competenza musicale, aveva un giudizio
negativo sul jazz, questo giudizio può essere
rivisto in nome di una diversa percezione della
bellezza della musica. Anche per la filosofia si
può notare come autori non pienamente apprezzati
in un'epoca godano successivamente di maggior
fortuna: si pensi a Leibniz, la cui opera logica è
stata pienamente apprezzata e rivalutata solo agli
inizi del XX secolo. L'appartenenza alla
«tradizione» implica da una parte il
riconoscimento di un'opera come eccellente,
dall'altra una frequentazione dell'opera stessa
che ne rivela aspetti inediti: per questo si può
continuare a leggere un classico e il classico
rimane attestato nella tradizione.
Le parole che abbiamo usato potrebbero suggerire
che un classico diventi tale in seguito a una
scelta, a un fiat arbitrario, ma non è così: come
ogni processo storico, il consolidamento di una
tradizione implica un laborioso processo di
elaborazione, revisione, approfondimento,
riscrittura. Periodicamente si può rendere
necessaria una sorta di semplificazione, un
riaccostarsi all'opera al di là di quello che la
tradizione ha depositato. Si può addirittura
chiamare in questione il concetto stesso di
tradizione, per una «decostruzione» che
rappresenta la massima espressione critica
riguardo alla tradizione stessa. A volte questa
diventa una necessità generazionale: come scriveva
Guccini, la sua generazione non credeva «in ciò
che spesso han mascherato con la fede, nei miti
eterni della patria o dell'eroe». La decostruzione
teorizzata da Derrida può essere intesa come la
messa in discussione del concetto stesso di
filosofia, con esiti diversi ma accomunati in una
prospettiva analoga. La filosofia diventa un
discorso tra gli altri, che può mescolarsi con
tutto perché in ultima analisi è solo uno stile di
scrittura.
In altre parole un filosofo scrive in un certo
modo, un po' complicato, mentre un pubblicitario
scrive in modo icastico e accattivante: sono solo
generi letterari. E così la filosofia pop e quella
«accademica» sono due generi letterari contigui,
rispetto ai quali ciascun autore può prendere
posizione in base alle scelte che ritiene più
opportune, dato che ogni tentativo di
organizzazione dei contenuti non farà che produrre
altri miti. Questa immagine presenta un quadro
sproporzionato: da una parte si esagera
l'arbitrarietà del classico (solo un mito
collettivo), dall'altra si presume che sia
possibile sfuggire a questa logica mediante la
messa in discussione di ogni mitologia possibile.
Ogni testo classico andrebbe demitizzato per
rivelarne un nocciolo originario, legato
presumibilmente a una forma di repressione
sociale. Ma se tutto è mitologia, la stessa
critica decostruttiva diventa una mitologia
pericolosa, perché nel nome del rifiuto della
repressione sociale finisce per assecondare
l'irresponsabilità, come sostiene Putnam. La
critica della tradizione richiede piuttosto di
usare le risorse a nostra disposizione per provare
a distinguere ciò che è mito da ciò che non lo è,
per mettere ordine nei nostri pensieri.
È qui che emerge una seconda e seria difficoltà
del rapporto tra filosofia pop e filosofia: il
progetto educativo che sta alla base. In effetti
la storia ci permette di cogliere questo dibattito
in una luce del tutto ironica, se lo accostiamo
alla riflessione sulla paideia proposta da Jaeger.
Nel confronto tra Isocrate e Platone si
contrappongono due modi diversi di concepire
l'educazione del giovane ateniese: da una parte,
l'idea di un sapere perfettamente innervato nella
vita pubblica, flessibile quanto ai contenuti ma
costante nella ricerca del successo; dall'altra,
un percorso articolato che mira ad acquisire un
punto di vista critico sulla realtà. La ricerca di
uno stile efficace nell'esprimere le proprie
opinioni si contrappone alla ricerca della verità
tout court: forse non è un caso che la tradizione
consideri Platone un filosofo eminente e Isocrate
invece un retore.
Non si tratta qui di dare un giudizio su quale
sia la disciplina migliore: è chiaro però che per
fare filosofia non basta riflettere sul senso di
una qualsiasi esperienza, ma occorre - per dirla
in modo davvero troppo sbrigativo - partire di lì
per cercare di arrivare alla verità. Una
riflessione filosofica implica quindi una
responsabilità etica precisa: una valutazione
critica del proprio sapere volta a stabilire se
sia vero oppure no, in modo da poter basare su di
esso l'azione libera. In questo gioco può
benissimo darsi che le domande del profano - chi
siamo, dove andiamo, che si mangia a cena... debbano subire una purificazione e una
trasformazione, e che per questo sia necessario
impadronirsi di un linguaggio difficile e di
concetti complessi. Ma, ed è questo il bello, non
c'è nessun obbligo a farlo: si può scegliere di
andare fino in fondo oppure fermarsi non appena si
trova una risposta minimamente plausibile, il che
a volte è la scelta migliore, visto che l'andare
fino in fondo non porta necessariamente a trovare
una risposta soddisfacente.
In questa ricerca si coglie il paradosso
dell'attività filosofica, la cui «utilità» ammesso che ci sia - non dipende dai risultati
pratici, ma dall'attività in sé. Accade lo stesso
per la matematica, i cui confini sono parimenti
nebulosi, tanto che forse la miglior definizione è
la seguente: matematica è ciò che fanno i
matematici. Un matematico fa matematica anche
quando si occupa di biologia o di politica, se
prova a costruire un modello matematico di
qualcosa, altrimenti è solo un uomo con degli
interessi. Un filosofo si può occupare (e forse
dovrebbe occuparsi) anche di ciò che è al di fuori
dell'accademia, ma sempre con lo scopo di far
filosofia: se lo scopo è semplicemente quello di
aggiungere un'opinione tra le altre, un genere
letterario tra gli altri, sta scegliendo la via di
Isocrate e non quella di Platone.
La pop filosofia è insomma filosofia - se la fa
un filosofo che vuole arrivare fino a una verità oppure pop, quell'insieme estremamente variegato e
flessibile di contenuti che Pascal chiamerebbe
divertissement. Si può scegliere di fare l'una o
l'altra cosa, ma non tutte e due insieme.
Roberto Presilla
(«Vita e Pensiero» n. 1/10)
La funzione nascosta della retina
- Il nostro organismo regola il ciclo
giorno/notte grazie a neuroni specializzati che si
trovano negli occhi. Lo studio di queste cellule
potrebbe favorire nuovi interventi contro il jet
lag e altri disturbi. Negli anni venti Clyde E. Keeler, che studiava
per il dottorato ad Harvard, scoprì due fatti
sorprendenti nei topi che allevava nella sua
mansarda. Il primo fu che la progenie era
completamente cieca, e il secondo che, pur essendo
ciechi, le loro pupille conservavano la capacità
di contrarsi in risposta alla luce ambientale,
anche se più lentamente. Molti anni più tardi i
ricercatori hanno ampliato l'osservazione di
Keeler, dimostrando che i topi manipolati
geneticamente per eliminare i coni e i bastoncelli
- i recettori della luce coinvolti nella visione reagivano alle variazioni di luce regolando
l'orologio circadiano, ossia il timer interno che
sincronizza l'attività ormonale, la temperatura
corporea e il sonno.
Di giorno i topi effettuavano le consuete
attività diurne e di notte quelle notturne.
Riuscivano a farlo benché la loro retina fosse
priva dei fotorecettori, le cellule che gli occhi
dei vertebrati usano per formare le immagini, e a
dispetto del fatto che la rimozione chirurgica
degli occhi abolisse questa capacità. Forse il
fenomeno è comune a molti mammiferi, compreso
l'uomo: esperimenti recenti hanno dimostrato che
anche presone non vedenti possono regolare i loro
ritmi circadiani e restringere le pupille in
risposta alla luce.
Una spiegazione di questo paradosso è che i
fotorecettori dell'occhio necessari alla visione
non sono responsabili della regolazione del
calcolo temporale dell'attività diurna, un compito
delegato ad altri recettori. Eppure fino a poco
tempo fa l'idea che gli occhi avessero
fotorecettori diversi dai coni e dai bastoncelli
sembrava assurda. La retina è uno dei tessuti più
studiati dell'organismo, e gli unici fotorecettori
di cui conosciamo l'esistenza negli occhi dei
mammiferi sono i coni e i bastoncelli. Tuttavia ci
sono indicazioni sempre più convincenti che gli
occhi dei mammiferi, compresi quelli umani,
abbiano fotorecettori specializzati che non si
occupano della formazione delle immagini. Le
molecole di queste cellule specializzate nella
rilevazione della luce sono diverse da quelle dei
coni e dei bastoncelli e si collegano a parti
differenti del cervello. Pertanto, come le
orecchie presiedono insieme al senso
dell'equilibrio e all'udito, così i nostri occhi
sono essenzialmente due organi in uno.
Questa scoperta potrebbe aiutare chi ha problemi
nella regolazione dell'orologio biologico. Il jet
lag è la manifestazione più lampante di
desincronizzazione circadiana, la perdita di
sincronizzazione tra il ciclo giorno/notte e il
nostro orologio interno. Si ritiene che lavorare
nei turni di notte aumenti il rischio di patologie
cardiovascolari, disturbi gastrointestinali,
tumore e di sindrome metabolica, una patologia che
aumenta il rischio di diabete di tipo 2 e di
infarto cerebrale. Alcuni incidenti industriali
fra i più noti, come l'incagliamento della
superpetroliera Exxon Valdez, l'esplosione
all'impianto della Union Carbide nel 1984 a Bhopal
in India e la fusione parziale del nocciolo nella
centrale nucleare di Three Mile Island nel 1979,
sono avvenuti durante il turno di notte, quando
l'attenzione dei lavoratori era compromessa.
Inoltre milioni di persone che vivono a latitudini
settentrionali o meridionali estreme soffrono di
disturbo affettivo stagionale, una forma spesso
grave di depressione che avrebbe fra le sue cause
la risposta a una mancanza di luce durante le
brevi giornate invernali. Una conoscenza migliore
di come il terzo tipo di fotorecettore controlla i
ritmi circadiani e le emozioni suggerisce oggi
alcune vie per ridurre al minimo gli effetti
negativi del jet lag, dei turni di notte e delle
lunghe notti invernali.
Sensibili ma trascurati
L'esistenza di organismi dotati di organi di
rilevazione della luce non usati nella formazione
di immagini è nota da tempo. Una variazione di
luce potrebbe segnalare a un animale la sua
esposizione ai predatori o a danni da radiazioni
ultraviolette. Molte specie animali hanno evoluto
adattamenti, come la mimetizzazione attiva o
l'evitamento della luce, per ridurre al minimo le
conseguenze dell'esposizione. Ma pur richiedendo
qualche sistema di rilevazione della luce, gli
adattamenti non implicano necessariamente la
vista. Per esempio, nel 1911 lo zoologo e futuro
premio Nobel Karl von Frisch scoprì che esemplari
ciechi di un pesce della famiglia dei ciprinidi si
scuriscono se sono esposti alla luce. Un danno
alla base del cervello aboliva però la risposta,
il che indusse von Frisch a proporre l'esistenza
di fotorecettori visivi nel cervello profondo.
Molte specie animali hanno queste cellule
sensibili alla luce. I passeri, per esempio,
modulano l'orologio circadiano anche senza gli
occhi, come ha dimostrato Michael Menaker,
dell'Università del Texas ad Austin. Esperimenti
successivi hanno confermato che gli uccelli hanno
nel cervello cellule sensibili alla luce. Una
quantità sorprendente di luce penetra attraverso
le penne, la pelle e il cranio di un uccello
attivando queste cellule.
La possibilità che almeno alcuni mammiferi
avessero recettori della luce non coinvolti nella
visione attirò per la prima volta l'attenzione dei
biologi negli anni venti, quando Keeler riferì dei
suoi incroci domestici dei topi. Poiché l'anatomia
della retina era ben conosciuta, si ipotizzò che
l'organo mancante sensibile alla luce avesse una
sede diversa dagli occhi. Ma all'inizio degli anni
ottanta gli studi di Randy J. Nelson e di Irving
Zucker dell'Università della California a Berkeley
su roditori privi di occhi sembrarono mettere in
dubbio l'ipotesi. Questi animali erano incapaci di
regolare i ritmi biologici al ciclo della notte e
del giorno, suggerendo che i recettori sensibili
alla luce avessero sede nell'occhio.
Menaker, trasferitosi nel frattempo
all'Università dell'Oregon, aveva iniziato a
indagare se gli occhi del topo avessero un ruolo
nelle risposte di sensibilità alla luce che non
richiedono la formazione di immagini. Insieme a
Joseph Takahashi e a David Hudson, studiò topi
mutanti privi di coni e bastoncelli funzionali,
con l'eccezione forse di pochi coni scarsamente
attivi. Con sorpresa dei ricercatori, i topi
ciechi riuscivano a limitare l'attività alle ore
notturne e rimanere relativamente inattivi durante
il giorno, proprio come i topi dotati di una
visione completa.
Una possibile spiegazione di questo
comportamento era che i pochi coni asfittici
sopravvissuti conservassero in qualche modo una
risposta non visiva alla luce. Tuttavia nel 1999
il gruppo di ricerca di Russell Foster
all'Imperial College di Londra usò topi mutanti
totalmente privi di coni e di bastoncelli per
dimostrare che queste cellule non erano necessarie
per le risposte non visive alla luce. Questo
lasciava aperta una sola spiegazione: l'occhio
doveva contenere un tipo di fotorecettore ancora
da scoprire.
L'ipotesi suonava come un'eresia. Le cellule
della retina implicate nella formazione delle
immagini sono note dalla metà dell'Ottocento, e
l'idea che un'altra cellula sensibile alla luce
nella retina fosse passata inosservata per quasi
150 anni sembrava assurda.
Eresia vincente
Ma la ricerca che io e Mark Rollag iniziammo a
metà degli anni novanta presso la Uniformed
Service University di Bethesda, nel Maryland,
contribuì a dimostrare che Foster aveva ragione.
Rolleg stava studiando una forma differente di
fotoricezione non visiva: la mimetizzazione negli
anfibi. Le cellule pigmentate della coda dei
girini si scuriscono in presenza della luce, una
risposta adattativa che favorisce l'occultamento
dell'animale. Le cellule, i melanofori dermici,
conservano la risposta anche quando sono rimosse e
coltivate in vitro. Insieme a Rollag identificammo
nelle cellule in coltura una nuova proteina la cui
composizione è straordinariamente simile alla
classe di pigmenti proteici, le opsine, che
permettono ai coni e ai bastoncelli di rilevare la
luce. Abbiamo chiamato la nuova proteina
melanopsina.
La somiglianza con le opsine conosciute indicava
in modo chiaro che la melanopsina era la molecola
capace di attivare la risposta di inscurimento.
Curiosi di sapere se la melanopsina svolgesse un
ruolo in altre cellule specializzate nel
rilevamento della luce, abbiamo studiato altri
tessuti della rana - di cui conosciamo la
sensibilità diretta alla luce - per esempio
particolari aree del cervello, e poi l'iride e la
retina nell'occhio. È risultato che né i coni né i
bastoncelli contenevano questa nuova proteina
sensibile alla luce. Con nostra sorpresa l'abbiamo
trovata in particolari neuroni della retina, le
cellule gangliari, da sempre considerate
insensibili alla luce.
La retina dei vertebrati è un'elegante struttura
a tre strati. Lo strato più profondo contiene i
coni e i bastoncelli, perciò la luce deve
attraversare gli altri due strati prima di essere
rilevata per la visione. Poi l'informazione in
arrivo dai coni e dai bastoncelli è trasferita
allo strato intermedio, dove è elaborata da
differenti classi di cellule, che comunicheranno
infine il segnale elaborato allo strato
superficiale, composto essenzialmente da cellule
gangliari. Lunghi assoni, vettori del segnale, si
estendono dalle cellule gangliari e trasmettono
l'informazione al cervello lungo il nervo ottico.
Nel 2000 io e i miei colleghi scoprimmo i primi
indizi che una frazione molto piccola di queste
cellule gangliari era direttamente sensibile alla
luce. Osservammo poi che il 2 per cento delle
cellule gangliari della retina contiene
melanopsina e che una piccola percentuale di
queste cellule la contiene anche nella specie
umana. Nel 2002 gli esperimenti di David Berson e
colleghi alla Brown University confermarono la
nostra teoria. Essi hanno disattivato i coni e i
bastoncelli e riempito le cellule gangliari
contenenti opsina con un marcatore colorante. Poi
hanno asportato le retine dagli occhi dei topi e
dimostrato che le cellule nervose marcate si
attivavano quando erano esposte alla luce. Poiché
i coni e i bastoncelli erano disattivati, la
risposta indicava che queste particolari cellule
gangliari erano capaci di rilevare la luce, oltre
a ritrasmettere i segnali dai coni e dai
bastoncelli.
L'ipotesi fu rinforzata da prove emerse nel
2002, quando Samer Hattar della Johns Hopkins
University e collaboratori hanno dimostrato che
alcuni assoni della retina del topo si collegano
al nucleo soprachiasmatico - l'area che regola
l'orologio interno - e che altri assoni si
collegano all'area del cervello che controlla il
restringimento delle pupille. Inoltre le cellule
gangliari collegate a quelle aree sono le stesse
che contengono melanopsina. Queste scoperte
indicavano tutte la stessa soluzione al nostro
enigma: cellule gangliari fotosensibili
consentivano a topi privi di coni e bastoncelli
funzionali di restringere le pupille e di
conservare l'organismo in sintonia con il ciclo
luce/buio. Tuttavia i topi senza occhi, e dunque
privi totalmente della retina, perdevano questa
capacità.
Rimaneva un ultimo test. Abbiamo pensato che, se
avessimo incrociato topi normali in tutto tranne
che per l'assenza del gene della melanopsina,
questi, incapaci di produrre il pigmento, non
avrebbero manifestato risposte non visive alla
luce. Ciò che accadde in seguito confermò
l'espressione «la scienza è un'amante crudele».
Proprio quando pensavamo di avere afferrato la
soluzione, rimanemmo letteralmente senza parole
scoprendo che i topi privi di melanopsina
regolavano quasi normalmente i ritmi circadiani.
Un ultimo ostacolo
Per spiegare lo smacco, abbiamo considerato la
possibilità che nella retina si annidasse un
ulteriore fotorecettore non visivo. Un'eventualità
improbabile per una serie di ragioni, ma
soprattutto perché il genoma completo del topo sequenziato nel periodo in cui stavamo completando
gli studi sui nostri topi knockout - non conteneva
altri evidenti geni per i fotopigmenti. La seconda
ipotesi era che i coni, i bastoncelli e le cellule
gangliari fotosensibili agissero insieme nel
controllo delle risposte non visive alla luce.
Quest'ultima possibilità è stata verificata quando
abbiamo prodotto topi mutanti privi di coni,
bastoncelli e melanopsina. Questi «frankentopi»
non mostrarono alcuna risposta visiva o non visiva
alla luce e si comportavano come se i loro occhi
fossero stati rimossi chirurgicamente. Ne abbiamo
quindi concluso che coni, bastoncelli e cellule
gangliari contenenti melanopsina lavorassero di
concerto per trasferire al cervello l'informazione
non visiva.
In realtà stanno emergendo prove che le cellule
gangliari fotosensibili funzionino anche da
condutture per trasmettere l'informazione luminosa
non visiva dai coni e dai bastoncelli al cervello,
proprio come le altre cellule gangliari
trasmettono informazione visiva alle aree visive
di quest'ultimo. Nel 2009 tre differenti gruppi di
ricerca, tra cui il nostro, concepirono un metodo
per uccidere le cellule gangliari fotosensibili
nei topi senza influenzare le altre parti
dell'organismo. Benché avessero conservato la
visione, i topi tendevano a confondere il giorno e
la notte e avevano difficoltà a contrarre le
pupille. In altre parole, le cellule gangliari
specializzate sono necessarie per generare le
risposte non visive alla luce, ma il sistema ha
una forma intrinseca di ridondanza: le gangliari
possono rivelare in modo autonomo la luce oppure
ritrasmettere l'informazione da coni e
bastoncelli, o da entrambi.
L'enigma era finalmente risolto, almeno nei
topi. Sono poi emerse le prove che la stessa cosa
vale nell'uomo. Nel 2007 Foster e collaboratori
hanno pubblicato uno studio su due pazienti ciechi
privi di coni e bastoncelli funzionali l'equivalente umano dei topi di Keeler - e che
tuttavia riuscivano ancora a regolare i ritmi
circadiani una volta esposti periodicamente alla
luce blu. Le lunghezze d'onda della luce blu, dove
la loro risposta era ottimale, erano precisamente
nella stessa gamma rilevata dalla melanopsina,
come risultò da misure effettuate dal nostro
gruppo in collaborazione con quello di Berson,
nelle quali costringemmo linee cellulari
normalmente non fotorecettive a produrre
melanopsina. Ora queste cellule rispondono alla
luce attivandosi in risposta alla luce blu.
Ma l'aspetto forse più interessante è la nostra
scoperta che la melanopsina, quando è colpita
dalla luce, avvia una cascata di segnali chimici
dentro queste cellule, simile più a quello che
succede nei fotorecettori dei moscerini o dei
calamari che nei coni e nei bastoncelli dei
mammiferi. Anche stavolta l'evento non era
inatteso. Infatti, anni prima avevamo ravvisato
che la sequenza genica della melanopsina
assomigliava più alle sequenze geniche dei
fotopigmenti degli invertebrati che a quelle dei
vertebrati. Pertanto nei mammiferi la melanopsina
sembra il fotopigmento di un sistema fotorecettivo
primitivo in precedenza sconosciuto, ospitato
nella retina insieme al cugino più «evoluto», il
sistema visivo.
Oltre all'interesse puramente scientifico, la
scoperta di questo nuovo organo «nascosto»
potrebbe avere ricadute cliniche, poiché indica un
legame, in precedenza sfuggito, tra la salute
degli occhi e quella mentale. Alcune ricerche
sostengono che l'esposizione alla luce blu
aumenterebbe la consapevolezza, contrastando il
jet lag o la privazione del sonno, e attenuerebbe
il disturbo affettivo stagionale, un problema
comune alle alte latitudini, che può causare
depressioni invalidanti e indurre al suicidio.
Sembra naturale ipotizzare che la terapia della
luce sia efficace perché colpisce le cellule
gangliari fotosensibili. Altri studi hanno
dimostrato che i bambini ciechi colpiti da
patologie come il glaucoma, che influenzano le
cellule gangliari della retina, corrono un rischio
maggiore di soffrire di disturbi del sonno
rispetto ai bambini ciechi per altre cause.
Individuare il grado di salute delle cellule
gangliari fotosensibili potrebbe dunque aprire la
via a una nuova classe di trattamenti per un'ampia
gamma di disturbi.
Ignacio Provencio
(«Le Scienze» n. 515/11)
Se l'hacker spegne la luce
- I virus informatici hanno iniziato a colpire
sistemi di controllo industriali. Il prossimo
bersaglio potrebbe essere la rete elettrica. L'anno scorso si è diffusa la notizia di un
virus informatico che è riuscito a penetrare tra
le maglie dei sistemi di sicurezza degli impianti
nucleari iraniani. La maggior parte dei virus si
diffonde senza criterio, ma Stuxnet aveva un
obiettivo specifico, che non era neppure collegato
a Internet. Stuxnet era installato nella chiavetta
USB di un tecnico al di sopra di ogni sospetto.
Una volta collegata la chiavetta a un computer
dell'impianto di sicurezza, il virus si è diffuso
silenziosamente per mesi, alla ricerca di qualche
altro computer che fosse connesso a
un'apparecchiatura semplice come un controller
logico programmabile, una piccola scatola di
plastica piena di circuiti usata per controllare
componenti degli impianti industriali: valvole,
ingranaggi, interruttori e motori elettrici. Una
volta individuata la preda, Stuxnet vi è penetrato
e, senza dare nell'occhio, ne ha assunto il
controllo.
I controller colpiti erano collegati alle
centrifughe, il cuore delle ambizioni nucleari
dell'Iran. Migliaia di queste apparecchiature
lavorano uranio per trasformarlo in uranio
arricchito necessario a realizzare un ordigno
nucleare. In condizioni operative normali, le
centrifughe ruotano tanto rapidamente che il loro
bordo esterno si muove a una velocità vicina a
quella del suono. Stuxnet ha incrementato questa
velocità fino a 1600 chilometri all'ora, superando
il limite oltre cui, secondo un recente rapporto
dell'Institute for Science and International
Security, probabilmente il rotore sarebbe stato
distrutto. Allo stesso tempo, Stuxnet ha inviato
falsi segnali ai sistemi di controllo, indicando
che tutto era normale. Sebbene l'entità del danno
al programma nucleare iraniano resti sconosciuta,
nel 2010 gli ispettori dell'International Atomic
Energy Agency hanno riferito che l'Iran ha dovuto
sostituire circa 1000 centrifughe nell'impianto di
arricchimento di Natanz tra la fine del 2009 e
l'inizio del 2010.
Stuxnet ha dimostrato quanto le apparecchiature
industriali possano essere vulnerabili agli
attacchi informatici: il virus ha infettato, e
probabilmente distrutto, un equipaggiamento
ritenuto sicuro senza essere rilevato per mesi. È
un esempio inquietante di come uno Stato o un
gruppo terroristico potrebbero usare una simile
tecnologia contro l'infrastruttura civile di un
qualunque paese del mondo.
Sfortunatamente, la rete elettrica è più facile
da penetrare rispetto a un impianto nucleare.
Possiamo immaginare questa rete come un circuito
gigantesco, ma in realtà è composta da migliaia di
componenti distanti tra loro diversi chilometri
che agiscono in modo coordinato. La fornitura di
energia elettrica che fluisce nella rete deve
aumentare e diminuire in parallelo con la domanda,
mentre i generatori devono distribuire energia in
fase con la frequenza, 60 cicli al secondo (50 in
Italia, N.d.t.), a cui funzionano gli altri
componenti della rete. Sebbene l'interruzione del
funzionamento di un singolo componente abbia
limitate ripercussioni su questo circuito esteso,
un attacco informatico coordinato su molteplici
siti potrebbe danneggiare il sistema in modo così
ampio da compromettere gravemente la capacità di
una nazione di generare e distribuire elettricità
per settimane, forse per mesi.
Considerando le dimensioni e la complessità
della rete, un attacco coordinato richiederebbe
probabilmente un tempo e uno sforzo significativi
per essere messo in atto. Stuxnet è il più
sofisticato virus per computer mai visto, il che
fa ipotizzare che sia opera dei servizi segreti di
Israele o degli Stati Uniti, o di entrambi. Ma il
codice di Stuxnet ora è disponibile su Internet, e
quindi aumentano le probabilità che un gruppo di
malintenzionati possa adattarlo per attaccare un
nuovo bersaglio. Probabilmente al momento un
gruppo meno sofisticato dal punto di vista
tecnologico, come al Qaeda, non ha le competenze
per infliggere un danno significativo alla rete
elettrica, che invece potrebbe essere inflitto da
hacker mercenari cinesi o dell'ex Unione
Sovietica.
L'intrusione
Un anno fa ho partecipato alla simulazione di un
attacco informatico simulato alla rete elettrica,
insieme a rappresentanti dei gestori della rete,
delle agenzie governative e delle forze armate
statunitensi (anche le basi militari dipendono
dalla rete elettrica, una circostanza che non è
sfuggita al Pentagono). Nello scenario simulato i
finti aggressori sono riusciti a penetrare in
diverse sottostazioni di trasmissione, mettendo
fuori uso dispositivi raffinati e costosi che
assicurano che la tensione rimanga costante via
via che l'elettricità percorre le linee ad alta
tensione. Alla fine dell'esercitazione, alcuni
dispositivi sono stati distrutti, privando di
elettricità uno Stato dell'ovest degli Stati Uniti
per molte settimane.
I computer controllano i dispositivi meccanici
della rete a ogni livello: dagli enormi generatori
alimentati da combustibili fossili o da uranio
fino alle linee di trasmissione che vediamo nelle
strade. La maggior parte di questi computer usano
sistemi operativi comuni come Windows e Linux, che
sono vulnerabili alle intrusioni quanto i computer
degli utenti privati. Un codice di attacco come
Stuxnet è efficace per tre motivi: questi sistemi
operativi implicitamente si fidano del fatto che i
programmi usati siano sicuri; spesso hanno difetti
che consentono un'intrusione da parte di malware
(software progettati per infiltrarsi nei sistemi
informatici e danneggiarli o rubare dati, N.d.t.);
le caratteristiche degli impianti spesso non
permettono l'uso delle difese già disponibili.
Anche sapendo tutto questo, fino a poco tempo fa
un progettista di sistemi di controllo avrebbe
giudicato impossibile un attacco da remoto ai
sistemi cruciali di un impianto proprio perché non
sono direttamente collegati a Internet. Poi
Stuxnet ha mostrato che anche le reti di controllo
prive di connessione permanente sono vulnerabili:
il malware può essere inserito con una chiavetta
USB che un tecnico può collegare al sistema di
controllo, per esempio. Quando si tratta di
circuiti elettronici critici, anche il più piccolo
buco può lasciar entrare un hacker intraprendente.
Si consideri il caso di una stazione secondaria
di trasmissione, punto di passaggio nel viaggio
dell'elettricità da un impianto di potenza alla
nostra abitazione. Le stazioni secondarie ricevono
la corrente ad alta tensione da una o più
centrali, sincronizzano le correnti alternate,
riducono la tensione e indirizzano l'elettricità
in diverse linee in uscita per la distribuzione
locale. A controllo di ciascuna di queste linee
c'è un interruttore automatico, pronto a tagliare
l'elettricità in caso di guasto. Quando un
interruttore su una linea di uscita scatta, tutta
l'energia elettrica che avrebbe trasportato
fluisce verso le linee rimanenti. Non è difficile
immaginare che, nel caso in cui tutte le linee
siano ai limiti della loro capacità, un attacco
informatico che tagli metà delle linee di uscita
può sovraccaricare le rimanenti.
Questi interruttori sono stati controllati da
dispositivi collegati a modem raggiungibili per
telefono dai tecnici. I numeri relativi non sono
difficili da trovare: già trent'anni fa gli hacker
avevano creato programmi in grado di chiamare
tutti i numeri in un commutatore telefonico e di
registrare quelli a cui rispondono i modem. I
modem collegati agli interruttori di un circuito
hanno un unico messaggio di risposta a una
chiamata, che rivela la loro funzione. Questa
circostanza, insieme con blande misure di
autenticazione che spesso difendono impianti del
genere, come quelle basate su password facili da
indovinare o quelle che addirittura ne sono prive,
rende possibile l'uso di questi modem per entrare
nella rete di una sottostazione. Una volta dentro,
si potrebbe cambiare la configurazione del
dispositivo in modo che sia ignorata una
condizione pericolosa che altrimenti porterebbe un
interruttore a proteggere gli equipaggiamenti.
D'altra parte non è detto che i sistemi più
recenti siano più sicuri dei modem. Sempre di più,
i nuovi dispositivi distribuiti nelle
sottostazioni potrebbero comunicare tra loro con
radio a bassa potenza, la cui portata tuttavia va
spesso oltre i confini della sottostazione. Chi
attacca può raggiungere la rete nascondendosi con
il suo computer nei boschi circostanti. Le reti
Wi-Fi criptate sono più sicure, ma un attacco
sofisticato può violare la crittografia grazie a
programmi già disponibili. In queste condizioni,
si può mettere in atto un attacco man-in-themiddle in cui le comunicazioni tra due dispositivi
sono intercettate o in cui tali dispositivi sono
ingannati ad accettare come legittimo il computer
dell'intruso. Così, il malintenzionato può inviare
messaggi fraudolenti per ingannare gli
interruttori del circuito e farne scattare alcuni
con l'obiettivo di sovraccaricare le altre linee
oppure assicurandosi che non scattino nel corso di
un'emergenza.
Una volta che un intruso o un malware si è
introdotto nel sistema che aveva puntato, come
primo passo di solito tenta di diffondersi il più
possibile. Ancora una volta, Stuxnet illustra
alcune di queste strategie: prolifera usando un
meccanismo del sistema operativo denominato
autoexec: ogni volta che un utente effettua il
log-in, i computer con sistema operativo Windows
leggono ed eseguono il file Autoexec.bat.
Tipicamente, il programma localizza i driver della
stampante ed esegue una scansione per la ricerca
di virus o altre funzioni di base. Inoltre,
Windows assume che qualsiasi programma con il nome
corretto sia affidabile. Gli hacker quindi cercano
il modo di alterare il file Autoexec.bat così che
esegua il codice fraudolento.
L'aggressore può anche usare metodi più astuti
che sfruttano l'economia dell'industria elettrica.
A causa della deregolamentazione, negli Stati
Uniti diversi gestori in concorrenza condividono
la responsabilità del funzionamento della rete e
l'energia elettrica è generata, trasmessa e
distribuita grazie a contratti ottenuti con aste
on line. Questi mercati operano a molteplici scale
temporali: in uno può essere commercializzata
l'energia per la distribuzione immediata e in un
altro quella per la richiesta di domani. La
divisione commerciale di un gestore deve avere
disponibile un flusso costante d'informazione in
tempo reale dalla sua divisione operativa per
concludere affari in modo rapido e intelligente.
Viceversa, il reparto operativo deve sapere quanta
energia produrre per soddisfare gli ordini che
arrivano alla divisione commerciale. Ed è proprio
questo il punto debole. Un hacker potrebbe
penetrare nella rete commerciale, sottrarre nomi
utente e password e usare queste identità rubate
per accedere ai network operativi.
Altri attacchi potrebbero diffondersi sfruttando
piccoli programmi chiamati script inclusi nei
file. Questi script sono molto diffusi, per
esempio i file pdf contengono spesso script che
aiutano la visualizzazione del contenuto, ma sono
anche un pericolo. Una società che si occupa di
sicurezza informatica ha recentemente stimato che
più del 60 per cento di tutti gli attacchi mirati
usa script nascosti in file pdf: la semplice
lettura di un file corrotto può consentire a un
hacker l'accesso al vostro computer.
Si consideri l'ipotetico caso in cui un
potenziale aggressore entri nel sito web di un
venditore di programmi e sostituisca un manuale on
line con uno fraudolento simile al primo.
L'aggressore telematico poi invia a un ingegnere
dell'impianto elettrico un'e-mail contraffatta che
induce la vittima a scaricare e ad aprire il
manuale fraudolento. Andando on fine per scaricare
un manuale aggiornato, l'inconsapevole ingegnere
apre le porte del suo impianto a un Cavallo di
Troia. Una volta all'interno, comincia l'attacco.
Cerca e distruggi
Un intruso in una rete di controllo può inviare
comandi con risultati potenzialmente devastanti.
Nel 2007 il Department of Homeland Security,
responsabile della sicurezza interna degli Stati
Uniti, ha condotto un attacco all'Idaho National
Laboratory con nome in codice Aurora. Durante
l'esercitazione, il ricercatore nelle vesti di un
hacker si è fatto strada in una rete connessa a un
generatore di potenza di medie dimensioni, che
come tutti i generatori produce corrente alternata
a 60 cicli al secondo. A ogni ciclo, il flusso di
elettroni comincia a muoversi in una direzione,
inverte il senso e ritorna al suo stato
originario. Il generatore quindi deve muovere gli
elettroni nella stessa direzione ed esattamente in
fase con il resto della rete.
Durante l'attacco Aurora, il nostro hacker ha
inviato comandi on/off in rapida successione agli
interruttori di un generatore di prova, mettendolo
fuori fase rispetto alla rete: questa funzionava
in un senso e il generatore nell'altro. In
effetti, l'inerzia meccanica del generatore è
andata contro l'inerzia elettrica della rete,
perdendo il confronto. In un video viene mostrata
l'enorme macchina di acciaio sobbalzare come se un
treno avesse investito l'edificio. In pochi
secondi, l'ambiente si è riempito di fumo.
Gli equipaggiamenti industriali possono rompersi
anche quando sono spinti oltre i loro limiti:
quando girano troppo velocemente, le centrifughe
si disintegrano. In modo simile, un aggressore
potrebbe indurre un generatore elettrico a
produrre un picco di energia che supera il limite
di ciò che le linee di trasmissione possono
sopportare. L'eccesso di energia dovrebbe dunque
essere dissipato sotto forma di calore, ma se si
protraesse per un tempo sufficientemente lungo
potrebbe causare un cedimento e infine una
fusione. Se la linea danneggiata è a contatto con
qualcosa - un albero, un pannello pubblicitario o
un edificio - potrebbe creare un enorme
cortocircuito.
I relé di protezione possono prevenire questi
inconvenienti, ma un attacco informatico potrebbe
interferire con il loro funzionamento, producendo
un danno. Inoltre, un attacco potrebbe alterare
l'informazione diretta a una stazione di
controllo, impedendo agli operatori di sapere che
qualcosa non va, come in quei film in cui i
criminali inviano false immagini a chi è di
guardia.
Anche le stazioni di controllo, stanze con
grandi schermi simili alla «stanza dei bottoni»
del dottor Stranamore, sono vulnerabili agli
attacchi. Gli operatori della stazione di
controllo usano gli schermi per monitorare i dati
raccolti dalle sottostazioni a cui poi inviano i
comandi per cambiarne le impostazioni. Spesso
queste stazioni sono responsabili del monitoraggio
di centinaia di sottostazioni costruite sul
territorio.
La comunicazione di dati tra stazione di
controllo e sottostazioni è basata su protocolli
specifici che possono essere vulnerabili. In un
attacco man-in-the-middle, un hacker può inserire
un messaggio o modificarne uno che guasti uno o
entrambi i computer. Un aggressore potrebbe anche
cercare solo di inserire un messaggio formattato
in modo opportuno ma fuori contesto, un non
sequitur digitale in grado di determinare un
guasto della macchina.
Gli aggressori potrebbero anche cercare di
ritardare i messaggi che viaggiano tra stazioni di
controllo e sottostazioni. Di solito il ritardo
tra una misurazione del flusso di elettricità
della sottostazione e l'elaborazione dello stesso
dato da parte della stazione di controllo è
limitato, altrimenti sarebbe come guidare un'auto
vedendo solo dove si era dieci secondi prima.
Questo tipo di mancato controllo della situazione
in tempo reale ha contribuito al blackout del
nord-est degli Stati Uniti del 2003.
Molti di questi attacchi non richiedono
programmi sofisticati come Stuxnet, ma
semplicemente gli strumenti standard di un hacker.
Per esempio, spesso gli hacker assumono il comando
di reti formate da migliaia o anche da milioni di
comuni computer (denominate botnet) che
istruiscono a eseguire le loro istruzioni. Il più
semplice tipo di attacco botnet inonda un sito web
con messaggi fasulli bloccando o rallentando
l'usuale flusso di informazioni. Questi attacchi,
chiamati denial of service, potrebbero anche
essere usati per rallentare il traffico tra
stazione di controllo e sottostazioni.
Le botnet potrebbero mettere radici negli stessi
computer delle sottostazioni. Nel 2009 la botnet
Conficker si è infiltrata in dieci milioni di
computer: chi la controllava avrebbe potuto
cancellare il disco rigido di un qualsiasi
computer collegato al network, se solo l'avesse
voluto. Allo stesso modo, una botnet come
Conficker avrebbe potuto entrare in alcune
sottostazioni della rete elettrica e chi la
controllava avrebbe potuto ordinare qualunque cosa
in ogni momento. Secondo uno studio del 2004 della
Pennsylvania State University e del National
Renewable Energy Laboratory, la scelta attenta di
poche stazioni - circa il 2 per cento, o 200 in
totale - avrebbe messo fuori uso il 60 per cento
della rete elettrica. Per provocare un blackout
nazionale, è sufficiente l'8 per cento.
Che cosa fare
Quando viene a conoscenza di un possibile
problema di sicurezza di Windows, Microsoft
normalmente distribuisce un aggiornamento (patch).
Singoli utenti e aziende in tutto il mondo
aggiornano il loro software e si proteggono dalla
minaccia. Sfortunatamente, sulla rete elettrica le
cose non sono così semplici.
Mentre la rete elettrica usa lo stesso tipo di
hardware e di software che usa il resto del mondo,
i responsabili delle centrali elettriche non
possono semplicemente predisporre una patch per un
difetto rilevato in un programma. Il sistema di
controllo della rete non può essere escluso per
manutenzione per tre ore ogni settimana: deve
funzionare in modo continuativo. Gli operatori
della rete elettrica nutrono anche un
conservatorismo profondamente radicato. Le reti di
controllo sono state attive da molto tempo, e gli
operatori hanno ormai un metodo di lavoro
consolidato. Per questo tendono a evitare
qualunque cosa possa minacciare la disponibilità
della rete o possa interferire con le operazioni
ordinarie.
Di fronte a un pericolo reale e imminente, la
North American Electric Reliability Corporation
(NERC), un'associazione che riunisce operatori di
rete, ha predisposto un insieme di misure per
proteggere l'infrastruttura critica. Ora agli
impianti viene richiesto di identificare i loro
aspetti critici e di dimostrare, nel corso di
valutazioni validate dalla stessa NERC, che
possono impedire un accesso non autorizzato.
Purtroppo, le valutazioni in materia di sicurezza,
come quelle finanziarie, non possono essere
esaustive. Quando si scende nel dettaglio, lo si
fa solo in modo mirato, anche per una forma di
condiscendenza.
La strategia di protezione stabilisce un
perimetro di sicurezza elettronico, una sorta di
linea di Maginot telematica. La prima linea di
difesa è il firewall, un dispositivo attraverso
cui devono passare i messaggi elettronici. Ogni
messaggio ha un'intestazione (header) che indica
da dove arriva il messaggio, a chi è indirizzato e
quale protocollo è usato per interpretarlo. Sulla
base di questa informazione, il firewall permette
ad alcuni messaggi di passare mentre altri vengono
bloccati. Il lavoro dei responsabili delle
validazioni è rendere sicuri centinaia di
firewall, assicurando che un impianto sia
configurato correttamente e non lasci passare, né
in entrata né in uscita, traffico indesiderato.
Tipicamente, chi si occupa delle validazioni
identifica alcuni aspetti critici, controlla i
file di configurazione del firewall, cerca di
simulare i modi in cui un hacker potrebbe violare
il firewall.
Tuttavia, i firewall sono tanto complessi che è
difficile analizzarli in modo completo: in questo
possono venire in aiuto alcuni programmi. Il
nostro gruppo dell'Università dell'Illinois a
Urbana Champaign ha sviluppato il Network Access
Policy Tool, programma che ora è usato sia dai
gestori sia dai consulenti per la valutazione
della sicurezza. Questo programma, che non deve
collegarsi alla rete perché necessita solo dei
file di configurazione del firewall dell'impianto,
ha già permesso di trovare diverse strategie che
potrebbero essere sfruttate dagli aggressori.
Il Department of Energy degli Stati Uniti ha
elaborato una tabella di marcia che definisce una
strategia con cui migliorare la sicurezza della
rete elettrica entro il 2016. Un obiettivo
specifico è realizzare un sistema in grado di
riconoscere un tentativo di intrusione e di
reagire in modo automatico che avrebbe bloccato un
virus come Stuxnet non appena uscito dalla
chiavetta USB. Ma un sistema operativo come può
sapere di quali programmi fidarsi?
Una soluzione riguarda una tecnica crittografica
denominata funzione hash a senso unico. Una
funzione hash prende un numero incredibilmente
alto, per esempio tutti gli 1 e gli 0 del
programma, e lo converte in un numero più piccolo,
che serve da «firma». Poiché i programmi sono di
grandi dimensioni, è altamente improbabile che due
programmi differenti diano la stessa firma. Si
immagini che ogni programma che intenda «girare»
su un sistema debba per prima cosa essere
analizzato da una funzione hash. La sua firma è
confrontata con un elenco di riferimento: se il
confronto non va a buon fine il programma è
bloccato.
Il Department of Energy raccomanda anche altre
misure, che riguardano per esempio la sicurezza
fisica delle stazioni di lavoro (si pensi ai chip
nei tesserini di identificazione), e sottolinea
anche la necessità di un controllo più stretto
sulla comunicazione tra i dispositivi all'interno
della rete. La dimostrazione di Aurora del 2007 ha
coinvolto un dispositivo fraudolento in grado di
ingannare il dispositivo di controllo di un
generatore facendogli credere che quelli inviati
fossero comandi degli uffici competenti: il
risultato è stata la distruzione del generatore.
Si tratta di passi importanti, che richiederanno
tempo, denaro e risorse. Se intendiamo proseguire
sulla strada di una rete elettrica più sicura nei
prossimi dieci anni, occorre mantenere il passo,
sperando che il tempo sia sufficiente.
David M. Nicol
(«Le Scienze» n. 517/11)
Addio principe azzurro?
- Che cos'è e come funziona lo speed dating? Una
pratica ormai ampiamente diffusa non solo negli
Stati Uniti ma anche in Canada, Australia, Europa
e ora anche in Italia. Lo speed dating nasce nel 1998 a Los Angeles da
un'idea del rabbino Yaacov Deyo e di sua moglie
Sue, prendendo spunto dall'antica tradizione
ebraica del shidduch, ossia l'incontro tra giovani
ebrei da tenersi segreto fino al matrimonio. Né il
rabbino né sua moglie, all'epoca, avrebbero però
mai pensato che lo speed dating sarebbe diventato
una specie di gioco gestito da organizzate ed
efficienti agenzie, con tanto di siti
specializzati in Internet.
Le regole generali dello speed dating sono
sostanzialmente le stesse ovunque si giochi. Gli
incontri sono organizzati perlopiù presso bar e
ristoranti e coinvolgono solitamente da venti a
ventiquattro persone selezionate all'interno di
una determinata fascia di età: per iscriversi è
sufficiente registrarsi in Internet fornendo i
propri dati personali, in modo che gli
organizzatori possano poi informare gli
interessati sul programma della serata; la quota
di partecipazione si paga al momento dell'ingresso
nel locale.
All'arrivo, i partecipanti vengono registrati
con un numero e dotati di un blocchetto; la
campana suona e il gioco comincia: un apposito
coordinatore dirige la serata, che scorre
all'insegna di un vero e proprio carosello di
«abboccamenti» con le donne che restano sedute ai
tavolini, mentre gli uomini, forse unico retaggio
della cavalleria tipica del corteggiamento vecchio
stile, scivolano da una sedia all'altra ogni seiotto minuti, a seconda del regolamento. Questo
schema è finalizzato a far sì che ciascuno dei
partecipanti sia messo nella condizione di poter
conversare con tutti gli esponenti del sesso
opposto per un intervallo di tempo che, seppure
breve, consenta ai giocatori di apporre sul
proprio blocchetto il fatidico giudizio, dal quale
dipenderanno le sorti di un'eventuale storia
futura: i «sì», oppure i «no», decretati sulle
schede personali in riferimento ad un determinato
interlocutore, rappresentano, infatti, la base
sulla quale lo staff dell'organizzazione procederà
a rilevare le possibili affinità di coppia. Le
persone che risulteranno appaiate da questa
embrionale sintonia saranno poi messe al corrente
e lasciate libere di decidere se procedere o meno
sulla via della reciproca conoscenza.
Perché lo speed dating?
In un'epoca e in una società nella quale
trascorrere il tempo con calma ci fa sentire
derubati di qualcosa di estremamente prezioso,
tanto che la rapidità sembra essere la parola
d'ordine, non è poi così sorprendente che anche le
modalità e le caratteristiche dell'approccio
romantico siano cadute nella trappola della
«velocizzazione». Il cerimoniale del
corteggiamento, che un tempo si dipanava fra
tentativi, attese, incertezze, conferme,
ripensamenti, in un clima di suspence, di
aspettativa, ma anche di cospicuo investimento di
energie personali, non sembrerebbe più funzionale
in un'epoca in cui anche la tecnologia cospira
contro l'attesa in funzione dell'immediatezza.
Sognare romantici Principi azzurri e tenere
Cenerentole da conquistare sembra così cedere il
passo al pragmatismo, per cui ciò che davvero
importa è trovare un partner dotato di requisiti
che risultino utili nelle battaglie della vita
quotidiana.
In questo quadro costituito dalla fretta e dalla
praticità, cosa c'è di meglio che tradurre un
possibile preludio romantico in una rapida
negoziazione a tavolino, durante la quale, uomo e
donna, su un piede di assoluta parità, scoprono,
in una sorta di gioco, le carte che giudicano
migliori e più salienti?
Funziona davvero lo speed dating?
Per stare al passo con i tempi, e non si tratta
solo di una metafora, non resta dunque che cercare
di capire come possa funzionare questa modalità di
incontro, vale a dire se sussistano e siano
necessari determinati presupposti perché due
persone, in una manciata così esigua di minuti,
otto se non di meno, siano davvero in grado di
individuare nell'interlocutore quel qualcosa che
faccia loro presagire di avere trovato un partner
adeguato e talvolta definitivo.
Un ulteriore punto da chiarire è quello relativo
alle caratteristiche che trasformano uno speed
dating in un incontro di successo e, ancora, se
donne e uomini si cimentano in questa pratica
secondo il medesimo punto di vista, ossia con
aspettative e coinvolgimento analoghi.
Come sottolineano i ricercatori americani Eli J.
Finkel e Paul W. Eastwick (2008) della
Northwestern University, la letteratura sulla
percezione interpersonale, così come le ricerche
condotte da Nalini Ambady e Robert Rosenthal
(1992), sulla percezione relativa a piccole
porzioni del comportamento sociale, e da David
Kenny (1994), sulle percezioni a partire da «zero
conoscenza», costituisce un ottimo trampolino di
lancio per indagare il fenomeno dello speed
dating: da tali studi è infatti emerso che le
persone sono realmente in grado di esprimere
giudizi sociali accurati e differenziati anche
sulla base di osservazioni o interazioni
estremamente ridotte.
Altri ricercatori americani, Marian L. Houser,
Sean M. Horan e Lisa A. Furler (2008), riportano
che, nonostante il tempo per scambiarsi
informazioni sia estremamente ristretto in uno
speed date di media durata, gli studi svolti
sull'argomento hanno comunque messo in evidenza la
potenziale esistenza di una serie di elementi
comunicativi che influiscono significativamente
sull'esito di questa forma embrionale di
interazione: tra essi, la comunicazione
dell'attrazione reciproca e l'esternazione di una
comunanza di interessi. In sostanza, se due
estranei si trovano attraenti dal punto di vista
sia fisico che sociale, si percepiscono simili e
manifestano atteggiamenti di gradimento reciproco,
vi sono consistenti probabilità che al primo
incontro faccia seguito un secondo appuntamento.
Nel contesto dello speed dating, l'importanza dei
fattori comportamentali a scapito di elementi
ritenuti di solito rilevanti nel determinare le
scelte interpersonali, come l'entità dei guadagni
personali oppure il credo religioso, è stata
confermata anche da una ricerca svolta da alcuni
psicologi dell'Università della Pennsylvania su
più di 10.000 speed dater (Kurzban e Weeden,
2005).
Infine, esistono delle differenze, tra i due
sessi, per quanto riguarda l'analisi dei
comportamenti comunicativi tipici di una prima
interazione. Dagli studi emerge, in generale, che
le donne tendono a essere più attente e accurate
nella valutazione della comunicazione non verbale
e sono maggiormente competenti nell'interpretare i
segnali facciali rispetto ad altri canali
comunicativi; tuttavia, l'accuratezza percettiva
femminile diminuisce quando l'interlocutore
fornisce informazioni menzognere. Questo può
essere uno svantaggio in un contesto come quello
dello speed dating, nel quale l'esagerazione e la
bugia possono rappresentare allettanti strumenti
di riuscita (elemento che peraltro rappresenta una
delle maggiori critiche che sono rivolte a questo
tipo di approccio).
In sintesi, possiamo dire che rispetto ad altre
modalità di socializzazione i vantaggi offerti
dallo speed dating non sono da trascurare:
innanzitutto, ogni partecipante può contare sul
fatto che anche gli altri compagni sono motivati
dalle sue stesse finalità; in secondo luogo,
accettazione o rifiuto rimangono sulla carta e non
c'è l'obbligo di impegnarsi in spiegazioni faccia
a faccia, più o meno imbarazzanti. Infine, ma
questo forse è l'elemento di primaria importanza,
già in partenza si sa che anche il dispiacere
prodotto da uno speed date infelice sarà... di
breve durata.
Non solo per amore
Lo speed dating fornisce ai ricercatori una
preziosa opportunità, quella di acquisire nuove e
importanti informazioni sulle dinamiche
dell'attrazione interpersonale e di studiare le
relazioni diadiche potenzialmente romantiche «dal
vivo», consentendo anche di investigare in maniera
immediata ambiti quali i processi decisionali, il
pregiudizio, l'emozione, la memoria, la
socializzazione e la personalità in generale. Come
affermano Finkel e Eastwick (2007), gli psicologi
sociali e cognitivi potrebbero utilizzare questa
procedura per studiare l'associazione tra il
piacere interpersonale e il successivo ricordo
dell'interazione, così come gli psicologi delle
organizzazioni e del lavoro potrebbero avvalersene
per indagare se la propensione di una persona a
stringere rapporti di lavoro dipende dalla
similarità percepita nell'interlocutore. Insomma,
le vie dello speed dating sembrano infinite.
Quando lo speed dating funziona
Fabrizio, libero professionista di 40 anni, e
Giovanna (entrambi i nomi sono fittizi a
protezione dell'anonimato), grafica pubblicitaria
di 45, si sono conosciuti proprio durante un
incontro di speed dating; sono fidanzati da tre
anni e convivono da circa un anno: nel corso di
un'intervista ho raccolto le loro impressioni
sull'esperienza di speed dater, sentiamo cosa ne è
emerso. Entrambi raccontano di aver sentito
parlare del gioco da amici e di aver voluto
«provare» più che altro per divertimento e per
fare qualcosa di diverso dal solito. A proposito
del suo primo speed dating Giovanna ricorda:
«Cinque anni fa la trovai un'idea fresca,
frizzante, moderna. Un modo carino per conoscere
nuove persone. Ricordo che ne uscii entusiasta. Ho
partecipato a diversi speed dating nell'arco di un
paio d'anni e ovviamente nei primi c'è più
emozione e interesse». Fabrizio, da parte sua, in
merito alle sensazioni provate nel corso del suo
unico e «galeotto» speed dating confessa: «Ci si
sente un po' come in catena di montaggio... Ti
alzi e ti risiedi e ricominci da capo in pochi
minuti; all'inizio c'è un po' di imbarazzo, ma
passa presto».
Sia Giovanna che Fabrizio concordano sul fatto
che il tempo previsto dal gioco non sia
sufficiente per fare conoscenza, però come
sottolinea Giovanna: «È qui che entra in gioco la
fortuna e l'intuizione. Comunque, una volta finito
il gioco, in genere ci si scambia ancora qualche
chiacchiera, magari al bancone del bar, ed è lì
che si approfondisce la conoscenza».
Anche nell'ambito dello speed dating sembrano
valere le regole generali sulle differenze tra i
sessi in tema di attrazione. A proposito della
prima cosa che lo colpisce delle sue
interlocutrici, Fabrizio dichiara: «Lo sguardo e
il modo di parlare... l'aspetto fisico cerchi di
notarlo già dall'ingresso al locale!». Giovanna,
invece, a tale riguardo, riferisce di notare
soprattutto «se è sicuro di sé, tranquillo, a suo
agio e se sa affrontare una conversazione anche su
argomenti diversi».
Una delle critiche principali rivolte allo speed
dating riguarda il fatto che nel corso del gioco,
per dare di sé un'immagine maggiormente
accattivante, si può facilmente cadere nella
tentazione di dire bugie: «Io non ho mai mentito»,
afferma Giovanna, «ma conosco ragazze che
mentivano su molte cose. Una ad esempio si
spacciava per hostess, perché era convinta che
avrebbe rimorchiato di più».
Il fatto che questo tipo di gioco stia
riscuotendo un grande successo è ormai innegabile.
«In poco tempo e in un luogo circoscritto trovi
altre persone che come te sono disposte a nuove
amicizie e/o relazioni», spiega Fabrizio e
Giovanna aggiunge: «Tutti noi abbiamo sempre poco
tempo a disposizione e trovarsi una serata già
organizzata fa comodo a tutti. L'invito ti arriva
qualche giorno prima con sms sul telefonino,
bisogna solo dare la conferma e il gioco è fatto».
In questo caso, gli intervistati sono due speed
dater, per così dire, «riusciti». Qual è allora il
segreto del loro successo? In questo la
confessione di Giovanna è rivelatrice: «Penso che
nell'arco di tempo previsto dal gioco non sia
possibile innamorarsi, però... nel mio caso sì! A
mia discolpa però voglio precisare che lo avevo
già notato mentre facevamo la fila per
l'iscrizione. Un vero e proprio colpo di fulmine e
quindi, se consideriamo che il colpo di fulmine
colpisce appunto in un attimo, allo speed dating i
3 minuti sono un tempo lunghissimo per
innamorarsi!».
Ma non sarà che allora, divertimento e comodità
dello speed dating a parte, quello che alla fine
funziona è il caro, vecchio e proverbiale colpo di
fulmine...?
Jolanda Stevani
(«Psicologia contemporanea» n. 214/09)