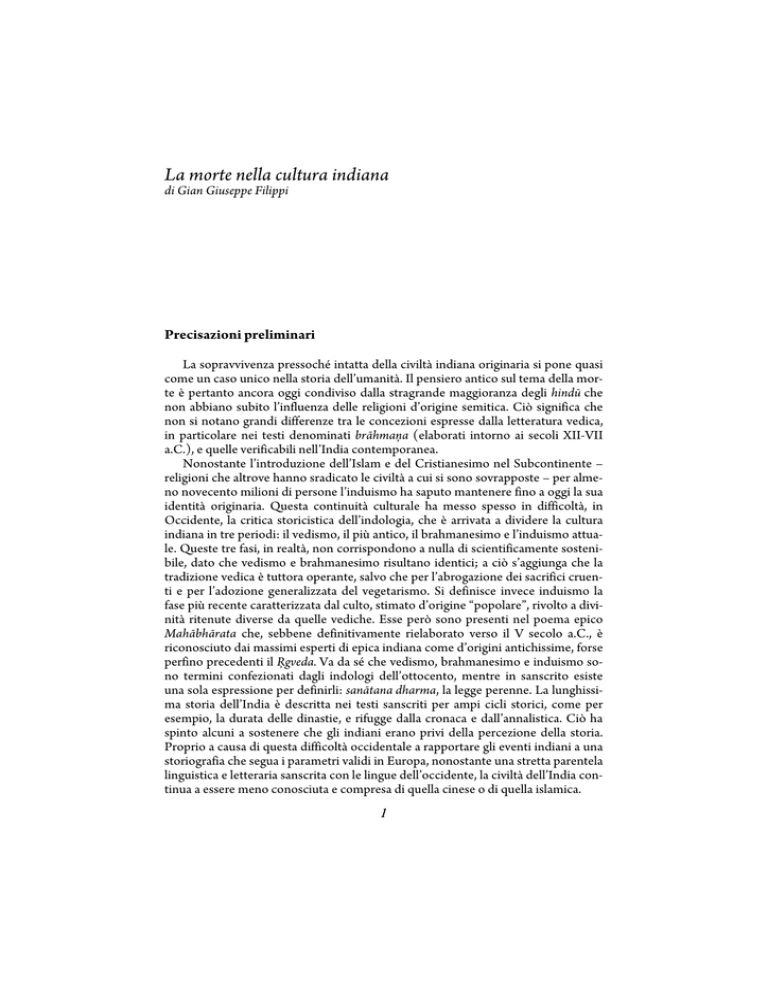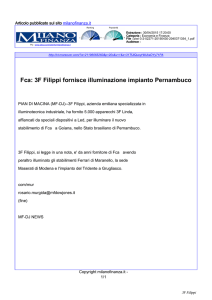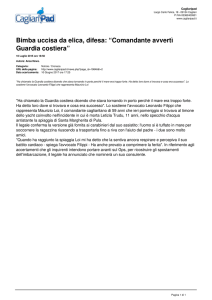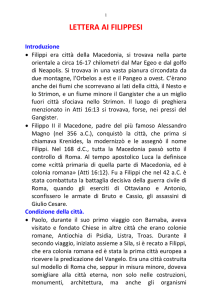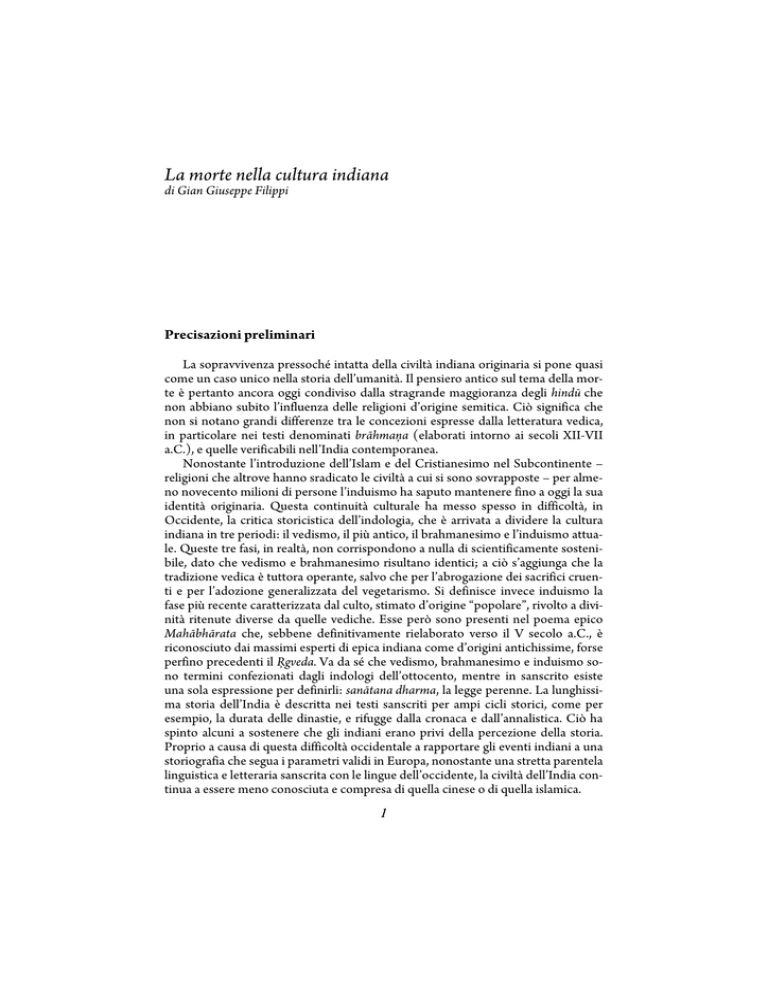
La morte nella cultura indiana
di Gian Giuseppe Filippi
Precisazioni preliminari
La sopravvivenza pressoché intatta della civiltà indiana originaria si pone quasi
come un caso unico nella storia dell’umanità. Il pensiero antico sul tema della morte è pertanto ancora oggi condiviso dalla stragrande maggioranza degli hindū che
non abbiano subito l’influenza delle religioni d’origine semitica. Ciò significa che
non si notano grandi differenze tra le concezioni espresse dalla letteratura vedica,
in particolare nei testi denominati brāhmaņa (elaborati intorno ai secoli XII-VII
a.C.), e quelle verificabili nell’India contemporanea.
Nonostante l’introduzione dell’Islam e del Cristianesimo nel Subcontinente –
religioni che altrove hanno sradicato le civiltà a cui si sono sovrapposte – per almeno novecento milioni di persone l’induismo ha saputo mantenere fino a oggi la sua
identità originaria. Questa continuità culturale ha messo spesso in difficoltà, in
Occidente, la critica storicistica dell’indologia, che è arrivata a dividere la cultura
indiana in tre periodi: il vedismo, il più antico, il brahmanesimo e l’induismo attuale. Queste tre fasi, in realtà, non corrispondono a nulla di scientificamente sostenibile, dato che vedismo e brahmanesimo risultano identici; a ciò s’aggiunga che la
tradizione vedica è tuttora operante, salvo che per l’abrogazione dei sacrifici cruenti e per l’adozione generalizzata del vegetarismo. Si definisce invece induismo la
fase più recente caratterizzata dal culto, stimato d’origine “popolare”, rivolto a divinità ritenute diverse da quelle vediche. Esse però sono presenti nel poema epico
Mahābhārata che, sebbene definitivamente rielaborato verso il V secolo a.C., è
riconosciuto dai massimi esperti di epica indiana come d’origini antichissime, forse
perfino precedenti il Ŗgveda. Va da sé che vedismo, brahmanesimo e induismo sono termini confezionati dagli indologi dell’ottocento, mentre in sanscrito esiste
una sola espressione per definirli: sanātana dharma, la legge perenne. La lunghissima storia dell’India è descritta nei testi sanscriti per ampi cicli storici, come per
esempio, la durata delle dinastie, e rifugge dalla cronaca e dall’annalistica. Ciò ha
spinto alcuni a sostenere che gli indiani erano privi della percezione della storia.
Proprio a causa di questa difficoltà occidentale a rapportare gli eventi indiani a una
storiografia che segua i parametri validi in Europa, nonostante una stretta parentela
linguistica e letteraria sanscrita con le lingue dell’occidente, la civiltà dell’India continua a essere meno conosciuta e compresa di quella cinese o di quella islamica.
1
L’Essere, gli esseri e l’esistenza
Quanto segue prenderà in esame la costituzione dell’uomo. È tuttavia bene
precisare che, nell’ottica indiana, ciò che qui si descrive è applicabile non solo agli
umani, ma anche agli altri esseri viventi provvisti di corpo, come gli animali e le
piante, seppure nelle modalità e forme che sono loro proprie (Filippi, 2011, pp. 7184).
Pur non potendo entrare nel dettaglio delle numerose e differenti dottrine metafisiche e ontologiche che si sono formate nel corso dei millenni, si cercherà di
sintetizzare in poche righe quelli che ne sono gli elementi comuni (Borman, 1990,
pp. 21-56). Anzitutto è necessario ritornare sul significato di sanātana dharma –
spesso reso impropriamente nelle lingue occidentali con “religione hindū” – che si
propone come una legge e un ordine che riguardano non solo gli esseri umani,
com’è il caso delle religioni abramiche, ma anche tutti gli altri esseri senzienti e non
senzienti. Con “essere”, sat, s’intende una possibilità precedente la sua manifestazione nel mondo, un’idea o archetipo, per usare una terminologia platonicoaristotelica, coeterna e unita all’Essere, Sat. Quest’ultimo è il participio presente
della radice verbale as, che è appunto il verbo essere; forse più letteralmente avremmo
potuto tradurla con i termini “essente” o “ente”, ma essi sarebbero potuti essere fuorvianti, dato che riecheggiano concezioni della filosofia e teologia occidentali.
Quando un essere (sat) è manifestato nel mondo, si trova proiettato nell’esistenza universale (bhavasamudra). Allora l’essere è definito bhāva, dalla radice bhū,
analogo al latino ex-sistere, che indica appunto lo stare fuori dall’Essere puro, Sat
(ovviamente l’uso delle maiuscole e delle minuscole è nostro, dato che in sanscrito
non si pone alcuna differenziazione grafica). L’Essere supremo, Sat, l’essere-archetipo,
sat, l’essere manifestato, bhāva, possono anche essere definiti puruşa. Questo spiega
perché si dica:
Nel mondo ci sono due puruşa, l’uno distruttibile e l’altro indistruttibile: il
primo è ripartito in tutti gli esseri; il secondo è l’immutabile. Ma v’è un altro Puruşa,
l’Altissimo (uttama), che si chiama Sé supremo (Paramātmā) e che, Signore
immortale, penetra e sostiene il triplice mondo. Poiché io supero il distruttibile e
l’indistruttibile, sono celebrato nel mondo e nel Veda con il nome di Puruşottama
(Bhagavad Gītā [d’ora in poi BG], XV. 16).
Gli esseri, bhāva, manifestati nell’esistenza cosmica e sottoposti al divenire, sono ulteriormente suddivisi in due categorie: coloro che appartengono alla prima
sono sottoposti a un ulteriore condizionamento, ovvero sono limitati dal nome e
dalla forma (nāma-rūpa). Queste due limitazioni ne fanno degli individui la cui
esistenza formale è definita vita, jīvan. Essi sono, oltre agli esseri umani, gli animali,
i vegetali e, secondo molte scuole di pensiero indiane, persino i minerali (Filippi,
2011, pp. 78-89). Il loro sé (ātmā) è quindi sottoposto alla condizione della vita,
motivo per cui è chiamato jīvātmā o anima. L’altra categoria di bhāva annovera tutti
quegli esseri che sono liberi dalle limitazioni dell’individualità, come per esempio le
2
gerarchie divine, il cui sé (ātmā), svincolato dal binomio nāma-rūpa, non è sottoposto alla condizione della vita; si tratta perciò di puri spiriti (ātmā), privi d’anima,
(jīvātmā). Questa categoria è paragonabile a quella degli angeli dei monoteismi,
anch’essi, come gli dei degli hindū, puri spiriti creati da Dio prima di tutti gli altri
esseri individuali. Va da sé che gli esseri manifestati, siano essi informali o formali,
avendo un’esistenza condizionata, essendo nati, dovranno pure morire (Filippi,
2005-2006, p. 51). Tuttavia gli esseri informali, gli dei, hanno un’esistenza di lunghissima durata, essendo manifestati assieme al mondo in cui devono sviluppare
quella loro esistenza; e proprio perché la loro esistenza è così lunga, essi dimenticano di essere nati e persino di dover morire. Per questa ragione presumono illusoriamente d’essere immortali. La morte degli dei, dunque, avviene con la dissoluzione
del loro mondo, mahāpralaya, come d’altronde narrano moltissime mitologie dei
più diversi popoli; dopo questo cataclisma, che Wagner denominò, con un’immagine colorita, “crepuscolo degli dei”, essi trasmigreranno immediatamente in un
altro grado d’esistenza (bhavanaṃ) (Filippi, 1996, pp. 11-13).
Gli esseri individuali (rūpavadbhāva), invece, pur essendo presenti nel mondo
per tutta la sua durata, sono costretti a una esistenza limitata nel corpo (deha). Solamente nei brevi termini di questa vita (jīvan) possono sviluppare la propria esistenza agendo liberamente: hanno così la possibilità di modificare in meglio o in
peggio il proprio destino, procurandosi una rinascita (punarjanma) in un mondo
successivo. Prima della nascita in un corpo, la presenza psichica dell’essere individuale in questo mondo si manifesta in forma seminale, in una condizione paragonabile a quella dei logoi spermatikoi dei neoplatonici. In questa condizione l’essere
individuale è del tutto inattivo, nell’attesa di essere rivestito di un corpo (dehin)
(Filippi, 2010, pp. 32-34). Similmente, dopo la morte del corpo, l’anima individuale (jīvātmā) stazionerà nei cieli (svarga) o negli inferni (naraka), in base ai meriti o
ai demeriti accumulati, in attesa della fine del mondo in cui svolse la sua breve vita;
anche in questa situazione l’anima individuale disincarnata si troverà impossibilitata ad agire e quindi a modificare il suo destino futuro, godendo o soffrendo passivamente gli effetti delle azioni compiute nel corso della vita corporea. Dopo questa
sosta nei prolungamenti sottili della propria individualità in attesa della fine del
tempo ciclico, kalpa, riservato a quel mondo, l’essere (bhāva), lasciata quella forma
di vita (jīvan), trasmigrerà in un altro grado d’esistenza (bhavanaṃ). È questa, in
breve, la dottrina della rinascita delle anime (punarbhava) o saṃsāra, operata in
base alle opere (karman) compiute in vita (Filippi, 2010, pp. 137-141).
Come si può notare, quindi, nel pensiero hindū con “vita” (jīvan) s’intende esclusivamente l’esistenza degli esseri individuali sottoposti alle condizioni di nāmarūpa. Con tale termine non solamente si definisce però il ristretto periodo di tempo passato in un corpo, ma anche la situazione inattiva prenatale (piņḍa avasthā) e
quella postuma (pitŗavasthā). In altre parole, l’individuo è vivo in questo mondo
caratterizzato dal nome e dalla forma (nāmarūpavat) prima, durante e anche dopo
la vita nel corpo (Filippi, 2006, pp. 204-213). Per le ragioni appena esposte, per gli
indiani “vita” è un termine che, da un certo punto di vista, ha un senso più limitato
e, da un altro, molto più ampio di quello che si ritrova nelle teologie e filosofie
3
dell’Occidente. Analogamente, anche la morte è concepita in modo assai differente. Infatti, come si diceva sopra, tutti gli esistenti (bhāva) e, tra questi, persino gli
dei, sono sottoposti alla morte (mŗtyu), in quanto sono manifestati nell’esistenza
universale. Anche quei bhāva che vivono una esistenza individuale, quindi particolarmente limitata, all’esaurirsi della vita (jīvan) s’imbattono nella morte (mŗtyu,
maraņa). Il fatto è che, come si ricorderà, questo passaggio, per loro, avviene a conclusione dell’intera esistenza individuale, non solamente limitata alla fine della vita
nel corpo: questo è invece l’unico senso che ha la parola “morte” nelle civiltà occidentali (Ghosh, 1989, pp. 13-14). La fine della vita corporea, in India, è definita
dehānta, che, appunto, significa “fine del corpo”. Questa idea della morte corporea
è illustrata dalla seguente immagine: “Quando il soffio vitale se ne esce dalla spoglia,
il corpo cade come un albero abbattuto” (Preta Mañjarī [Garuḍa Purāņa, GP], II. 31.
28).
Morte, ri-morte e immortalità
Come si è accennato, l’esaurimento completo della vita, compresa quella passata nei prolungamenti psichici, rappresenta la morte (maraņa) dell’anima vivente
(jīvātmā). Il bhāva, libero così anche dalle componenti sottili della individualità
appena abbandonata, può trasmigrare o
per assumere una nuova individualità o
per migrare in una condizione sopraindividuale. Questo processo è definito rinascita, punarjanma (Caland, 1893, pp. 181193). Naturalmente, considerando che
nell’ottica hindū la manifestazione universale contiene un illimitato numero di
mondi, loka – detti anche gradi di esistenza (bhavana), che si succedono in
una illimitata serie di cicli cosmici (kalpa)
– ogni rinascita è necessariamente seguita da una ri-morte, chiamata punarmŗtyu:
“Ogni avanzamento da uno stato dell’essere a un altro, sebbene sia una “ri-morte” (punarmŗtyu), è considerato da un
punto di vista vedico come un passaggio
da una stazione a un’altra di un viaggio
[…]” (Coomaraswamy, 19771, p. 405).
Da ciò si deduce che rinascite e ri-morti
si succedono perpetuamente per un singolo essere posto in esistenza (bhāva) e
Fig. 1 – Mŗityu, con mazza e cappio, in una così condannato a migrare di ciclo in
scultura contemporanea.
ciclo, indipendentemente dal fatto che
4
queste nuove esistenze, punarbhava, siano per lui migliori o peggiori delle precedenti. Fanno eccezione i perfetti realizzati, mukta, i quali ottengono la liberazione
(mokşa, mukti) dalla corrente del saṃsāra, identificandosi così con il Principio metafisico stesso. Costoro, per raggiungere tale grado spirituale supremo, devono
ottenere l’estinzione, nirvāņa, della propria esistenza manifestata. Essi devono vincere o con-vincere il dio della morte, Mŗityu, e diventare immortali, amara o amŗta
(Filippi, 2001, pp. 42-43). Lasciando da parte questo argomento della morte iniziatica (Filippi, 2004, pp. 65-79), sarà comunque interessante considerare che il
dio della Morte rappresenta il limite della manifestazione oltre la quale si è proiettati nella dimensione metafisica e ultracosmica. Il passaggio oltre Mŗityu avviene in
termini esattamente paragonabili al “passaggio al limite”, che permette di uscire da
una concatenazione numerica per passare a una realtà qualitativamente superiore.
Per questa ragione il dio della morte è il sole, sūrya, che illumina dall’alto e manifesta tutti i mondi, ma che, al tempo stesso, è la porta per uscire dal cosmo, sūryadvāra. Mŗityu è dunque la morte che conduce al di fuori dell’esistenza, dove i singoli
esseri, sat, s’identificano con l’unico Essere supremo, Sat, “un principio che anima
e dà forma a un corpo dopo l’altro, non essendoci nessun altro che trasmigra da un
corpo all’altro, che mai nasce e mai muore, pur presiedendo ogni nascita e morte” (Coomaraswamy, 19772, p. 428). Per questa ragione è detto che la morte è
“una, in quanto è lassù, e molteplice, in quanto è nei suoi figli” (Śatapatha
Brāhmaņa, ŚB, X. 5. 2. 16), essendo il sole la morte suprema, Mŗityu, e i suoi figli
tutti gli innumerevoli punarmŗtyu, le singole ri-morti (Filippi, 2001, pp. 26-40). Sia
detto per inciso che l’immortalità (amŗtatā), cui si è fatto cenno a proposito della
vittoria sulla morte, è considerata in un senso puramente spirituale. Non si trova
infatti nella cultura indiana alcun ideale di immortalità corporea. Sono menzionati
soltanto sette casi di longevità straordinaria, cirańjīvan, che concernono esclusivamente dei personaggi mitologici incaricati di speciali missioni, i quali dovranno
comunque morire prima della fine del mondo in cui si sviluppa l’attuale umanità.
La morte come fine del corpo
Dopo le precedenti precisazioni d’ordine metafisico e cosmologico, ci si può
occupare della fine del corpo (dehānta), ossia della morte com’è comunemente
intesa in Occidente (Filippi, 1995, pp. 117-121). Anche in questo caso una puntualizzazione non è eludibile: in genere non si contrappone la morte (dehānta) alla
vita (jīvan), come si suole fare dalle nostre parti, ma la si paragona alla nascita
(janma). Come fa notare Franklin Edgerton, la nascita e la morte sono un cambiamento di stato rappresentato dal simbolismo del passaggio; per esempio, una porta
attraverso cui si passa può essere considerata, di volta in volta, sia come un’entrata sia
come un’uscita (Edgerton, 1926-27, p. 222). La porta, di per sé, non è null’altro se
non la soglia che permette il passaggio tra due ambienti. Come la discesa e la salita,
anche l’entrata e l’uscita sono determinate dal senso del movimento di chi cammina. È
dunque la coscienza dell’essere che compie il passaggio che stabilisce quando la porta
5
deve essere considerata un’entrata e quando un’uscita: “Nascita e morte non sono mai
state considerate dagli antichi come fenomeni molto diversi. Essi sono due inseparabili aspetti di un e medesimo ciclo di rigenerazione. La morte è il precursore della futura
nascita” (Atre, 1986, XLV, p. 1).
Una conseguenza immediata è che se il passaggio morte-nascita è il solo e medesimo fenomeno, considerato da due punti di osservazione diversi e in successione temporale tra loro, lo stesso non può dirsi del binomio inverso nascita-morte. Questi due
termini infatti non coincidono, poiché tra di essi si interpone una durata, nel corso
della quale, e contenuta proprio tra gli stabiliti limiti di nascita e morte, si sviluppa una
determinata esistenza, che nel nostro mondo è la vita corporea. Infatti, se l’entrata
simboleggia la nascita e l’uscita rappresenta la morte, tra l’entrata e l’uscita si deve percorrere per intero la lunghezza della stanza (Filippi, 2010, pp. 11-12).
Si è detto che la longevità (cirańjīvan) è un dono straordinario concesso soltanto a
cinque individui. Ciononostante, anche in epoca recente, alcuni uomini si sono impegnati con tecniche ascetiche a raggiungere una parziale longevità (āyuşya) al fine di
godere di una vita sufficientemente lunga da ottenere la liberazione (mukti). Questo
fenomeno non arresta il declino fisico, ragion per cui non si deve confondere la longevità ottenuta in virtù di discipline ascetiche con ciò che è definito impropriamente
“eterna” giovinezza. Il prolungamento artificiale di un aspetto perennemente giovanile
(kaumārakāya), generalmente da sedicenne, com’è perseguito con la tecnica detta
kāya sādhana della scuola yogico-alchemica siddhā (Varenne, 1997, pp. 98-101), subisce una brusca interruzione non appena lo yogi interrompe la sua concentrazione;
allora egli invecchierà repentinamente, acquisendo un aspetto corrispondente alla sua
vera età, la decrepitezza e, qualora la giovinezza artificiale avesse superato la quantità
di tempo concesso ordinariamente alla sua vita, persino la morte (Filippi, 1996, pp.
101-102).
Come norma generale, la scrittura, śruti, indica in cent’anni il limite della vita umana in questo periodo ciclico (Ŗgveda, ŖV, VII. 66. 16; VII. 10. 161). Tale traguardo è
oltretutto difficile da raggiungere (GP, II. 24. 1-2) a causa degli effetti del karman negativo (GP, II. 24. 10). Quest’ultimo può essere però dissolto compiendo i riti prescritti (GP, II. 24. 33). In casi del tutto eccezionali, nella presente Età Oscura, si può
raggiungere al massimo i centoventicinque anni, ma pochissimi sono così virtuosi da
arrivarvi(Parry, 1989, pp. 496-497).
Perciò, anche nella prospettiva ascetica, la lunghezza della vita è celebrata e perseguita, tanto che il raggiungimento dei limiti estremi della permanenza nel corpo è considerato espressione di una buona morte, sumara (Filippi, 2004, p. 65). A una più
attenta osservazione appare infatti evidente che l’orrore per la morte e la sua conseguente contrapposizione alla gioia della vita concernono esclusivamente la morte prematura: “Proprio destinata a te, o vecchiaia, questa persona cresca, non le nuocciano
le altre morti che sono cento” (Lazzeroni, 1988, pp. 181-183). Tra i cento diversi pericoli di morte prematura, tra incidenti, delitti e malattie, non è compresa la morte in
guerra, che è parificata al sacrificio e che ha pertanto una valenza sacrale: “Felici quei
guerrieri che, in una battaglia come questa, trovano una porta per il cielo” (BG, II. 32).
6
Lo svolgimento delle facoltà individuali
Ritornando alla concezione che vede nell’esistenza corporea il periodo vitale compreso tra i limiti speculari di nascita-morte, risulterà ora evidente come sia sottintesa in
essa la dottrina ciclica del tempo, caratteristica della cosmologia hindū. Il ciclo vitale è
così considerato in armonia con il ciclo diurno, che si svolge tra alba e tramonto, con il
mese lunare, tra il primo falcetto lunare crescente e la luna nuova, con l’anno, tra la
primavera e l’inverno, e così via. La vita
umana nel corpo è intesa in questa precisa prospettiva. La crescita è, pertanto, un
allontanamento da quella soglia che è
stata l’entrata in questo mondo. La prima
parte della vita appare dunque come un
passaggio dalla potenza all’atto, ovvero
come il processo di manifestazione e sviluppo delle potenzialità vitali geneticamente presenti nell’individuo fin dalla
nascita. Il mezzogiorno della vita coincide
con la maturità, nella quale l’uomo è nel
pieno delle sue forze, con tutte le sue caratteristiche psichiche e fisiche pienamente attive e sviluppate. All’apice della
maturità, la nascita del primo figlio maschio è il primo segnale dell’imminente
riavvolgimento delle energie psicosomatiche, a cui seguirà una lenta ritrazione
dalla vita sociale; da questo momento, in
cui appare al mondo chi potrà sostituirlo Fig. 2 – Punarjanm in una stampa popolare
nella famiglia e nella società, l’individuo contemporanea.
comincia a brillare di luce meridiana (Filippi, 1996, p. 85). La vita, dapprima quasi impercettibilmente, poi lentamente, comincia a volgere al declino; ciò andrà aumentando progressivamente di velocità con il
passare degli anni. Questo ciclo vitale è segnato da alcune tappe che corrispondono
all’attivazione dei sensi, jñanendriya, delle facoltà di azione, karmendriya, e del senso
interno, la mente, manas. I cinque sensi sono ben noti e non ci attarderemo a descriverli. Ricorderemo soltanto che gli organi corporei corrispondenti alle funzioni dei
sensi sono: l’orecchio per l’udito, la pelle per il tatto, l’occhio per la vista, la lingua per
il gusto e il naso per l’odorato. Le cinque facoltà di azione e gli organi corporei per
mezzo dei quali i karmendriya agiscono nel mondo sono: la parola e il suo organo la
lingua; la prensione, che si serve delle mani (ma talora della bocca, come, per esempio,
fanno gli animali); la deambulazione, che usa i piedi; la generazione e gli organi genitali; la escrezione, che usa gli organi di deiezione, pori sudoriferi compresi. Quanto alla
mente, essa riceve gli stimoli del mondo esterno dai sensi per poi reagire con ordini
alle facoltà d’azione tramite lo strumento del cervello, mastişka (Filippi, 2010, pp. 82-85).
7
Venendo al mondo, dunque, il neonato anzitutto mette in atto l’escrezione con lo
zampillo di pipì elicitata dalla prima inspirazione (Filippi, 2010, pp. 39-40). Segue lo
sviluppo della prensione, dapprima esercitata dalla bocca per afferrare i seno materno,
poi dalle manine. Tramite la prensione il bimbo attiva anche il senso del tatto. Verso i
quaranta giorni si stabilizza il senso della vista: il bimbo, infatti, alla nascita appare quasi cieco. Con il passaggio a un cibo diverso dal latte materno, il bimbo sperimenta anche il senso del gusto. In seguito egli comincia a distinguere il significato di alcune
parole che gli vengono rivolte, sviluppando così il senso dell’udito. Verso il volgere del
primo anno di vita il bambino comincia a deambulare, prima a quattro zampe, poi
drizzandosi in piedi. Subito dopo comincia a sillabare e a pronunciare le prime semplici parole. Ultima facoltà di sensazione ad apparire, verso l’inizio del secondo anno di
vita, è l’olfatto. Infine l’ultima facoltà di azione a diventare operativa è la generazione
che, con una piccola discrepanza temporale tra le femmine e i maschi, s’attiva con la
pubertà. La mente invece, in concordanza con le usanze diffuse presso tutte le civiltà,
si considera sufficientemente attiva verso i sei-sette anni, età in cui i fanciulli sono per
la prima volta affidati ai maestri. Naturalmente, tutti questi undici indriya raggiungono
la massima efficienza durante la maturità, che in India si pensa sia raggiunta tra i venticinque e i trentacinque anni.
Il riavvolgimento delle facoltà individuali
Un processo speculare rispetto a quello dello sviluppo prende forma nell’invecchiamento (Caraka Saṃ hitā, I. 3. 4). La progressiva ritrazione dai loro organi periferici delle facoltà di sensazione e d’azione verso la sede centrale del cuore è considerata
l’inizio della decadenza che porterà alla morte:
“Parlerò”, disse la parola; “Vedrò”, disse l’occhio; “Ascolterò”, disse l’orecchio.
La stessa cosa dissero tutti gli altri [indriya] affermando la loro attività. La morte,
mettendosi in azione, li vinse, li strangolò, li neutralizzò. Per questo motivo la
parola si fiacca, e parimenti accade all’occhio e all’orecchio. La morte però non
riuscì ad aver ragione del prāņa che sta nel centro [degli indriya]. Gli altri
pensarono: “Il migliore di noi è questo [prāņa], che non soffre pericolo o danno, sia
che si muova, sia che stia fermo. Ognuno di noi diventi dunque un suo componente
secondario” [...] (Bŗhadāraņyaka Upanişad, BU, I. 4. 21).
In altri termini, gli organi di senso e d’azione, che erano le porte d’informazione
verso l’ambiente esterno e gli strumenti per mezzo di cui interagire, si fanno ottusi
e progressivamente si occludono a causa del lento inviluppo delle facoltà psichiche,
indriya, che li animano. La prima ritrazione colpisce la facoltà della generazione,
più evidente nelle donne con il fenomeno della menopausa, che segna l’inizio del
declino degli appetiti del piacere, kāma. Anche la mente, poi, comincia a ritirarsi
dal suo organo funzionale corporeo, il cervello, con l’attenuazione dell’interesse
nei confronti del flusso incessante delle sollecitazioni provenienti dal mondo ester8
no, e intervenendo attivamente in quest’ultimo sempre più svogliatamente. La
mente tende a riavvolgersi in se stessa in un riordino dei dati immagazzinati nella
memoria, a partire da quelli più recenti, per poi riconsiderare quelli più antichi.
L’anziano tende a rifugiarsi nella memoria del passato e, man mano che invecchia,
egli richiama alla mente i ricordi della sua giovinezza per poi sprofondare in direzione dell’adolescenza e dell’infanzia. In questa revisione egli consuma ed esaurisce
gran parte dei dati registrati, ovvero cancella i ricordi più recenti, apparendo così ai
suoi famigliari smemorato, prigioniero delle rimembranze puntigliose del più remoto passato. Il disinteresse verso il mondo esterno prosegue con l’indebolirsi
dell’olfatto, della voce, dell’udito, l’incertezza nella deambulazione, la perdita del
gusto, la presbiopia che s’aggiunge ad altre debolezze della vista, la progressiva insensibilità del tatto, il tremolio delle mani e l’incontinenza senile (Filippi, 1996, pp.
105-108). Naturalmente questo declino raggiunge il suo apice sul letto di morte,
allorché il corpo perde anche le ultime capacità di spostarsi dal giaciglio, per poi
non ascoltare più: “Quando un infermo sta per trapassare, gli astanti gli chiedono:
«Mi riconosci? Mi riconosci?». Ma egli continua a riconoscerli fino a quando non
abbandona il corpo” (Chāndogya Upanişad, ChU, VIII. 6. 4). La congiunzione avversativa “ma”, con cui inizia la seconda parte dello śloka citato, sottintende che,
pur udendo, il morente non è più in grado di rispondere. Anche la vista se ne va, le
mani giacciono inerti e, alla fine, il morente interrompe la comunicazione per mezzo della parola, richiudendosi in se stesso. Subentra l’incoscienza, il coma, tāmasi
nidrā, (Suśruta Saṃhitā, I. 4. 33). Si arresta anche la facoltà dell’escrezione, con il
conseguente rilassamento dei muscoli di controllo. “La parola [assieme agli altri
indriya] del morente si ritira nella mente, la mente nei soffi vitali, i soffi vitali nel
calore, tejas, il calore nella divinità a lui superiore [l’anima, jīvātma]” (ChU, VI. 8.
6). Oppure:
Quando lo spirito si indebolisce e sembra svanire, allora tutti i sensi si affollano
attorno a lui; esso, riassumendo in sé questi elementi vitali, si concentra all’interno
del cuore. Quando la facoltà che dimora nell’occhio se ne ritorna, allora esso non
distingue più le forme. Allora si dice che esso non vede, non fiuta, non gusta, non
parla, non ascolta, non pensa, non tocca, non conosce, perché tutte queste cose
sono in esso una sola cosa. Allora l’apice del suo cuore brilla. Attraverso l’apice che
brilla, l’anima se ne esce o attraverso l’occhio, o attraverso la testa, o attraverso
qualsiasi altra parte del corpo. Quando esso se ne va, il prāņa lo segue, e quando se
ne va il prāņa , tutti gli altri spiriti vitali [gli undici indriya] lo seguono (BU, IV. 4. 12).
E ancora: “Ora l’udāna è il calore corporeo. Per questo, quando il calore [tejas]
del corpo s’è estinto, assieme agli indriya che si sono già ritratti nella mente, assieme alla sua coscienza [citta], in qualunque stato essa sia, e ai soffi vitali, procede
verso la rinascita” (Praśna Upanişad, III. 9). Per inciso, qui con udāna non
s’intende il semplice atto dello spirare. Infatti all’esalazione dell’ultimo respiro il
calore corporeo non se ne va con esso. Udāna, in questo caso, è dunque l’uscita
9
attraverso i canali sottili, nāḍ ī, con cui lo spirito vitale se ne va al di fuori del corpo
grosso. Una volta attuato questo riavvolgimento dei sensi e chiuse le porte di comunicazione con il mondo, la mente non ha più esperienza dell’ambiente esterno.
Manas si trova dunque in una situazione analoga a quella sperimentata nello stato
di sogno: questa volta, tuttavia, il ritorno allo stato di veglia è reso arduo per il decadimento degli organi e del corpo in generale (Filippi, 19782, pp. 21-22). Questa
condizione di coscienza del morente corrisponde alla fase della vita intrauterina del
feto, considerato specialmente nel periodo in cui, in caso di nascita prematura, la
sopravvivenza è possibile (Filippi, 1992, pp. 273-274). La mente è impegnata nella
revisione dei dati della propria memoria in una ridda di impressioni incongruenti.
Queste rappresentazioni oniriche sono costrette dalla mente a una reductio ad unum, che, quando avviene, mette in quiescenza le attività mentali. Allora, come s’è
visto nei passi testuali citati, la mente si ritira nei prāņa, qui intesi non solamente
nel senso dei soffi che permettono la prosecuzione della respirazione, ma come
principi della vita vegetativa. In questa fase la coscienza individuale tende a uscire
dallo stato di sogno, senza tuttavia passare ancora a quello di sonno profondo. Il
corpo giace immobile in coma, rimanendo sulla porta che mette in comunicazione
i due diversi stati di sogno e di sonno profondo. Questa è la soglia della morte, dalla quale tuttavia è pur sempre possibile tornare. Infatti:
Lo stato d’incoscienza è in parte un tipo di sonno profondo e in parte un altro
[stato di sogno]. Abbiamo già mostrato la somiglianza e la diversità [della perdita di
coscienza] con il sonno profondo. Questa è la porta della morte. Se il karman
dell’individuo non è concluso, la sua parola e la mente [e gli altri indriya] ritornano
dallo stato d’incoscienza. Ma quando non vi è più alcun residuo di karman [da
compiere], il suo respiro e il suo calore se ne vanno (Brahma Sūtra Śaṃ kara Bhāşa,
III. 2. 10).
La soglia tra due stati di coscienza è considerata un luogo pericoloso. Colui che
sogna ed entra naturalmente nello stato di sonno senza sogni – come quando ritorna dallo stato di sogno a quello di veglia – non fa altro che sperimentare, senza alcun pericolo, un continuum naturale di coscienza. L’arrestarsi sulla soglia tra due
domini rappresenta invece una interruzione di tale continuum. Lo iato temporale
tra due cicli mette in comunicazione i due domini temporali successivi, ma può
essere anche la porta d’uscita dall’intero cosmo (Filippi, 2012, pp. 237-247). Così
pure la porta lunare può essere l’uscita dal mondo terrestre e l’entrata in un’altra
dimensione della terra. O la porta solare che permette il raggiungimento dell’immortalità. Per esempio, nel mito della discesa di Vişņu come uomo-leone, il dio
supremo si nasconde nello stipite della porta per divorare chi si trova “né in casa né
fuori casa”. E ancora Indra uccide il demone Namuci alla porta del crepuscolo,
poiché il demone non poteva morire né di giorno né di notte. Da queste concezioni si comprende anche perché sia considerato molto pericoloso richiamare troppo
bruscamente alla veglia un dormiente.
10
Le fasi dell’abbandono del corpo
Il moribondo ora giace sul suo giaciglio e gli astanti sono colti dal dubbio se la
morte sia già avvenuta. È questo il momento in cui cominciano i controlli per accertare il decesso. Il primo consiste nel verificare se l’agonizzante respiri ancora,
ponendogli davanti alla bocca uno specchio. A livello empirico, la constatazione
della morte consiste infatti principalmente nella verifica dell’esalazione dell’ultimo
respiro. Questo è dovuto al fatto che al momento della nascita la forza vitale, l’aria
di Vişņu (espansione), era penetrata nel corpo del bimbo per mezzo della prima
energica inspirazione. La morte, come è descritta dai miti, è sempre considerata
come colei che ruba il respiro dei vivi, che soffoca e strangola il morente. Per questa ragione gli dei della morte sono raffigurati come armati di un cappio. La stessa
difficoltà di respiro, le malattie polmonari o l’oppressione della regolare respirazione causata da un incubo sono considerate premonizioni della vera e propria morte.
In particolare, gli incubi, uragraha, sono immaginati come esseri sottili che opprimono il petto dei dormienti, talvolta fino a procurarne morte per soffocamento.
Ciò ha delle implicazioni erotiche, le quali si riscontrano anche nella morte per
strangolamento o impiccagione (Filippi, 1997, cap. VII).
La cessazione del respiro comporta l’arresto della circolazione dei fluidi corporei, primo tra tutti il sangue. Il cuore rallenta e poi si arresta. Il sangue non irrora
più gli organi corporei. Cessa il ricambio di elementi provenienti dall’esterno e la
conseguente espulsione di scorie che garantivano la vita. All’arresto del circolo
sanguigno si conclude l’esperienza “animale” della vita. Nondimeno l’effimera prosecuzione della circolazione linfatica mantiene il morente in uno stadio di vita vegetativa (da ciò si deduce erroneamente che il coma, in cui sprofondano alcuni
malati pur conservando attività cardiaca e respirazione, sia una condizione di “vita
vegetativa”). Quando l’individuo si trova in vita vegetativa, il ripristino delle attività
cardiache e polmonari è ancora possibile e, con esso, il ristabilirsi della “vita animale” o, se si preferisce, l’uscita dalla morte apparente. Normalmente la linfa continua
dunque a circolare per inerzia ancora per breve tempo; infine il suo arresto apre la
strada alla putrefazione, che parte dagli organi più delicati in cui tale liquido corporeo si concentra.
L’arresto della respirazione e del battito cardiaco non sono tuttavia segno definitivo della morte avvenuta. Come s’è visto, tutte le facoltà di percezione sensoriale
e di azione, con l’aggiunta della mente e dei soffi vitali, alla fine si riassorbono nel
calore, tejas. Il calore è, dunque, la vita; la differenza tra un corpo vivente e un cadavere è pertanto definitivamente segnalato dal raffreddamento. L’anima vivente,
jīvātmā, è dunque la sede del calore: il raffreddamento del corpo segna il progressivo trapasso dell’anima verso un altro stato d’esistenza. Come s’è già letto nelle citazioni, tutte le facoltà individuali, abbandonando la periferia corporea, si concentrano all’interno, in direzione del cuore. Quando tejas si riassorbe nell’anima vivente,
la concentrazione di calore si trasforma in una luce brillantissima. Avvolta in questa
forma luminosa, l’anima abbandona il corpo composto dai cinque elementi, bhūta
(Filippi, 1995, pp. 117-121), uscendo da una delle sue numerose aperture. Per
11
accertare la morte, il medico ayurvedico, ossia il cultore di medicina tradizionale
indiana, appone sul petto del morente, in prossimità del cuore, una pallina di burro
chiarificato, ghŗtha o ghī. Se il corpo è ancora caldo, il ghī si scioglie rapidamente.
La pallina di burro va allora sostituita ripetutamente finché non s’arresta lo scioglimento. Generalmente il momento in cui essa non fonde più coincide con i 25° centigradi, pur variando a seconda della temperatura dell’ambiente. Nel frattempo si
manifesta il rigor mortis (Filippi, 1996, pp. 122-127). A questo punto il medico
ayurvedico, che è preposto a preservare la vita corporea, si ritira per lasciare il proprio posto al sacerdote, medico della vita extracorporea (Caland, 1896, p. XII).
Naturalmente, nei periodi di calura estiva la prova del ghī è meno determinante: si
preferisce allora attendere i primi segni di decomposizione, ovvero gli umori che
colano dalle narici e dall’orecchio, il che avviene entro le ventiquattro ore dalla
dipartita. È questo il vero e proprio momento della morte alla vita corporea.
Nella āyurveda non vi è alcuna forma di accanimento terapeutico: la medicina
tradizionale infatti, pur essendo presente in India in più di una quarantina di facoltà universitarie e in vari centri di ricerca d’eccellenza, non ha mai fatto ricorso a
quelle tecnologie che pongono tanti problemi bioetici alla medicina allopatica.
Tantomeno si è riscontata alcuna interferenza nelle cure ayurvediche da parte della
magistratura. D’altronde i testi antichi in sanscrito lasciano aperte molte possibilità: vi si narra addirittura di trapianti di arti e organi (persino di teste!) o del trasferimento di feti da un utero all’altro. Ma questa è un’altra storia (Filippi, 1991, pp.
9-15; 202-237).
In sintesi, il processo della morte si esprime attraverso le seguenti fasi: esalazione dell’ultimo respiro, raffreddamento del corpo e comparsa del rigor mortis, primi
segni di decomposizione. In presenza di questi fenomeni si può quindi affermare
che l’individuo è stato divorato dalla bocca della morte (Filippi, 19781, pp. 79-81)
e che i suoi resti dovranno essere distrutti da uno dei cinque elementi che li compongono: la terra, con l’inumazione; l’acqua, con l’abbandono del cadavere alla
corrente d’un fiume; il fuoco, con la cremazione; l’aria, con esposizione; infine
l’etere, con l’abbandono del cadavere in una grotta o altra cavità (Filippi, 1997, pp.
183-190; Filippi, 2006, pp. 311-322).
In conclusione, si coglie l’occasione per ribadire che nell’induismo non è mai
stata concepita la possibilità di una rinascita su questa terra: “Quando è strappato
con le radici, nemmeno l’albero può più rinascere. L’uomo colpito dalla morte da
quale radice mai potrà risorgere? Chi è nato più non rinasce; chi mai potrebbe farlo
rinascere? [...]” (BU, III. 9. 28. iv-vii). “Da vivo si può ottenere il risultato del karman positivo: si può ottenere un villaggio, una proprietà, una casa, un cavallo o
ricchezze; ma mai si può ottenere indietro un corpo umano” (GP, II. 49. 19). Le
teorie reincarnazioniste pertanto o appartengono in toto alle fantasie occidentali o
sono dovute alla più completa incomprensione della dottrina della trasmigrazione
(Filippi, 2010, p. 143, n. 45).
12
Bibliografia
Abegg E. (1921). Der Pretakalpa des Garuḍ a-Purāņa. Berlin und Leipzig: W. De Gruyter.
Atre Sh. (1986). Many Seeds Apple: The Fruit of Fertility. Bulletin of the Deccan College, 45,
pp. 1-16.
Baldissera F. (1989). Le Grandi Madri che uccidono. ACME, 42 (3), pp. 5-10.
Bhishagratna K.L. (Ed.) (1991). Sushruta Samhita (Vols. 1-3). Varanasi: Chowkhamba
Sanskrit Series.
Borman W.A. (1990). The Other Side of Death: Upanisadic Eschatology. Delhi: India Book
Centre.
Caland W. (1893) Altindische Ahnencult. Leiden: Brill.
Caland W. (1896). Die altindischen Todten- und Bestattungsgebräuche mit Benutzung handschriftlicher Quellen dargestellt. Amsterdam: Müller.
Coomaraswamy A.K. (1977)1. Flood in Indian Tradition. In Lipsey R. (Ed.), Coomaraswamy 2: Selected Papers. Metaphysics (pp. 398-407). Princeton: Princeton University
Press.
Coomaraswamy A.K. (1977)2. Meaning of Death. In Lipsey R. (Ed.), Coomaraswamy 2:
Selected Papers. Metaphysics (pp. 426-429). Princeton: Princeton University Press.
Edgerton F. (1926-27). The Hour of Death: Its Importance for Man’s Future Fate in
Hindu and Western Religions. Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, 8
(3), pp. 219-249.
Eggeling J. (Ed.) (1963). The Śatapatha-Brāhmaņa (Vols. 1-5). Delhi: Motilal Banarsidass.
Filippi G.G. (1978)1. Kīrttimukha e Kālamukha. Annali di Ca' Foscari, 17 (3, SO 9), pp. 7987.
Filippi G.G. (1978)2. Mort et Libération d’après Śaṃkarācārya. Milano: Archè.
Filippi G.G. (Ed.) (1991). Salute Malattia Morte: India ed Europa a confronto. Milano:
I.p.L.
Filippi G.G. (1992). The Secret of the Embryo according to the Garbha Upanişad. Annali
di Ca' Foscari, 31 (3, SO 23), pp. 271-279.
Filippi G.G. (1995). On Some Aspects of bhūtas in the Birth-death Passages. In Saraswati
Bh. (Ed.), Prakŗti, the Integral Vision (part 1, pp. 117-121) (Vols. 1-5). New Delhi: DK
Printworld.
Filippi G.G. (1996). Mŗtyu: The Concept of Death in Indian Traditions. New Delhi: DK
Printworld.
Filippi G.G. (1997). Alcune considerazioni sui bhūta come composti corporei. Atti del Settimo Convegno Nazionale di Studi Sanscriti (3, pp. 183-190). Torino: AISS.
Filippi G.G. (2001). Dialogo di Naciketas con la Morte: Taittirīyabrāhmaņa, III.11.8 - Kaţhaupanişad. Venezia: Cafoscarina, Cina e altri Orienti.
Filippi G.G. (2004). The Guru and Death. In Rigopoulos A. (Ed.), Guru. Indoasiatica (2)
(pp. 61-79). Venezia: Cafoscarina VAIS.
Filippi G.G. (2005-2006). Note sul terrore della morte. In Marchianò G. (Ed.), Elémire
Zolla dalla morte alla vita, numero speciale di Viator (9, n.s.), pp. 51-60.
13
Filippi G.G. (2006). Conservazione delle ceneri umane nell’India tradizionale. La dottrina
del resto. In Remotti F. (Ed.), Morte e trasformazione dei corpi. Interventi di tanatometamorfosi (pp. 311-327). Milano: Bruno Mondatori.
Filippi G.G. (2006). Considerazioni sull’Inno 135. Ŗgveda, X maņḍala, dedicato a Yama dal
ŗşi Kumāra Yāmāyana, in versi anuşţubh. Annali di Ca' Foscari, 45 (3, SO 37), pp. 201213.
Filippi G.G. (2010). Il mistero della morte nell’India tradizionale. Vicenza-Bassano: Itinera
Progetti Indoasiatica.
Filippi G.G. (2011). Posizione dell’Umanità nella scala degli esseri secondo il Vişņu Purāņa. In Filippi G.G. (Ed.), Il concetto di uomo nelle società del Vicino Oriente e dell’Asia
Meridionale (pp. 71-89). Venezia: Cafoscarina Eurasiatica.
Ghosh Sh. (1989). Hindu Concept of Life and Death. New Delhi: Munshiram Manoharlal
Pbls.
Lazzeroni R. (1988). Il nettare e l’ambrosia. Su alcune rappresentazioni indoeuropee della
morte. Studi e Saggi linguistici, suppl. de L’Italia dialettale, 51 (28 n.s.), pp. 177-195.
Miśra S◦ P.V., Agninārāyaņa Sv.P. (Eds.) (1988). Preta Mañjarī [Garuḍa Purāņa]. Vārāņasī: Saṃkŗt Pustakālaya.
Parry J.P. (1989). The End of the Body. In Feher M., Naddaff R., Tazi N. (Eds.). Fragments
to a History of the Human Body (3, pp. 491-518). New York: M. Femer ed. Urzone. Inc.
Satavalekar S◦ Ś. D. (Ed.) (1957). Ŗg Veda Samhitā. Bombay: Svādhyāya Maņḍala, Pāradī.
Śāstrī M◦ A. (1938). Brahma Sūtra Śānkara Bhāsya. Bombay: Nirņaya Sagar Press.
Shāstrī Paņśīkar W.L. (1936). Srimadbhagavadgita [Bhagavad Gītā]. Bombay: Nirņaya
Sagar Press.
Śāstriņā P◦ J. (Ed.) (1970). Upanişad Samgraḥa. Dillī: Moţīlāla Banārsīdāsa.
Sharma P. (Ed.) (1981). Caraka Saṃ hitā. (Vols. 1-3). Varanasi: Chaukambha Sanskrit
Series.
Veda Vyasa (1892). Śrimad Bhāgavatam. Bombay: Gopal Narayan Co.
Varenne J. (1997). Le Tantrisme. Mythes, rites, métaphysique. Paris: Albin Michel.
14