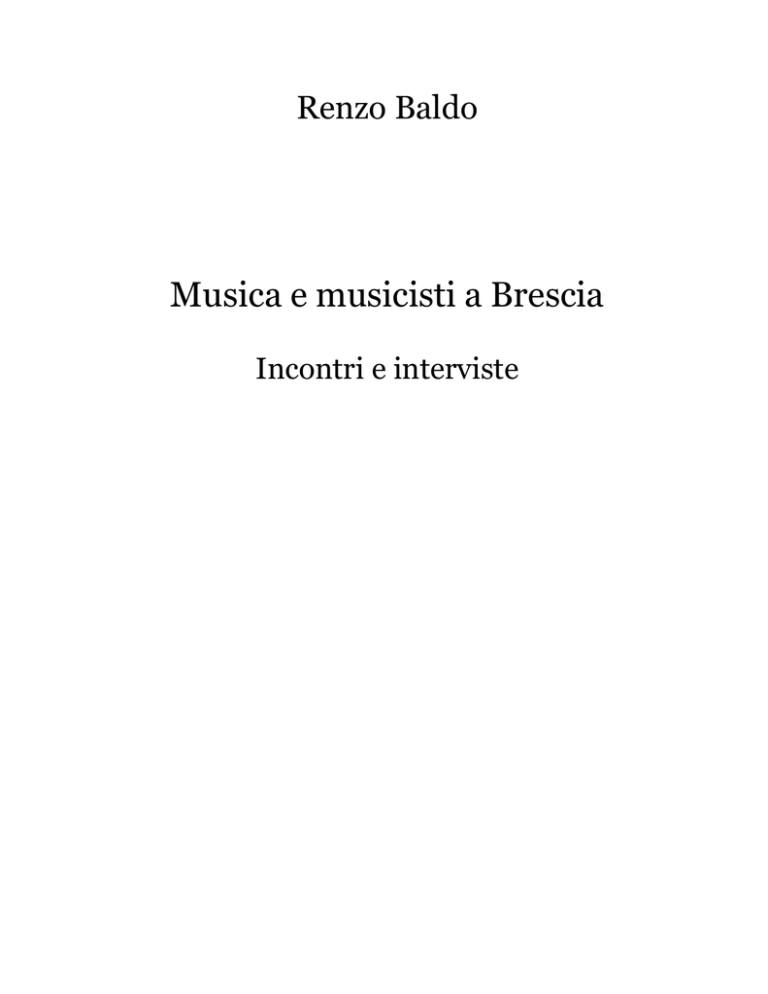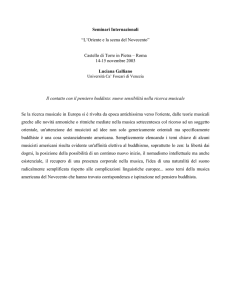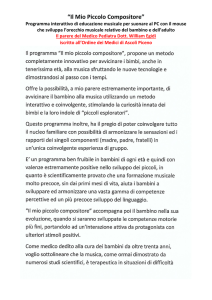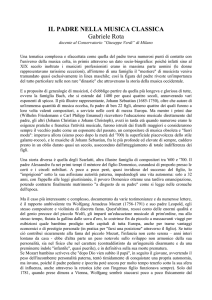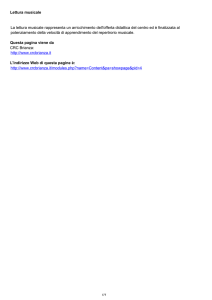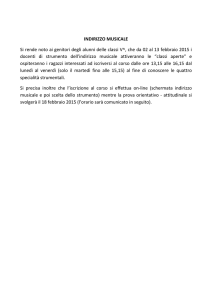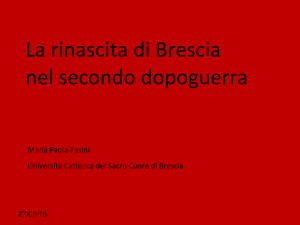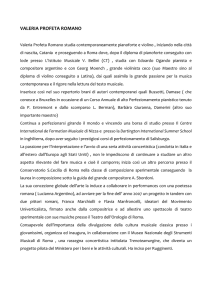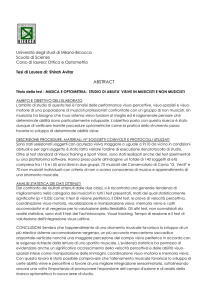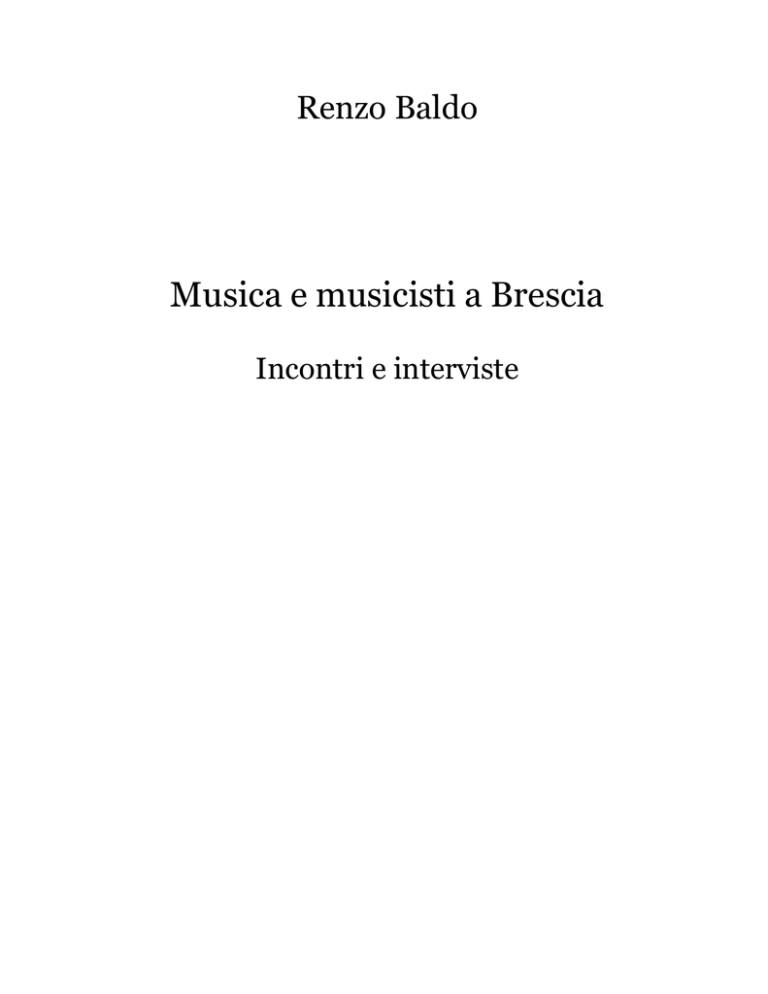
Renzo Baldo
Musica e musicisti a Brescia
Incontri e interviste
Tutti gli scritti qui raccolti sono comparsi sul bimestrale BresciaMusica
Quest'opera di Renzo Baldo è concessa sotto la Licenza Creative Commons
Attribuzione: Non commerciale - Non opere derivate
INDICE
A colloquio con Giancarlo Facchinetti
Franco Piavoli ci parla della sua regia de “La forza del destino"
Intervista a Camillo Togni
Intervista ad Alceo Galliera
Intervista a Franco Margola
Intervista a Ugo Orlandi
Una conversazione con Isacco Rinaldi
Incontri con musicisti bresciani: Paolo Ugoletti
Incontri con musicisti bresciani: Antonio Giacometti
Intervista a Giuseppe Scarpat
Intervista a Giovanni Ligasacchi
A colloquio con Giancarlo Facchinetti
Una conversazione con Mario Conter
A colloquio con Emanuele Severino
Intervista a Mario Cassa: il “destino” della musica
Il “gesto” di Diego Chimini
3
RENZO BALDO
C’È UN’OPERA IN ARRIVO
A colloquio con Giancarlo Facchinetti
Penso sia opportuno cominciare questa conversazione partendo dall’opera che sta
scrivendo e che, se non erro, dovrebbe andare in scena nella stagione del 1987. Può darci
qualche anticipazione? Sul soggetto, p. es., ma anche su quelle che presumibilmente
saranno le sue caratteristiche sceniche e musicali.
Il soggetto è stato tratto da un racconto di Laforgue. La musica è, ovviamente, in stato di
gestazione. Anche il libretto non ha ancora assunto la sua veste definitiva. Librettista è Nanni
Garella, che probabilmente ne sarà anche il regista. Dal punto di vista musicale posso dire
questo: nel primo atto una orchestra piena, sinfonica, con un coro, che probabilmente sarà
situato non sulla scena, ma nella sala, e una banda sul palcoscenico; nel secondo atto, di
carattere intimista, niente più coro né banda, l’orchestra ridotta alle dimensioni di
un’orchestra da camera; nell’epilogo questa situazione si accentuerà: vi sarà solo un trio o un
quartetto, sul palcoscenico con il protagonista, al quale sarà affidata una grande aria che
chiuderà l’opera.
Questo processo di assottigliamento dell’organico penso abbia una funzione precisa, sì da
conferire un particolare significato all’insieme.
Sì. Va tenuto presente che l’opera racconta la vicenda di un uomo, un maestro di banda, già
avanti in età, che rivede casualmente una donna che ha amato in gioventù (e che è rimasta
giovane). La insegue, cerca di raggiungerla, di avvicinarla, ma invano. Alla fine rimane solo,
la donna svanisce nel nulla. L’assottigliamento degli organici strumentali accompagna questo
progressivo venir meno della speranza dell’incontro.
Soltanto due personaggi allora?
No, compaiono anche altri personaggi, dei quali uno è fondamentale, una specie di dottor
Freud, che, in scena come prologo, poi guida l’intera vicenda, chiarendo di volta in volta la
situazione psicologica dei personaggi e soprattutto del protagonista.
Dott. Freud... c’è dunque una componente psicanalitica?
Direi di sì, anzi la mia intenzione era proprio che fosse veramente Freud. Ora ci sto
ripensando. Comunque non ho ancora deciso.
Come mai la scelta di questo racconto? Voglio dire: Laforgue è uno scrittore da lei sentito
come portatore di qualche particolare messaggio, di qualche tematica a lei congeniale?
No. Anzi le dirò che in un primo tempo avevo pensato ad un racconto di Kleist, che mi
interessava molto. Ma mi dava dei problemi, ne risultava una dimensione teatrale troppo
ampia. La proposta di Laforgue mi è venuta da Garella. E devo anche dire che il racconto di
Laforgue è stato trattato molto liberamente, fino a veramente coincidere con quel che effettivamente cercavo.
Questa è la sua prima opera, se si escludono le musiche di scena da lei composte in varie
occasioni (l’ultima recentissima per il Faust nella regia di Castri) e le sue operine
“didattiche”. È stata una scelta improvvisa e nuova o ci pensava da tempo?
Ci pensavo da tempo. E questa è stata l’occasione giusta per decidermi.
Lei dunque è arrivato all’opera non casualmente, anzi direi con piena convinzione. Il che
vuol dire che lei è schierato con quei compositori, che ritengono ancora viva, attuale, la
dimensione “opera”, non la pensano cioè come un capitolo, che appartiene inesorabilmente
al passato.
Musica e musicisti a Brescia
4
RENZO BALDO
È così. Ma non credo di costituire un’eccezione. Quasi tutti i musicisti contemporanei,
anche i più giovani, si cimentano con l’opera. Essa costituisce un richiamo intramontabile.
Certo non può più essere quella di prima, ma il teatro musicale continua la sua presenza, anzi
è decisamente in ripresa.
Non può più essere quella di prima. Il che rimanda ad un grosso problema, che
naturalmente non riguarda soltanto l’opera, ma che nel caso specifico dell’opera sembra
essere ancora più difficile da risolvere, quello della scelta del “linguaggio”. Su questo che
cosa mi può dire? E in particolare, lei a quali modelli di teatro d’opera guarda?
Se devo parlare di modelli, citerei volentieri Berio, soprattutto “La vera storia” e
“Passaggio”. Meno invece il grande affresco corale alla Luigi Nono, le cui opere sono più
oratori scenici che teatro vero e proprio. Ma un compositore che mi piace molto è Ligeti, del
quale ho sentito a Bologna “Il gran macabro”.
E l’esperienza operistica dei viennesi?
Direi soprattutto Wozzeck di Berg e anche alcune parti di Lulù.
E Schoenberg?
Sì, ma forse più Erwartung che Mosè e Aronne, anche se quest’ultima resta fuori d’ogni
dubbio un punto di riferimento fondamentale per la musica del nostro secolo.
Per quanto riguarda invece la prima parte della sua domanda, le dico subito che io non
condivido per nulla la tendenza, che oggi viene definita neoromantica, del recupero della
tonalità, recupero antistorico e acritico. Non condivido nemmeno il caos che viene prodotto
dall’uso disordinato, acritico, appunto, di tutti i mezzi, di tutti i linguaggi, senza filtri e analisi
adeguate. Anche Strawinskj ha usato stili e linguaggi diversi, ma ha applicato un filtro che li
assorbiva e ricreava in nuovi significati. Comunque, se devo definire il mio linguaggio, devo
dire: fedeltà sostanziale alla tecnica seriale, potremmo dire “neoespressionismo”.
Il che significa, sostanzialmente, riconoscere all’espressionismo una valenza non spenta,
una carica di attualità.
La dimensione storico-culturale che l’ha prodotto è ancora di scena e l’espressionismo non
ha quindi esaurito il suo significato, la sua ragion d’essere. Un esempio probante è l’opera
recente di Camillo Togni.
Da quel che ha detto, “fedeltà alla dodecafonia”, sembra dunque che lei faccia coincidere
espressionismo e dodecafonia. Sì, direi di sì.
Ma allora le chiedo: poiché, credo, certamente c’è già espressionismo là dove compare,
come nel primo Schoenberg, un linguaggio che si manifesta come esasperazione del
cromatismo wagneriano e dissolvimento del sistema tonale, lei, quando compone, si
organizza sulla base di una rigorosa dodecafonia o lascia spazi a un più libero impiego di
impasti fono-cromatici? In altre parole: l’analisi delle sue partiture porterebbe a scoprire
un rigoroso impiego delle serie dodecafoniche?
Direi di no. Io uso dei blocchi serializzati, che non corrispondono più alla dodecafonia
schonberghiana, ma non riportano nemmeno più alla libertà cromatica del primo
Schoenberg, quello della pura atonalità. Il mio è il linguaggio che si è formato intorno agli
anni ‘50, che potremmo definire dei postdodecafonici. È il linguaggio usato da Berio,
Stockhausen, Ligeti.
Quindi lei non ha seguito la strada che ha condotto a Webern e, credo, a certo Boulez, quel
percorso che ha portato la dodecafonia a una sorta di lucida astrazione.
No. Questo è uno sbocco che ha permesso di raggiungere risultati di grande interesse. Ma io
non ho percorso questa strada. Non la sento a me congeniale.
Percorso weberniano, neo-espressionismo, neo-romanticismo. E aggiungiamo anche le
vie dello sperimentalismo, da quello della linea che fa capo a Cage e che è andata anche
Musica e musicisti a Brescia
5
RENZO BALDO
verso la gestualità, a quella della musica elettronica. Una molteplicità, forse anche un caos,
come lei prima ha detto, nella quale il compositore moderno può pescare a piene mani. Ma
non si pesca mai a caso. Lei ha scelto, ha sentito come suo, il linguaggio neoespressionista.
Evidentemente perché lo ha sentito come quello più capace di esprimere, di dare voce alla
musica di oggi. È così?
Certamente. Ho già detto quello che penso dei neoromantici. Le dirò che anche la
sperimentazione elettronica, secondo me, non ha dato grandi risultati e la considero, tutto
sommato, una strada conchiusa, esaurita. Anche se devo riconoscere che in alcuni casi, per
es. Stockhausen e qui in Italia Luigi Nono, c’è stata una geniale capacità di fondere il
linguaggio neo-espressionista con ricerche sperimentali.
A proposito di esperienze e di linguaggi musicali, lei cosa pensa di quello che è avvenuto
ed avviene nei paesi dell’Est?
Tra i musicisti sovietici io considero veramente degno di grande considerazione
Sciostakovich, e mi trovo in buona compagnia, perché questa era anche l’opinione di
Schoenberg. Sappiamo che nell’Urss c’è stata qualche difficoltà negli anni, che chiameremo,
per intenderci, zdanoviani, e non è detto che qualche difficoltà non ci sia stata anche
recentemente. Non dimentichiamo però che a Mosca c’è uno dei più sofisticati laboratori di
musica elettronica e che a Varsavia agisce un Festival di musica contemporanea, nel quale
figurano esperienze musicali molteplici, fino agli sperimentalismi più raffinati e avanguardistici. Penso quindi che sia infondata l’opinione che attribuisce all’Est una sorta di blocco, di
stasi della vita musicale nei suoi aspetti di ricerca e di novità. Certo non siamo molto
informati. Ma penso, p.es., in Urss a Denisov, musicista di tutto rispetto e tutt’altro che in
fase di stasi; penso ai musicisti polacchi e ungheresi, che appaiono particolarmente e
vivacemente attivi. Tra l’altro mi permetto di ricordare che le mie musiche sono state eseguite
in Ungheria, dove, tra l’altro, ho conosciuto, stringendo una vera amicizia, il maggior
compositore attuale, Ferenc Farkas, la cui musica, per certi versi sulla linea di Bartok,
conosce ben larghe aperture di ricerca. Credo infine che pochi sappiano che recentemente c’è
stato un importante festival di musica elettronica a Cuba.
Tornando al suo lavoro di compositore, nel percorso da lei seguito c’è omogeneità e
continuità nell’uso del linguaggio o ci sono stati degli scarti e delle deviazioni?
Parlerei di continuità, salvo per il periodo tra il 61 e il 66, quando ho tentato un’esperienza
neoclassica usando soprattutto procedimenti politonali. Ma poi sono ritornato al linguaggio
che ho definito “neo-espressionista”.
Mi sbaglio o qualche volta nella sua musica sono comparsi dei procedimenti che
chiamerei di “ironia”?
Sì, in molti pezzi questo elemento c’è. Ma preferirei definirla ironia tragica, che nasce da un
sottofondo amaro.
Questa ironia, secondo lei, è nata da una situazione di isolamento o da un’impressione di
urto con la realtà?
Direi che quella giusta è la seconda spiegazione. Anche se non mi sentirei di escludere del
tutto la prima.
Quando parlo di isolamento non alludo tanto ad una situazione psicologica soggettiva,
quanto a una condizione oggettiva nella quale, credo, si può sentire il compositore di oggi,
dovuta alla indubbia difficoltà di trovare un referente sicuro, un orizzonte ben definito di
fasce di fruizione, a cui erano invece abituati i musicisti del passato, fino ai primi del nostro
secolo.
Questo indubbiamente si verifica, anche se devo dire che oggi è abbastanza frequente la
figura del compositore che se ne infischia del tutto di avere un pubblico.
Musica e musicisti a Brescia
6
RENZO BALDO
Fa quello che ritiene giusto e va avanti per la sua strada. Personalmente non condivido
questo atteggiamento, come devo chiamarlo? apollineo. Io penso che si deve comporre, così
come si deve scrivere o dipingere, ipotizzando sempre un’area di fruizione, ci si deve, cioè,
porsi il problema del farsi capire, senza per questo, ovviamente, giungere a compromessi con
consuetudini di gusti, che si ritengano deteriori o mercificate.
Lei sa che molti sostengono che i linguaggi della musica colta si presentino oggi come
inesorabilmente elitari. Ho sentito un esperto affermare: è la vera musica, anche se la
capiscono duemila persone soltanto. Lei cosa ne pensa?
Indubbiamente il linguaggio postwagneriano ha rispecchiato, come tutte le arti del ‘900,
una profonda crisi. Ma io ritengo che anche nella crisi, nel caos, come ho detto prima,
continuamente affiorino dei valori che si impongono, delle musiche, che rivelano di avere un
autentico significato, diciamo pure che prima o poi diventano dei “classici”. È un processo
che si è verificato nella pittura e che, secondo me, avviene anche nella musica. Oggi più
nessuno metterebbe in dubbio l’autenticità, il significato oggettivamente assunto da
musicisti, tanto per fare degli esempi, come Strawinski, come Berg, persino come Webern.
Lei pensa che questo fenomeno si verificherà anche con i musicisti delle generazioni che
adesso sono sulla breccia?
Non lo si può escludere. Penso per esempio a Berio, Nono, Stockhausen.
C’è chi sostiene che l’area del pop-folk-rock costituisce una delle matrici più vitali della
musica d’oggi e della musica futura. Lei è dell’opinione che quest’area oltre che un
fenomeno di costume e di mercato, costituisca anche un fenomeno musicale nel senso pieno
del termine?
Non credo. Lo vedo soprattutto come un fenomeno di costume, e anzi, soprattutto come un
fenomeno di mercato. È certamente un fenomeno che, p. es., può produrre il
perfezionamento di strumenti elettronici, ma la dimensione di mercificazione mi sembra
decisamente prevalente. Per non parlare dell’incredibile involuzione dei mezzi linguistici che
si sta verificando in questo genere di musica. Esattamente il contrario di quello che è
avvenuto per il jazz.
Lei non pensa che la musica colta possa assorbire qualcosa da queste aree musicali, come
per esempio ha fatto Strawinki con il jazz?
Tra i musicisti contemporanei che si sono serviti di questi linguaggi cito Stockhausen e
soprattutto Berio. Ma se ne sono serviti assorbendoli, convogliandoli nel proprio linguaggio,
adoperandoli, come Berio, per fare “teatro”. Come aveva già fatto Berg in una scena del
Wozzek con l’uso della fisarmonica inserita in una orchestra da ballo.
Le chiedo, a questo punto: la musica contemporanea, e quindi anche la sua, che impatto
ha con la realtà entro la quale nasce e vive? Che cosa esprime di essa? Mi rendo conto che a
qualcuno può sembrare una domanda banalmente sociologica, ma forse non è il caso di dimenticare che, come per la pittura o per la poesia, si può e si deve parlare anche di una
“storicità” della musica.
Mi trova d’accordo. È però tutt’altro che discorso facile. Posso provare a dire questo: la
nostra non è una società idillica, è, anzi, una società stracarica di tensioni, di contraddizioni,
oserei dire, semmai, che tende al tragico. Del resto è molto significativo il fatto stesso che oggi
non esista un linguaggio omogeneo, che esistono tanti linguaggi fino al caos. Soprattutto a
partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Come il linguaggio dell’espressionismo e
della dodecafonia schoenberghiana (ma anche il linguaggio scettico e beffardo di Strawinski)
hanno rappresentato l’inquietudine, la tensione tragica dell’Europa del primo ‘900, così i
linguaggi di oggi nel loro impiego più sfrenato e incontrollato sono un indice della situazione.
Questa difficoltà nelle scelte, questa difficoltà a stabilire dei “valori” (non si sa più quale sia la
Musica e musicisti a Brescia
7
RENZO BALDO
strada valida) è un indice particolarmente eloquente.
Lei però ha scelto il linguaggio neoespressionista, evidentemente nella convinzione che sia
la strada giusta, quella che può fissare dei “valori” fuori dal caos e fuori dalle
mercificazioni.
Esatto. Ed è, evidentemente, un linguaggio che esprime la crisi. I neoromantici fingono
disinvoltamente che la crisi non esista. È per questo che considero la loro strada fittizia e
fuorviante.
Cancellare il tormento in una società tormentata è il segno di una rinuncia...
È così. E devo anche dire che tra i compositori più giovani affiora, purtroppo, un
atteggiamento di sicurezza che sfocia nell’arroganza, nel rifiuto di qualunque serio legame e
con la tradizione e con la realtà, un protagonismo segnato da un individualismo che lascia
sconcertati.
Quale potrebbe essere, allora, secondo lei, la figura del compositore di oggi?
Il compositore, oggi — come sempre, del resto — deve saper comporre entro un largo
ventaglio di generi, dal sinfonico alla canzonetta, alla musica per banda. Questo gli consente
di superare chiusure settoriali, che si trasformano facilmente in sperimentazioni astratte,
senza referenti. Sì deve scrivere pensando ad un pubblico, oserei dire ad un pubblico di
massa.
E la figura dell’insegnante di composizione?
Qui si tocca un tasto dolente. l’arretratezza dei programmi ministeriali, la mancata riforma
dei Conservatori fa sì che le cattedre di composizione, se vogliono essere ossequienti alle
norme, producono dei competenti nei linguaggi musicali dei secoli passati, con un vuoto
assoluto nei linguaggi di oggi. Creiamo, nei casi migliori, dei bravi scolari, che superano bene
gli esami, dei volonterosi ma un po’ inutili accademici. Per diventare compositori devono
arrangiarsi da soli.
A proposito di accademici: sembrerebbe ovvio poter affermare che il musicista non può
vivere di sola musica, ha bisogno di addentellati culturali largamente molteplici. Per
esempio, nel campo della letteratura e delle arti figurative, anche perché il movimento delle
altre arti provoca dei riferimenti analogici, che danno vitali nutrimenti.
Senza dubbio. Anche se, da questo punto di vista, scorgo, nella musica, più analogie con la
pittura che con la letteratura.
Certo: l’espressionismo, l’astratto, il materico e via dicendo. Ma mi consenta una verifica
personale. Lei, quali espressioni figurative ha sentito come “sue”?
Chagall, forse sembrerà strano...
Non direi. Per un neo-espressionista è comprensibile.
E ancora: Kandinski, Rauschenberg, Vedova, Vespignani.
E nel campo della letteratura? Quali scrittori ha trovato che davvero contavano per la
sua formazione, alludo cioè non a letture “informative”, ma ad un altro tipo di lettura,
quello dell"‘incontro’, per cui la cosa letta diventa veramente “nostra”. .
Mi riesce difficile dire in che modo, ma certamente mi hanno aiutato nella mia formazione
Thomas Mann, più ancora con La montagna incantata che col Doctor Faust; 11 castello di
Kafka; Sartre, soprattutto nella sua opera di teatro; e anche Pasolini.’’i
Un’ultima domanda: a qualcuno la musica dei neo-espressionisti dà l’impressione di una
esperienza straordinaria, ricca, duttile, ma, come dire?, un po’ troppo “viennese”, quasi di
un raffinato intellettualismo ancorato su una esperienza vissuta come una dimensione, che
li ha scioccati, ma dalla quale non riescono più ad uscire. Cosa pensa di questa obiezione?
La sento come possibile. Forse anch’io, qualche volta, mi ci sono ritrovato dentro. Va però
detto che quel che ha dato la scuola viennese, e poi la scuola di Darmstadt, non trova alcun
Musica e musicisti a Brescia
8
RENZO BALDO
riscontro, per ampiezza e profondità, in altri linguaggi e in altre esperienze. Uscire da quel
cerchio è, per un musicista d’oggi, difficile e rischioso. Bisogna superarlo, andare oltre, ma è
un risultato che non si può perseguire con un astratto volontarismo, e tanto meno con un
salto, una rottura, che rischiano la presunzione e quindi un intellettualismo anche peggiore,
di più basso conio. La forza di quella tradizione è immensa, e con essa bisogna fare i conti.
Dicembre 1985
Musica e musicisti a Brescia
9
RENZO BALDO
UN GRANDE AFFRESCO VERDIANO
Franco Piavoli ci parla della sua regia de “La forza del destino"
Tu sei arrivato al melodramma dopo l’esperienza del cinema. Ma se vai indietro con la
memoria, puoi rintracciare qualche tuo lontano incontro con l’opera lirica?
Da piccolo, a nove, dieci anni, si andava nelle contrade e nelle piazzole a fare l’opera. “Oh
dolci baci e languide carezze...”. Le madri ci chiamavano in casa, mentre qualche passante si
fermava per assistere allo “spettacolo”. Ridevano, battevano le mani e, tra sorrisi e commenti,
lasciavano trapelare un filo di commozione.
Poi, con la scuola media e l’università, si divenne più colti e quando i “vecchi” ascoltavano
alla radio il “Rigoletto”, noi li prendevamo in giro. Dicevamo che era musica da circo, roba
per donnine dal fazzoletto facile. E questo si diceva non tanto per lo spirito di contraddizione
che oppone una generazione all’altra, ma piuttosto perché, nelle discussioni tra i giovani
“colti”, si esaltavano le vette sublimi raggiunte da Bach e si snobbavano le opere di Puccini
come fossero “collinette” per villeggianti poveri o addirittura zucchero filato per frequentatori
di fiere.
Eppure oggi anche i “nuovi” giovani scoprono e frequentano il melodramma. Perché?
Le spiegazioni sono molte: i “cicli”, il ritorno periodico alla tradizione, il “riflusso”, il ritorno
al “privato”...
Un recupero e una vittoria dei “sentimenti”?
Non voglio addentrarmi in indagini sociologiche. Posso solo dire che anch’io mi sono
accostato alla lirica con spirito nuovo e con rinnovato entusiasmo.
In “La forza dei sentimenti”, Alexander Kluge analizza con lucidità e passione il mondo del
melodramma e ci mette in guardia contro il “ricatto” delle emozioni. È un problema antico e
sempre attuale. E potremmo constatare come spesso, troppo spesso, l’uomo ha
strumentalizzato i sentimenti più nobili per le cause più indegne. Ora ci limitiamo a notare
che i sentimenti più elementari sono anche i più “universali ed eterni”. E il melodramma, da
Monteverdi a Britten, attinge principalmente ad essi. Per questo è sempre così eloquente, al
di là delle età e delle mode. Per questo in esso, nelle storie che racconta, si identificano strati
così ampi di persone.
Gramsci ha detto che il melodramma è il romanzo popolare musicato e quindi la forma
d’arte che ancor oggi maggiormente si identifica con la vita nazionale. Tu sei d’accordo?
Il libretto è legato spesso agli stilemi e ai gusti dell’epoca in cui è stato scritto. La lingua e le
sistemazioni sceniche appartengono alla moda e alla cronaca. Ma la musica, la grande musica
naturalmente, travalica il contingente legato al testo letterario e lo riduce a semplice “pretesto”. È quanto generalmente accade nelle opere dei nostri grandi musicisti.
Giuseppe Verdi, ad esempio. In tutte le sue opere ritroviamo i grandi sentimenti. L’amore,
la gelosia, l’amicizia, l’orgoglio, l’odio, la vendetta, il tradimento, la prepotenza... i lamenti
amorosi, i pianti, le urla, le invocazioni, i canti di gioia degli eroi verdiani sembrano
appartenere ad un mondo antico come l’uomo: richiamano Eschilo, Sofocle e Omero. Certe
situazioni drammatiche, spogliate dagli arredi dell’epoca, conservano un sapore barbarico,
primitivo, animale. E non importa il fatto contingente, se la causa prossima è da addebitarsi
al duca di Mantova o al marchese di Calatrava.
L’opera verdiana, dunque, non è datata.
Verdi, pur partendo da una situazione storicamente datata, astrae da essa. Voglio dire che la
Musica e musicisti a Brescia
10
RENZO BALDO
musica di Verdi, pur essendo così sanguigna e densa e realistica, è ad un tempo “astratta”, nel
senso che astrae dalla contingenza storica e ambientale che l’ha occasionata. Ecco perché, ad
esempio, la “Forza del destino” sopravvive intatta pur essendo partita da un feuilletton come
la “Fuerza del sino” del duca di Saavedra.
Tu però nella tua regia della “Forza del destino” non ti sei limitato a mettere in luce i
personaggi con le loro passioni, ma hai dato largo spazio a situazioni ambientali, ti sei
sforzato di creare “atmosfere”.
Certamente. Ad esempio nel brano corale che precede la “Vergine degli angeli”, e che io
chiamerei “la tempesta”; il musicista evoca la furia degli elementi naturali con una potenza
espressiva degna della grande pittura romantica e del sinfonismo germanico.
È opinione comune che la “Forza del destino” sul piano strutturale lasci spesso a
desiderare. Sbaglio se dico che tu ti sei sforzato di superare l’ostacolo ricorrendo a soluzioni
eclettiche? Provo a enumerarle: scene d’ambiente, come quella d’apertura, con una, secondo
me, indovinata ed efficace prospettiva su quegli eloquenti quadri secenteschi; scene
d’atmosfera, come quella della vestizione; scene di realismo tradizionale, corali e di massa;
scene ridotte ad un simbolismo essenziale, come nel finale...
Tentare di ricucire, di fondere e di mimetizzare è impresa vana anche per l’interprete d’oggi.
Tanto vale lasciare scoperte le debolezze strutturali. Per questo la scelta di soluzioni eclettiche
mi è parsa la più adatta. Devo dirti che all’inizio avevo pensato a soluzioni omogenee e
unitarie, tutte sul tipo dell’ultima scena, col massimo di essenzialità. Ma poi mi è sembrato
che fosse un tradimento o un’operazione intellettualistica ed estetizzante. In particolare ha
pesato su questa decisione la convinzione, difficilmente smentibile, che Verdi guardava
sempre, specie in opere come questa, al mondo shakspiriano, naturalmente tradotto nel
clima e nel gusto dell’ottocento: un grande affresco in cui potessero trovare posto il tragico e
il comico, il sublime e il popolare.
Sulla questione, in questi ultimi anni molto combattuta, se nella messa in scena il regista
debba rispettare il testo o rinnovarlo, tu dunque non hai dubbi: anzitutto rispettare la
musica e lo spirito dell’opera e quindi anche le situazioni sceniche e ambientali che sono
state concepite contestualmente alla partitura.
Ciò vale in particolare per le opere verdiane, per le quali l’autore contribuì direttamente alla
stesura del libretto. Perciò io mi sono cimentato nella regia della “Forza del destino” con lo
spirito di chi si accinge a dare aria e luce ad un quadro antico. Contro la moda corrente, non
ho voluto fare una rilettura in chiave moderna di un’opera del passato. Sarebbe come se un
editore volesse rilanciare i “Promessi sposi” facendone aggiornare il lessico o, peggio,
sostituendo le “grida” con brani di maggior presa per il lettore d’oggi. Per quanto mi è stato
possibile, invece, ho voluto rievocare le atmosfere e i climi dell’epoca, rifacendomi ai pittori
del tempo e più spesso all’iconografia popolare, a costo di apparire scontato. Così per la
gestualità dei protagonisti, per la scenografia e per le luci ho preferito assecondare (ma non
sempre) le didascalie del libretto e rifarmi a modelli ottocenteschi e al clima dell’epoca.
A proposito di didascalie, avrai visto che in una recensione ti hanno rimproverato di
essere stato troppo ligio alle indicazioni del libretto.
Quanto ai recensori, io li ringrazio dell’attenzione, ma, devo proprio dirlo, alle volte si tratta
di un’attenzione... un po’ distratta. Uno, per esempio, ha detto che ho guardato solo i
personaggi; un altro proprio il contrario, e cioè che ho dato rilievo solo alle scene corali. Sì
mettano un po’ d’accordo... Non tocca a me giudicare i risultati, ma certo ho l’im pressione
che si siano lasciati sfuggire quel che giustamente hai chiamato l’eclettismo, che io ho
perseguito con piena convinzione. L’opera verdiana lo esige, per le ragioni che prima ho
detto, e ribaltarne la molteplicità e la profondità delle dimensioni mi sembrerebbe sviante e
Musica e musicisti a Brescia
11
RENZO BALDO
arrogante.
Ma veniamo pure alle didascalie. Le ho seguite quasi alla lettera quando mi consentivano di
realizzare ambiente e atmosfere, le ho largamente disattese quando rischiavano banali
risultati di verismo un po’ pompieristico. E ciò in particolare nella scena della battaglia e nel
finale. Il finale prevedeva boschi, rocce, cascate d’acqua: ho spazzato via tutto, anche perché
qui la musica raggiunge una essenzialità tragica alla quale, a parer mio, meglio si attaglia quel
nudo ed essenziale simbolismo cui poco fa tu hai accennato.
Veniamo a una domanda un po’ scontata, ma che pur devo farti. Dal cinema al
melodramma. Esperienze diverse o esperienze con dei tratti di continuità e di analogia?
Direi esperienze che si integrano. Per molti elementi, che ho cercato di sfruttare: l’uso delle
luci, l’impiego della tela bianca come schermo panoramico; le sequenze su piani lunghi e su
piani ravvicinati; l’inquadratura che isola un brano della realtà, cioè il tempo di
rappresentazione come tempo chiuso.
Nel tuo cinema, però, non ci sono mai concessioni veristiche, è un cinema d’atmosfera.
Non si può dire altrettanto di questa tua regia.
Certo, da questo punto di vista avrei preferito un’opera come il “Pelleas et Melisande”. Ma
trovandomi tra le mani la “Forza del destino”, non potevo comportarmi diversamente, per le
ragioni che ho già detto. Per fare un discorso analogico: capire e apprezzare, per esempio,
Fontana o Burri, non significa rifiutare, per esempio, Guttuso. Credo sia più giusto e
coraggioso scegliere questa via, eclettica, polilinguistica, invece che quella di fare ribaltamenti
effettistici, cercando una omogeneità forzata e travisante. In fondo la “Forza del destino” è
una favola popolare e in questa chiave va rivissuta, senza pretendere di nascondere i panni
sdruciti, anzi, riproponendola nella sua ingenuità nativa e lasciando allo spettatore di oggi la
libertà di identificarsi in essa per quanto vi è di autentico e di sorridere invece del
manierismo d’epoca e del gusto démodé. Rinvigorire la fragilità di alcune situazioni sceniche
o addirittura sostituirle con altre sarebbe stato facile e maggiormente gradito agli
“intenditori”, ma anche arbitrario ed oscurante. Un kitch nel kitch.
Dicembre 1986
Musica e musicisti a Brescia
12
RENZO BALDO
UN MITTELEUROPEO A BRESCIA
Intervista a Camillo Togni
Il successo di Blaubart ti ha battezzato ormai anche come musicista di teatro d’opera.
Sembra anzi che il tuo interesse attuale di comP4sitore sia prevalentemente orientato in
questa direzione, come recentemente ci ha dimostrato l’esecuzione, sia pure in forma orchestrale, di alcune scene di Barrabas. Corre voce che completato il Barrabas metterai subito
mano ad una terza opera, sempre su testo di Trait. Una vera e propria trilogia, visto che
oltre ad avere un comune denominatore letterario, l’esecuzione di queste partiture teatrali è
prevista nell’ambito di una stessa serata. Ce ne vuoi parlare?
sì, a Barrabas deve seguire Maria Magdalena. Tre testi di Trakl, ci;tscuno, si badi, con un
sottotitolo, che ne fissa le caratteristiche essenzi;,ilicome “generi”. Nell’ordine: ein Puppenspiel
(teatro di marionette), ei’1e phantasie, ein Dialog. Barrabas è stato finora sentito
parzialmente; a Venezia la II, la III e la IV scena, tenendo oltretutto presente che la seconda
parte della terza scena, per difficoltà insorte nel completamento delle prove, è stata eseguita
senza orchestra e senza coro come a solo di tenore, quasi in forma di cadenza. Ciò ha
accentuato quel carattere di “oreficeria” che alcuni critici vi hanno intravisto.
Qui tocchi già una questione importante per la valutazione della tua m ca, Ho anch’io
notato che nelle recensioni si è sottolineato molto questo aspetto, quasi che segno decisivo
del tuo far musica sia una sorte di cesellamento, direi quasi, liberty, un trionfo di eleganze e
raffinatezze foniche, di “gioielleria” appunto. Mentre a me sembra che sii un’altra la
componente decisiva, anzi preminente, e cioè un elemento tragico.
Esatto. Nella scena che ho detto, eseguita in modo incompleto, l’asse;nza dell’elemento
corale e orchestrale ha dato un aspetto di virtuosismo alla parte fiorita del tenore,
sottraendole proprio l’elemento drammatico, ch 1e implicito nel testo, tolto dal racconto del
vangelo di San Marco (episodio del giovane che se ne va triste e scoraggiato quando Gesù gli
dice: “Se vuoi essere perfetto vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, vieni e seguimi”) e
che prende risalto, nella mia partitura, dal tono somnatesso dei primi e secondi tenori del
coro, e dal legame con la scena segutente (Barrabas oggetto di regali e di trionfi) nonché con
la scena fina le, che rappresenta la passione di Cristo con un coro a cappella, che tratteggia il
dramma del Venerdì Santo (“il sole si oscurò, uno sgomento attraversò le vie del mondo e la
creatura tremò”).
Veniamo allora a Maria Magdalena
Sì tratta di un dialogo (teatralmente, quindi, di difficile realizzazione, e la cosa, ti dirò, mi
stimola molto) tra un romano di stanza in Palestina e un giovane ebreo. I due personaggi
passeggiano all’imbrunire fuori dalle mura di Gerusalemme. Il primo esprime la sua nostalgia
per Roma, accentuata da quella che gli sembra la incomprensibilità della gente di Galilea, che
ha costumi e mentalità così diverse, quasi inafferrabili. Soprattutto gli sembrano
incomprensibili e misteriose le donne. E ricorda in particolare una danzatrice, scatenata nella
danza fino a cadere svenuta, pronta ad ogni prostituzione, che poi ha visto al seguito di quello
strano profeta condotto al supplizio sul Calvario, di cui non ricorda più il nome. I due si
salutano, il romano, rimasto solo, ripensa a questo strano profeta, e improvvisamente si
ricorda del suo nome: Jesus di Nazareth. E Trakl annota: “in quel momento il cielo si copre di
innumerevoli stelle” (analogia col finale di Blaubart, quando il protagonista per compiere il
delitto aspetta che sia “spenta l’ultima stella”).
Musica e musicisti a Brescia
13
RENZO BALDO
Mi sembra, dalla tua esposizione, che di Trakl, solitamente letto come poeta dell’angoscia,
tu senta molto il richiamo, che filtra da alcune immagini suggestive, anche se solo
fuggevolmente suggerite, verso il superamento del tragico tramite una sorta non diciamo
di speranza, che sarebbe, credo, eccessivo, ma, almeno, di sommessa possibilità di uno
sbocco religioso. Insomma l’Angst (angoscia) e il Tod (la morte), non escludono il Gott (dio).
Sì, il tragico di Trakl non si ripiega totalmente sul negativo. Il tragico vi domina sovrano,
ma apre sempre uno spiraglio su “altro”. Penso si possa parlare di angoscia religiosa. Del
resto non va dimenticato che il protestante Trakl aveva una profonda cultura biblica,
determinante per comprendere la sua opera. Tra parentesi, lo stesso va detto per Brahms, che
in materia biblica metteva in difficoltà anche i più esperti teologi.
Puoi dirci come è nata questa tua predisposizione per Trakl? Che cosa hai trovato nella
sua poesia, che ti ha, diciamo così, conquistato...
Una gran parte della mia attività musicale è stata assorbita da Trakl. Mi ha affascinato la
sua dimensione originalissima, espressione dell’anima più profonda dell’angoscia
espressionista sia nel suo aspetto di tensione morale che nel suo aspetto di “protesta”, che
nasce dal profondo nei confronti della realtà, di certi aspetti inquietanti e dolenti della realtà
Colpisce il fatto che tu non lo traduci mai, ti servi direttamente del suo testo in lingua
tedesca. Intraducibilità della poesia? Atto di omaggio, anche nel suo contesto fonicolinguistico, all’atmosfera mitteleuropea?
Il testo di Trakl è di fatto intraducibile, pena il suo dissolvimento verso significati che non
gli competono. Ho letto recentemente delle sue traduzioni in francese. Ne esce un Trakl a
metà fra il morbido e il “maudit”. Ma Trakl è tutt’altra cosa, è, come abbiamo sottolineato
prima, “angoscia” tragica, mitteleuropea, appunto.
Se mal non intendo, tu vuoi dunque dire che leggendolo in chiave di “maudit” Trakl viene
apparentato indebitamente a Baudelaire e a Rimbaud, mentre l’anima di Trakl è
l’angoscia, nel senso che è stato sottolineato da Heidegger in un suo celebre articolo. Di
questa angoscia, dunque, si permea anche la tua musica, soprattutto in questa trilogia,
anche se il tragico sembra assumervi talvolta, per la ricchezza d’impiego dei mezzi fonici, di
una sorta di ricchezza carica di raffinata preziosità. E qui sta, se non erro, la tua,
chiamiamola così, parentela con l’area mitteleuropea, il tuo gravitare in essa, tramite, naturalmente, la precisa scelta del linguaggio schoenberghiano-weberniano, perseguito e
dilatato, mi sembra, con il piacere, stavo per dire la voluttà, di scoprirne le più riposte e
molteplici possibilità.
Sì, a questo legame tengo molto, se non altro per la ragione molto semplice che l’anima più
vera, più profonda della recente civiltà europea è stata espressa proprio dall’area
mitteleuropea. Per quanto riguarda la musica in particolare, se si esclude Debussy, la cui
opera sempre più mi si rivela un capitolo straordinario della civiltà musicale, accanto e dopo
la grande esperienza mahleriana, sono stati Schoenberg e Webern a tracciare la via che io
ritengo impossibile non percorrere, se non si vuole rischiare l’accademia.
Pensi che in questo rischio sia caduto anche Strawinski?
Devo proprio dire di sì, soprattutto a partire da dopo il “Sacre”.
Ma torniamo alla tua trilogia. Ho letto in un’intervista che stai pensando anche ad un
“Intermezzo”. Puoi dircene qualcosa?
Dopo aver composto Blaubart, soprattutto dopo averlo sentito in teatro, ho pensato che il
passaggio al secondo dramma, il Barrabas, aveva bisogno di una pausa della tensione
drammatica, di un Intermezzo, di una atmosfera completamente diversa. Lo spunto per
questo intermezzo mi è stato suggerito dalla lettura di un racconto di Jakobsen: “E qui ci
Musica e musicisti a Brescia
14
RENZO BALDO
sarebbero volute delle rose “. Ho trascritto questo testo con un mosaico di frammenti attinti
alle letterature più disparate, legandoli all’Ode quinta del primo libro di Orazio. È un’ode che
mi ha colpito moltissimo, fin da quando ero sui banchi del liceo. Il tema di fondo di questa
esile, ma poeticissima ode è quello della rosa, che assunto in una chiave che potrei chiamare
simbolica, percorre tutto l’Intermezzo, nella successione di brani che ho coordinato quasi
come un mosaico. Questo Intermezzo, affidato ad un’orchestra da camera (quindi molto
ridotta rispetto a Blaubart e al Barrabas) inizia con la prima parte dell’ode oraziana.
Seguono le tessere del mosaico: testi trovadorici, di Chistian Gùnther (un poeta tedesco del
seicento), un sonetto di Shakespeare, un testo del neoclassicismo tedesco del 700 di Gleim,
infine un testo di Verlaine, che fu già musicato dal giovane Debussy, per chiudere con la
seconda parte dell’ode oraziana. Ti dirò, come curiosità, che questa lirica di Gleim è stata
musicata in modo delizioso dal giovane Berg. Sempre a titolo di curiosità, questo testo
berghiano mi è stato regalato da Leibowitz, che l’aveva avuto in dono dalla vedova di Berg, la
quale aveva l’abitudine, quando qualche amico l’andava a trovare, di aprire un baule dove
c’erano gli inediti di Berg e di cavarne fuori un testo da dare in omaggio.
E tutti questi inediti che fine hanno fatto? Il baule dove è andato a finire?
Non lo so. Mi auguro che sia stato dato alla Universal, che ha in corso la pubblicazione, che
va molto a rilento, dell’intera opera berghiana.
Torniamo all’intermezzo. Mi sembra di aver capito, da quanto hai detto, che, rispetto alla
trilogia, esso assuma una fisionomia del tutto particolare, di carattere lirico.
Sì, dall’Intermezzo esula il tragico.
Possiamo allora dire che nella tua musica il tragico e il lirico si alternano o, meglio, si
rinviano a vicenda?
In un certo senso sì. I sette episodi che costituiscono il corpus centrale dell’Intermezzo
culminano nel quarto, che s’intitola Lyrisches Intermezzo. Ma qui vorrei richiamare
l’attenzione su un fatto strutturale importante. I sette episodi si sovrappongono, fluendo dal
primo all’ultimo in un continuo intreccio, in una serie di sovrapposizioni strettamente geometriche. Questo è un dato fondamentale per la realizzazione del teatro musicale. Il teatro
musicale (pensiamo a Mozart), permette la sovrapposizione dei testi psicologicamente più
lontani, con le situazioni più diverse, in una contemporaneità, che solo le figure musicali
consentono. Personaggi, dunque, musicali, che fuori della musica non avrebbero senso.
Questa è la quintessenza del dramma musicale: la realizzazione di una polifonia di
personaggi. Ciò nella prosa è assolutamente inattuabile.
Pensi che questa dimensione strutturale, così tipica del teatro musicale, e che tu intendi
realizzare appieno, riveli un carattere di continuità rispetto al teatro musicale del passato?
Certamente. Ma tenendo presente che questo discorso riguarda l’intera musica, sinfonica o
da camera. Perché, sotto sotto, qui siamo di fronte al problema della “forma” e delle
“relazioni”.
È in questo senso che si può parlare delle sinfonie di Mahler come potenziale “teatro”?
Sicuramente. Ma andiamo più indietro, alla fine del ‘700. Mi ricordo di una
raccomandazione veramente rivelatrice di Casella a proposito della interpretazione delle
sonate per pianoforte di Mozart: “Per non renderle noiose, ricordatevi che ogni tema è un
personaggio”. Se il problema è quello della forma, non ha, per esempio, senso la
contrapposizione, che così spesso è stata formulata, fra Brahms e la forma del teatro. E
sull’onda di questo discorso sarebbe interessante richiamarsi al Wozzek di Berg, dove ogni
atto è costruito su cinque scene, ciascuna fondata su uno schema strutturale tradizionale.
Un’operazione di grande sapienza, che ha testimoniato che il problema formale di qualunque
musica per Berg e per molti altri musicisti del nostro secolo non è diverso da quello del
Musica e musicisti a Brescia
15
RENZO BALDO
teatro. La musica, oggi come ieri, ma forse oggi anche più di ieri, offre la possibilità di
“relazionare” gli elementi fra loro, in modo che ciascuna parte illumini l’altra. Da questo lato
mi ha fatto molto piacere Stockhausen, quando, interrogato a proposito dell’introduzione di
certi motivi diatonici che oggi egli usa frequentemente, ha risposto che gli interessa
diversificare dei personaggi e delle situazioni. “Se scrivessi — ha aggiunto — tutte le figure
alla Webern, non potrei farlo”.
Tu però quando componi la tua musica adoperi la dodecafonia, anzi ti servi
rigorosamente di una sola serie, sei uno schoenberghiano puro. Non accetti, per esempio, il
criterio berghiano dell’impiego, nel medesimo pezzo, di una pluralità di serie.
Certamente. La serie unica mi consente di garantire l’unità della composizione.
Accetti la definizione di neo-espressionismo per la tua musica?
No. L’espressionismo ha avuto la sua enorme importanza, ma se vogliamo evitare
confusioni la linea Schoemberg-Webern, sulla quale io mi trovo, non può accettare questa
definizione.
Pancromatismo?
Sì, si usa chiamarla così, e deriva direttamente da Webern. Ho incominciato a lavorare in
musica così fin dal 1940 e ho proseguito costantemente su questa linea.
Ma nel 1940 non avrai avuto molto materiale schoemberghiano sottomano.
Ne facevo delle ricerche accurate, anche con l’aiuto di amici, che perlustravano i negozi
musicali di Milano e altrove. Le leggi razziali, come è noto, proibivano la diffusione di testi
“ebraici” o di testi cosiddetti “degenerati”. Ma per fortuna i libri che non figuravano sugli
scaffali si trovavano sotto il banco, e qualcosa si riusciva a racimolare.
Dal 1940 ad oggi sono passati molti anni, lungo i quali tu hai continuato a comporre con
assiduità esemplare e, soprattutto, con rigorosa e coerente scelta di campo. Pensi che nel
corso del tuo lavoro, come qualcuno ha detto, ci siano delle “maniere” diverse?
Non direi. Ho praticato la serialità per precise convinzioni teoriche e con precisi fini
espressivi dilatando ed arricchendo, semmai, nel senso della complessità.
Una complessità che spiega, credo, anche quella che a qualcuno è sembrata la “lentezza”
del tuo lavoro. Su Blaubart, mezz’ora di musica, hai lavorato per anni.
Mi limiterò a dirti che per quel che nella partitura di Blaubart corrisponde a un secondo di
minuto mi è stato necessario un lavoro di circa due ore e mezza.
Quando si parla di Togni si usa apparentarlo con Stockhausen, Boulez, Maderna. Senti
davvero delle affinità con questi musicisti?
Un punto in comune l’abbiamo, l’esperienza di Darmstadt, fra il ‘46 e il ‘55. Ma poi ognuno
ha seguito strade decisamente diverse e personali.
Il risultato “fonico” della tua scrittura musicale è, all’ascolto, di un’agghiacciante
cristallinità e di una fantasmagorica ricchezza, quasi labirintica. Ti puoi riconoscere in
questa definizione, per quanto approssimativa?
Assolutamente sì.
Per il Blaubart hai optato per scene che si ispiravano a Klimt. Non credo si sia trattato di
una scelta casuale o di comodo. La complessità al tempo stesso sontuosamente decorativa e
“floreale” e inquietante sull’orlo di labirintici meandri del segno figurativo di Klimt è in analogia, credo, con la tua musica.
Non c’è dubbio. La Vienna di Klimt esprime il doppio volto di quella civiltà, luminosa e
perfino piacevole, e insieme cupamente profonda e introversa, voluttuosa e tragica. E sempre
con un linguaggio progressista.
Puoi fare altri riferimenti a esperienze figurative che senti affini al tuo modo di far
Musica e musicisti a Brescia
16
RENZO BALDO
musica?
Per Maria Magdalena, e forse anche per la prima scena di Barrabas, mi servirò di Nolde,
un’altra esperienza figurativa che sento molto vicina.
Una domanda di prammatica: quando si parla con un compositore d’oggi: tu senti di
avere un tuo pubblico o avverti una sensazione di solitudine?
Se per pubblico s’intende un preciso schieramento, che si manifesti nel senso tradizionale
del termine, posso anche avere qualche dubbio. Ma se s’intende un possibile referente in
grado di lentamente cogliere il significato di un’esperienza musicale, penso di si. Dico
“lentamente” pensando, per esempio, che Schoenberg non è stato ancora digerito, che Mahler
a mala pena ci si avvia oggi ad intenderlo, dopo incredibili incomprensioni da parte di pur
autorevoli musicisti e direttori d’orchestra... È del resto dai tempi dell’ultimo Beethoven,
quello soprattutto dei quartetti, che la cosiddetta frattura fra compositore e pubblico è così
spesso operante. Una storia destinata a ripetersi. Ma ciò che è veramente significativo prima
o poi diventa linguaggio accettato e compreso.
Giugno 1986
Musica e musicisti a Brescia
17
RENZO BALDO
SULLE INFINITE VIE DEL MONDO
Intervista ad Alceo Galliera
Un anziano signore, dal portamento distinto e dagli occhi penetranti. Forse un po’
diffidente e comunque non del tutto persuaso che le interviste servano a qualcosa. Però, sì,
due chiacchiere si possono fare.
Alceo Galliera, forse per timore di non apparire scortese, si accinge alla conversazione.
Credo gli dia la sensazione di un riemergere di memorie, che prendono corpo in sfaccettature
caleidoscopiche. L’esperienza vitale di un direttore d’orchestra, che per decenni percorre le
infinite vie del mondo e della musica, non può infatti che avere i contorni di una
fantasmagorica avventura, un fluire di immagini e di suoni, sul tessuto di incontri affascinanti e fuggevoli. Questo del resto, molto più che per altre arti, è il destino della musica: un
armonioso fluire di suoni, la creazione di atmosfere, che per qualche istante sembrano
addirittura negare il tempo e lo spazio, e poi si fanno “ricordo”, quasi inattingibile
stratificazione di memorie.
Alceo Galliera abita da qualche anno a Brescia, con la moglie Eva Frick, bresciana, titolare
di cattedra d’organo presso il conservatorio di Milano. È a Brescia da quando ha deciso di
chiudere la sua lunga avventura musicale e di ritirarsi nel silenzio museale di chi, avendo ben
speso la propria vita, può contemplare i propri ricordi, come tanti quadri appesi alle pareti
della propria esistenza. Forse per temperamento, forse per precisa scelta, Alceo Galliera vive
oggi in una sorta di splendido isolamento, rarefatti e ridotti al minimo i rapporti con persone
e ambienti. Quanti sono a Brescia che lo conoscono, che sanno che abita nella nostra città?
Eppure si tratta di un nome che ha dominato le cronache musicali per decenni. Diciamo però
la verità: molto più all’estero che in Italia.
Maestro, come è cominciata la Sua carriera di direttore d’orchestra?
Diciamo che ha avuto due cominciamenti. Uno, quando dopo aver seguito il corso tenuto da
Antonio Guarnieri all’Accademia chigiana mi si sono aperte le prime occasioni: alla basilica di
Massenzio e alla Scala. A Milano mi è toccata la simpatica ventura di dirigere il primo
concerto pubblico di Benedetti Michelangeli reduce dal trionfale successo di Ginevra.
La critica aveva già avvertito fin dagli inizi, diciamo così, la Sua “presenza” di direttore?
Direi di sì. Ricordo in particolare l’entusiasmo di Bruno Barilli, che io allora non conoscevo
personalmente, il quale tracciò un intervento critico, che certamente mi sorprese per la
finezza d’analisi e per la positività del giudizio. Usava, come era sua consuetudine, un
linguaggio pittoresco e inusuale, con immagini di divertente efficacia. Io, per esempio, ero
paragonato ad un orso, che fa crescere intorno a sé una foresta di suoni.
Tutto questo avveniva tra la fine degli anni trenta e i primissimi anni quaranta, quando
di Lei si parlava anche come di un organista molto apprezzato.
Sì, io avevo la cattedra di organo al conservatorio di Milano e tenni effettivamente un certo
numero di concerti. Ma erano tempi tristi, per la musica d’organo in particolare, che non
aveva assolutamente un suo pubblico, a differenza di quanto fortunatamente avviene oggi, già
da parecchi anni. L’ultimo concerto d’organo lo tenni nel ‘42.
Comunque è da quel momento che si perdono le Sue tracce in Italia. Cos’era avvenuto?
Le dirò che nel ‘43 per motivi razziali (la mia prima moglie era ebrea) mi rifugiai in
Svizzera. Qui ebbi l’occasione di partecipare a qualche iniziativa musicale e di dirigere una
Musica e musicisti a Brescia
18
RENZO BALDO
piccola orchestra a Lugano (come internato non avevo nemmeno il diritto al compenso). Qui
a Lugano una sera si trattenne in sala Aloys Moser, il critico de “La Suisse” di Ginevra, che
godeva di grande autorità in materia di musica. Io nemmeno lo conoscevo. Comparve sul suo
giornale un articolo nel quale si parlava della sensazionale scoperta di un direttore italiano,
che riusciva a far musica eccellente anche con un’orchestra che non era certo di alto rango. A
farla breve: mi vennero a cercare per invitarmi al festival di Lucerna. Così la Svizzera aperse
la mia carriera internazionale.
E dopo Lucerna e la Svizzera, è incominciato il Suo peregrinare per il mondo…
Sì, è stato proprio un percorrere le vie del mondo. E a questo ha contribuito anche un altro
ascolto casuale in sala. A Berna ad un concerto era presente Walter Legge, della casa
discografica Columbia (quello che ha sposato Elisabeth Schwarzkopf). Era un inglese, di
straordinario fiuto nello scoprire i talenti musicali. Ha scoperto e lanciato non so dirle quanti
grossi nomi della musica. Immodestamente dirò che ha fiutato anche me, più o meno grosso
che il mio nome sia. Da quel momento ho incominciato a incidere per la Columbia (per una
ventina d’anni). E così la mia attività ha percorso contemporaneamente le due strade del
concerto pubblico e della incisione discografica. L’una coinvolgeva l’altra. ‘‘
Può ricordare quali sono state le sue principali incisioni discografiche?
Il Barbiere di Siviglia con la Callas; i Notturni e La mer di Debussy, Dafni e Cloe di Ravel,
tutti e cinque i concerti di Beethoven con Arrau; il quarto e il quinto con Gieseking; il
concerto di Grieg con Lipatti, il Don Giovanni di Strauss; Ciaikowski con Geza Anda;
Prokofieff; il doppio di Brahms con Oistrak e Fournier.
Lei ha avuto anche degli incarichi stabili?
Sì, tre anni al Comunale di Genova e poi a Strasburgo, dove sono stato “directeur de la
musique” dal ‘64 al ‘72.
Di Strasburgo si dice che è una città per eccellenza musicale.
È così. Non è nemmeno una grandissima città, è poco più di Brescia, conta sui 350.000
abitanti. Ma è, forse, favorita, oltre che da un’eccellente e radicatissima tradizione, anche
dalla posizione geografica tra Francia e Germania. Il numero degli abbonati alla stagione
musicale pubblica esige sempre la ripetizione di ogni concerto. Gli anni di Strasburgo sono
stati per me indimenticabili per lo straordinario fervore che la città intera dimostrava.
Ricorda in particolare qualche sua altra esperienza di pubblico?
Potrei citare i mesi trascorsi in Australia. Soprattutto mi ha colpito il pubblico di
Melbourne, dove la stagione concertistica è seguita da novemila abbonati. E quello di Sidney,
dove gli abbonati sono addirittura undicimila.
Mi consenta una parentesi. Durante questi suoi viaggi, in questi grandi centri stranieri,
ha avuto l’impressione che ci fosse una qualche diffusione della cultura italiana, sul tipo di
quella che fanno in Italia organismi come il “Centre” francese o il “Goethe Institut”?
Non so oggi come vadano le cose. Per il passato, salvo lodevoli eccezioni, piuttosto male. Ma
per non sfuggire alla sua domanda dovrei chiederle il permesso di fare qualche pettegolezzo.
Faccia pure. C’è chi sostiene che il pettegolezzo è il sale della vita...
A Melbourne, in una serata dedicata alla musica italiana, c’era un gruppo di mandolini (sì,
lo so, si può fare musica eccellente anche con i mandolini, ma là non era proprio il caso) e una
cantante che cantava “Vorrei baciare i tuoi capelli neri...”. A Brisbane ho assistito a un
concerto con un pianista che si voltava lui stesso le pagine, si può immaginare con quali
risultati. Mi ricordo di una signora, moglie di un personaggio altolocato, lei stessa con pretese
di organizzatrice di cultura, che, in occasione di una messinscena del “Gianni Schicchi” di
Puccini ebbe a dire che si trattava della celebre opera con la battuta “Che fai paggio
Musica e musicisti a Brescia
19
RENZO BALDO
Fernando, che parli e non favelli?”. Vedi, mi spiegò causticamente un amico che assisteva alla
conversazione, ha confuso “Una partita a scacchi” con una partita a schicchi. In un’altra
occasione una signora, anch’essa impegnata (!) culturalmente, mi chiese se avevo diretto
ancora “Il concerto dell’“Otello” (sic). Ma mi consenta invece di ricordare, tra le lodevoli
eccezioni, l’operato di un bresciano, addetto culturale a Strasburgo, Giuseppe Cerri, che ha
fatto per anni un lavoro esemplare, con iniziative organiche ed intelligenti, di prim’ordine.
Torniamo a Lei e alla sua attività. Può dirmi in breve quali sono stati gli orizzonti del Suo
repertorio musicale?
Le dirò che io sono stato, e ancora mi sento, un “tradizionalista”. Il mio orizzonte, diciamo
così, è la musica da Mozart a Mahler, con particolare devozione al momento del
romanticismo, del post-romanticismo e dell’impressionismo.
Niente “avanguardia”? la musica finisce con Mahler?
Non ho alcun atteggiamento preconcetto nei confronti della cosiddetta “avanguardia”, ma,
semplicemente, la “sento” poco. Ho fatto qualcosa di Strawinski (che a dir la verità è forse
l’unico che “sento” molto, e mi dispiace di non aver avuto l’occasione di coltivarlo
maggiormente). Ho fatto anche Prokofieff, Sciostakovich, Bartok. Ma l’avanguardia vera e
propria mi è sempre rimasta un poco estranea.
Le dirò anche: ho sempre avuto la fortuna di far musica per “piacere” e non per “dovere”, ho
fatto musica da “signore”, con un grande piacere personale. e questo piacere, lo confesso, io
lo provo, come ora le dicevo, sulla musica tra romanticismo e impressionismo.
Fino a Mahler, dunque, la musica come “piacere”. Dopo Mahler la musica come “dovere”...
È uno spunto che nella sua forza sintetica potrebbe dire molto, e meriterebbe qualche
approfondimento. Ma lasciamo pur stare. Mi dica piuttosto cosa pensa effettivamente di
Mahler.
Di Mahler ho fatto la prima e la quarta, i Cinque canti di Ruckert, e i Lieder eines
fahrenden Geseller. Lo considero un grande musicista. Qualcuno dice: l’ultima tappa della
musica occidentale. Io non dirò così. Mi limito a constatare che è una grande tappa.
E di Rachmaninoff che cosa pensa?
Ho fatto il secondo concerto con Geza Anda, la Rapsodia con Firkusny. È uno Chopin
rammodernato, con una venatura russa, nobile e raffinato, ma forse non così significativo
come qualcuno ritiene.
La professione del direttore d’orchestra consente l’incontro con gli ambienti e le realtà più
disparate. Quali ricordi più forti ha in proposito?
Invero ogni ambiente e ogni pubblico costituiscono un’esperienza. Dirigere un’orchestra
significa far musica, e durante le prove il contatto, quello più vero e autentico, è con gli
orchestrali e con i solisti. Un contatto difficilmente definibile razionalmente: è una specie di
fluido, che si instaura e che governa l’incontro. Il momento veramente culminante, che dà
brividi di intensa soddisfazione, è sempre stato, per me, il momento delle prove. Poi, il
concerto vero e proprio. col pubblico, è una specie di appendice, necessaria ed anche, se si
vuole, per certi suoi aspetti esaltante, ma non così profonda ed assorbente come l’altro
momento che la precede.
A proposito di solisti, quali sono stati gli incontri più vivi per lei, quelli che Le hanno
lasciato un ricordo più profondo?
Molti: Schnabel, a Londra; Rubinstein con il secondo concerto di Brahms; Lipatti
(veramente indimenticabile) la cui morte precoce impedì la realizzazione di programmi, che
già erano stati concordati, e ancora, sempre indimenticabili, Clara Haskil con Mozart e Bach;
Fournier, Oistrak, Rabin (un altro grande scomparso giovanissimo). Né posso dimenticare
Musica e musicisti a Brescia
20
RENZO BALDO
Kogan, Grumiaux, Geza Anda (col quale sono venuto a Brescia con l’orchestra di Strasburgo
in occasione di un festival).
Una bella galleria di nomi...
Sì, e le dirò che la cosa più straordinaria, nell’incontro con il solista, è che di solito ci si
scambia pochissime parole, anche perché spesso la diversità della lingua lo impedisce. Anche
a questo proposito sono costretto a parlare di fluido: ci si intende con pochi sguardi e con la
percezione, un po’ misteriosa, di quel che si debba fare. Quando partono le prime note, pare
si intrecci un dialogo, in quella straordinaria lingua che è la musica. Ricordo le prove di un
concerto con Kogan: non ci siamo detti neanche una parola, non ha avuto nulla da ridire,
tutto è filato via meravigliosamente, dalla prima all’ultima nota. Naturalmente non è
casualità, come a qualche sprovveduto potrebbe sembrare; il lavoro preparatorio con le prove
d’orchestra determina concretamente questa incantevole possibilità.
Abbiamo parlato finora di musica sinfonica. Ma Lei non ha fatto esperienza direttoriale
anche con il teatro musicale?
Sì, ma non molto: Falstaff, Rigoletto, Bohème, Norma, Sonnambula. Ho anche dei ricordi
molto belli di cantanti di eccezionale bravura: Rossana Carteri, Alfredo Kraus, la Moffo, la
Callas. Ma non ho mai cercato di incrementare la mia attività nel campo dell’opera, credo per
questa ragione, che mi metteva un po’ di disagio la difficoltà di trovare un cast di cantanti
omogeneo nella qualità. Questo frequente handicap nella messinscena di un’opera mi ha
sempre un poco infastidito, un poco disamorato da questo settore della direzione musicale.
Che cosa deve esigere un direttore d’orchestra, perché tutto funzioni per il meglio, perché,
appunto, ci sia “qualità”?
Qualità dell’orchestra, numero di prove adeguato, programmi ben ragionati e non
raffazzonati.
E le qualità del direttore quali devono essere?
Prima di tutto non pensare che dirigere significhi battere il tempo. Quello che conta è la
concertazione: sottolineare il ritmo, modellare le sonorità, scoprire il fascino delle coloriture,
far emergere le parti nel loro giusto equilibrio. E naturalmente: studiare accuratamente la
partitura.
La capacità di dirigere è un fatto di natura o di cultura? È un vecchio dilemma, sul quale
sentirei volentieri la sua opinione.
Occorrono entrambe. La cultura è fondamentale, e quel che pocanzi ho detto vi rientra. Il
dato “natura” è invece un imponderabile, appartiene alla stratificazione profonda della
personalità. Io non saprei come esattamente definirlo o analizzarlo. Resta sempre, credo, un
dato un po’ misterioso. Come si spiega il fatto che un grande musicista come Debussy fosse
assolutamente incapace di dirigere un’orchestra?
Lei dice che dirigere non significa “battere il tempo”. Il gesto però ha una sua significanza
non secondaria.
Certo. Ma il gesto è anche occhio, sguardo, espressione del viso, è polso, braccio, mezzo
braccio. Il tutto in funzione della definizione di ogni attimo del discorso musicale, di ogni
battuta nella sua espressività.
Un’ultima domanda. Cosa pensa dell’attuale “espansione” che la musica da qualche anno
registra nel favore della gente?
È un dato certamente interessante e positivo. Talvolta però ho l’impressione che ci siano
degli entusiasmi un po’ ingenui o un po’ patologici; non bisognerebbe dimenticare che la
musica non è una corrida. I pubblici di qualche anno fa, più ristretti, erano forse più
“attrezzati”. Ritengo comunque importante che siano centri di attività musicale ad alto livello
Musica e musicisti a Brescia
21
RENZO BALDO
non soltanto le grandi città, le metropoli, ma anche altre città minori, le città di provincia.
Solo così la musica può diventare un nutrimento diffuso e non elitario.
Ottobre 1986
Musica e musicisti a Brescia
22
RENZO BALDO
NELLA TRINCEA DELLA MUSICA
Intervista a Franco Margola
Al centro di una stanza straripante di libri e di partiture, una scrivania stracarica anch’essa
di libri e di fogli di musica, che dilagano da padroni. Più che uno studio sembra un archivio o
un laboratorio. Un marcato gusto liberty colorisce l’ambiente. Alle pareti un medaglione di
Bistolfi con busto di Toscanini, la riproduzione di un mosaico ravennate che sembra intinta
nel gusto degli anni dieci, qualche quadro di buona fattura vagamente primo novecento, due
Di Prata al posto d’onore sopra un pianoforte Ehrard, che nella linea e negli intagli rivela la
sua nascita negli anni ‘20 (ne premo qualche tasto: ottima tenuta di suono, solo sottilmente
arcaico, come si addice ad uno strumento, che ha più di sessant’ anni).
Franco Margola di anni ne ha anche qualcuno di più, e precisamente settantotto: il decano,
credo, dei musicisti bresciani. Pronto e vivace nel gesto e nella parlata, mi riceve con un garbo
che sfuma simpaticamente in un po’ di ironia. Veda un po’ se riesce a trovare un angolo dove
sedersi... Sì, c’è una sedia con sopra dei libri, neanche tanti. Basta toglierli che si può trovare
un posto per conversare.
Ma Lei, Maestro, vive qui come in una trincea, gli dico, accennando al cumulo di
materiale che si assiepa da ogni parte.
Sì, è la mia trincea, la trincea della musica. Passo qua dentro l’intera giornata. Un po’
suono, un po’ leggo, e soprattutto compongo, perché, guardi il caso, mentre per anni ho
composto musica quasi sempre, come si usava dire una volta, per “ispirazione”, quando mi
veniva l’estro, adesso compongo quasi esclusivamente su “ordinazione”, di editori, che mi
chiedono soprattutto musiche per pianoforte e, non le sembri strano, per chitarra. Uno
strumento che avevo trascurato per tanto tempo e che da una decina d’anni, invece, mi
occupa molto. È uno strumento che mi affascina e per il quale c’è una grande richiesta.
Sicchè il già lungo elenco delle sue composizioni non è ancora chiuso.
No, non è ancora chiuso, e ciò, devo dirlo, mi dà una certa soddisfazione, mi fa sentire vivo,
e mi aiuta a vivere come sempre mi è piaciuto, a tu per tu con le note musicali.
Una vita per la musica e con la musica?
Direi proprio di sì. Mi sono impregnato di musica fin da ragazzino. Andavo al pianoforte e
mi veniva istintivo di comporre qualcosa.
Lei viene da una famiglia di musicisti?
No. Le dirò anzi che mio padre usava ripetere (parlava un dialetto veneto): “Mi non vòio
sonador in casa”. Ma poi si rassegnò e mi lasciò percorrere la mia strada, anche sempre con
una cert’aria di sopportazione e di indifferenza. Mi ricordo che quando tornai da Parma felice
e trionfante per aver preso dieci nella prova di “fuga”, un voto che mandò in visibilio i miei
maestri, mio padre ostentò la più assoluta indifferenza. Era fatto così, ma gli sono grato di
non avermi mai messo bastoni tra le ruote e di avermi lasciato dare sfogo alla mia passione
per la musica.
Lei ha studiato a Brescia?
Mi sono diplomato in violino sotto la guida di Romanini e ho studiato pianoforte e
contrappunto con Capitanio. Ho poi terminato i miei studi di composizione a Parma con
Carlo Jachino e a Napoli con Achille Longo.
L’impianto fonico delle sue musiche, almeno quelle che ho avuto l’occasione di sentire, si è
sempre mantenuto, se non vado errato, entro l’orizzonte della tonalità. È così anche per le
Musica e musicisti a Brescia
23
RENZO BALDO
sue più recenti composizioni?
Sì. Non sono mai rimasto persuaso della dodecafonia, soprattutto dal suo uso totalizzante e
indiscriminato. Qualche volta l’ho adoperata anch’io, ma soltanto quando mi sembrava utile e
necessaria per ottenere un determinato risultato espressivo. Farne un uso costante ed
esclusivo mi sembra che contrasti con la natura stessa della musica, perché toglie di mezzo la
forza dei contrasti. Sono intervenuto più volte, anche per iscritto, su questo dibattito. Sono
rimasto dell’opinione che il linguaggio dodecafonico può essere adoperato per ottenere
qualche risultato connotato da caratteristiche di asprezza, di inquieto dissolvimento, ma che
il suo uso sistematico e indifferenziato dia luogo ad un appiattimento espressivo, che rischia
la noia e una nuova forma di accademismo. Detto con altre parole: il mondo non è soltanto
“dissonanza”.
Da quanto mi sta dicendo mi sembra anche di capire che Lei ritenga che c’è una precisa
corrispondenza tra il fatto musicale e gli stati d’animo.
Certamente. La dodecafonia può esprimere certi stati d’animo, così come, per esempio, la
diatonia altri. Ogni organizzazione del dato sonoro, nei più vari sistemi, nelle più varie
gamme, consente di mettere in luce, se creativamente adoperato, diversità e molteplicità di
stati d’animo. Sì potrebbe definire la musica come un incessante studio per la
rappresentazione di situazioni dell’anima. L’impiego rigido ed esclusivo della dodecafonia
esclude arbitrariamente di portare lo sguardo sulla infinita molteplicità dell’animo umano.
C’è, credo, senz’altro qualcosa di vero quando Lei afferma la rispondenza tra musica e
stati d’animo. Sì potrebbero, per esempio, leggere Mozart o Beethoven o Debussy
individuando di volta in volta, nella singola pagina, nella singola frase, allegria, tenerezza,
slancio, accoratezza (e così via dicendo, con una buona dose di approssimazione, ma
sicuramente con un utile approccio didascalico). Nella pagina musicale c’è però qualcosa di
più, c’è la realizzazione di un linguaggio che la rende individuabile nella sua originalità,
nella sua capacità di porsi, vorrei dire, “storicamente”, con un suo preciso significato e una
sua rigorosa valenza espressiva. I sostenitori della dodecafonia sono, su questo, irriducibili:
la musica d’oggi, se non vuole perdersi in una stanca ripetitività, non può non essere che
così, saldamente legata al linguaggio dodecafonico, che essi sentono come coerente, necessario risultato di uno svolgimento che non può avere diverso approdo.
Conosco bene questo loro ragionamento, ma mi sembra astrattamente teorico. Rimango
della convinzione che il patrimonio fonico di cui disponiamo è una immensa miniera dove il
musicista può attingere a piene mani. E il risultato del suo lavoro acquisterà la valenza che il
compositore sarà stato capace di imprimergli, insignificante, mediocre, interessante, grande,
al di là delle scelte compiute tra le gamme sonore che fisicamente e storicamente gli si
offrono. Non credo si possa giudicare il valore di una musica in base alla scelta del materiale
fonico. Anche il compositore rock può contribuire a creare l’orizzonte della musica d’oggi.
Quali esperienze musicali moderne ha sentito a Lei più congeniali, a Lei più vicine?
Direi, qui in Italia, soprattutto Casella, ma anche Pizzetti e, su un diverso versante, Ghedini.
Fra gli stranieri Strawinski e Prokofieff, che considero entrambi grandi creatori di musica.
Assai meno, a mio parere, Sciostakovic, che mi sembra monotono e ripetitivo.
Facendo un breve passo indietro, Rachmaninoff e Skriabin le dicono qualcosa?
Rachmaninoff è un abilissimo cucitore di suoni, ma non è un musicista creativo. Skriabin
non lo capisco.
Della tradizione ottocentesca c’è qualche musicista che ha contribuito a determinare il suo
linguaggio musicale?
Direi Schumann, soprattutto nei primi anni del mio lavoro di compositore.
Musica e musicisti a Brescia
24
RENZO BALDO
Tra le numerose sue musiche, può indicarmi quelle che Lei ritiene più significative?
È una domanda alla quale non saprei bene come rispondere. L’apprezzamento della
“significatività” forse spetta più all’ascoltatore che all’autore. Posso dire a quali mie partiture
sono forse più affezionato. Dico forse, perché a me succede (ma credo succeda a tutti i
compositori) di sentire le mie composizioni come tanti figli, per i quali si sente sempre affetto, anche se qualcuno è un po’ più bellino degli altri... Ma se devo proprio scegliere, ecco,
sceglierei il Kinderkonzert per piano e orchestra, le Sonate per pianoforte, il Concerto per
due pianoforti e orchestra, il Quintetto per due violini viola e violoncello, i Tre epigrammi
greci, le Impressioni per trio d’archi e chitarra. Non le nego che su questa scelta incide un po’
anche il fatto che queste sono fra le musiche che hanno avuto maggior successo e gli
apprezzamenti più lusinghieri di esecutori e di critica. Alcune di queste musiche hanno avuto
anche edizione discografica.
Tra le esecuzioni di Sue musiche, ne ricorda qualcuna che Lei ha particolarmente
apprezzato?
Direi, sopra tutte, Benedetti Michelangeli, che più volte ha eseguito il concerto per
pianoforte e orchestra; il Quintetto Chigiano, il trio Casella Bonucci Poltronieri. Anche questa
però è una domanda imbarazzante, perché molte altre esecuzioni mi hanno soddisfatto, e mi
riuscirebbe qui troppo lungo elencarle.
Cambiando argomento: Lei segue la vita musicale bresciana?
Sì, mi sembra abbastanza ricca, ma un po’ disordinata e qualche volta un po’ ripetitiva.
Lei ha partecipato in prima persona alla vita musicale bresciana?
Sì, ma per brevi anni, e in anni assai lontani. Poi ho insegnato composizione a Messina, a
Bologna, a Roma, e ho diretto il Conservatorio di Cagliari. Tutti impegni che mi hanno tenuto
lontano da Brescia.
Per chiudere, un’altra domanda. Lei dice che passa la giornata anche leggendo. Quali
sono le Sue letture preferite?
Leggo un po’ di tutto, senza un programma preciso.
C’è un suo autore preferito?
Sì, Thomas Mann. E, le sembrerà strano, un autore oggi poco letto, Anatole France. Ma Le
devo dire che come musicista ho forse subito più l’influenza della pittura che della letteratura.
In particolare ho sentito molto Picasso, che mi sembra un pittore che ha molto da insegnare
anche a un musicista.
Dicembre 1987
Musica e musicisti a Brescia
25
RENZO BALDO
IL MANDOLINO ESCE DALL’ECLISSI
Intervista a Ugo Orlandi
Il mandolino, singolare strumento, oggetto di amore e di disprezzo. Per secoli lo strumento
più diffuso, più simpaticamente in grado di identificarsi con la passione amatoriale per la
musica, presso tutti i ceti, dalle osterie alle corti. Accarezzato, sognato, goduto con gli occhi,
suonato, strimpellato; al chiaro di luna, all’alba e al tramonto; sulle scene dei melodrammi,
nei salotti di dame colte e raffinate, sulle barchette mollemente ondeggianti sull’acqua del
laghi, negli angiporti, nelle scampagnate, nelle taverne. In Italia e in tutta Europa. Ma in
Italia con tale capillare presenza che qualcuno l’ha considerato quasi un simbolo. E qualcuno
ci si è anche arrabbiato, pensando che fosse il simbolo di un popolo esangue e senza nerbo,
un popolo canoro e strimpellante, che aveva sostituito la spada con il plettro. Fra gli
arrabbiati, in un suo celebre discorso, pure S.E. il cav. Benito Mussolini, che, come è noto,
nella sua immagine pubblica ci aveva messo anche il violino (infinite sono le vie attraverso le
quali si ottengono consensi), ma i mandolinisti, proprio, no, non gli andavano a genio. Forse
non sapeva che tra i migliori mandolinisti del ‘700 c’è un suo antenato o comunque uno della
sua stirpe, Giulio Cesare Mussolini, nato a Predappio e autore di canzoni per mandolino voce
e cembalo.
Difficile, in realtà, pensare che dei possibili, o presunti, italici snervamenti sia stato
colpevole il mandolino. Fatto sta, però, che, almeno presso le persone cosiddette colte, il
mandolino ha subito, per qualche tempo, un’eclissi di prestigio. Dire di uno che suonava il
mandolino era come metterlo ai margini della musica. Solo da pochi anni si sta uscendo da
questo antistorico pregiudizio, un po’ altezzoso e un po’ ridicolo, come tutti i pregiudizi. Il
mandolino sta riprendendo quota, per merito di valenti strumentisti, che ne stanno
recuperando l’immagine più autentica e culturalmente fondata.
Uno di questi strumentisti è un bresciano, Ugo Orlandi. Ventotto anni, titolare a Padova
dell’unica cattedra italiana di mandolino, solista preso i Solisti veneti, concertista affermato
— per niente esangue e snervato — sempre in giro per il mondo, dall’Europa al Giappone,
dove, a quanto pare, il mandolino non provoca disagi alla coscienza colta.
Bisogna prenderlo al volo, Ugo Orlandi, in una sosta a casa sua, in via Battaglie. Su un
tavolo, su una parete, dietro i vetri trasparenti di una scaffalatura, numerosi strumenti a
plettro; uno russo, uno turco, uno argentino, uno brasiliano, uno splendido mandolino
dell’800 intarsiato e filettato con arte squisita. Ah!, penso, l’Orlandi è sulla strada del
collezionismo. Bisognerà tornare a trovarlo un’altra volta per parlare di questi strumenti.
Ma oggi dobbiamo parlare d’altro. E cominciamo, come si usava dire un tempo, ab ovo.
La cosa che forse m’incuriosisce di più, in lei, è di sapere come le è nata la passione per il
mandolino, portata fino all’apice del concertismo.
La passione la devo a una persona: Giovanni Ligasacchi. Facevo la seconda elementare,
quando venne alla scuola Calini per cercare di avviare qualcuno alla musica: scelse i più
disperati, fra i quali c’ero anch’io. Ci mise a suonare il tamburo, e in breve diventammo i
tamburini della banda. Dopo qualche tempo tirò fuori gli strumenti nobili: il clarinetto, l’oboe, la tromba... Strumenti nobili, da dare in mano a ragazzi che garantissero di non
guastarli... Io non ero fra quelli; mi misero in mano un mandolino tutto scalcinato, tenuto
insieme con dei fili da sacchetto di limoni. Ne ero orgogliosissimo. Per un anno però non
combinai niente. Poi, improvvisamente, mi impadronii con grande rapidità della tecnica dello
strumento: lo sentivo parte di me. Ma compiuti i sedici anni Ligasacchi decise di iscrivermi al
Musica e musicisti a Brescia
26
RENZO BALDO
corso di tromba del Conservatorio, nella convinzione che con quello strumento avrei avuto
facilmente uno sbocco professionale. Ma io continuavo a suonare anche il mandolino, e mi
arrabbiavo quando mi dicevano che era uno strumento inferiore. E quando ebbe notizia che
era stata istituita la cattedra di mandolino a Padova, mi iscrissi, di nascosto. Mi diplomai in
tromba, nel frattempo, ma a Padova nel ‘78 suonai il mandolino con i Solisti veneti. Subito
dopo ebbi l’occasione di suonarlo in un film di Reichenbach sulla vita di Vivaldi. Mi resi
conto, allora, che la mia strada era quella. E mi buttai a fondo nel recupero del patrimonio
storico che sta alle spalle di questo strumento.
I corsi che aveva seguito a Padova le avevano dato indicazioni in questa prospettiva?
Sostanzialmente devo dire di no. Il mio maestro, Anedda, era un uomo di grandi qualità,
che mi avviò molto bene al possesso della tecnica dello strumento, ma, come gusto, aveva una
formazione romantico-ottocentesca, e ciò che era fuori di questo ambito non lo interessava.
Io, invece, avevo la passione delle biblioteche e degli archivi. E mi si spalancò una realtà
musicale di grandi proporzioni: Beethoven, Mozart, la musica
del ‘600 e del ‘700. Mi resi conto che bisognava approfondire con coscienza critica questo
vasto repertorio (basti pensare che del ‘700 ci sono ben 30 concerti per mandolino e
orchestra), non solo, ma collocarlo nell’ambito, diciamo così, dei suoi antenati, nella
complessa storia degli strumenti a plettro. Una storia affascinante, che ci riporta, su per i
secoli, fino al mondo arabo-medio orientale, che, del resto, è stata la matrice dell’intera vita
musicale europea.
Lei, dunque, si è reso conto che recuperare il mandolino significava recuperare
un’autentica dimensione culturale, che affonda le sue radici nei secoli. La sua carriera
concertistica, perciò, si è appoggiata anche ad un approfondimento della immagine storica
dello strumento; ha avvertito che doveva farlo uscire dall’immagine stereotipata, alla quale
spesso è stato ingiustamente ridotto, mediante una ricerca che ne chiarisse il significato
culturale. Non ha mai scritto qualcosa in proposito?
Non ho osato ancora farlo, perché si tratta di una realtà così complessa, anzi intricata, che
può far prendere facilmente degli svarioni, come ho notato che è capitato anche a illustri
storici della musica. È un campo ancora tutto da dissodare. Ma va detto che oggi i giovani
musicisti si rendono conto di questo, seguono la ricerca musicologica e stanno rapidamente
crescendo nel gusto e nella capacità di realizzare questo approfondimento culturale.
Che cosa mi può dire di come si è svolta la sua carriera concertistica?
Forse sono stato fortunato. Se penso che si tratta di uno strumento fino quasi ad oggi poco
preso in considerazione, poco richiesto, che non dà grandi possibilità di carriera, quasi mi
stupisco della grande quantità di impegni concertistici. Evidentemente qualcosa sta
cambiando, e forse lo sforzo che abbiamo fatto per far comprendere questa area della musica
sta dando i suoi frutti. Suonare con i Solisti veneti mi è stato estremamente utile: mi hanno
aperto la strada verso pubblici esperti e ben selezionati.
Più all’estero o più in Italia?
All’estero sicuramente l’interesse, anzi la passione per il mandolino è più diffusa. Forse per
una ragione storica. Nel ‘700 c’erano più insegnanti di mandolino a Parigi che in tutta Italia.
La cultura mandolinistica napoletana era stata trasferita in Francia tramite Mazarino. Tutti i
metodi per mandolino sono stati stampati in Francia e poi tradotti in inglese a Londra. Non
dimentichiamoci che Rousseau era un appassionato del mandolino, tanto è vero che è sua la
voce “mandolino” sulla Encyclopedie. Tuttora in Francia il mandolino è uno strumento
familiare. Basti ricordare che nell’83, in un ciclo della Sala Pleyel, la più importante sala da
Musica e musicisti a Brescia
27
RENZO BALDO
concerti della Francia, intitolato “Prestige de la musique”, hanno voluto che figurasse il
mandolino.
E nei paesi tedeschi?
Le basti dire che l’Associazione mandolinistica tedesca ha settecentomila iscritti. Con la
Germania ho un rapporto veramente privilegiato. Anzi, posso dire abbiamo, perché oltre ad
esservi invitato personalmente per concerti e per partecipare a giurie di concorsi,
ripetutamente ci siamo andati con l’Orchestra a plettro “Città di Brescia”. Le riviste musicali
tedesche ci hanno dedicato a più riprese articoli e servizi.
Quali sono i musicisti più noti che si sono occupati del mandolino?
Paisiello, Vivaldi, Giuliani, Mozart, Beethoven (quattro sonate), Strawinski, Schoenberg,
Webern, Mahler, che lo ha inserito nella settima e nella ottava sinfonia. Per non dire
dell’ampia presenza nella letteratura musicale, barocca, dove il mandolino ha largo spazio.
Ma per la nostra città è sicuramente importante il concerto di Hummel dedicato al bresciano
Bartolomeo Bortolazzi (eseguito per la prima volta a Brescia nel 1985 in occasione della
rassegna degli strumenti a pizzico - n.d.r.).
C’è una qualche attenzione, fra i giovani, per questo strumento? E che cosa consiglierebbe
a chi volesse avviarsi su questa strada?
La cattedra di Padova prevede dieci iscrizioni. Dato il numero delle richieste, io me ne
prendo volentieri altri cinque. Consiglierei però di impegnarsi in questo studio non tanto per
la possibilità di fare carriera, quanto per il piacere di suonarlo, di praticarlo come scelta
dettata da un preciso gusto personale, guidato da una passione interiormente convinta.
Secondo me è fondamentale che si pratichi la cosiddetta attività amatoriale. Molte crisi di
molti professionisti dipendono dall’assenza di questo piacere. Se non sono chiamati a
sostenere un concerto pubblico, non suonano. L’attività nei gruppi amatoriali consente, tra
l’altro, di mantenere e di controllare con continuità la propria pratica musicale, è un
incentivo a migliorare, con una convinta e personalmente persuasa partecipazione.
La terminologia “attività amatoriale” corrisponde, credo, a quello che una volta si
chiamava “dilettantismo”.
Certamente. Ma quel termine ha assunto un significato deteriore, ed è stato bene
sostituirlo. Ma non dimentichiamoci che i cosiddetti “dilettanti” hanno costituito l’ossatura
portante della civiltà musicale. Senza di essi probabilmente non ci sarebbero stati neanche i
grandi musicisti, che hanno quasi sempre scritto avendo come referente l’area del dilettantismo.
Da quanto lei dice, però, mi sembra di ricavare anche una sua convinzione che fra area
“amatoriale” e area “professionista” non c’è diaframma.
Certo. I professionisti, secondo me, devono partecipare all’area amatoriale, e nell’area
amatoriale, spesso, si formano i professionisti. Ed è l’area amatoriale, oltretutto, che stimola
la ricerca dei testi, il recupero della musica, che giace nelle biblioteche e negli archivi, e
consente di far conoscere musiche, che rompano il cerchio chiuso, la routine che caratterizza
troppo spesso i programmi delle società concertistiche.
Aprile 1987
Musica e musicisti a Brescia
28
RENZO BALDO
LA MUSICA È SPETTACOLO?
ANCHE... PURCHE’ NON SIA SNOB
Una conversazione con Isacco Rinaldi
Isacco Rinaldi, bresciano di Flero, attualmente direttore del Liceo Musicale pareggiato di
Bergamo, ha alle sue spalle una carriera di concertista e una intensa attività di organizzatore
della cultura musicale. È uno dei tanti bresciani, che a Brescia ormai hanno poche radici, ma
che a Brescia hanno respirato il clima culturale locale e da esso hanno tratto le prime linfe
che li hanno portati a percorrere le vie della musica.
Cordiale, ma di non molte parole, Rinaldi ci riceve nella sua abitazione di Desenzano, dove
ama soggiornare quando si disimpegna dal suo lavoro professionale. È un piccolo
appartamento, quasi disadorno, che sembra rispecchiare il personaggio: asciutto, essenziale
nei gesti e nel discorso, senza alcuna concessione estetizzante, né per sé né per l’ambiente
dove vive. Per chi è convinto, come il celebre Swann di Proust, che ogni persona sia già stata
immortalata nelle figure di qualche pittore, che l’ha sicuramente pre-vista, e tocchi a noi
rintracciarla nelle immagini che incontriamo sulle pale d’altare o nelle tele dei musei, beh,
potremmo azzardare che Isacco Rinaldi sembra a qualche personaggio ritratto da Césanne,
per esempio il celebre “Chocquet seduto”: un personaggio recettivo e sensibile, dallo spirito
indipendente, che ti guarda con dolcezza e al tempo stesso con un forte distacco.
Personaggi siffatti un po’ ti intimidiscono, e non sai bene da che parte prenderli. Ma c’è
sempre una scappatoia; proviamo un po’ a chiedergli da dove è partito: ognuno ha avuto la
sua partenza, in anni più o meno lontani; e questi recuperi della memoria, dove sapori
“nostrani” si mescolano col fascino del “remoto”, consentono di creare un terreno d’ incontro.
Quali sono, dunque, le “origini” musicali di Isacco Rinaldi?
Io sono nato alla musica in modo un po’ strano. Avevo cinque o sei anni quando mio padre,
che cantava nel coro della parrocchia e suonava la chitarra, si accorse che sapevo riconoscere
e riprodurre i suoni. Mi portava in giro come un fenomeno da baraccone, a dar prova di
questa mia abilità. Poi mio padre mi fece trovare in casa un vecchio pianoforte viennese
(credo sia ancora in uso oggi, all’asilo di Flero) e ci strimpellavo sopra, combinavo gli accordi,
inventavo melodie, insomma giocavo volen tieri con la tastiera. Mi mandarono a lezione dalla
maestra Bonetti, allora molto nota in città, allieva di Anfossi, poi da un certo Gatti, a casa del
quale, un bel giorno, mentre stavo suonando, entrò Benedetti Michelangeli, che manifestò un
qualche interesse per il mio modo di suonare e mi incoraggiò a continuare iscrivendomi al
Conservatorio. Qui ebbi la fortuna di essere allievo di Enrico Moroni, che era un didatta di
eccezionale bravura e sensibilità. Devo a lui l’impianto del mio pianismo. Come devo
moltissimo a Benedetti Michelangeli, che mi fece iscrivere alla sua scuola di Bolzano e del
quale frequentai i corsi di Appiano, dove Benedetti aveva trasformato la sua casa in un vero e
proprio centro di perfezionamento.
E quando iniziò la sua carriera di concertista?
Anche prima di diplomarmi suonavo un po’ dappertutto, dove mi capitava. Sentivo il
fascino di suonare in pubblico. Ma una attività più sistematica e ben orientata l’iniziai dopo il
diploma, prima in duo con Franco Braga, poi in quintetto e in duo col violinista Piovesan. Poi,
“solidificata” la mia esperienza del pianoforte con Benedetti Michelangeli, iniziai anche come
solista.
Lei come ricorda Benedetti Michelangeli “insegnante”?
Musica e musicisti a Brescia
29
RENZO BALDO
Gli devo moltissimo. È incredibile la sua capacità di farti penetrare un testo musicale. Con
Benedetti s’impara non a suonare per suonare, ma a suonare per conoscere. La pagina
musicale per lui è una miniera, un tessuto che va riconosciuto e scoperto nelle sue più riposte
sfumature. Veramente un’esperienza esaltante.
Come si è svolta la sua carriera di concertista?
Ho suonato, oltre che in Italia, in Cecoslovacchia, Svizzera, Spagna, Ungheria. Talvolta con
un ritmo di lavoro quasi stressante. Ricordo per esempio l’integrale delle sonate per violino di
Beethoven con Accardo, che ci impegnarono moltissimo.
E la sua attività di insegnante?
Benedetti mi affidò incarichi di insegnamento a Bolzano e ai corsi di Arezzo. Poi entrai nel
conservatorio di Ferrara, alla cattedra di pianoforte.
Lei, a quanto mi risulta, è anche diplomato in composizione.
Sì, ho studiato composizione, all’inizio con Manenti. Poi soprattutto con Riccardo Nielsen.
Questo titolo mi ha permesso di vincere il concorso per la direzione del conservatorio di
Modena.
La sua attività di compositore?
Scarsa. In un primo tempo mi ci ero buttato con entusiasmo, ma poi sono entrato in crisi,
ho avuto la sensazione, che so anche altri hanno provato, che il comporre, oggi, nell’ambito
della cosiddetta musica colta, non abbia referenti, che si componga per a mala pena avere
qualche esecuzione in un Festival per un pubblico un po’ artefatto e chiuso in un cerchio
elitario e un po’ snobistico. Questo fenomeno mi ha scoraggiato, mi ha dato un senso di
inutilità, e ho preferito interrompere questa attività. Anche perché, nel frattempo, a Modena
ho incominciato a sentire urgentemente il problema della diffusione della cultura musicale, e
mi ci sono buttato dentro a pieno ritmo.
Mi parli un po’ di questa sua attività.
Ho cominciato con l’organizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti elementari e
per insegnanti di scuola media. Particolare attenzione ho dedicato al canto popolare. Dopo un
biennio di lavoro, abbiamo preso contatto con la scuola di Kodaly in Ungheria. Sì avviò così
un’esperienza che ben si stratificava nel tessuto della città e della provincia e che speravo
potesse trapiantare in Italia la straordinaria capacità di educazione musicale di base che
caratterizza l’Ungheria.
Abbiamo lavorato per due anni, che culminarono in uno spettacolo al Comunale di Modena.
Vi collaborarono tecnici del Piccolo di Milano. Un’esperienza indimenticabile. Speravo che la
cosa mettesse radici e si potesse svolgere in modo sistematico. Purtroppo non fu così. È
mancata volontà culturale-politica, la consapevolezza dell’importanza di una iniziativa unica
nel suo genere in Italia. Il piano dei costi equivaleva, globalmente, a non più di quanto
occorre per la replica di un’opera. Ma ho trovato, incredibilmente, un muro di
incomprensione. È stata, a mio vedere, una grande occasione mancata. Ho avuto la
dimostrazione di come prevalga la tendenza a pensare la musica come una faccenda
mondana, un’occasione di “spettacolo” destinato ad esaurirsi in se stesso, a scapito della
ricerca dei modi per intenderne la reale portata culturale e sociale. Quando prevale la
dimensione “spettacolo”, la sostanza e il significato della musica svaniscono. È fenomeno,
purtroppo, largamente diffuso e fortemente diseducante.
Vedo che l’argomento la rattrista. Passiamo ad altro. Lei ha accennato prima ad un certo
suo disagio nei confronti della musica contemporanea. Proviamo ad approfondire.
Per anni l’ho seguita con attenzione e con vivo interesse. Ma devo confessare che ora sono
un po’ perplesso. Talvolta ho come l’impressione che si siano perse le “radici”, che la
Musica e musicisti a Brescia
30
RENZO BALDO
sperimentazione, che pur è necessaria per andare avanti, abbia finito col prevalere sulla
capacità di creare qualcosa di veramente “significante”, di “espressivo”, insomma di saper
dire veramente qualcosa.
Anche lei pensa a una possibile “morte della musica”?
Me ne guardo bene. Il mio non è un “giudizio”, ma, come ho detto, un"‘impressione”.
D’altra parte, dobbiamo anche riconoscere che le occasioni d’ascolto non sono molto
frequenti, sicchè le possibilità di orientarsi con un minimo di documentazione restano molto
approssimative. Poiché a pochi è consentito di correre dietro ai festival, ci si deve accontentare di qualche disco e di quanto trasmettono le nostre reti radiofoniche, che qualcosa fanno
in proposito, ma non molto, e un po’ troppo frammentariamente.
Lei pensa che la diffusione della cultura musicale abbia un supporto importante
nell’ascolto del disco e della radio?
Penso di sì. L’ascolto dal vivo è certo molto importante, ma l’ascolto mediante la
riproduzione è, oggi, strumento insostituibile. Per questo mi meraviglia un po’, per esempio,
che non ci si preoccupi troppo di dare alle trasmissioni radio, maggiore organicità e ampiezza
di contenuti. Meglio organizzate — senza sottovalutare quel che già fanno, che è per più
aspetti pregevole — potrebbero dare un contributo assai notevole all’educazione musicale.
Questo discorso vale, naturalmente, anche per la musica del passato, non solo per la
contemporanea. Intere aree, interi capitoli di grande musica compaiono rarissimamente o
addirittura mai.
Ottobre 1987
Musica e musicisti a Brescia
31
RENZO BALDO
E DOPO L’ABIURA, L’OMBRA DI SKRIABIN
Incontri con musicisti bresciani: Paolo Ugoletti
Siamo andati a Nave, dove abita, a trovare Paolo Ugoletti. Con un po’ di titubanza, lo
confessiamo, anzi con un po’ di preoccupata circospezione. Sarà un pregiudizio, ma i giovani
compositori mi si configurano, nella mente, come un terreno sul quale si può facilmente
inciampare o non capire bene da che parte ci si deve muovere per ragionevolmente orientarsi.
Insomma, coi compositori un po’ meno giovani, se conosci almeno qualcosa dei sentieri che
hanno percorso, sai un po’ meglio come regolarti; con i giovani e giovanissimi - e spesso
accade anche che non siano molte le occasioni di vedere o ascoltare le loro musiche - devi
andare un po’ a tentoni. Ugoletti, poi, fa un po’ paura anche per un altro motivo. Ho qui
l’elenco delle sue musiche (sono pubblicate da Zuvini Zerboni): fra l’80 e oggi assommano a
ben quaranta (le ho contate attentamente: sono proprio quaranta), compresa l’ultima, un’opera, anzi, come dice la didascalia, una “festa teatrale”, “Argo o l’isola d’amore”, su testo di
Giovanni Carli Ballola (1 ora e 20 minuti). Un fiume di musica.
Visto che lei, M.ro, è del ‘56 e gode fama di essere stato un compositore precoce, anzi,
precocissimo, come mai questo elenco parte dall’80?
Ahimè, Lei tocca subito il tasto chiave della mia situazione di compositore. Io nell’80 ho
avuto una conversione, ho fatto un’abiura: dal postwebernismo - chiamiamolo così tanto per
intenderci - sono passato a coltivare l’arte della musica in una posizione di rifiuto
dell’avanguardia. Mi sono persuaso che l’avanguardia è finita, è morta; e che non ha più
senso lavorare dentro ad un gruppo, in una chiesa o chiesuola. Pensi un po’: mi sono messo a
studiare Ravel, e ho provato a ripercorrere la sua esperienza musicale, affidandomi
esclusivamente alla mia sensibilità, cercando, proprio così, il piacere dell’indagine sul suono,
studiato, recepito nella sua forza espressiva, nella sua capacità di produrre emozioni.
Vuol dirmi che è passato nella schiera dei cosiddetti “neoromantici”?
No. Mi hanno interessato per qualche breve momento, ma poi mi sono rapidamente accorto
che anche quello è un “movimento”. E io dall’80 aborro, come le ho detto, dai “movimenti”,
dai raggruppamenti, dalle ideologie. Penso che ognuno debba comporre ascoltando solo se
stesso.
Ma lavorando così, su Ravel, qualcuno potrebbe dire che, anche ammesso che lei non
voglia fondare un “ravelismo”, la sua musica rischia una vera e propria regressione, un
assestamento su posizioni di conservatorismo musicale.
Può darsi che sia una regressione, ma la parola non mi fa paura. L’importante, per me, è di
aver rifiutato di pensare la musica in astratto, di aver escluso la tentazione della “musica
combinatoria”.
Ma allora, come compositore, oggi, Lei come lavora?
Prendo dei materiali (dall’83 ho sostituito Ravel con Skriabin) e cerco di svilupparli
secondo le loro potenzialità. Il prodotto, a differenza di quanto si fa con i procedimenti della
musica combinatoria, risulta così sempre riferibile a qualcosa che già c’è. Insomma, non
credo più nella musica come gioco matematico, come strutturalismo, come assoluta novità,
come astrazione sonora.
Ravel, Skriabin... Mi sembra di capire che non si tratta però di un comporre “alla
maniera di...”, ma della ricerca di un appoggio, di un legame, che consenta al “nuovo” di
Musica e musicisti a Brescia
32
RENZO BALDO
addentellarsi su una tradizione.
Sì, è così. Anche perché non può esistere, non può essere significante, una “novità” fuori da
concreti legami storici.
Lei mi sta dando con nettezza le motivazioni della sua “abiura”. Ma Le dispiace dirmi
qualcosa del percorso precedente agli anni ‘80?
Ho studiato a Brescia con Giancarlo Facchinetti, poi con Franco Donatoni. Ero un
entusiasta. Sì figuri che a 17 anni sono andato ad Amburgo per incontrarmi con Ligeti. Ho
avuto un periodo di innamoramento per Sciarrino... Ma poi ho fatto il salto. Devo
ammirazione e riconoscenza a Donatoni, ma quando lavoravo con lui ho avuto a un certo
punto la sensazione di lavorare sotto un tritasassi. Adesso compongo esclusivamente per il
piacere di far musica (sottolineerei la parola piacere) di sentire la musica come
comunicazione.
Comunicazione con quale pubblico?
Sì, lo so, non c’è pubblico. Ma io mi sgomento quando penso che il 95% del pubblico con
interessi musicali non tollera la cosiddetta musica moderna, e che quel restante 5% è stato
costruito artificialmente, con una presenza totalizzante, con un elitarismo da iniziati.
Diciamolo pure, un pubblico non reale. Ma quando parlo di “comunicazione”, la intendo nel
senso più elementare. Se è vero, come credo sia vero, che è andata a pezzi la persona come
“unicum”, non vedo come possa reggere l’idea di un pubblico come un “unicum” omogeneo e
garantito. L’unico pubblico reale è, oggi, quello del rock. E ciò dovrebbe far riflettere. Il
compositore che non intenda praticare il rock deve, umilmente, ascoltare se stesso,
esprimersi e, se qualcuno entra in comunicazione con quanto espresso, questo è il massimo
che ci si può augurare. Il mio pubblico ideale è di 10 persone, con le quali ci si incontri per
affinità di sensibilità.
Adesso capisco perché sul suo pianoforte c’è il ritratto di Skriabin.
Sì, Skriabin è stato per me un’affascinante scoperta. Un compositore che, per capirlo,
occorre, appunto, sensibilità. La sua è stata una straordinaria operazione di ricerca del suono
come espressione, come ripeto, ricerca di comunicazione e non come pura sperimentazione.
Ma fra i musicisti del dopo Webern c’è qualcuno che Lei senta dotato di capacità
“espressive” oltre che combinatorie?
Sì. penso a Berio, a Maderna, ma anche a Togni, che è stato, come è noto, un
protostrutturalista, ma che è dotato di una cultura e di una raffinatezza che lo hanno salvato
dalla pesantezza del fanatismo strutturalista, che gli hanno consentito, sostanzialmente, di
sottrarsi alla calata dei barbari del “darmstadtismo”.
Posso chiederle come è stato il suo rapporto con Donatoni?
Da pupillo reietto. A Siena, nel 1979, ho subito un vero e proprio pubblico processo:
accusato di “invenzione”, di “fantasia”, di leso strutturalismo, di cercare di ottenere risultati
“espressivi” (mi viene in mente un famosissimo e indubbiamente intelligente e coltissimo
critico, che ama dichiarare di sentirsi irritato quando si accorge che una musica gli piace). Insomma, avrei dovuto sentirmi un verme. Poi, (glielo racconto perché la vita talvolta è proprio
una allegra commedia) è arrivato Petrassi. Le composizioni presentate dovevano essere un
omaggio a lui, in occasione del suo 75°. Le ha esaminate e, orrore! ha scelto la mia. Mi
trovavo là in mezzo, fra Petrassi che mi batteva le mani sulla spalla e il mio maestro
Donatoni, che mi avrebbe sbranato vivo e doveva compiacersi con me. Gli ho voluto bene
anche per questo. Ma da allora sono andato per la mia strada.
Ma questo nuovo percorso, dopo l’abiura, che apprezzamenti ha raccolto?
Musica e musicisti a Brescia
33
RENZO BALDO
Molto spesso critiche sfavorevoli. Qualcuno ha parlato di “Ravel scorticato”, di “Skriabin
maciullato”...
Che effetto le fanno queste stroncature?
Qualche volta mi sono arrabbiato, qualche volta mi hanno lasciato indifferente, il più delle
volte mi divertono; ma qualche volta penso che forse hanno ragione, almeno da un certo
punto di vista, che ovviamente non è il mio. L’unica cosa però che veramente mi interessa è
che mi riconoscano abilità artigianali, e onestà intellettuale.
Lei insegna composizione a Bologna. Vuole dirmi qualcosa della sua esperienza come
insegnante?
Le confesso che non mi piace insegnare. Innanzitutto perché i programmi dei conservatori,
nei quali l’insegnante è imbrigliato, sono di una arretratezza e assurdità intollerabili; in
secondo luogo perché insegnare composizione in classi numerose, come attualmente avviene,
è un non senso; in terzo luogo perché ormai purtroppo la maggior parte degli allie vi
frequenta esclusivamente in funzione del titolo che darà loro sbocchi professionali di lavoro:
l’impressione che spesso danno è che della musica, della reale conoscenza della musica, gli
importi ben poco. Da questo punto di vista dovrei, doverosa parentesi, ricordare che
l’insegnante che più ha lasciato traccia in me per il suo entusiasmo a far capire che studia re
musica significa soprattutto capire e conoscere la musica è stato Giovanni Ugolini, qui a
Brescia, dove spero che ancora ci si ricordi di lui.
Penso che molti se lo ricordino, e BresciaMusica confida di poterne presto parlare
adeguatamente. Ma mi dica ora, come curiosità finale, qualcosa delle sue letture e dei suoi
riferimenti culturali extramusicali.
Strindberg, soprattutto; e poi: Cechov, Robert Walser, Dostojewski. In pittura: Schiele,
Klimt, anche Munch.
Mi vuole dire qualcosa in chiusura?
Sì. Salvador Dalì una volta ha detto: “I compositori si distinguono soprattutto perché
quando parlano dicono sciocchezze”.
Dicembre 1987
Musica e musicisti a Brescia
34
RENZO BALDO
MUSICA... SENZA ETICHETTE
Incontri con musicisti bresciani: Antonio Giacometti
Il musicista che pratica il concertismo ha una sua fisionomia ben definita, una
professionalità dai contorni chiari e facilmente decifrabili, socialmente riconosciuta,
insomma è un animale, nel senso aristotelico, che sai a priori come incasellare. Il
“compositore”, invece, si configura come una specie un po’ misteriosa, che ti può dare
qualche sorpresa. Perciò continuiamo questa nostra “promenade” fra i compositori nostri
concittdini quasi con lo stato d’animo dell’etologo, che vien scoprendo, con piacevole
soddisfazione della propria curiosità, costumi e comportamenti rari e poco noti.
Antonio Giacometti (anni 30) lavora in una sorta di bunker: una stanzetta di pochi metri
quadrati, di un biancore un po’ allucinante (unica macchia nera un Blutner verticale) con un
tavolo da geometra, che domina, sovranamente ingombrante, l’intero ambiente: Lì sopra,
fogli di musica, lucidi, patinati, che sembrano usciti da un computer, fittamente tramati come
geroglifici, con scrittura nitidissima, ben colorata, da miniaturista.
Sfoglio qualche quaderno di appunti. Stessa impressione: pentagrammi, note musicali in
forma di pendagli, di collane, di serpentine, che si intrecciano come predisposti ad essere
usati come ornamenti per un codice.
Su una cartella abbastanza voluminosa leggo un nome che mi solletica: Erostrato.
Caro Giacometti, che significa questo titolo sartriano?
Eh, sì, è proprio Sartre, il racconto intitolato Erostrato.
È l’ultimo mio lavoro, una pièce teatrale per flauto, clarinetto, corno, tromba, arpa, chitarra,
violino, violoncello, una voce femminile, due nastri magnetici e diapositive; costruito sul testo
di Sartre, e contrappuntato da frammenti dalle “Illuminationes” di Rimbaud.
Vedo che lei è un musicista che accoglie volentieri suggestioni letterarie.
Sì, quasi sempre compongo sotto la sollecitazione provocatami dalla lettura di un testo
letterario, che cito come riferimento che può aiutare la comprensione della pagina musicale.
Per esempio: i “Sette pezzi per chitarra” hanno, come “citazione”, testi di Verlaine,
Apollinaire, Baudelaire,
Rimbaud. Sono citazioni che avvertono di una “intenzione” espressiva, prefigurano
l"‘atmosfera” entro la quale si muove la musica. E spesso mi servo anche di citazioni musicali,
che hanno la stessa funzione. Qui, per esempio, il “Notturno” del 3° volume del Microcosmo
di Bartok. Altre volte ho “citato” Hugo Wolf, Berg....
La citazione, dunque, mi sembra di capire, non come materiale da elaborare, ma come
avvertimento linguistico-culturale, come suggerimento percettivo-espressivo. Ma prima di
approfondire questo argomento, sarebbe forse utile che mi dicesse qualcosa sulla sua
formazione musicale a partire dai primi anni, dal suo primo approccio con la musica.
Per prima cosa le dirò che a casa mia nessuno si occupava di musica (pare soltanto che un
mio trisavolo fosse violinista alla Scala). Fu una mia insegnante della scuola media, la signora
Citterio Bellabona, che disse ai miei che, secondo lei, io avevo una certa inclinazione per la
musica. Così mi mandarono a lezione dal maestro Guastoldi, che mi insegnava chitarra e
pianoforte. A 17 anni, quando ero al liceo, ho fatto l’esame di ammissione al corso di
composizione sperimentale col M.ro Rotondi, che ho poi seguito a Milano, dove mi sono
diplomato.
Musica e musicisti a Brescia
35
RENZO BALDO
Mentre compiva questi studi, come si delineava il suo gusto musicale e quindi il suo
orientamento di compositore?
C’è forte discrasia fra ciò che si fa come studio e ciò che si fa o si dovrebbe fare come lavoro
personale, creativo. Io, comunque, mi sono buttato sulla “contemporaneità”, sulla serialità.
Studiavo Rognoni, Boulez, Schoenberg. Ho fatto il contrario di quel che di solito si fa. A un
certo momento, però, mi sono accorto che mi mancava il “Grund” musicale, e devo proprio al
M.ro Rotondi l’acquisizione di un patrimonio culturale-linguistico conquistato attraverso un
percorso a ritroso, alla ricerca del “fondamento”.
Un esercizio di assimilazione dei linguaggi musicali?
Sì, i cosiddetti “lavori in stile”, come allora, un po’ pomposamente, si chiamavano.
Questo è stato il suo percorso “scolastico”. Ma quando lei si è sentito impegnato nella
pagina musicale con autonomia personale e disponibilità creativa?
Mah... io penso di non esserci ancora arrivato.
Prendo questa sua risposta, più che come un segno di umiltà, come testimonianza della
sua volontà di ricerca e di sperimentazione, verso un più solido assestamento del suo
lavoro. Ma mi vuol spiegare come mai il suo nome continua a figurare nei concorsi
nazionali e internazionali, di musica contemporanea? Ho qui un bell’elenco: una decina
almeno fra premi, segnalazioni, presenze come finalista: primo premio al Costantino
Fiocchi, secondo premio ad Avignone, secondo premio, senza il conferimento del primo, a
Sablé, primo premio all’Atem, finalista a Tokio...
Tra i giovani compositori lei mi sembra un superdecorato... Per non parlare del numero
delle sue composizioni: ne ho contate trentacinque, tutte nel giro di pochissimi anni.
Sì, si, guardi: ho le pareti decorate di diplomi e pergamene, tutte ben incorniciate, fanno
colore e gloria... A parte gli scherzi, partecipo ai concorsi perché mi serve come sondaggio e
accertamento, come presa di coscienza con persone e ambienti.
È un modo per rompere la solitudine?
Certo. È anche questo uno strumento, anche se per certi aspetti discutibile, per rompere il
cerchio della solitudine, per realizzare comunicazione. Non riesco a condividere del tutto
l’ascetismo del compositore che, come spesso è stato dichiarato, va per la sua strada, senza
minimamente preoccuparsi che quanto scrive possa interessare a qualcuno. Io sento la
musica come comunicazione. Presuppongo sempre, quando compongo, di poter dire qualcosa
a qualcuno.
"Neoromantico”?
No. Musica, come, credo, è sempre stata: senza etichette. Le “etichette” dovrebbero venire
dopo, a cura degli storici (ammesso che possiamo essere oggetto di storia); il musicista deve
comporre ascoltando se stesso, coltivando il proprio incontro con la ricchezza dei linguaggi,
che storicamente gli si offrono e, insieme, tenendo d’occhio possibili referenti. Per questo,
dopo i primi entusiasmi seriali e “combinatori”, ho incominciato a comporre “ascoltando” il
senso espressivo della scrittura musicale.
A quando risale questa convinzione?
All’82, quando ho frequentato Darmstadt, il gruppo francese de “L’itineraire”, alcuni
neoromantici con a capo Wolfang Riehm, e un inglese, Ferney-Hough, personaggio di
vastissima cultura, che compone musiche che potremmo chiamare “trasformabili” con
complessi sistemi armonici su supporti matematici e filosofici. Sì ascoltava e si discuteva di
tutto, comprese le avanguardie dell’Est. È stato allora, proprio a Darmstadt, che mi sono
persuaso che dovevo uscire dall’incasellamento in un linguaggio rigidamente predeterminato.
Musica e musicisti a Brescia
36
RENZO BALDO
Questa convinzione, questo avvio all’autonomia personale mi si è ulteriormente radicato
quando, subito dopo, ho seguito i corsi di Siena con Franco Donatoni.
Sembra proprio che Donatoni sia per tutti un passaggio obbligatorio.
Devo dire che questo grosso personaggio gode di tutta la mia ammirazione e aggiungo che
ho ricevuto da lui molte prove di apprezzamento per come io lavoravo sulla pagina musicale.
Ma anche il contatto con la sua scuola mi ha spinto nella direzione che le ho detto.
Questo è stato dunque il suo percorso, il suo apprendistato...
Vorrei aggiungere però ancora una cosa: a questa spinta ha dato una virata decisiva
l’incontro con Marco De Natale. De Natale non è un compositore, è un musicologo, ma di tale
ampiezza e profondità di orizzonti, che posso ben dire che l’incontro con lui, con la sua
cultura, con il suo insegnamento, è stato per me decisivo. Mi ha definitivamente aiutato a
intendere la musica come “umana” attività per “dire” qualcosa.
Vediamo se, in base a quanto finora mi ha detto, riesco a orientarmi sul suo modo di
lavorare, a comprendere qual’è il suo modo di comporre. Lei dunque parte, mi sembra di
capire, da delle suggestioni foniche, da occasioni e suggerimenti di materiali preesistenti,
elabora questi sedimenti in una logica musicale che si organizza intorno alla sua sensibilità,
alla sua percezione personale del dato sonoro; una logica “interna”, non precodificata e
variabile.
Sì. E non sono più disponibile ad accettare l’idea, tipica della musica combinatoria, che la
logica interna, immanente, “mia”, venga soppressa, calpestata da una logica “esterna”, che mi
obbliga ad accettare un linguaggio rigidamente predeterminato. Certo, così si hanno meno
“certezze”, la certezza, per esempio, che dà la serie, o la cellula da rigorosamente sviluppare.
Vorrei arrischiare una definizione: possiamo chiamarla una poetica dell’“attimo”?
Penso di sì. È una poetica rischiosa, me ne rendo conto; potrebbe approdare a risultati
discutibili, incoerenti (l’attimo “dopo” potrebbe essere in contraddizione, sfasato rispetto
all’attimo precedente), ma è un rischio che va accettato, se si vuol evitare la musica sia fatta
come calcolo meccanico e matematico.
Mi sembra, adesso, di capire anche meglio la sua diffidenza, anzi il suo rifiuto delle
etichette.
Scrivendo in questo modo, penso che dal punto di vista delle classificazioni correnti quanto
io vengo componendo non possa subire etichettature. Ciò a cui in ogni caso non rinuncio è lo
scrivere musica come “piacere” e come voglia di comunicare. Che la comunicazione sia
ristretta, lo sappiamo (a ciò lei ha fatto riferimento in altre precedenti interviste e non è certo
problema di poco conto) ma non è poi così inesistente come qualcuno sostiene.
E su questo problema, che ritorna, inevitabilmente, così insistente, lei cosa mi dice?
Tenendo anche presente che la frattura arte-pubblico, quale si è verificata a partire
dall’inizio del nostro secolo, sembra, credo, aver avuto qualche recupero nel campo delle
arti figurative e letterarie, ma non nella musica cosiddetta colta.
Io sono convinto che gran parte dei guasti sano stati prodotti da una pluridecennale
mancanza di occasioni e da una inadeguata educazione all’ascolto, che ha provocato l’attutirsi
della “coscienza del contemporaneo”.
Questa probabilmente è la ragione per cui lei da anni si occupa, soprattutto tramite la
Siem, ma anche a livello di pubblicistica, di creare queste occasioni e di diffondere una
educazione musicale, che parta dalla “contemporaneità”.
Se il bambino, il ragazzo, fosse abituato ad avere come suo “parco” la musica
contemporanea, quindi prima ancora che il suo cervello sia imbevuto di messaggi massmediali, nei quali c’è tutto tranne la musica contemporanea, si potrebbe nell’arco di un certo
Musica e musicisti a Brescia
37
RENZO BALDO
numero d’anni recuperare, saldare qualcosa. Ma non bisogna essere catastrofici: un certo
pubblico giovanile c’è già, e non dunque soltanto un pubblico elitario.
Mi vuol dire qualcosa di questa sua attività? L’animazione culturale, la didattica, la
Siem...
È un terreno fondamentale. Me ne occupo sul piano pratico e sul versante teorico (con
pubblicazioni edite da Ricordi). Il futuro della musica esige che questo terreno venga arato
con energia. Scetticismi e fatalismi sono pericolosi. Sarò sincero: ho lavorato molto, con
grande fatica e consumo di energie, ma talvolta, per la modestia dei risultati, con qualche
deprimente punto interrogativo. Siamo dentro cerchi chiusi, che è difficile spezzare. Ad
esempio: la Siem nazionale è riuscita ad ottenere le due ore di insegnamento della musica
nella scuola media; ma quasi niente è stato fatto perché gli insegnanti delle medie abbiano
una adeguata preparazione. Tranne poche esemplari eccezioni, in fatti di didattica della musica c’è poco da stare allegri.
Il conservatorio, è risaputo, prepara strumentisti, spesso di valore, ma non insegnanti che
sappiano cosa significa insegnar musica. Le citerò un caso recente: l’anno scorso la Siem
locale ha organizzato un corso di aggiornamento didattico. Sì sono iscritti in otto!!! Stiamo
ora organizzando un secondo corso. Vorrei approfittare di Brescia Musica per lanciare un
appello agli insegnanti di musica, perché si rendano conto che la loro partecipazione a queste
iniziative è molto importante ai fini del loro “peso” qualitativo.
Altro anello del cerchio: la Siem nazionale è riuscita a far passare nuovi e adeguati
programmi per la scuola elementare. Ma mi vuol dire a cosa possono servire se non ci si
decide a rinnovare i programmi degli istituti magistrali, dove dovrebbero formarsi i futuri
insegnanti capaci di attuare questi programmi?
Lanciamo l’appello e condoliamoci dei cerchi chiusi, sperando che si aprano. E passiamo,
intanto, ad altro. Lei insegna nel Liceo musicale annesso al Conservatorio di Milano. È un
tipo di scuola sul quale si scontrano opinioni antagonistiche: c’è chi lo sostiene come una
assoluta necessità, c’è chi lo contesta come dannoso. Anche in base alla sua esperienza, può
dirmi cosa ne pensa?
Io sono della prima opinione, per più ragioni. Ne abbozzerò alcune (si tratta di un discorso
complesso, che esigerebbe interventi approfonditi). Ritengo innanzitutto che sia un
pregiudizio arcaico credere che la formazione della professionalità del musicista possa oggi
prescindere da una buon formazione culturale (credo che lo si pensi solo in Italia...). È d’altra
parte assai duro e difficile, come fanno molti studenti con impegno esemplare, frequentare
contemporaneamente il conservatorio ed un’altra scuola superiore. Sì aggiunga che chi
frequenta il conservatorio non può avere l’automatica certezza di mantenere o di conquistare,
nel corso dei suoi studi, sicure qualità musicali, le quali, come è noto, dipendono da una
quantità tale di fattori, da rendere aleatorio il risultato, assai più che in qualunque altro
ordine di scuola. Ciò comporta, è facile intuirlo, casi umani dolorosi, ai quali sarebbe facile
ovviare, se tutti gli studenti del conservatorio potessero acquisire un diploma di maturità che
gli consentisse di eventualmente avviarsi per altre strade, verso diversi sbocchi professionali.
La possibilità stessa che oggi i diplomati di conservatorio hanno di accedere all’insegnamento
dell’educazione musicale nella scuola media esige, perentoriamente, una formazione
culturale che il conservatorio, da solo, oggi non è in grado di dare.
Mi tolga, se non le spiace, una curiosità: può dirmi quali musicisti, secondo lei, non
abbiano solo prodotto sperimentazioni, ma siano approdati a risultati musicalmente
genuini?
Penso a Luciano Berio, a Luigi Nono, che hanno scritto cose splendide, e anche a certo
Donatoni. Ma in questo abbozzo di elenco voglio mettere anche il nome di Camillo Togni, il
Musica e musicisti a Brescia
38
RENZO BALDO
cui lavoro di musicista, fondato su un linguaggio che, secondo me, è ormai ossificato e
consunto, è la dimostrazione vivente per la ricchezza e densità dei risultati espressivi, di come
quello che conta non sia l’adesione ad un linguaggio, ma il risultato che con esso si ottiene:
risultato che è condizionato dalla sensibilità, da quello che una volta si chiamava la
“personalità”.
E fra gli stranieri?
Ho una ammirazione sviscerata per Boulez, che unisce massimo rigore a grande musicalità.
Ma anche Ferneyhough, di cui ho detto prima, purtroppo ancora poco noto in Italia.
Un’ultima battuta: di tutta la sua attività, cos’è che le dà più soddisfazione?
L’insegnamento, il rapporto con i giovani, con i miei alunni. Quando compongo sono preso
da mille dubbi, il risultato mi lascia sempre in forse; quando insegno mi prende l’entusiasmo.
Febbraio 1988
Musica e musicisti a Brescia
39
RENZO BALDO
IL FILOLOGO E LA MUSICA
Intervista a Giuseppe Scarpat
Entri nei locali della Paideia — incontri subito la tipografia con le sue macchine, là sulla
sinistra c’è una scaletta che ti porta agli uffici e al pensatoio, dove l’editrice riceve i suoi
impulsi — e ti avvolge una cascata di suoni d’organo. Ti domandi un po’ stupito che cosa stia
succedendo, e là in fondo, ecco intravedi il grande strumento che troneggia su un’intera
parete. Alla consolle siede, di schiena, l’organista. È Giuseppe Scarpat, il filologo, il glottologo
Scarpat, che sul leggio del suo strumento ama cimentarsi con quel particolare linguaggio, che
si è costruito lungo i secoli della tradizione organistica: l’occhio del filologo si è esercitato con
i puntini neri che costellano i pentagrammi, su quei righi che si succedono incessanti per
migliaia di pagine. Gli scaffali, che si alzano all’intorno, stracolmi di partiture di ogni tempo e
d’ogni paese, testimoniano una attenzione rigorosa, sistematica, alla lettura organistica, una
indagine a tutto campo. Non so quante biblioteche di conservatorio possano disporre di un
altrettanto patrimonio librario: edizioni rare, edizioni bibliograficamente preziose, “opera
omnia”, un mare di musica.
È un piacere farsi guidare da Giuseppe Scarpat in questa perlustrazione, in questa
“promenade” nel sontuoso giardino di una secolare civiltà musicale. Giuseppe Scarpat toglie
giù le partiture con gesto deciso e amoroso allo stesso tempo, ne indica i contenuti, ne fa
osservare le caratteristiche “esterne” (il tipo di carta, la veste tipografica, i criteri adottati dai
compilatori e dai revisori), mette a confronto i testi con l’ardore dell’appassionato di musica e
la competenza dell’esperto di arte libraria, che con occhio vigile ed esercitato coglie l’oggetto
nelle sue riposte strutture e nelle sue secrete qualità.
Giuseppe Scarpat ha fondato e tuttora dirige, col figlio Marco, la Paideia, l’editrice
bresciana, che si occupa di filologia classica e biblica, con le sue pubblicazioni dettate da una
solida e raffinata volontà editoriale. Testi, collane, che incutono rispetto solo a leggerne i titoli
o anche solo a guardarli. A cominciare dal catalogo, che ha sul frontespizio un emblema
cinquecentesco, con il drago che sorveglia il vello d’oro (forse è stato scelto per significare che
i percorsi della filologia sono un po’ come viaggi di argonauti?) e, intorno, un motto in lettere
greche capitali, che sembrano, così allineate, senza spazi che distinguano le parole, un criptogramma.
Professore, il mio scarso greco non mi aiuta. Può tradurmi questa scritta?
Non è successo solo a lei, ma anche a illustri cattedratici, di non riuscire a decifrarla.
L’unico che ci è riuscito è stato Mario Lussignoli. È un verso dell’Edipo Re di Sofocle, che
tradotto significa: “Tutto quanto si ricerca si può ottenere”. L’emblema, con la scritta, è stato
tolto da un’edizione de L’Italia liberata dai Goti di Giangiorgio Trissino. Il testo di Sofocle, di
seguito, aggiunge: “Sfugge quanto si tralascia”.
Bello! Mi pare una straordinaria sintesi di spiritualità umanistica. Capisco perché l’avete
scelto.
Sfoglio il catalogo: “I grandi lessici dell’Antico e del Nuovo Testamento”; “Miscellanee
filologiche, linguistiche e filosofiche”; “Esegesi biblica”; “Atti del sodalizio glottologico
milanese”; “Filosofia della religione”; “Storia e storiografia dei tempi biblici”; etc., etc.
Musica e musicisti a Brescia
40
RENZO BALDO
Sorpresa finale: “Monumenti di musica italiana”, “Biblioteca classica dell’organista”, “Studi di
musicologia”...
Professore, come è stato possibile questo abbinamento? Anche la musica, dunque,
orizzonte da non “tralasciare”?
Certamente. È un orizzonte che ho frequentato non da professionista, ma che ritengo
decisivo per la formazione culturale.
"Non da professionista”. Ma lei gode fama di essere un eccellente organista e di aver
suonato il suo strumento anche in pubblici concerti...
Sì, in Italia e anche in Germania, in qualche particolare occasione, su sollecitazione di
amici, che erano interessati a far sentire pubblicamente certi repertori, soprattutto della
tradizione organistica italiana. Ma, come devo dire, erano occasioni per “far musica”. Il che,
mi consenta, è un piacere che talvolta taluni professionisti sembrano non avere. È una
questione importante questa: la musica come fatto vitale, la musica come piacere della
conoscenza.
Lei tocca un tasto che ho sentito star a cuore anche ad altri. Ma ora vorrei sentire da lei
come si è formata la sua passione per la musica, da quali radici è germogliata la sua
competenza musicale.
Dopo la scuola elementare ho goduto di insegnamenti molto seri sia di musica (pianoforte e
organo), sia di materie varie letterarie e scientifiche, ma non inquadrati in programmi
scolastici che portassero a un titolo.
La cultura che ne derivava aveva approfondimenti, che, in genere, non sono richiesti nelle
scuole, e anche lacune, ugualmente non ammesse nelle scuole. Questo tipo di cultura ha
segnato in sostanza tutta la mia vita, ma positivamente: fare quel che piace, ma con molto
impegno e all’insegna di grande professionalità.
Con chi ha studiato musica?
Per l’organo e, soprattutto, per la composizione mi fu guida sicura per tre anni il M° Begalli,
organista alla cattedrale di Verona. Ma nel frattempo mi presentai come privatista a
sostenere gli esami di licenza ginnasiale (Ginnasio- Liceo statale di Udine). Fu allora che la
filologia ebbe la parte maggiore del mio tempo e la musica rimase solo oggetto di grande
passione, senza più mire professionali. Mi sono laureato all’Università Cattolica a Milano con
una tesi in glottologia sotto la guida del Prof. Vittore Pisani. A 30 anni la libera docenza in
grammatica greca e latina mi ha avviato all’insegnamento universitario, prima a Genova e a
Milano, poi a Parma dove insegno tuttora letteratura latina.
Fra il fascino della filologia e il fascino della musica che rapporti intercorrono?
Possono sembrare due mondi antitetici. Ma la cosa sta molto diversamente. L’habitus
mentale del filologo sollecita a comprendere la musica come una realtà non da assaporare
epidermicamente, ma da scavare in profondità. Il sistema scolastico italiano, che pur è,
nonostante tutto, all’avanguardia in Europa (un eventuale suo appiattimento sugli attuali
standard europei, magari in nome dell’unità europea, sarebbe una iattura) ha però sempre
trascurato l’incòntro con la musica, creando un’assurda frattura, che, nonostante qualche
progresso registrato negli ultimi anni, ci pesa ancora malamente addosso. In Italia si
sentirebbe come scandalo che ad un esame di maturità un candidato non sapesse chi è Dante
o Omero o Leopardi, ma si accetta tranquillamente che non abbia mai sentito nominare Bach
o Beethoven o che non sappia distinguere fra Mozart e Palestrina.
Eppure lei ha dimostrato qualche perplessità sul problema della istituzione a Brescia del
Liceo Musicale, cioè di un forma di integrazione fra queste due culture, quella musicale e
quella della tradizione umanistica.
Musica e musicisti a Brescia
41
RENZO BALDO
È vero, perché temo che ne facciano una scuola in funzione del “titolo” e non in funzione di
una autentica formazione culturale, a scapito, soprattutto, di una rigorosa formazione
musicale. Può rischiare di darci dei “titolati” con una manciata di sottocultura e inceppati
nell’acquisizione della formazione professionale, che esige rigore di applicazione, incondizionata dedizione e possibilità di sfruttare le cosiddette “doti naturali”, che non sono un
mito, ma una realtà.
Il problema ha sicuramente questo risvolto sul quale lei giustamente insiste. Penso, però,
che il servizio che sul numero scorso di Brescia Musica è stato dedicato al liceo musicale ne
abbia tenuto conto.
Sì, ma per farmi meglio capire mi servirò di un riferimento analogico. Io, come editore di
testi di cultura religiosa, provo talvolta qualche amarezza quando mi accorgo che la
prospettiva di approfondimento, il richiamo alla dignità della preparazione culturale, il
bisogno di una seria conoscenza della materia che dovrebbe essere pane quotidiano di chi su
di essa deve costruire la propria “professionalità”, restano mete lontane o indifferenti.
Qualcosa di simile può accadere anche nel mondo della musica, con “professionisti” privi di
autentiche radici professionali, che si contentano di qualche spolveratina di vaghe cognizioni,
insomma che sentano la musica come un mezzo per conseguire un impiego ma che della
musica, in fin dei conti, poco gli importa.
Mi pare che lei, con questa precisazione, faccia anche meglio capire quel che prima
accennava sul problema della musica come “far musica”.
Certo. Come chi ha consuetudine con la letteratura legge i testi degli scrittori, li cerca,
amplia il proprio orizzonte di conoscenza, così non si vede perché altrettanto non debba
verificarsi con la musica: la musica come consuetudine di “lettura”. L’esempio classico è
Schubert, al quale importava di “far musica”. Naturalmente “far musica” non significa strimpellare, ma studiare, approfondire, migliorare le proprie capacità esecutive, arricchire le
proprie conoscenze della letteratura musicale.
Lei pensa dunque che la scarsa diffusione del “far musica” sia dovuta essenzialmente a un
difetto “culturale” nella formazione di coloro che hanno avuto un’educazione musicale?
C’è, credo, un altro fattore, più complesso. La vita moderna, la sua spinta consumistica,
irretisce le persone, togliendo ad esse spazi di autonomia, spazi di tempo libero. Ho, per
esempio, l’impressione che si faccia più musica nelle città povere, nelle aree non ancora del
tutto coinvolte nel ritmo frenetico della vita quotidiana quale oggi si svolge. Il far musi58
ca “per sé esige che il “sé” non sia del tutto alienato. Più una città è ricca, meno fa musica; la
ascolta, talvolta la compera, ma non fa musica. Ascoltar musica, per carità, è meglio che
niente; ma non è abbastanza.
Lei ha detto che il mestiere del filologo l’ha aiutata a comprendere meglio la musica. E la
musica, può aiutare il filologo?
Penso di sì. Anche il filologo può inaridirsi. La musica gli può ricordare che un testo è
sempre una “vox umana”. D’altra parte io sono convinto che i grandi interpreti della musica
sono dei veri filologi. Cos’altro fanno, se non profondamente capire un testo e
comunicarcelo?
Vedendo questa sua biblioteca musicale ben si capisce quando lei insiste sul concetto di
“lettura”, sull’invito ad “ampliare” le proprie conoscenze. Ma le posso chiedere dove vanno
le sue preferenze?
Ho il culto di Bach, ma mi interessa tutta la musica fra ‘700 e ‘800. Qualche perplessità ho
sul ‘900.
Musica e musicisti a Brescia
42
RENZO BALDO
Editorialmente cosa state progettando?
Continueremo le pubblicazioni della collana Musica classica dell’organo. È una collana che
contiene anche dei testi di non assoluto valore, diciamo così, “provinciali”, ma servono
anch’essi per capire la storia della letteratura organistica, anche mediante accurate
prefazioni, che ne illustrano il significato storico. Nei Monumenti della musica italiana
pubblicheremo presto le Sonate inedite di Padre Martini.
E di questo nuovo organo che qui troneggia, cosa possiamo dire?
Questo nuovo organo di recentissima costruzione (il precedente, per metà “storico”, l’ho
ceduto ad una chiesa di Roma, dove viene sistematicamente adoperato per stagioni
concertistiche), consta di tra manuali e pedaliera con 45 registri reali, costruito ex-novo —
salvo qualche registro di recupero — dall’organaro Formentelli di Pedemonte (Verona). Il
Formentelli è un italo-francese stabilitosi in Italia da una ventina di anni, ma operante
prevalentemente in Francia, Svizzera, Olanda.
Di tutta la sua attività, cos’è che ritiene l’abbia più profondamente impegnata?
La Paideia con la ricerca che l’ha caratterizzata, orientata a far conoscere il testo religioso
nella sua storicità, fuori di ogni compromissione, anche con rinunce economiche, che
abbiamo affrontato di buon grado, pur di mantenere il rigore scientifico della nostra
impostazione editoriale.
La sua ambizione più grande?
Lavorare con serietà.
Ha avuto qualche incertezza?
Sì, quando mi sono accorto che troppi interessi — mi lasci dire senza falsa modestia,
l’eccesso di versatilità — mi facevano correre qualche rischio.
Che cosa consiglierebbe ai giovani musicisti?
Di amare la musica.
Giugno 1988
Musica e musicisti a Brescia
43
RENZO BALDO
UNA ESEMPLARE OSTINAZIONE
Intervista a Giovanni Ligasacchi
Dopo decenni di intenso lavoro, condotto avanti, tra mille difficoltà, con puntigliosa
costanza e, come affermano affettuosamente i suoi ammiratori ed amici, con esemplare
ostinazione, non c’è da stupirsi, se ci sono voluti tre anni per ottenere da Giovanni Ligasacchi
una intervista da pubblicare su BresciaMusica, di cui pur è stato uno dei più convinti
promotori.
Abbiamo a che fare con un caso, credo, assai raro di personaggio carismatico che preferisce
l’anonimato. Un personaggio da filosofia zen, alla ricerca del metodo per far sparire la
soggettività. Se dovesse scrivere, poniamo, una “storia” o una “cronaca”, credo che
accoglierebbe l’idea del vecchio Catone, che dalle istorie escludeva i nomi, nella convinzione
che quello che conta è il risultato prodotto da una collettività. Il generale può anche condurre
alla vittoria, ma quelli che contano sono i soldati, e il suo nome non ha importanza.
Dopo un anno di vita del giornale, la risposta era stata: “ma lasciamo perdere, io non sono
un musicista!”. Dopo il secondo anno: “c’è tanta di quella gente da intervistare!”. E qui non si
capiva bene, se prevaleva la tendenza ad aprir spazi agli altri o una sottile ironia sulle umane
ambizioni. Perché bisogna vederlo e ascoltarlo da vicino, il Ligasacchi, che perfino nei tratti
del volto e nel modo di parlare rivela una straordinaria mescolanza di sorridente bonarietà e
di pungente aggressività, la prima una dote della sua natura, cementata con la propria
esperienza di vita e con le proprie convinzioni, la seconda, che inconsciamente gli affiora,
probabile frutto di una somatizzazione provocatagli dalle battaglie e dagli scontri per
modificare la durezza della realtà.
Al compimento del terzo anno del giornale, gli sono arrivato in casa con la scusa di vedere la
sua biblioteca, che contiene alcuni testi rari e preziosi. C’è, per esempio, una introvabile
Storia della musica del Padre Martini, che più di due secoli or sono mise le prime basi per
questi studi in Italia; un manuale settecentesco di “Canto fermo”, che è un singolare gioiello
di antica arte tipografica; e manoscritti, partiture, microfilm di opere, che giacciono in unico
esemplare in biblioteche di Francia, Germania, Stati Uniti.
Lei dunque, M.ro Ligasacchi, insiste nel dire che non è un musicista.
Non sono un musicista. Se proprio vuole una definizione, sono un artigiano della musica.
musica in particolare, sia una faccenda per anime elette. E in me si solidificava invece l’idea
che la musica fosse un fatto vitale, corposo, molto concreto, qualcosa che aveva a che fare con
la vita quotidiana, con le nostre scarpe impolverate di quando tornavamo dal Vantiniano,
qualcosa che ci permetteva di sopportare l’emarginazione e la solitudine.
Ma lei ha fatto studi regolari?
Mi iscrissero al Venturi; ma proprio quando avevo quindici anni, il collegio fu chiuso. Mia
madre era morta poco dopo il mio ingresso al collegio. Ero completamente solo. Il giudice mi
affidò al M.ro Ravelli, che si trasferiva a Salò come direttore di banda. Vissi con la sua
numerosa famiglia, dandomi da fare per guadagnare qualcosa. Andavo in giro per l’Italia con
una compagnia di operette. Ma studiavo, occupando ogni possibile ritaglio di tempo. A 19
anni vinsi un concorso per entrare come effettivo, a Milano, nella banda della Terza Armata,
la cosiddetta banda presi-diaria (come vede, ho corso perfino il rischio di far carriera
militare). Ma l’anno dopo, la guerra. Finii sul fronte occidentale, poi in Albania e in Grecia
Musica e musicisti a Brescia
44
RENZO BALDO
(qui, ad Atene, frequentai con profitto due bravissimi insegnanti, che furono entrambi fucilati
dai tedeschi). E poi, la deportazione in Germania, dove mi misero a lavorare in una miniera.
Una singolare carriera di musicista.
Ho fatto anche il sindacalista, a Varese, e mi diplomai. Nel ‘56 entrai, quale direttore, nella
banda cittadina di Brescia.
Che situazione ha trovato?
Per la verità, abbastanza disastrata. Mi resi conto che il problema era di creare una nuova
leva di strumentisti.
Siamo arrivati al nocciolo del nostro discorso. È da qui, credo, che incomincia, possiamo
dire così, la seconda parte della sua vita.
Diciamo pure così. Ma prima di continuare mi conceda una breve parentesi, per ricordare
uno dei personaggi più straordinari dell’ambiente musicale bresciano. che nessuno purtroppo
più ricorda, e del quale invece bisognerebbe ricostruire la biografia e recuperare le opere, che
sono sparse un po’ dappertutto e rischiano di andare disperse. Alludo a Carlo Bossini, un
personaggio che definirei volentieri dostojewskiano, vissuto in una radicale povertà (rifiutò
sempre di iscriversi al fascio, e non potè quindi mai avere un posto di insegnante), animato
da una fervida capacità creativa, dotato di una cultura e sensibilità musicale di eccezionale
ricAllora mi parli un po’ di questo suo artigianato.
Ma lei mi vuol costringere a fare dell’autobiografia, ed è una cosa che mi dà un po’ fastidio.
Tanto più che si tratta di faccende, che, più o meno, almeno qua al Carmine, conoscono tutti.
Ma lei abbia la santa pazienza di brevemente ricostruirle, perché ne siano informati
anche quelli che non abitano al Carmine. Anzi, siccome, a quanto mi risulta, lei non è nato
al Carmine, mi racconti qualcosa che ci spieghi come e perché ci è arrivato e ci si è radicato,
e mi racconti anche qualcosa, che ci faccia capire come le si è formata questa idea della
musica come artigianato.
Beh, a costo di dare nel patetico, le dirò che a sei anni, al mio paese, a Preseglie, andavo a
tirare il mantice dell’organo ed ero letteralmente innamorato di quel convivere così da vicino
con lo strumento. È stata la mia prima esperienza musicale. Ero orfano di padre. Continuavo
a dire a mia madre che volevo studiare musica. Noti bene, che non sapevo quasi leggere,
anche perché bruciavo scuola frequentemente, per andare a camminare nei boschi. La
risposta fu che per fare questo dovevo andare in collegio, quello dei Derelitti. Accettai l’idea,
ed entrai nel collegio, che aveva sede dove attualmente c’è il Liceo scientifico Calini. Il
direttore, Antonio Giacometti, non aveva preparazione musicale, ma era un entusiasta della
musica. Quando gli dissi che ero entrato in collegio per studiare musica, mi affidò al M.ro
Giovanni Ravelli, che dirigeva la banda del collegio. Vedendomi così giovane e mingherlino,
questi si limitò a regalarmi una breve storia della musica. Fu il mio sillabario. Imparai a
leggere compitando quel libretto. Quando Ravelli si accorse che lo sapevo a memoria, mi
diede una tromba e incominciai a suonare. Poi mi fece dare delle lezioni, gratuite, di solfeggio, pianoforte e armonia da Giuseppe Benedetti Michelangeli.
C’era nel collegio una biblioteca con spartiti d’opera per pianoforte e per banda. Me li lessi e
studiai accanitamente. La banda del collegio, due o tre volte alla settimana, accompagnava i
funerali di prima classe (ci davano per compenso un pane e una mela). Sentivo quella musica
che risuonava per le strade come un’esperienza collettiva, sociale. Per farla breve, a 15 anni
ero già in grado di sostituire, in caso di assenza, il direttore della banda.
Mi sembra un racconto alla Dickens.
Sì. Ma in Italia non abbiamo avuto molti scrittori che si siano occupati di queste realtà. Non
Musica e musicisti a Brescia
45
RENZO BALDO
mi dica che sono polemico. A me sembra che in Italia abbia avuto, ed abbia, troppo larga
diffusione l’idea che l’arte, la musica in particolare, sia una faccenda per anime elette. E in me
si solidificava invece l'idea che la musica fosse un fatto vitale, corposo, molto concreto,
qualcosa che aveva a che fare con la vita quotidiana, con le nostre scarpe impolverate di
quando tornavamo dal Vantiniano, qualcosa che ci permetteva di sopportare l'emarginazione
e la solitudine.
Ma lei ha fatto studi regolari?
Mi iscrissero al Venturi; ma proprio quando avevo quindici anni, il collegio fu chiuso. Mia
madre era morta poco dopo il mio ingresso al collegio. Ero completamente solo. Il giudice mi
affidò al M.ro Ravelli, che si trasferiva a Salò come direttore di banda. Vissi con la sua
numerosa famiglia, dandomi da fare per guadagnare qualcosa. Andavo in giro per l'Italia con
una compagnia di operette. Ma studiavo, occupando ogni possibile ritaglio di tempo. A 19
anni vinsi un concorso per entrare come effettivo, a Milano, nella banda della Terza Armata,
la cosiddetta banda presidiaria (come vede, ho corso perfino il rischio di far carriera
militare). Ma l'anno dopo, la guerra. Finii sul fronte occidentale, poi in Albania e in Grecia
(qui, ad Atene, frequentai con profitto due bravissimi insegnanti, che furono entrambi fucilati
dai tedeschi). E poi, la deportazione in Germania, dove mi misero a lavorare in una miniera.
Una singolare carriera di musicista.
Ho fatto anche il sindacalista, a Varese, e mi diplomai. Nel '56 entrai, quale direttore, nella
banda cittadina di Brescia.
Che situazione ha trovato?
Per la verità, abbastanza disastrata. Mi resi conto che il problema era di creare una nuova
leva di strumentisti.
Siamo arrivati al nocciolo del nostro discorso. È da qui, credo, che incomincia, possiamo
dire così, la seconda parte della sua via.
Diciamo pure così. Ma prima di continuare mi conceda una breve parentesi, per ricordare
uno dei personaggi più straordinari dell'ambiente musicale bresciano. che nessuno purtroppo
più ricorda, e del quale invece bisognerebbe ricostruire la biografia e recuperare le opere, che
sono sparse un po' dappertutto e rischiano di andare disperse. Alludo a Carlo Bossini, un
personaggio che definirei volentieri dostojewskiano, vissuto in una radicale povertà (rifiutò
sempre di iscriversi al fascio, e non potè quindi mai avere un posto di insegnante), animato
da una fervida capacità creativa, dotato di una cultura e sensibilità musicale di eccezionale
ricchezza. Gli devo molto. È stata per me una fonte di esperienza e una fonte di entusiasmo.
Ma veniamo al problema della formazione degli strumentisti, problema che aveva
sostanzialmente tre risvolti: dove trovare la materia umana da coltivare in modo sistematico;
come procurarsi gli strumenti; dove trovare dei locali adatti per l’insegnamento e, insieme,
per la realizzazione di un progetto di aggregazione sociale (non si trattava, infatti, semplicemente di “insegnare a suonare”).
Non era un problema da poco.
No davvero. Per il primo di questi problemi ci siamo rivolti al Provveditorato agli Studi, che
ci ha dato l’assenso per un accordo con la scuola elementare del Carmine, perché, ripeto, il
problema non era solo quello di formare degli strumentisti, ma di operare in un ambiente
sociale per, diciamo così, aiutare, mediante l’aggregazione intorno a una iniziativa musicale,
la “bonifica sociale”. È un’espressione brutta, ma rende l’idea.
Nessuno vi ha detto che eravate degli illusi o degli astratti idealisti?
Qualcuno credo di sì. Ma forse qualcuno di più lo ha pensato senza dirlo. Il Carmine degli
anni 60 aveva, notoriamente, caratteristiche - usiamo pure un eufemismo - non troppo
Musica e musicisti a Brescia
46
RENZO BALDO
esaltanti. I ragazzini, dopo le ore di scuola, vivevano nelle strade e nelle osterie. Puntavamo a
creare, per loro, qualcosa di diverso, che sentissero però non come una “scuola”, ma come un
loro ambiente.
Ma mi lasci aprire un’altra parentesi: Tra le persone che ci hanno aiutato voglio ricordare
l’ispettore Vincenzo Mantero, che ha fatto moltissimo perché l’iniziativa si realizzasse; e
l’assessore Mario Cattaneo, che ci ha consentito l’acquisto degli strumenti presso la ditta
Benasi, che generosamente ha accettato una rateazione di quindici anni.
Avete dunque incominciato a insegnare ai bambini della scuola elementare. Con quale
metodo?
Ho detto, prima, di tre risvolti. Ma non ci rendevamo conto che ce n’era un quarto: “come
insegnare?”. Ci siamo subito resi conto che non sapevamo insegnare. E non era una carenza
personale. Possiamo dire che era una carenza nazionale. Ci siamo accorti che in Italia non
esisteva alcuna seria tradizione di insegnamento “popolare”.
E come avete rimediato?
Non c’era che una sola soluzione: andare all’estero a imparare, frequentare le scuole più
avanzate nella elaborazione dei metodi moderni dell’insegnamento. Mia moglie è andata
all’Istituto Orff di Salisburgo, io in Germania e in Ungheria, alla scuola Kodaly (tra l’altro, ci
hanno fornito gratuitamente tutto il materiale del metodo Kodaly). Ben presto, impegnandosi
in questo lavoro di acquisizione del metodo, impegnandosi a tradurlo nella pratica
dell’insegnamento, gli strumentisti della banda civica e della “C. Quaranta”, l’orchestra a
plettro che allora dirigevo, hanno rapidamente garantito le possibilità di sviluppo
dell’iniziativa.
Mi chiarisca una cosa: le lezioni avvenivano nelle ore di orario scolastico?
In un primo tempo sì; ma ben presto quelle ore si sono rivelate insufficienti, e allora si è
posto il problema, cui accennavo prima, di avere dei locali sia per la custodia degli strumenti
sia per la frequenza di lezioni nelle ore pomeridiane. Col tacito consenso delle autorità
formalmente responsabili, abbiamo occupato dei locali comunali abbandonati e in pieno
disordine. Per rimediare ai problemi dell’umidità e ai problemi dell’acustica abbiamo fatto
incetta su larga scala di contenitori di uova, applicandoli scrupolosamente alle pareti.
Ma chi sono stati, materialmente, gli occupanti?
I genitori dei ragazzi. Molti di essi hanno “sentito” il significato di tutto quello che si stava
facendo, e hanno sempre largamente collaborato. Non tutti, purtroppo. Di molti ragazzi, che
per anni hanno frequentato queste iniziative, i genitori non li abbiamo mai visti.
Ma quando, col passare degli anni, i ragazzini uscivano dalle elementari, come avete
mantenuto il collegamento?
Abbiamo instaurato il medesimo rapporto con la scuola “Mompiani”, allora “Avviamento al
lavoro”.
Che numero di frequenze avete avuto?
Un numero sempre crescente, fino a raggiungere le due-tre centinaia. Oggi sono circa
trecento. Ed è una cifra che si mantiene stabile da molti anni.
Il Carmine è rimasto l’unico vostro punto di riferimento?
No, negli ultimi anni, per una serie di fattori (qualche modifica positiva dell’ambiente del
quartiere; la richiesta che ci veniva da altre parti; etc.), la scuola è frequentata da ragazzi che
provengono anche da altre circoscrizioni. Gli animatori, oggi, sono ventiquattro, molti dei
quali provengono dalle file di coloro che avevano seguito negli anni scorsi la scuola, che oggi
abitano altrove, e naturalmente fanno da canale di immissione da altre zone della città.
...Le dirò che questo ci ha creato, inizialmente, qualche problema. Quando sono cominciate
le richieste anche da altre parti, c’è stato un preannunciato quasi generale di rifiuto. Non li
Musica e musicisti a Brescia
47
RENZO BALDO
volevano. Ciò se da un lato testimoniava la forte e “vissuta” partecipazione sia dei genitori che
dei ragazzi, rischiava anche di essere il sintomo di un pericolo, quello di una sorta di
“chiusura” campanilistica. Io ed altri abbiamo insistito per “l’integrazione”, che ci sembrava
ormai un passaggio utile ed opportuno.
Quando si è definita formalmente la scuola?
Nel ‘67, quando è stata inaugurata ufficialmente come “Centro Giovanile Bresciano”,
intestato successivamente a Gioietta Paoli Padova, la concertista dolorosamente e
repentinamente scomparsa. Il “Centro” è retto da un Consiglio, formato dai genitori. I
genitori versano, per aiutare il finanziamento, una cifra libera, anche niente, ciascuno
secondo le sue possibilità, secondo quello che liberamente crede. Il contributo comunale è
attualmente di 15 milioni annui. Non sono previsti compensi per nessuno, soltanto rimborso
spese. Ultimamente sono state istituite delle borse di studio.
Il “Centro”, oltre che strumenti musicali, possiede altri “strumenti” di lavoro e di
informazione?
Abbiamo costituito un archivio e una biblioteca, che comprende attualmente circa mille
volumi, dispone di tutte le riviste di didattica, anche internazionali, più materiale vario
(partiture e simili).
Dovrebbe ora, per favore, consentirci di orientarci con precisione tra il groviglio delle
vostre sigle, chiarire la differenza tra “Associazione”, “Centro”, “Gruppo”, etc.
La associazione “Isidoro Capitanio” è nata nel 1951 al fine di ricostituire, con precisa veste
formale, un organismo al quale facesse capo la Banda Cittadina (dobbiamo ricordare che la
vecchia “Banda civica”, come tutte le organizzazioni similari, era stata sciolta negli anni ‘20
dal fascismo). La associazione è stata la matrice del “Centro”, di cui prima abbiamo detto
nascita e fini. Col crescere delle capacità del Centro di formare strumentisti, molti di questi
sono progressivamente entrati nella Banda Cittadina, ma al tempo stesso si è delineata
l’opportunità di creare una Orchestra a plettro, denominata “Città di Brescia”, e un Gruppo di
ottoni per l’esecuzione di musica antica, gruppo che è stato intitolato a musicisti bresciani
66 del ‘500, Paride e Bernardo Dusi. La matrice di tutto è stata la “Capitanio”, il Centro è
stato il propulsore delle altre iniziative, che, rapidamente, pur mantenendo rapporti e legami
“ideali” e operativi con il Centro, hanno acquistato la loro autonomia organizzativa, culturale
ed amministrativa.
Vi sarà anche accaduto di avere perso qualcuno degli strumentisti usciti dalla vostra
scuola e avviati a percorrere la loro carriera professionale musicale.
Certo, questo era inevitabile. Molti dei nostri strumentisti sono entrati in orchestre di altre
città, sono diventati insegnanti di conservatorio. Però devo dire che mi ha sempre commosso
l’attaccamento che hanno mantenuto con noi. Nonostante i loro impegni, che li hanno portati
a svolgere la loro attività altrove, trovano sempre il modo, anche con personale sacrificio, di
cercare dei ritagli di tempo per darci il loro aiuto sia come animatori sia mettendosi tra le fila
delle nostre compagini orchestrali, di cui contribuiscono a tenere alto il livello qualitativo.
A proposito di livello qualitativo, lei non ne ha a male, spero, se le dico che nei suoi
confronti c’è una specie di amore e di stima, che si accompagna con una sorta di inquieto
sgomento. Mi spiego. Dicono che lei non è mai soddisfatto, che, per esempio, il succo dei
suoi discorsi, anche e soprattutto dopo qualche successo, è sostanzialmente questo: ragazzi,
non datevi delle arie; c’è ancora molto da fare per essere davvero soddisfatti...
Sì, può darsi che abbiano ragione. Ma credo di avere ragione anch’io. Sono dell’opinione che
chi si accontenta è perduto. Per far musica, occorre una costante tensione al meglio, alla
Musica e musicisti a Brescia
48
RENZO BALDO
conquista di una più ampia e sicura cultura musicale, di più solido e perfezionato
rendimento.
Se dovesse concentrare in poche frasi il senso complessivo che ha animato queste
iniziative, come si esprimerebbe?
Fondamentalità dell’"usare” la musica; cioè suonare e non solo ascoltare. L’educazione
musicale come puro ascolto determina fenomeni di elitarismo (la cultura musicale come
patrimonio di piccoli gruppi intellettuali) o fenomeni di sostanziale indifferenza, per non dire
ottusità, mascherata da rituali (la frequenazione delle sale e dei teatri), che con la musica
hanno poco a che fare.
Pensavo di aver finito qui l’intervista, ma questa risposta mi obbliga, se ha un po’ di
pazienza, a portare avanti il discorso.
Emerge, da quanto ha detto, il problema che forse costituisce il punto centrale della sua
idea della musica e che certamente ha stimolato tutta la sua attività.
Mi pare che lei la pensi così: la musica è un fenomeno socialmente rilevante, cui tutti
dovrebbero partecipare “usandola”, non limitandosi, dunque, ad ascoltarla o con orecchio
mondanamente disattento e distratto e con una partecipazione fondata sulla convinzione,
che da una parte ci stanno i musicisti, il cui compito è di darci la musica, e dall’altra i
cosiddetti competenti, che la assorbono nel proprio patrimonio culturale, magari di buono
o alto livello, ma elitariamente chiuso. Lei non pensa, in questo modo, di prestare il fianco
all’accusa
d correre il rischio di diffondere un basso livello di formazione musicale, che si
accontenta, dietro il paravento dell"‘uso”, di risultati discutibili e superficiali, di simpatico,
ma modesto dilettantismo?
Ma questo è proprio un intollerabile equivoco. Se la musica è un fatto socialmente rilevante,
ciò significa che è, e deve essere, un fenomeno “popolare”, cioè largamente diffuso. Ma chi
l’ha mai detto che “popolare” significhi superficiale dilettantismo? “Popolare” significa che la
musica deve appartenere a tutti, deve coinvolgere tutti in modo serio, rigoroso, fatto
di competenza tecnica e di orizzonti culturali adeguati. “Popolare” significa che non è
accettabile il costume, ancora largamente diffuso, che trasforma la musica in una specie di
Olimpo al quale accedono pochi privilegiati. Le bande, i cori, i complessi di ogni tipo sono i
mezzi — sociali — per conseguire il risultato di una educazione musicale solida, concreta,
fattiva. Certo, so benissimo che spesso ci si accontenta di livelli bassi. Ma questa è la battaglia
da condurre: diffondere la consapevolezza che bisogna conseguire livelli alti. E ciò apre, lo
sappiamo bene, gravi problemi: didattiche aggiornate e severe; il coraggio di rinnovare i
repertori e le programmazioni; la conoscenza della più avanzata cultura musicale. Le voglio
fare io una domanda. Come mai così in pochi dimostrano di essere in grado di ca pire e di
apprezzare la musica contemporanea, gli Schoenberg, gli Hindemith o i Cage o i Boulez, tanto
per fare qualche nome? Ma la risposta gliela do subito io: perché nessuno sa leggere e tanto
meno suonare le loro musiche, perché non c’è “l’uso” della musica. E così queste musiche le
ascoltano in quattro gatti, o poco più, in qualche Festival o in qualche convegno per
musicologi. E non è nemmeno detto che tutti quei quattro gatti capiscano e apprezzino
davvero, se si pensa che ci sono dei musicomani che si vantano di non avere mai appreso a
suonare, nemmeno il tam tam. Ma che bravi!
Febbraio 1989
Musica e musicisti a Brescia
49
RENZO BALDO
LA “FINTA LUNA” AL GRANDE
A colloquio con Giancarlo Facchinetti
Giancarlo Facchinetti arriva sulla scena del Grande. Da qualche tempo si attendeva questo
approdo. Ne avevamo accennato già sul n. 0 di Brescia Musica, nell’ormai lontanissimo
dicembre 1985, nel corso di un’intervista. Ora che la notizia è diventata ufficiale, con tutti i
sacri crismi, è il caso che entriamo in argomento, in preparazione dell’ascolto de “La finta
luna” inserita nella stagione d’opera del prossimo autunno. E il mezzo migliore ci è parso
quello di intervistare l’autore.
Caro Maestro, lei ha inaugurato la serie delle interviste di BresciaMusica, alla fine dell’85.
Ora ci reincontriamo per parlare di uno specifico argomento, questa sua opera. Se mi
consente, le pongo subito una questione, a metà fra l’affermazione e l’interrogativo.
Lei, dunque, è di quei compositori contemporanei, che contribuiscono a farci pensare che
il melodramma non muore mai, nonostante tante estreme unzioni che gli sono state
praticate.
Io ritengo che nessuna “forma”, quando si sia dimostrata vitale, sia destinata a morire.
L’importante è riproporla in modo non stereotipato, darle cioè un’anima, farle acquistare un
senso, che, pur collegandosi a una tradizione, riveli un accento nuovo e originale. Non è detto
che ci si riesca, ma si può, anzi si deve tentare.
Lei pensa che questa “riproposta” si sia positivamente realizzata con i tentativi dei
musicisti del nostro secolo? Da quando, cioè, non nascondiamocelo, il melodramma ha
cessato d essere “popolare”?
Penso di si. Non esiterei a riconoscere nel Wozzeck, in Lulù, nella Carriera di un libertino,
nel Mosè e Aronne, per citare gli esempi più celebri, una forte rivitalizzazione del
melodramma.
E in tempi e in esperienze più recenti?
Qui è più difficile pronunciare giudizi sicuri. Ma se penso a Ligeti, e ai nostri Togni o
Manzoni, e a Berio e a Luigi Nono, direi di si.
Ma veniamo a lei. Sì armi di sincerità, e mi dica se ha scritto quest’opera proponendosela
come meta necessaria da raggiungere nella sua carriera di compositore, come
testimonianza di bravura (lei una volta ha detto che il vero compositore deve sapere
affrontare tutte le forme musicali, dalla banda all’opera) o se, invece, ne abbia sentito la
nascita come risposta ad un suo bisogno profondo, se, cioè, davvero lo spi rito del
melodramma faccia parte della sua cultura e della sua sensibilità musicale.
Devo dirle che la mia educazione musicale si è formata, inizialmente, sul melodramma. Mi è
entrato nel sangue fin da ragazzino. E il teatro, d’altra parte, mi ha sempre attratto. Direi
quindi senz’altro che il melodramma mi appartiene come personale inclinazione.
Non si può certo dire che il teatro sia rimasto fuori dalla sua esperienza. C’è un lungo
percorso di musiche di scena, se mal non ricordo a partire da “Esperimento ‘64” di Mina
Mezzadri. Questo tipo di impegno e di ricerca può essere considerato come un antefatto,
una marcia di avvicinamento all’opera?
La musica di scena certamente, pur nella sua diversità, costituisce un ottimo terreno di
preparazione all’opera vera e propria, soprattutto per l’esigenza ch’essa implica di rapportare
continuamente l’elaborazione musicale ad una precisa situazione scenica.
Musica e musicisti a Brescia
50
RENZO BALDO
Ma in quali anni ha steso la partitura di quest’opera?
Dall’‘85 all’‘87.
Mi vuol dire come è arrivato alla scelta dell’argomento, al “libretto”?
Cercavo un argomento che mi consentisse un filo scenico narrativo non troppo ampio.
Avevo fermato l’attenzione su un racconto di Kleist (è uno scrittore che amo particolarmente,
forse per la sua forza drammatica, per il costante senso del teatro che lo pervade), ma mi
risultava troppo vasto e complesso. Il regista Nanni Garella mi propose 1l flauto di Pan, un
racconto di Laforgue. Lo trovai interessante, ma un po’ statico. Garella lo riscrisse,
trasformandolo completamente. Di fatto si può dire che da Laforgue è stato tratto soltanto lo
spunto.
Può accennare brevemente alla struttura dell’opera, al suo filo narrativo?
C’è un prologo e due atti. Quattro personaggi: il protagonista, che è un anziano direttore di
banda; un “presentatore”, che si configura in realtà come una sorta di “ombra” del
protagonista; una ragazza, che è flautista nella banda; un giovane clarinettista.
L’intreccio?
11 prologo, a sipario chiuso, è affidato al “presentatore”. Nel frattempo arrivano i suonatori
della banda, che si apprestano ad un concerto. Arriva la gente (nella dislocazione scenica, un
coro, che prende posto nei palchi di proscenio), che aspetta il concerto, chiacchiera, vocia,
disturba.
Siamo all’atto primo; l’anziano direttore entra in scena con la banda, che si sistema per il
concerto. Sì prova una marcia: la flautista e il clarinettista sbagliano, ne nasce una
discussione, una schermaglia. Gradualmente l’anziano direttore scopre che la flautista è la
ragazza di cui si era innamorato in gioventù. Come è possibile che sia ancora lì, ventenne? Il
clima da realismo grottesco si trasforma in lirico sognante. L’anziano direttore si assopisce,
mentre la banda, con i due giovani, se ne va.
Ed eccoci all’atto secondo: il vecchio è assopito su di un prato, è un prato d’Arcadia.
L"‘ombra” vorrebbe svegliarlo, con una canzone (lo spunto è di Laforgue). Il vecchio si
risveglia , caccia via l"‘ombra”, poi tira fuori uno zufolo e suona. Al suono dello zufolo
compare la ragazza. Il vecchio la insegue, ma un fiume li separa; poi si rassegna: forse è un
sogno...
Stando al testo, parrebbe un recupero del melodramma in chiave molto composita. Mi
pare di intravedere qualche ascendenza strawinskiana: il risveglio in Arcadia (una scena
analoga c’è ne La carriera del libertino); qualcosa da l’Histoire (il rapporto vecchio-ragazza mi pare richiami il rapporto soldato-diavolo). Ma questi sono aspetti secondari e
marginali (anche se potrebbero essere interessanti per denotare il terreno prescelto di
immagini e di concettualizzazione). La cosa importante, però, mi sembra la ricca
“contaminatio” fra suggestioni liriche, ironia, gusto del grottesco, una buona dose di surrealismo, un pizzico, forse perfino abbondante, di onirico in chiave freudiana...
Sì, il personaggio “ombra”, che segue costantemente il vecchio direttore, come una presenza
incombente, che appare, riappare, alla fine scompare, può certamente essere interpretato
come una voce del subconscio. Quanto al surrealismo, è certamente dominante nel secondo
atto, che si contrappone, da questo punto di vista, al primo atto, che è quasi tutto in chiave
realistica, un realismo misto di ironia e di grottesco, di paradossalità.
Ma mi vuole dire perché è intitolato “La finta luna”?
La luna incombe nel primo atto, fa da interlocutrice col vecchio direttore. Poi, nel secondo
atto, diventa, o dovrebbe diventare, il sole. È un titolo, dunque, con prevalente intenzione
allusivo-simbolica.
Musica e musicisti a Brescia
51
RENZO BALDO
Veniamo alla realizzazione musicale. Cominciamo dall’organico.
Nel corso dell’opera avviene una progressiva trasformazione dell’organico. Nel primo atto la
partitura prevede orchestra sinfonica, banda, coro, solisti. Nel secondo atto l’orchestra è
impiegata a gruppi, con una scelta che si va facendo sempre più cameristica, fino a concludersi con un quartetto, che è collocato sul palcoscenico, di flauto, clarinetto, violoncello,
arpa, quartetto, che a sua volta tace prima dell’aria finale del protagonista: un vero e proprio
andamento in decrescendo.
Anche se si tratta di un discorso un po’ specifico e tecnico, parliamo un po’ del linguaggio
musicale che lei ha impiegato (visto che scriviamo su Brescia Musica, che di musica pur
dovrebbe occuparsi). Lei da tempo ha sempre largamente preferito l’impiego del linguaggio
seriale. È così anche per quest’opera?
Sì, ho usato le serie, sempre in modo rigoroso.
Le serie... Quante?
Due, una per il primo atto e una per il secondo atto. Solo raramente, per una durata di
pochi secondi, compare qualche breve struttura aleatoria, che fa da sottofondo, per esempio
nel Prologo, quando al canto del personaggio si aggiunge, per pochi attimi, il brusio dei
componenti della banda.
Ha detto “rigorosamente seriale”. Anche quando suona la banda?
Sì; anche se l’effetto sonoro, quando suona la banda, è veramente tonale. È un risultato
volutamente perseguito, per creare la sensazione di atmosfera bandistica “banale”.
Penso che anche in quest’opera lei usi le serie col procedimento che si usa chiamare dei
“blocchi seriali”. Se è così, vuol brevemente spiegare che cosa significa?
Significa che la serie, la quale può essere usata in molteplici combinazioni, viene applicata
alla singola scena, al singolo frammento strutturale, in modo coerente e rigoroso.
Lei parla di “serie” usata in molteplici “combinazioni”. Può farci degli esempi di come si
costruiscono queste “combinazioni”? E quante ne ha usate in quest’opera?
Ne ho usate nove.
Mi accenni in che cosa consistono queste nove combinazioni. Lo so che è un discorso
tecnico, e noioso, ma è pur sempre un discorso che può destare, oltre all’interesse del lettore
competente in materia, curiosità anche negli altri.
La prima combinazione è costruita col metodo della “inversione”.
Vale a dire, se non erro, che la serie viene proposta andando dall’ultima alla prima nota.
Nihil (o quasi) sub sole novi. La praticavano i contrappuntisti già secoli orsono.
È vero. E anche la seconda combinazione, che consiste nel “rovesciamento”, non è una gran
novità: gli intervalli ascendenti vengono rovesciati in discendenti e, viceversa, i discendenti in
ascendenti. Più complessa la terza combinazione, che consiste nell’inversione del rovesciamento. Vale a dire: la successione dei suoni ottenuta con la precedente combinazione viene
invertita, partendo dall’ultimo e arrivando al primo.
Passiamo alla quarta combinazione. Io mi sforzo volonterosamente di seguirla, e penso
che così faranno anche i lettori.
La quarta combinazione l’ho realizzata mettendo, in successione, prima i suoni che
corrispondono al numero dispari e poi quelli dei numeri pari.
Esattamente come sul tavolo della roulette. Ma andiamo avanti.
Quinta combinazione: ho diviso la serie in gruppi di quattro suoni, quindi tre gruppi, e ho
realizzato la combinazione prima con il primo suono dei tre gruppi, poi col secondo, poi col
terzo.
Musica e musicisti a Brescia
52
RENZO BALDO
Adesso che siamo entrati dentro in questo ludus mathematicus, mi è facile dedurre che la
stessa combinazione sarà stata realizzata con gruppi di tre suoni, usando prima il primo,
poi il secondo, poi il terzo.
Proprio così. E passo quindi alla settima combinazione, realizzata con due gruppi di sei
suoni.
Col solito giochetto: prima il primo, poi il secondo, etc. fino al sesto.
Molto bene. Sono cose così semplici che perfino un giornalista può riuscire a capirle.
Grazie. Ma, in realtà, penso che molti queste cose riescano a capirle, se — mi consenta la
battuta - abbiano avuto consuetudine con la pratica del rosario: nel primo mistero si
contempla...; nel secondo mistero si contempla... etc. E così, quasi specularmente: nella
prima combinazione si contempla... nella seconda... etc. etc.
Benissimo. Ma nonostante il mestiere di giornalista e nonostante, magari, sue antiche
consuetudini con lo spirito contemplativo, l’ottava combinazione da solo non riuscirebbe a
immaginarla. Perciò gliela spiego, perché sia lei che i lettori del giornale riescano ad
adeguatamente comprenderla e contemplarla.
Sentiamo un po’ di che si tratta.
L’ottava combinazione è fatta di 48 suoni, così ottenuti: il primo suono della serie originale,
il primo dell’inversione, il primo del rovesciamento, il primo della inversione del
rovesciamento. Il che fa quattro. Segue, come è ovvio, il secondo di tutte e quattro le
combinazioni ora elencate; poi il terzo, il quarto, il quinto...etc, fino all’ultimo, cioè al dodicesimo. Dodici per quattro fa quarantotto, ecco ottenuta la ottava combinazione, di 48 suoni
appunto.
Per fortuna siamo alla fine. Sentiamo come è nata l’ultima combinazione, la numero nove.
È ancora più complessa.
Giusto cielo! Che gli dei, che sono notoriamente buoni e generosi, aiutino i nostri lettori a
sopportare e a comprendere. Proceda pure.
Se guardiamo (lo può vedere anche uno che non abbia una gran consuetudine con la
scrittura musicale) la serie nella sua veste originale, è facile, è ovvio, avvertire che fra un
suono e l’altro intercorre un certo intervallo, un certo spazio coperto da un certo numero di
note. Ciascun gruppo di suoni, di cui si costituiscono questi brevi spazi, preso a sé può
costituire una serie, diciamo meglio, un segmento seriale. Questi segmenti sono stati
variamente e liberamente usati nel corso dell’opera.
Come coriandoli che animano una festa o pigmenti che arricchiscono di colore e di sapore
un piatto già di per sé succulento. Ha sentito che belle immagini?
Tra il poetico e il giornalistico.
Le dirò che quasi tutti i giornalisti sono seguaci, magari inconsci, della teoria
dell’ornatum: le cose bisogna ornarle bene, se vogliamo farle capire.
Ma, a proposito, non ha più nessuna diavoleria da aggiungere?
Questa teoria dell’ornatum sembra presupporre che l’oggetto in questione abbia così scarsa
sostanza da aver bisogno di lenocinii oratori per essere abbellita.
Molto più semplicemente: il giornalismo, e in particolare la pratica dell’intervista, ha, tra
le sue molteplici funzioni, anche quella di rendere accoglienti e piacevoli le cose, pure nel
caso che siano complesse, dure e difficili; è una funzione pedagogica.
Dure, difficili e magari indigeste, come molti pensano delle opere moderne e in particolare
del linguaggio seriale...
Musica e musicisti a Brescia
53
RENZO BALDO
Ne parleremo quando avremo sentito la sua “Finta luna”. Registreremo umori e opinioni
di critici e di pubblico. Qui ci siamo limitati a descriverla.
Giusto. E allora, quanto alle diavolerie, ce n’è forse ancora una, abbastanza semplice: i
suoni della serie del primo atto sono stati combinati in modo che fra loro realizzino gli undici
intervalli dalla scala tonale.
Bene, aggiungiamo anche questo. Ma mi viene in mente che chi pratica i procedimenti
seriali usa anche il “trasporto” della serie, come mai lei non me ne ha parlato?
Infatti, e desidero precisarlo, non l’ho mai usato.
Se mi permette, vorrei a questo punto chiederle: in base a quale criterio il compositore
decide di scegliere questa o quella combinazione, nel momento, cioè, in cui le deve
“applicare” alla singola scena o episodio o passaggio?
A seconda degli effetti fonici ch’essa implica, che da essa possono sprigionarsi.
Lei usa delle espressioni, come “creare sensazioni”, “fare delle scelte a seconda degli effetti
fonici”, espressioni che sembrano implicare, sì, un uso del linguaggio seriale, ma sempre
con l’orecchio teso a controllare il risultato fonico-espressivo. Ciò significa che il suo modo
di comporre esclude la cosiddetta “logica combinatoria”?
Decisamente. Non mi riconosco nella pratica della musica combinatoria. Sono un fervente
sostenitore della serialità, resto convinto che sia il linguaggio più avanzato e autentico del
nostro tempo, ma l’uso della serie è, appunto, l’uso di un linguaggio, di combinazioni foniche,
che contano, o dovrebbero contare, per il risultato espressivo, dal quale non si può prescindere, al quale il compositore deve mirare. Comporre musica è un comunicare o, almeno,
un tentativo di comunicare, non un chiudersi nel solipsismo di una costruzione logicomatematica.
Tutte queste precisazioni riguardano, ovviamente, anche le parti vocali, che penso
rientrino, di diritto e di fatto, nella complessità delle strutture seriali da lei adoperate. Le
voci, però, si possono usare in tanti modi diversi. Lei come le ha usate?
La voce interviene in cinque modi diversi. C’è, naturalmente, il canto vero e proprio, quello,
diciamo così, tradizionale, anche se con qualche falsetto; ho usato lo Sprachgesang, quello,
per intenderci, del Pierrot Lunaire di Schoenberg, tra il recitato e il cantato; compare anche il
“parlato” intonato a varie altezze; e in fine il parlato libero.
Ci sono delle parti puramente orchestrali?
Sì, soprattutto un interludio tra il prologo e il primo atto.
Mi cavi una curiosità: su una partitura di questo tipo, qual è il suo metodo di lavoro?
Penso che presupponga gradi diversi di approccio.
Sì, potrei dire, sostanzialmente, tre gradi. Il primo è dato da una serie di appunti sul testo.
Segue una realizzazione, un abbozzo, per pianoforte. Infine passo alla strumentazione.
Qual è il momento più impegnativo?
Il più impegnativo intellettualmente è forse il primo, che corrisponde ad una sorta di
individuazione del nucleo genetico dell’opera. Il più faticoso è sicuramente il terzo, la
strumentazione, che inesorabilmente procede con una defatigante lentezza.
I suoi amici dicono che non riescono a capire quando lei trovi il tempo per questi suoi
lavori, tra la scuola, la preparazione di concerti, incarichi vari, frequentazione di luoghi e
ritrovi pubblici.
Sono un devoto di S. Antonio, dal quale ho ricevuto il dono dell’ubiquità: mentre sono,
poniamo, al Frate, a brindare con gli amici, sono anche a casa al tavolino con la penna in
mano.
Giugno 1989
Musica e musicisti a Brescia
54
RENZO BALDO
QUATTRO... CINQUE... MOLTE ANIME...
Una conversazione con Mario Conter
Proviamo ad immaginare un solerte studioso di cronache locali che, poniamo sul finire del
prossimo secolo, il XXI, si dia da fare per tracciare il quadro della vita musicale a Brescia
lungo gli anni della seconda metà del XX. Pur non nutrendo alcun dubbio sulla oggettiva
possibilità che avranno mille altre fonti e documenti di proiettare luce su persone ed eventi,
la redazione di BresciaMusica si conforta nella convinzione di aver portato il suo contributo
ad aiutare l’ipotetico storico futuro, anche, perché no?, mediante la serie di interviste che si
sono susseguite a partire dal numero zero. Lacunose, frettolose, approssimative; destinate,
come probabilmente molti pensano, a lasciare il tempo che trovano. Ma quanti sono in grado
di intervenire sul tempo per cambiarlo?
Il lettore avveduto si sarà accorto che stiamo un po’ polemizzando — col maggior garbo
possibile — con coloro — tutte, d’altro canto, rispettabilissime persone, che sinceramente
stimiamo e persino consideriamo amiche — che ci vorrebbero “più incisivi”, in grado di
“scardinare” quanto di confuso e di negativo, pur in mezzo a molti dati positivi, affiora nella
vita e nella organizzazione musicale locale. Ma dovrebbe anche aver avvertito, il nostro
lettore avveduto, che la linea da noi scelta, modestamente informativa, “moderata”, non priva
di qualche punta scettica (e, inevitabilmente, anche incline ad indulgere a qualche accento
celebrativo) potrebbe ricevere qualche utile spinta e perfino correzione di rotta, se le opinioni
che corrono e le informazioni di cui eventualmente si disponga, prendessero corpo mediante
l’uso della penna (o di suoi recenti surrogati).
Detto questo, possiamo continuare nei nostri ludi intervistatorii, con i limiti che di essi,
quasi inevitabilmente, sono propri. Il ludus intervista-torio si muove a mo’ di caleidoscopio:
una piccola scossa e le immagini si cambiano, si susseguono, si alternano. Oggi è la volta di
Mario Conter.
L’autore di questa intervista, il maestro Conter l’ha abbastanza alla mano, non perché lo
frequenti assiduamente (ognuno va per la sua strada, e raramente le strade si intersecano),
ma perché l’ha conosciuto fin da giovanissimo, e si permette quindi di portare elementi per
l’individuazione del suo temperamento richiamandosi a un ricordo assai lontano, ma assai
vivo, quando il poco più che ventenne Mario Conter, costretto, ahi lui! (e ahi noi), a passare i
giorni, non proprio piacevolmente, come militar soldato in una scuola allievi ufficiali, era
riuscito a scovare, in qualche luogo, degli strumenti che rispondevano al nome di pianoforte,
sui quali, ogni volta che gli era possibile, cercava di chiudere la durezza della giornata con
momenti di educazione musicale, nei quali coinvolgeva compagni di corso e perfino qualche
autorevole stivalato superiore.
Possiamo partire da questo ricordo? E ti dico subito il perché: mi sembrava, e mi sembra,
simbolico di un tuo atteggiamento, quello di richiamarti sempre alla musica come
“atmosfera”, come “aura” da perseguire, da realizzare.
Ti ringrazio di questo ricordo e di questa individuazione. Devo dirti, molto francamente,
che comunque si voglia giudicare (ovviamente non tocca a me questo giudizio) il risultato del
mio impegno con la musica, è sempre stato preminente in me il bisogno della presenza della
musica. Allora la musica, in quelle ore serali, ci sottraeva alla assurdità barbarica delle armi,
ma anche oggi (sempre) credo la musica abbia questo compito fondamentale, di sottrarci alla
Musica e musicisti a Brescia
55
RENZO BALDO
durezza e dall’assurdo, spesso, della realtà. Non pretendo di dire “la vita come musica”, ma
certamente la musica come elemento principe della vita, questo sì.
La tua partecipazione alla “realtà musica” ti ha spinto anzi su molte strade, su molte
forme di attività, che nella loro varietà e diversità non sempre facilmente convivono.
Intendo dire: hai percorso le strade dell’attività concertistica , dell’insegnamento, della
critica musicale, della organizzazione culturale. Ben quattro modi d’essere! Se è vero, come
qualcuno ritiene, che ognuno di noi è condizionato, o addirittura sfruttato, da una entità
numerica, la tua è il numero quattro.
Come il gioco dei quattro cantoni.... o le quattro stagioni, o meglio, visto che sono stati
quasi sempre concomitanti, come i quattro elementi empedoclei (teniamoci un po’ su di tono
con le immagini)... anche se, in verità, ora che ci penso, c’è anche un quinto elemento, la
direzione orchestrale.
Sì, da circa vent’anni dirigo un complesso strumentale. Ciò mi ha consentito un ulteriore
approfondimento della conoscenza della musica.
Il che, mi pare, può significare che tu hai sentito questa esperienza come un
proseguimento, con altri mezzi, come un’appendice del primo elemento, quello della attività
concertistica. Recuperato, dunque, così, coerentemente, il numero quattro, e continuando
queste nostre quattro chiacchiere, ti vorrei chiedere: quale di questi elementi ti ha più
coinvolto? Quale ti ha dato più soddisfazione? Detto in altro modo: se tu potessi
ricominciare da capo (capita a tutti di avere pensieri faustiani) a quale più decisamente
non vorresti rinunciare?
Direi senz’altro all’insegnamento. Il concertismo ti dà sì dei momenti elettrizzanti (piace a
tutti sentirsi applauditi e sentire, diciamo così, il riconoscimento di massa per il risultato del
proprio lavoro), ma l’insegnamento consente più ricchi e veritieri rapporti umani, ti consente
di vedere la musica costruirsi come patrimonio, che tu gestisci e del quale rendi altri
partecipi.
Sappiamo bene che si può parlare di una “scuola Conter”. Quanti diplomati ne sono
usciti? Credo un numero considerevole.
Sono un centinaio circa, e parecchi entrati nella attività concertistica. Posso ricordare
Angelo Campori, che non ha mai voluto saperne di concorsi, ma che ha fatto una breve
quanto splendida carriera di concertista del pianoforte prima di passare alla direzione
d’orchestra; Ettore Peretti, 2° Premio Casella di Napoli, 1° Concorso “Chopin” di Palma di
Majorca, vincitore al concorso di Rio De Janeiro; (vado in ordine di tempo); Sergio
Marengoni, 1° Premio internazionale “Viotti”, vincitore a Ginevra, 3° al “Cziffra” di Parigi;
Riccardo Bettini vincitore al “Cortot” a Milano, finalista al “Beethoven” della Rai; Teodoro
Simoni (che venne da me già diplomato) vincitore all’internazionale di Bardolino; Gerardo
Chimini, vincitore a La Spezia e a Taranto; Daniele Alberti, il più giovane, primo premio
all’internazionale “Città di Parigi”, secondo ad Oporto, vincitore a La Spezia e a Taranto,
Firenze, ed altri primi premi nazionali. Tutti questi, tranne Alberti, hanno portato la loro
esperienza pianistica nell’insegnamento nei Conservatori.
Pensi che si possa parlare, nel caso della “scuola Conter”, di una linea di continuità
all’interno di una vera e propria “scuola bresciana”?
Penso proprio di sì. Io sono dentro in questa linea di continuità: sono stato allievo della
Muzio, che era allieva di Chimeri, e poi di Arturo Benedetti Michelangeli. Devo dire però che
devo molto anche a Lipatti, che ho frequentato in Svizzera. Per la composizione ho avuto
come insegnante Margola, Giuseppe Benedetti Michelangeli e Bruno Bettinelli.
Che osservazioni di fondo puoi fare ripensando alla tua attività didattica?
Musica e musicisti a Brescia
56
RENZO BALDO
Essenzialmente queste: nonostante la struttura disastrata dei conservatori, l’insegnante, se
vuole, può fare molto ed ottenere buoni risultati.
Certo bisogna curare gli allievi, anche fuori dalla scuola, aiutarli a comprendere e a
costruire la propria personalità. Devo dire che i migliori sono, quasi sempre, quelli che
seguono anche altri studi: è fondamentale curare la cultura generale, rifiutare il mito del
pianista, del concertista, che vive solo del suo strumento. Anche se resta vero che un
musicista, un concertista, può costruire la propria cultura pur non frequentando studi
regolari extramusicali.
Veniamo all’attività concertistica, al Duo Mario Conter-Lydia Saottini.
Lydia viene dalla scuola di Capitanio, che a sua volta veniva dall’insegnamento di Chimeri.
Ci siamo trovati quindi in perfetta omogeneità di orientamenti, di tecniche, di sensibilità.
Abbiamo fatto una quantità enorme di concerti, circa 800. Devo dire però, per inciso, che sul
terreno dell’insegnamento Lydia ha attuato una sua scuola, con risultati autonomi e di rilievo
con numerosi allievi che hanno praticato l’attività concertistica.
Che ricordi hai in relazione agli ambienti che avete conosciuto, alla partecipazione di
pubblico, alla diffusione della cultura musicale?
I pubblici più preparati e più attenti sono all’est, dove la cultura musicale evidentemente è
curata in modo rigoroso e diffuso. La cultura musicale dell’Est punta però quasi
esclusivamente sulla tradizione; Bartok e Strawinski sono come le colonne d’Ercole oltre alle
quali c’è l’abisso. Può darsi che le recenti aperture politiche consentano di superare questo
limite.
Mi ha molto impressionato il Canada, dove abbiamo suonato in 35 città: dappertutto sale
capienti e perfette, con grande risposta di pubblico. In forte crescita il movimento musicale
nell’America latina, ma ancora con qualche disuguaglianza e, specie nelle orchestre, con
livello volonteroso, ma non sempre sicuro e di prestigio. Forse il paese più avanzato nella
cultura musicale è l’Argentina. Abbiamo trovato però buone orchestre anche a Lima e nel
Messico.
Quale è stato l’orizzonte dei vostri programmi?
Abbiamo sempre cercato di non occuparci soltanto della musica classica, ma anche di quella
moderna e contemporanea. Abbiamo programmato tutte le sonate di Mozart, tutto Brahms,
dalle Variazioni su un tema di Haydn alla Grande Sonata op.34 bis, ai Valzer, alle Danze
ungheresi, e parecchio Schubert, Beethoven, Clementi; gli spagnoli Padre Soler e Turina,
tutto Debussy, quasi tutto Ravel... Insomma di fatto credo che abbiamo dato fondo a quasi
tutto il repertorio per due pianoforti e per pianoforte a quattro mani. Fra i contemporanei
Bartok (la splendida e ardua Sonata con percussioni), tutto Strawinski, Busoni, Poulenc,
Bussotti, Donatoni, Ghedini e altri, senza dimenticare Saint-Saens e Chabrier. Abbiamo fatto
conoscere anche le musiche per due pianoforti dei bresciani Manenti e Margola.
Mi risulta che tu abbia sempre seguito con attenzione la musica contemporanea. Cosa mi
dici in proposito?
Ritengo sia importante conoscerla. Questo l’ho appreso fin da giovanissimo, frequentando
le audizioni di casa Togni. E ho continuato a interessarmene. Ho seguito tutti i Festivals di
Venezia. Certo non è facile orientarvisi e talvolta è anche difficile sentirla davvero come
qualcosa in cui ci identifichiamo. Credo, perché è una musica che spesso dà più angoscia che
gioia. Ma forse il nostro tempo vi si rispecchia proprio, perché è più tempo di angoscia che di
gioia. Ritengo comunque sia un grossolano errore il rifiuto aprioristico, che ancora è
largamente diffuso. Penso che le attuali iniziative anche a Brescia, per abituare all’ascolto
della musica contemporanea, siano da incoraggiare. Se ben gestite, possono davvero essere
utili. Non si può ignorare ciò che appartiene al nostro tempo.
Musica e musicisti a Brescia
57
RENZO BALDO
E veniamo alla tua terza anima, quella del critico musicale, nonché alla quarta, quella
dell’organizzatore culturale. Voglio subito portarti su una questione scabrosa, anche per
non dare agli eventuali lettori il destro per accusarci di stare sul pressappoco e sullo scontato. Tu certamente sai che chissà quanti possono aver sentito come sostanzialmente
incompatibili l’esserti collocato sul terreno della organizzazione culturale e della attività
musicale, quale sopra abbiamo indicato, e, contemporaneamente, su quello della critica
giornalistica, che ha come suo compito di giudicare quelle attività. Tu cosa dici in
proposito?
È un problema che conosco bene e che mi sono posto spesso, anche con qualche
inquietudine. In linea di principio, in linea astratta, l’obiezione ha qualche fondatezza. Ma in
concreto io credo che situazioni di questo genere vanno giudicate in base al modo con il quale
le cose vengono fatte. Parliamoci chiaro: una partizione dei ruoli e dei compiti costruita in
modo che formalmente non appaia il rischio della cosiddetta incompatibilità non esclude
affatto che le cose vengano gestite male, confusamente e con poca chiarezza. Io, per carità,
me ne guardo bene dal tessere un pubblico elogio delle mie attività, devo però dire in
coscienza che in tutti i campi dove mi sono impegnato ho cercato sempre di aiutare le
iniziative culturali, di conoscere onestamente meriti e capacità. Credo davvero di poter dire di
aver messo tutto il mio impegno per servire la causa della musica a Brescia, mettendo in luce
valori di persone e di iniziative; cercando anche, sul terreno più strettamente culturale, di
diffondere la conoscenza del patrimonio musicale, di farne comprendere la portata e il significato. Le occasioni sono state tante e credo sinceramente di averle usate al meglio. Anzi,
come meglio ho potuto.
C’è chi sostiene che l’attività di critico musicale è affaticante e in certi casi perfino
stressante... tu che ne pensi?
Stressante si, nel senso che facilmente ti trovi nei guai se “tocchi”, anche gentilmente,
qualcuno. Anni fa sono stato minacciato di morte di lupara perchè avevo scritto che una
cantante aveva stonato. Tutti l’avevano sentita, non si poteva nascondere. Il marito telefonò
di notte a casa mia, io ero al giornale. Immagina lo spavento di mia moglie. Dovetti farmi
accompagnare a casa dalla polizia. E ne potrei raccontare tante altre, soprattutto nel campo
dei cantanti. Se scrivi a favore, nessuno ti dice niente. Se fai una riserva, ti fai dei nemici
(anche se magari ricevi qualche complimento dei lettori). Insomma è un compito ingrato! A
questo punto uno potrebbe chiedermi: e chi te lo fa fare? Ti rispondo che non lo so. Penso che
sia, al fondo, una disponibilità non diciamo missionaria, ma un po’ altruistica, sì. Se ci
ripenso, quel che mi ha spinto, tanti anni fa, ad accettare la rubrica musicale sul quotidiano
locale è stata la persuasa convinzione che con quel lavoro si possono aiutare i giovani
meritevoli e sostenere l’opera delle varie organizzazioni musicali. Ho anche sempre pensato
che uno del mestiere, che sa cosa vuol dire stare sul palcoscenico e suonare per un pubblico,
possa meglio comprendere la psicologia dell’interprete e il frutto del suo studio. Certo, chissà
quante volte ho sbagliato. Ma sempre sforzandomi di cercare la massima obiettività possibile.
Dicembre 1989
Musica e musicisti a Brescia
58
RENZO BALDO
IL FILOSOFO E LA MUSICA
A colloquio con Emanuele Severino
Che ha a che fare Emanuele Severino con la musica? Beh, ci ha avuto e ci ha a che fare.
Cominciamo col ricordare, per esempio, che all’interno dell’arco della sua speculazione
filosofica più volte il tema “musica” fa una sua non trascurabile comparsa. Segnaliamo, per
chi voglia affrontarne la lettura, il capitolo secondo, “Il grido”, ne “Il parricidio mancato”
(ed, Adelphi) e, nel recentissimo “Il giogo” (sempre Adelphi), la seconda sezione dall’ultimo
capitolo, il dodicesimo, “La parola degli eroi
Però, lo confessiamo, l’idea di portare Emanuele Severino sulle pagine del nostro giornale,
tramite quello strumento persecutorio che è l’intervista, ci è balenata sotto tutt’altra spinta.
Se è vero, come qualcuno sostiene, che la casualità è la matrice del mondo e che le occasioni
che essa offre vanno subito sfruttate, ebbene questa intervista è, fra tutte quelle che abbiamo
accumulato nel succedersi dei numeri di Brescia Musica al fine di individuare qualche aspetto
delle tessere e dei frammenti di cui si compone il mosaico musicale bresciano, certo la più
“occasionale” fra tutte. Essa nasce, infatti, dal casualissimo ritrovamento di una partitura per
pianoforte, che un nostro redattore ha scovato fra gli scaffali zeppi di musica della pianista
Roma Ferrari, un manoscritto dei primi anni quaranta, firmato Emanuele Severino, intitolato
I pensieri delle Parche. Un pezzo denso di scrittura strawinskiana, di irruenza fonica
percussiva e di taglienti intrecci tematici. Come sottrarsi alla curiosità di sapere da quali mai
retroterra sbucasse fuori? Rinunciare alla tentazione di telefonare all’autore di quel lontano
trascorso giovanile, per chiedergli di dirci qualcosa sul suo rapporto con la musica, allora e
oggi?
Allora un esuberante enfant-prodige, che si arrampicava con entusiasmo sulle scogliere
della musica contemporanea; e oggi? tra Eschilo e Parmenide, tra l"‘essere” e il “niente”, tra
Nietzsche e Heidegger, nello sforzo — come dice un risvolto di un suo libro — di “scalzare la
fede nell’esistenza del divenire”, che frequentazione ha con la musica il “filosofo”, che usa
soggiornare tra le più ardue strutture del pensiero teoretico?
Professor Severino, quando le abbiamo telefonato per annunciarle il ritrovamento di una
sua partitura, ci ha risposto, tra il sorpreso e il divertito, che tutto si sarebbe aspettato
tranne che di essere interpellato, e minacciato di intervista, sulla sua attività di
compositore di musica, un’esperienza di anni ormai lontani, rimasta dispersa su carte che
nemmeno lei sa dove possano essere finite. Ma che cosa le ricordano quelle pagine? quei
pentagrammi ormai scoloriti dal tempo? da cosa nasceva quella inclinazione?
In questi casi si usa dire “peccati di gioventù”, ma sarebbe banale. È stata infatti una viva e
stimolante esperienza. La vostra telefonata mi ha fatto ripensare a quegli anni quaranta (i
miei anni, all’incirca, fra i dodici e i venti), all’entusiasmo con cui mi buttavo sulla musica e
sulla carta pentagrammata, per riempirla di note. Mi ha fatto ripensare all’atmosfera,
all’ambiente, alle persone che frequentavo: il Maestro Luigi Manenti, che mi avviò alla
composizione, organizzando e dando ordine a una sorta di impulso originario, che mi portava
a scrivere musica, a coordinare i suoni fra loro; la casa di Roma Ferrari dove è stata eseguita
la composizione che avete ritrovato (ricordo anche, tra l’altro, una serata con un programma
di musiche di musicisti bresciani, Togni, Margola, Manenti e, si licet, anche mie).
La partitura che è stata ritrovata, dunque, non è stata l’unico suo impegno di
composizione.
Musica e musicisti a Brescia
59
RENZO BALDO
No, tutt’altro, ho scritto molte cose, specie per pianoforte e per strumenti a fiato. Anzi, dopo
la vostra telefonata mi sono dato da fare per vedere se riuscivo a ripescarle, ma non le ho
trovate, chissà dove sono finite. Ho trovato soltanto una Suite per strumenti a fiato, del
‘47-’48. per flauto, oboe, corno inglese, clarinetto, fagotto, tromba in si bemolle, pianoforte “a
guisa di timpani”, una ampia composizione, che è stata anche eseguita in pubblico.
Il pianoforte come strumento a percussione. Abbiamo ragione di pensare che il suo punto
di riferimento era Strawinshi?
Sì, ero imbevuto di fonica e di formule strawinskiane, ma forse soprattutto bartokiane.
Ma chi l’aveva avviato alla musica?
Mio fratello - aveva otto anni più di me - era un ottimo pianista. Lo ascoltavo volentieri, e
poi, quando potevo, mi mettevo anch’io al pianoforte, e “componevo”. Mi ha sempre attirato,
fin da ragazzino, il mondo dei suoni, mi attirava il combinarsi dei rapporti sonori. Sopra di
noi abitava il M.ro Guastalli, l’insegnante di mio fratello, che deplorava quel mio modo di
suonare, e mi esortava a studiare regolarmente, ma io, ostinato, preferivo combinare suoni.
Ho anche, per la verità, negli anni successivi, studiato con un certa regolarità, ma non sempre
con continuità. Sono rimasto, così, un modesto pianista.
Lei però ha continuato a suonare, ho visto sul leggio del suo pianoforte le Sonate di
Mozart.
Sì, però mi è rimasta soprattutto l’inclinazione a sentire lo strumento come luogo di un
personale impatto, in altre parole il piacere della improvvisazione, che ancora adesso mi
attrae fortemente.
Ma alla composizione, con quel “taglio” strawinskiano-bartokiano, come ci è arrivato?
Oltre all’insegnamento di Luigi Manenti, che si muoveva in un ambito abbastanza vicino a
quelle esperienze e sensibilità musicali, ascoltavo dischi e, soprattutto, musica trasmessa per
radio. Ricorderà certamente anche lei quale è stata l’importanza della radio tra gli anni ‘30 e
‘40, quando comparvero nelle nostre case quelle scatole gracchianti...
Ricordo bene. I dischi erano pochi e costosi, le radio, imprecise ed incerte nella ricezione,
portavano però per la prima volta possibilità di informazioni musicali fino ad allora, specie
in provincia, assolutamente inattingibili. Del resto, credo che non solo allora, ma anche og gi, un ascolto attento e calibrato delle trasmissioni radio costituisca una base fondamentale
per una educazione musicale.
Ebbene, da quell’ascolto, unito alla lettura di alcune partiture, avevo assimilato un
entusiasmo fonico che mi pulsava nella testa e che riversavo nella scrittura di molte pagine
musicali, oltre che nel piacere della improvvisazione sulla tastiera del pianoforte.
Lei ha citato Luigi Manenti. Ha avuto altri contatti con persone dell’ambiente musicale
bresciano?
Ricordo l’avvocato Grassi, presidente della Società dei Concerti, che mi ascoltò suonare
alcune mie pagine per pianoforte. Ma voglio ricordare anche quello che poi divenne mio
suocero, Francesco Mascialino, eccellente strumentista di clarinetto e oboe, e dotato di una
notevole cultura musicale, che mi aiutò a entrare nei segreti degli strumenti a fiato. È sta to,
fra l’altro, il librettista delle opere di Manenti.
Oggi che impressione le fa riguardare le sue composizioni?
Troppo “piene”, manca il “silenzio”. Mi divertivo molto, troppo, a combinare suoni, ritmi e
timbri. D’altra parte, ripensandoci ora, ero proprio immerso, avevo proprio assimilato una
delle caratteristiche della cosiddetta musica moderna, l’assenza o, quanto meno,
l’annebbiarsi della Stimmung.
(N.d.r.: si può tradurre con “sensibilità”, “atmosfera”, “stato d’animo”).
Musica e musicisti a Brescia
60
RENZO BALDO
A questo punto mi consenta, allora, di chiederle più specificamente il suo parere sulla
musica d’oggi. Non senza prima ricordarle alcune frasi che si trovano in un suo scritto,
dove si legge che oggi “la scissione fra musica e società è netta”, che “i musicologi, quando
fanno seriamente il loro mestiere, sono meno comprensibili dei matematici”, e ancora, che
“la musica contemporanea, non solo per il popolo, è un enigma”.
La musica contemporanea è un fenomeno, che si sviluppa in modo conseguente col
fenomeno che massimamente caratterizza il nostro tempo: la distruzione di strutture eterne.
Sì prende congedo dall’eterno, dall’immutabile, da ogni possibile apriori. Per fare delle
analogie: la critica marxiana dell’economia politica, le geometrie non-euclidee, la “crisi” del
sapere scientifico di tipo positivista, etc.
Nel campo della musica, secondo lei, quando ha avuto inizio questo fenomeno?
Direi da Beethoven, il quale non ne aveva consapevolezza, anzi riteneva di dominare e
continuare la tradizione. Il fenomeno si fa macroscopico in Wagner (aveva perfettamente
ragione Thomas Mann quando affermava che il Tristano è, contemporaneamente, opus
metaphisicum maximum e decadente consolazione per i decadenti), per raggiungere piena
consapevolezza, essere teorizzato, nel nostro secolo. La dodecafonia costituisce il volto più
coerente di questa consapevolezza: la negazione di ogni apriori immutabile, la negazione
dell’apriori armonico — tonale.
Ma Schoenberg non si limita a negare l’apriori tonale. Con la proposta seriale intende
ricostruire un ordine, una organizzazione del linguaggio musicale, che si pone come salda e
immutabile, a sua volta un apriori.
Certo, ma è un apriori “sperimentale”, che, cioè, come la scienza moderna, si propone come
“metodo” e non come “sistema”, può quindi sempre essere rivisto e modificato, non ha nulla
di immutabile (contrariamente a quello che credono alcuni schonberghiani; diversamente da
Schoenberg, il quale ebbe ad affermare che resta ancora della buona musica da scrivere in do
maggiore).
Ma questo non è un riconoscere, semplicemente, la “storicità” dei linguaggi, di ogni
linguaggio? per stare all’analogia che lei mi ha prima suggerito col riferimento alla critica
marxiana dell’economia politica: Marx ci ha detto che la cosiddetta “economia politica” non
è un assoluto, un immutabile, ma un modo d’essere “storico” della organizzazione
economica; così Schoenberg ci ha fatto capire che anche il sistema tonale è “storico”,
altrimenti, come lei in una sua pagine si è argutamente espresso, bisognerebbe pensare che
Adamo ed Eva cantassero in do maggiore.
Ernest Ansermet nei suoi Fondamenti della musica nella coscienza umana afferma
l’esistenza, nell’uomo, di una struttura apriori acustica, apriori nel senso kantiano, cioè che
garantisce le condizioni immodificabili sotto le quali l’uomo percepisce la realtà. Se si accetta
questo punto di vista, la dodecafonia appare come una violazione dell’ordine naturale. Il
fatto, però, che la violazione avvenga, e che la sua risultante sonora venga percepita è, si
voglia o no, ormai accettata, è il segno di ciò che lei chiama “storicità”, ma che, in realtà,
guardando più in profondità, è il fenomeno della distruzione di ogni struttura che voglia porsi
come immutabile.
Detto con altre parole: è il segno del dispiegarsi di una volontà che vuole il dominio del
divenire. Possiamo dire, con linguaggio nicciano: la musica è testimonianza del dionisiaco,
della gioia-dolore del dissolvimento; la musica è la voce della struttura stessa del divenire
come gioia-dolore. Nei miei scritti, se mi si consente questo richiamo, ho cercato di spiegare
l’origine della musica come espressione, per dirla con le esatte parole di Nietzsche
“dell’eterno piacere del divenire, che comprende in sé anche il piacere dell’annientamento”.
Musica e musicisti a Brescia
61
RENZO BALDO
In base al riferimento a Beethoven, che lei prima ha fatto, dobbiamo dedurre che dal
romanticismo in qua sempre più forte è il trionfo del dionisiaco, e quindi del “tragico” e del
dissolvimento? E che l’apollineo rimarrebbe, per quanto parziale, per quanto ipotetico, un
requisito della musica, diciamo così, fino a Mozart - Haydn?
Sì, si può sostenere, purché, però, non si cada nell’errore di Nietzsche, il quale, avvertendo
che la musica, con Wagner, si faceva sempre più “romantica” e quindi “la meno greca di tutte
le possibili forme d’arte”, non si era accorto che il teatro greco, perfino nella forma, non era
molto diverso dal tempio di Bayreut. La “dissoluzione”, il “tragico” son cominciati con la
grecità, che è alle radici di tutto lo svolgimento culturale successivo, fino ad oggi. La grecità
cattura tutto, anche la musica.
Quanto alla “storicità”, cioè alle differenze, sono si importanti, ma rischiano di essere una
banalizzazione, se si trascura di vedere, sotto quelle differenze, i significati che il fenomeno
assume nella sua “unità”.
C’è qualche rapporto fra questa lettura, chiamiamola così, “epocale” della musica e
l’immagine che di essa si delinea nel Doctor Faustus di Thomas Mann, la musica come sfera
del “demoniaco”?
Credo proprio di sì, credo che con metafore diverse si metta a fuoco il medesimo problema:
il “demoniaco”, la “follia”, che sono impliciti nel rigoroso dispiegamento del dionisiaco. Mann
rappresenta lo sgomento di fronte allo scatenarsi del puro dionisiaco: il “patto col diavolo”
del musicista Adrian Lewerkuhn in concomitanza con lo scatenarsi della follia “tedesca” (ma
si può correttamente intendere, tout court, “moderna”). Il nazismo e la musica (“moderna”,
“tedesca”) come culmine della volontà di potenza, che si risolve in culmine della decadenza,
della negazione della volontà di vivere, nel senso che questo concetto ha in Schopenhauer. Gli
sfuggiva, però, che l’espressione più pura della volontà di dominio non spetta, oggi, alla
musica, ma alla scienza e alla tecnica.
È per questo che lei dice, in un suo libro che “la musica è divenuta un’evasione provvisoria
dai nostri problemi reali”?
Certo, come la religione: dopo le funzioni religiose, fosse anche un papa che riempie gli
stadi, come dopo l’ascolto di una musica, ognuno torna ai suoi affari, nei quali soltanto si
identifica. Essi sono per ciascuno la vera realtà, non la religione o la musica.
La separazione fra musica e popolo, che Nietzsche si proponeva di superare?
Sì, il tempo della musica, originariamente, era un tempo sacro; la vita dei popoli antichi si
raccoglieva comunitariamente attorno al canto, al suono, al ritmo. Oggi “l’incantesimo” della
musica vive in brevi spazi concessi come evasione dal grande spazio del tempo profano.
Ma il suo rapporto personale con la musica, oggi, qual è? È un fatto diventato marginale
o in qualche modo ancora conta nel suo orizzonte di sensibilità, di riflessione, di
consuetudine culturale?
Non l’ascolto spesso, anche se non posso però dire di trascurarla. Le confesso d’altra parte
che il momento nel quale mi sento più a mio agio con la musica è quello di cui le ho
accennato, del diretto impatto, della “composizione-improvvisazione”. Ma vorrei aggiungere
una cosa: sottrarsi alla musica non è possibile, perché la musica resta sempre, nei secoli, la
voce dell’impatto con quella “incrinatura”, che, come ho cercato di chiarire nei miei scritti,
segna la presa di coscienza “originaria” dell’uomo nei confronti della realtà. Hanslick
insisteva nel dire che la musica esprime soltanto il puro movimento. Aveva ragione. Ma
questo non significa che si distacchi dal mondo, anzi ne rappresenta l’essenza, cioè il
divenire, il movimento appunto.
Ottobre 1989
Musica e musicisti a Brescia
62
RENZO BALDO
TRA FELICITÀ E STRAZIO
Intervista a Mario Cassa: il “destino” della musica
Sì può parlare di musica collocandosi dai più diversi punti di vista, con discorsi, che,
ovviamente, si muovono su contesti diversi, a seconda delle specifiche competenze
dell’interlocutore: il compositore, il concertista, il musicologo e via dicendo. Sono ormai molti
coloro che abbiamo intervistato per Brescia Musica. Ci siamo ora rivolti a Mario Cassa, che,
ci tiene a dirlo, non appartiene a nessuna di queste categorie. Lo sappiamo, però,
particolarmente attento alla “dimensione musica”, per una lunga consuetudine d’ascolto.
Questa assidua frequentazione dell’area musica, collocata all’interno di un vasto e
sistematico percorso nelle zone “alte” del pensiero moderno, può forse condurci a qualche
riflessione, alla individuazione di qualche opinione o di qualche criterio di giudizio, pertinenti
con gli interessi e gli orientamenti del nostro giornale e dei nostri lettori.
È almeno dai tempi del Romanticismo (uso il termine nel suo senso più lato, di capitolo
chiave della cultura moderna) che la riflessione sulla musica è diventata punto di
riferimento non marginale, e particolarmente in grado di aiutarci a penetrare in
profondità, diciamo pure così, nell’anima della nostra civiltà. Al punto in cui questa oggi è
giunta, se è vero — come credo si desuma anche dall’orientamento delle riflessioni che tu
hai sistematicamente condotto sulle tematiche che riguardano proprio il problema della
civiltà — che siamo, inesorabilmente, in tempi di dominante “reificazione”, quale ritieni sia
il “destino” della musica? Detto con altre parole: che posto può avere la musica nella civiltà
quale oggi si configura, tenendo soprattutto presente che, fra tutte le arti, essa appare come
la più squisitamente soggettiva, più forse di ogni altra predisposta alla funzione di esprimere la “interiorità”, cioè proprio il contrario della reificazione?
Tutto nel mondo si fa oggettivo: la “reificazione”, la potenza meccanica, prendono possesso
di tutti gli spazi della coscienza vitale. Ma propria del suono è la vibrazione di quell’elemento
puro e insostituibile che abita lo spazio dell’interiorità, entro il quale le parole musicali
s’immergono come stelle nel firmamento, smisurato. La musica è spazio soggettivo, è regola
prospettica, grazie alla quale il vuoto, con il suo sgomento, la sua vertigine, assume voce e
significato.
Ma questa, come tu la chiami, “regola prospettica” e, quindi, la battaglia per fare
assumere voce e significato al “vuoto” e allo “sgomento”, non è propria di tutte le arti?
La musica, il suono regolato e ordinato nel discorso propriamente musicale, immerge
parole, pensieri, emozioni, azioni, nella luce, nell’umore dell’interiorità, della soggettività; in
tal modo che ogni attimo del vivente riveli con trasparenza immediata la vera radice, anzi la
vera sostanza della vitalità elevata a cultura. Così in essa, nel suo elemento, ogni inezia si
ritrasmette, riecheggia nell’universale, nella profondità inaccessibile: fin là dove non possono
penetrare le forme o figure d’ogni altra arte, poetica, pittorica, ecc.
Di questo destino sono partecipi, s’intende, tutte le arti, a modo loro. Ma non bisogna
dimenticare tuttavia la particolarità della musica. Consentimi questa citazione hegeliana
(Hegel l’ha detto così bene, che non è il caso di ricorrere ad altre parole): “il compito
peculiare della musica consiste nel fatto che essa rende per lo spirito, ogni contenuto, non
quale si trova nella coscienza come rappresentazione generale, o esiste per l’intuizione come
determinata forma esterna (...), ma quale diviene vivo nella sfera della interiorità soggettiva.
Musica e musicisti a Brescia
63
RENZO BALDO
Il difficile compito da affidare alla musica consiste proprio nel far risonare per sé, in suoni,
questo vivere e vibrare in sé latente” (Hegel, Estetica. Milano, 1963, pagg. 1188-89).
Dobbiamo dedurne che il peso della “reificazione” si fa sentire nella musica più ancora che
sulle altre arti?
Ben si capisce come l’arroganza, la sopraffazione che oggi esercita la rappresentazione
oggettiva, la forma esterna, insomma la cosa nella sua oggettività alienata, nella sua
meccanicità, incida sul “compito peculiare” della musica più che su ogni altra arte: sulla
scultura, per esempio, ma anche sulla pittura, che pure è “arte romantica”, assai più intrisa,
grazie al colore, alle luci, di soggettività profonda, oggettivamente inafferrabile.
"Il destino”, abbiamo detto prima, ma forse meglio potremmo dire “la situazione” della
musica, è dunque segnata dalla vittoria della meccanicità? In un conflitto nel quale ormai il
compito peculiare della musica, la sua capacità di farsi “coscienza” e “interiorità”, è andato
perduto?
In questo conflitto sta la situazione della musica, la ragione della sua vita e morte, della sua
storica presenza, che va verso il suo compimento. In questa situazione di morte, di
dissipazione, bussa il “convitato”; si fa avanti l’assolutezza del fatto musicale: che esce dal
tempo, ossia non dura nel tempo, non si ripete come variante canzoncina, sempre da capo,
nei secoli. Il tempo moderno della musica è sul finire e la musica sale al cielo degli immortali.
A lungo la musica ha lottato contro questa forza nemica, insita nella civiltà, contro la sua
potenza pratica, reificante. Non a caso i secoli della sua più alta manifestazione, della sua vera
gloria, sono stati quelli, nei quali la musica era la voce che chiamava alla lotta, faceva appello
a tutte le risorse della cultura, dava prova del suo genio stupefacente nel dar ordine libero e
disciplina fecondatrice a tutte le potenzialità della interiorità minacciata: da Bach a Mozart, a
Beethoven, a Schubert e Schumann.
La sconfitta incomincia dunque già da ciò che accade dopo Schubert e Schumann?
Con Wagner comincia ad affiorare il disagio, l’infelicità, il presagio della sconfitta. Il
sentimento di Tristano e dell’ultimo Wotan, il senso della vita, la pura, innocente risonanza
delle sue quiete profondità, “l’oro del Reno”, tutto ciò sfugge sempre più all’intimo possesso
del linguaggio musicale. La lotta tra musica e civiltà si fa impari.
Ma da Wagner in poi ci sono pur segni di “combattimento”, di musica nella quale si legge
la volontà di resistere alla sconfitta, di farsi voce capace di significato, capace, se non altro,
di dire qualcosa sulla civiltà nella quale nasce e della quale si fa espressione. Faccio dei nomi: Mahler, Skriabin, Bartok... o, perché no?, Schoenberg.
Ora dire soggetto, interiorità, è dire decadenza, disperazione, dissociazione, morte. La
musica si difende da ultimo con la straziante rievocazione delle voci passate: Mahler è, per
questo aspetto, dicevo, immerso nella corrente disperata della sublime enfasi wagneriana,
votata alla morte.
Dopo d’allora la musica — come l’architettura — compie a volte piccoli prodigi di
ristrutturazione, in ambienti e con anima assai mutati. Skriabin ristruttura Chopin e i Beatles
fanno eco nostalgica alla liederistica del primo ottocento. Ma il caso più diffuso e vistoso è
dato dalle ristrutturazioni diverse della musica popolare e rituale primitiva, negra, jazzistica.
Sta a sé il caso grandioso di Schoenberg, che si offese vedendosi allegoricamente ritratto da
Thomas Mann nel Doctor Faustus; si offese, perchè si riconobbe esattamente in Adrian
Leverkuhn.
Nella vicenda della “scuola” dodecafonica si disegna il corso più profondo, disperato, della
musica, in un’età, che ha esautorato interamente il soggetto nei confronti delle cose. E lo
condanna all’esperienza estrema della solitudine e del’impotenza. La scuola dodecafonica ha
Musica e musicisti a Brescia
64
RENZO BALDO
perseguito con lucida, vertiginosa “follia” la fine della musica. Sta in essa, perciò, l’episodio
decisivo di più alta vocazione artistica del tempo nostro; si devono ad essa le parole musicali
estreme, con le quali vien detta, annunciata, la morte della musica. Strazianti voci contratte,
dove ogni suono ubbidisce a un ordine rigorosamente riconoscibile dall’intelletto, ma non
dalla sensibilità, proprio perché strenuamente orientato a liberare il dire musicale dalle
figure del sentire — ritmi, strutture morfologiche tradizionali — a vantaggio
dell’intransigente struttura intellettuale, purificata, liberata dall’abituale. Proprio come ogni
individuo della civiltà nostra, serrato nella morsa, dominato da un eccesso parossisitico di
regola, di “macchina”, vive, nell’intimo suo, in una solitudine sempre più vuota, a distanze
siderali da ogni altro suo simile.
E fuori dalla musica colta?
Sì chiama oggi popolare quella musica nella quale la gesticolazione, il piccolo teatro o
cabaret tra l’isterico e l’eretico, hanno una parte assolutamente sovrastante nei confronti del
più povero, del più insignificante balbettio musicale. Tanto più povero e insignificante,
quanto più assordante. Non nego affatto il valore, il significato sintomatico di questi spettacoli “musicali”, così rigorosamente mimetici nei confronti della trama e dell’ordito, che
disegnano la vita reale dei giovani nella società civile che ci appartiene: tutta cose, tutta
oggetti, tutta forza meccanica, tutta riflessi condizionati, tutta isterismo e paranoia.
Vuoi chiarire quel che prima hai detto della musica “che sale al cielo degli immortali”?
Immortale vive, e si fa ascoltare, la musica di Bach e di Beethoven: dalle Variazioni su tema
di Goldberg alle Variazioni su un valzer di Dia-belli. Sono due vertici.
Anche tu, mi sembra di dedurne, condividi l’opinione sulla centralità che ha assunto la
“variazione” nel definire i processi più profondi della musica occidentale?
La variazione è il segno di un nuovo concetto dello spazio musicale: non si edifica più in
esso un edificio, che, anche solo per un attimo, possa apparire chiuso, concluso, oggettivo; un
tempio, piccolo o grande, che custodice una ben riconoscibile divinità, domestica o esotica.
La variazione è un sistema solare che può moltiplicare le sue orbite all’infinito per ricadere
sempre, inesorabilmente, intorno ad un unico sole.
Di questa musica oggi non è più nulla. Sì torna sempre a riascoltare il “classico”: la musica
dal Sei all’Ottocento, da Monteverdi a Wagner. E al centro, a incommensurabile altezza in
confronto a tutti gli altri, stanno le vette di Bach, Mozart, Beethoven, Schubert e Schumann.
Nient’altro è confrontabile con loro. Di Bach e di Beethoven è più facile parlare, di Mozart,
che sta al centro, è più difficile; come di Schubert, che sta, con Schumann, al limite estremo.
Wagner è già in lotta con il nulla o, meglio, con il nichilismo, ossia con il nulla assunto come
valore; e perciò, in questa lotta, deve continuamente alzare la voce o mostrare muscoli; è costretto insomma a richiamare continuamente l’enfasi, l’oratoria, la retorica: quella via dove
tutti andranno poi a finire, spesso con gran decoro. Tranne, unico, il grande, tragico e
irripetibile Mahler: con quella sua inconscia e profonda astuzia dell’ironia e della
rievocazione.
Allora: “felicità” e “inattualità” del classico?
Sì ritorna sempre ad ascoltare il classico; con emozione felicitante sempre nuova, ma
equamente divisa con uno strazio sempre più inguaribile. Felicità per l’eterno cui quella
musica appartiene, e strazio per la sua insanabile inattualità, per il divieto assoluto che
definitivamente pesa sul suo ritorno. Sempre meglio lo comprendiamo e sempre più acuto si
fa lo strazio, che contende con la sublime felicità, che da quei messaggi ci perviene e in eterno
ci perverrà.
Giugno 1990
Musica e musicisti a Brescia
65
RENZO BALDO
IN POLIFONICA ARMONIA
Il “gesto” di Diego Chimini
Sì è detto e si è scritto molto di quel singolarissimo personaggio, che ha la funzione di
dirigere un’orchestra o un coro, e fa germogliare la musica sul silenzio di una sala o di una
navata. Un gesto che sa di magico e di scenografico, di affascinante e anche, magari, un
tantino di istrionico. Certamente un gesto che non ha — o non dovrebbe avere — nulla di
meccanico e di metronomico, un gesto nel quale, a saperlo leggere ed ascoltandolo nel
risultato sonoro che ne scaturisce, confluiscono, come in un terminale, ondate di composite
realtà, addirittura l’intera storia di un uomo, dai più remoti sottofondi culturali ai vibrati
sobbalzi della soggettività. Insomma, tutto un mondo da capire, e, spesso, da godere.
Perché questa introduzione che sta un po’ tra l’ovvio e il pomposo? Perché non
diversamente possiamo iniziare il discorso su un personaggio — su un “direttore” — di una
assoluta e, crediamo, rarissima singolarità.
Chi ha avuto l’occasione, la sera del 15 agosto scorso, di transitare per uno dei luoghi più
carichi di attrazioni ferragostane della nostra provincia, e cioè Maderno, tra le offerte che il
lago di Garda propone nel pieno dell’estate e si sia lasciato persuadere dagli smilzi volantini
distribuiti alle spalle del monumento a Sant’ Ercoliano — che in tempi lontani fece cessare la
peste ottenendo eterna gratitudine dalle popolazioni del luogo (ogni tempo ha le sue pesti,
anche se non ogni tempo i suoi santi) a entrare, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale, poteva,
sul tracciato di un programma corale, che andava da B. Marcello a Orff, da Pachelbel a
Monteverdi, da Mendelssohn a Bruckner, fare la conoscenza del “gesto” di Diego Chimini, in
altre parole trovarsi a fare i conti con una realtà direttoriale, che non esitiamo a definire
sorprendente.
***
Va detto che ci è accaduto, nel lungo giro di molti anni, di avere avuto più di una volta un
saggio della “musicalità” di Diego Chimini, ascoltando la sua corale “S. Cecilia”. E ancora una
volta l’abbiamo sentita riproposta nella sua pienezza. Ma, anche, in quello che potremmo
definire il suo “mistero”. Cosa c’è infatti al di là del “terminale”, dietro il “gesto” di Diego
Chimini? Quali sono le sue radici, il suo humus, le sue ascendenze culturali? A prima vista
domanda senza risposta.
Diego Chimini non risulta aver fatto studi regolari, il suo nome non è rintracciabile sui
registri di nessun conservatorio o scuola di musica; Diego Chimini ha passato la vita a gestire
un’azienda di floricultura, lavorando fin da ragazzino — quando non gestiva aziende, ma
pensava suo padre ad adeguatamente gestirle — le intere giornate tra serre, terricci, erpici e
rastrelli. Ancora adesso (settant’anni suonati) chi passa accanto ai vivai di Maderno e vi sbirci
dentro, lo può scorgere, segaligno e diritto come un fuso (ma quante volte deve chinarsi...) a
falciare, tosare, potare, trapiantare doverosamente cinto di ruvidi grembialoni e armato dei
gommosi guantoni di prammatica.
Di un simile personaggio, per tradizione familiare, per responsabile scelta di lavoro
produttivo, agganciato alla terra, alle sue zolle e al suo fiorire, al suo “peso” aziendale e a
quella faticosa gravezza, che, al di là di ogni entusiasmo georgico, essa duramente impone, si
potrebbe al più pensare che la passione per la polifonia corale gli sia cresciuta dentro come
Musica e musicisti a Brescia
66
RENZO BALDO
uno di quei fiori esotici, che casualmente sbocciano su un’aiuola casalinga, e che, nella loro
attraente, ma stentata diversità, possono metaforicamente paragonarsi a molti dei cosiddetti
hobbies, quali un po’ ingenuamente e semi-oziosamente rallegrano le cosiddette ore del
tempo libero o, più ancora, a quelle attività, cariche di onesta dedizione, che spesso sono il
frutto della volonterosità degli autodidatti. Il “direttore di coro” in una contrada di provincia
può essere visto un po’ come il celeberrimo sarto manzoniano, entusiasta delle letteratura e
benevolmente oggetto di aristocratico sorriso da chi, nel mare delle umane lettere, naviga su
ben diversi fondali.
Ma è proprio qui il punto, il “mistero”. Dalle mani di Diego Chimini le partiture escono
“sonorizzate”, fatte musicale armonia, a livelli che raggiungono spesso il brivido della più
salda e raffinata pienezza, frutto di un connubio fra sensibilità e consapevolezze tecniche, che
lascia interdetti.
***
Scavando nella biografia di Diego Chimini, in verità, si trova un aggancio, che aiuta a
trovare, almeno parzialmente, una spiegazione. Trovatosi a nemmeno vent’anni nella
necessità di dirigere il coro della parrocchiale, “promosso”, insomma, da semplice voce ad
assumersi la responsabilità di tenere in piedi la compagine corale, Diego intravede la strada
giusta, la strada da percorrere per sottrarsi al rischio delle volonterose approssimazioni e dei
risultati da benevolo sorriso. La sera, terminato il lavoro che gli assorbiva la giornata, per
anni, ogni volta che era possibile, veniva a Brescia da don Giuseppe Berardi.
Ecco un altro personaggio che meriterebbe di essere bene ed adeguatamente ricordato.
Forse sono ancora abbastanza numerosi i bresciani che si rammentano a quali risultati, negli
anni Cinquanta, fino alla morte dolorosamente prematura nel 1968, questo umile e
straordinario servitore della musica aveva portato il coro del seminario.
Con don Berardi il nostro Diego “legge”. Legge partiture. In quegli anni — così egli ricorda
— ha imparato a “vedere” il suono sulla carta e a sentirlo emergere dal “silenzio” carico di
significati del pentagramma. Diego Chietini ha assiepato nella sua biblioteca un migliaio di
partiture, accumulatesi col procedere sistematico della “lettura”. È la sua banca, con i suoi
lingotti aurei.
Don Berardi proveniva dalla scuola di Raffaele Casimiri, che negli anni ‘20-’30 (morì nel
1943) fu uno dei più assidui frequentatori della polifonia vocale, specie rinascimentale.
Al suo nome si legò allora, col cosiddetto “movimento ceciliano”, la riscoperta e il rilancio
dell’area che possiamo chiamare “Palestrina e dintorni”.
***
Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, e sul problema dell’interpretazione di quegli
incunaboli, anzi di quel mare magnum di cui si costituisce la polifonia vocale, sacra e non, si
son dette e fatte molte cose, si sono accese discussioni, si sono affacciate diversità di linee
interpretative, è nata e si è diffusa una robusta consapevolezza filologica, che ha messo in
ombra quegli entusiasmi da “Renaissance”, che animarono i Casimiri e i don Berardi.
Casimiri propendeva per una “lettura” che oggi si potrebbe definire “romantica”:
inclinazione a dilatare i tempi, una scansione energica, ma in funzione di una espressività
dagli accenti lirico-drammatici. Don Berardi l’aveva fatta propria, sia pure con un taglio
vigoroso che conferiva alla pagina una solidità statuaria, un rilievo architettonico. Da lì deriva
quel piglio netto, scattante, del taglio interpretativo di Diego Chimini, che nella sua Maderno,
sotto gli archi solenni della sua “cattedrale”, continua ad alzare quei “monumenti” sonori,
Musica e musicisti a Brescia
67
RENZO BALDO
accarezzandone i contorni con una commossa dedizione, che li sfuma in una sorta di
armoniosa lievitazione.
Forse qui, in questa lievitazione, è intravedibile un altro aggancio in grado di spiegarci il
fascino e i contorni della musicalità del nostro Chimini.
E qui il lettore ci deve permettere un piccolo gioco di parole, che può sembrare un po’
bizzarro ed artificioso, ma che invece, si confida, può aiutare a capire. Quando Chimini, come
ogni altro direttore che si rispetti, fa lievitare la pagina musicale - sì, lievitare, con la “i”,
proprio come il panettiere fa prendere forma al suo pane - egli, probabilmente, in modo
inconscio crea una sensazione di levitazione, senza la “i”, cioè quel fenomeno, che viene
attribuito ai mistici, di sollevarsi un tantino da terra. Chimini è lì, ma “al di là”, quasi
sollevato da terra, abstracto e absorto nella sua aura musicale. Al di qua, al di sotto, ci sono i
problemi, gli affanni, i rumori, il frastuono della vita quotidiana, l’azienda e il mercato, i
cantori che bisogna racimolare con paterna pazienza, amalgamare con duttile sapienza; le
riforme liturgiche, che qualcuno potrebbe adoperare per emarginare il patrimonio musicale
che egli ama; le incomprensioni, le difficoltà, i disagi... “Al di là” c’è la musica, così come
trasognatamente si alza dal suo gesto nelle navate della chiesa e dell’animo.
Ottobre 1993
Musica e musicisti a Brescia
68