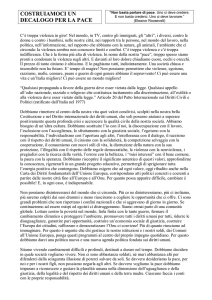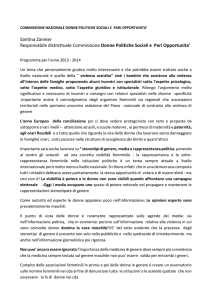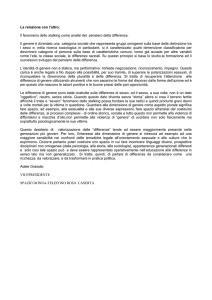Interpretazioni antropologiche della violenza, tra natura e cultura
Fabio Dei
(pubblicato in (in AA.VV., Alle radici delle violenza. Per spiegare l’inumanità dell’uomo, a cura del CIDI della Carnia
e del Gemonese, Udine, Paolo Gaspari editore, 1999, pp. 31-55)
1. Premessa
In questo intervento vorrei discutere il problema della violenza dal punto di vista della disciplina di
studi cui appartengo, l’antropologia culturale. In particolare, mi chiederò quali strumenti
interpretativi l’antropologia possa offrire per comprendere la massiccia presenza della violenza e
della crudeltà nella storia del Novecento.
Il nostro secolo, se da un lato è stato il culmine di quello che Norbert Elias chiama il “processo di
civilizzazione”, ha dall’altro assistito a eventi terribili come stermini, genocidi e altre forme di uso
sistematico della violenza; eventi che hanno avuto nella Shoah il punto di maggior orrore e
visibilità, almeno per l’Europa, ma che di fatto hanno costellato con regolarità l’intero corso del
Novecento e anche gli anni a noi più vicini (basterà pensare ai casi dell’Indonesia, del Vietnam,
della Cambogia, dei Balcani e del Ruanda). Non solo: la cosa più sconcertante è che tali violenze
sono state commesse da persone normali, da “uomini comuni”, per citare il titolo dell’ormai celebre
libro in cui Christopher Browning (1992) ricostruisce la carriera di assassini e massacratori di un
gruppo di tranquilli padri di famiglia amburghesi, trovatisi quasi casualmente coinvolti nelle
strategie naziste della soluzione finale.
Come comprendere questi fenomeni? Vale a dire, come rapportarli a quella che è la nostra idea di
esseri umani razionali e civilizzati? Lo studio dei massacri nazisti, o i racconti della vita nei campi
di sterminio, sembrano suggerirci la presenza - dietro tali eventi - di determinanti profonde e in
certo qual modo nascoste del comportamento umano; determinanti che non sono semplicemente
riconducibili a un contesto storico-sociale e ad una logica della situazione, investendo invece
dimensioni più generali di carattere psicologico, antropologico o persino etologico. Per usare le
efficaci e suggestive parole dello storico Leonardo Paggi, il massacro nazista, in ragione del suo
carattere passionale [...], si configura dunque anche come risultato di una «eredità arcaica», come
collasso dei sistemi di autocoercizione, come emergenza di comportamenti e significati quasi in via
di principio sbrigativamente estromessi dal nostro presente. Si apre qui il terreno di una analisi
antropologica del massacro, ancora tutta da fare, che difficilmente potrà evitare di misurarsi - credo
- con il grande tema dei riti sacrificali di morte, che segnano profondamente, in senso sincronico e
diacronico, tutta la storia della civiltà umana (Paggi 1996: 8)
Paggi non vuol dire semplicemente che i nazisti sono individui regrediti a un comportamento
“primitivo”. Troviamo infatti lo stesso intreccio tra dimensione storica, antropologica e
psicoanalitica studiando il punto di vista delle vittime - ad esempio le reazioni dei superstiti dei
massacri e le modalità della loro elaborazione del lutto, che non sembrano comprensibili senza il
riferimento a configurazioni culturali più ampie, a modelli universali di comportamento. E la
riflessione sui massacri è solo un esempio possibile (per quanto centrale); analoghe considerazioni
possono esser e sono state di fatto svolte a proposito di molti altri fenomeni o eventi della storia
recente. Citerò come particolarmente significative le riflessioni di Primo Levi (1986) sul lager come
società primitiva o regredita, nella quale non solo scompaiono le istituzioni e le regole di
convivenza civili, ma si consolidano con straordinaria rapidità modelli antropologici di tipo
“barbaro” e arcaico; e il recente studio di Gabriele Ranzato (1997) sul linciaggio di un ex
funzionario fascista nella Roma del 1944, che scopre il ripresentarsi di antichi modelli socioculturali in un’esplosione di furore popolare apparentemente cieca e disordinata. Naturalmente non
è qui possibile dar conto della complessità di questo tipo di riflessioni, avanzate peraltro dagli autori
con grande cautela e consapevolezza critica. Il punto che interessa è un altro: ci troviamo in tutti
questi casi di fronte a fatti i cui contorni spazio-temporali sembrano dilatarsi a dismisura di fronte ai
tentativi di comprensione storica e umana del ricercatore, il quale si trova rinviato a dimensioni
assai generali dell’essere dell’uomo nel mondo.
Questo tipo di problema - l’intreccio fra dimensione storica e antropologica - è certamente
ineludibile, ma rischia anche di condurre verso soluzioni semplicistiche e fuorvianti. Esso può
spingerci a ricercare nelle scienze umane (o nell’etologia, o persino nella biologia) delle leggi
generali del comportamento, in grado di fornire quelle spiegazioni che non riusciamo a trovare nella
semplice analisi del contesto storico. “L’uomo è una belva” è il paradigma di questo tipo di
atteggiamento esplicativo: una affermazione (fatta propria da molti teorici, sia pure in formulazioni
complesse e raffinate) che riconduce la violenza, e molti comportamenti che contrastano con una
certa nozione di civiltà, a una presunta essenza naturale degli esseri umani.
Tesi di questo tipo, per quanto siano suggestive e per quanto le si possa difficilmente dir false,
rischiano tuttavia di risultare fuorvianti; sia perché, proprio in virtù della loro estrema generalità,
esse non riescono a spiegare nulla, a dirci cioè cose che già non sappiamo; sia perché possono
sviare la nostra attenzione dal piano delle pratiche umane storicamente situate e dei loro significati.
Vorrei sostenere che l’antropologia culturale, se può portare un contributo alla comprensione di
specifiche pratiche di violenza e crudeltà, può farlo solo a patto di non sottrarsi alla irriducibile
complessità del giudizio storico, in vani tentativi di attribuire a “leggi” universali ciò che è invece
prodotto di pratiche culturali, di motivazioni in senso lato politiche, di strategie sociali. Non è
compito dell’antropologia scoprire essenze che stanno al di là della storia. Come ogni altra
disciplina sociale, essa non può fare a meno di immergersi nei contesti storici e di accettarne tutta la
complessità e la specificità.
Nella comprensione di un fenomeno intensamente etico come la violenza, lo stesso richiamo
all’oggettività della valutazione scientifico-naturalistica può risultare ambiguo: non per caso la
naturalizzazione e l’appello a un fondo di “elementarmente umano” è una delle più diffuse strategie
di giustificazione della violenza da parte di chi ne fa uso, di occultamento dei suoi significati in
senso lato politici (v. Heritier 1997: 18 sgg.).
In altre parole, del tutto indipendentemente dalle basi biologiche e istintuali dell’aggressività
studiate dagli etologi, la violenza che si manifesta nella storia e nella vita sociale non è il contrario
della cultura ma il prodotto di un certo tipo di cultura. Non è uno sfondo naturale del
comportamento umano che si manifesta quando venga meno per un momento la vernice sottile della
civilizzazione. E’ invece un atteggiamento costruito, che si apprende con l’educazione e la
socializzazione, e che sta in stretto rapporto con le forze che regolano la cosciente vita associata
degli esseri umani: il desiderio, il potere, persino la razionalità.
Esporre il punto di vista dell’antropologia culturale, peraltro, è piuttosto difficile, dal momento che
le classiche tradizioni di studio in questa disciplina hanno raramente affrontato il problema della
violenza in modo diretto. Per motivi che non è qui possibile discutere (ma si veda in proposito
Clastres 199 ), gli antropologi hanno spesso rappresentato le società “altre” di cui si sono occupati
come libere dalla guerra e da forme vistose di violenza interpersonale. Occorrerà dunque
accerchiare il problema da prospettive, per così dire, laterali. Dopo alcune ulteriori osservazioni sui
rapporti tra determinanti naturali e determinanti culturali della violenza, passerò schematicamente in
rassegna due punti di vista che l’antropologia e le scienze umane hanno sviluppato a proposito del
comportamento violento. In primo luogo, gli studi sulle istituzioni e le pratiche culturali volte al
controllo sociale della violenza; in secondo luogo, il tema della violenza come fondazione della
civiltà. Tornerò infine sulle peculiarità di un possibile approccio antropologico a questo tipo di
problemi. Vorrei sottolineare come si tratti non di una trattazione sistematica ma di una pista di
lavoro, volta semplicemente a sollecitare successivi approfondimenti e affinamenti della riflessione.
2. Violenza tra natura e cultura.
La risposta alla domanda «perché gli uomini sono violenti?», almeno in un certo senso, è molto
semplice e scontata. Ovviamente, aggressività e violenza fanno parte della dotazione biologica e
istintuale del genere umano. Noi sentiamo il bisogno di «spiegare» il comportamento violento
perché lo vediamo come una contraddizione in relazione ai valori della cultura - di quella cultura su
cui si basa la nostra identità di esseri umani. Ma dobbiamo considerare che l’evoluzione culturale ha
avuto ed ha tempi assai più rapidi di quella biologica; cosicché, siamo in presenza di uno scarto fra
la costituzione zoologica dell’uomo e la sua cultura - intendendo qui con cultura, naturalmente,
l’insieme delle pratiche, delle idee, degli strumenti, delle istituzioni e di tutti gli elementi non
biologici attraverso i quali una comunità umana si adatta al mondo.
Scrive l’etnologo francese A.Leroi-Gourhan, in Il gesto e la parola :
L’homo sapiens è nato al tempo delle steppe per la caccia al cavallo selvatico e si è adattato
progressivamente alla locomozione seduta, in un’atmosfera di petrolio bruciato [...]. Tutta l’ascesa
delle civiltà si è realizzata con quello stesso uomo fisico e intellettuale che faceva la posta al
mammuth; la nostra cultura elettronica, che ha appena 50 anni, si regge su un apparato fisiologico
che risale invece a 40000 anni fa. Se c’è motivo di aver fiducia nelle possibilità di adattamento,
tuttavia la distorsione esiste ed è evidente la contraddizione fra una civiltà dai poteri quasi illimitati
e un civilizzatore la cui aggressività è rimasta immutata dal tempo in cui uccidere la renna
significava sopravvivere (Leroi-Gourhan 1964-5: 464)
Sembrerebbe dunque di poter considerare la violenza e l’aggressività come limiti della civiltà retaggi di una costituzione naturale che la cultura non è riuscita ancora a modificare o soffocare, e
che riemerge, per così dire, negli interstizi della civiltà.
Ma questa sarebbe una concezione semplicistica: perché in realtà gli aspetti naturali e quelli
culturali dell’evoluzione, come ha mostrato lo stesso Leroi-Gourhan, non si sono semplicemente
contrapposti gli uni agli altri, ma si sono compenetrati. In particolare, è caratteristica peculiare della
cultura, intesa in senso antropologico, la capacità di plasmare la «dotazione naturale» degli esseri
umani - in modo tale che è difficile parlare di una pura base naturale del comportamento. Ciò che
noi consideriamo «naturale» ha spesso il carattere di una seconda natura. O, per dire la stessa cosa
in termini un po’ diversi, è all’interno di un insieme di condizioni culturali che si determina il
concetto stesso di natura - cioè, ogni cultura definisce al proprio interno la linea di demarcazione tra
ciò che è naturale e ciò che è culturale. Questa demarcazione è dunque culturalmente plasmata.
Possiamo forse capire meglio questo punto pensando al concetto di paesaggio naturale. Noi
consideriamo come natura boschi o campagne che in realtà sono profondamente modificati
dall’intervento umano, spesso persino costruiti, e sono dunque in senso stretto paesaggi culturali.
Nondimeno, noi giustamente li contrapponiamo oggi ai paesaggi urbani, cementificati, etc. - e
usiamo le categorie di naturale e artificiale per dar senso a questa contrapposizione, che è parte
importante e cardine della nostra visione del mondo. Si può criticare questo punto di vista in quanto
arbitrario, ma non avrebbe molto senso appellarsi a una natura più pura e autentica, che per noi non
può esistere. Anche le politiche del “rinselvatichimento” e della regressione radicale all’animalità,
come sono teorizzate ad esempio da alcune frange del pensiero ambientalista, sono scelte
profondamente culturali.
Per usare un’altra metafora, possiamo immaginarci la cultura come il software per il cui tramite
dialoghiamo col mondo: un programma o un sistema operativo che ha alle spalle un hardware, il
quale pone limiti oggettivi (la capacità di memoria, la velocità del processore etc.). Ma dalle
caratteristiche dell’hardware non si può inferire molto delle caratteristiche del software. E in ogni
caso, trovandoci all’interno del programma, non possiamo sfuggirgli appellandoci per così dire a un
dialogo diretto con la macchina che lo fa girare. Inoltre, ci troveremmo di fronte ad un software
molto particolare, in grado, in tempi lunghi, di modificare le stesse caratteristiche dell’hardware che
lo sostiene, potenziando magari il processore, aggiungendo o eliminando alcune periferiche etc.
Tutto questo per sottolineare che la violenza e l’aggressività, per quanto indubbiamente radicate
nella costituzione biologica ed etologica dell’uomo, si manifestano nel comportamento umano,
all’interno di determinate civiltà e società, in modi culturalmente e storicamente plasmati. E’ questo
un punto essenziale per la nostra riflessione. Il senso comune può oggi farci considerare la violenza
come un residuo - ciò che resta quando si cancelli o si azzeri momentaneamente la cultura, la «belva
dentro di noi» che talvolta riemerge alla superficie. In realtà, ciò che noi oggi consideriamo
violenza è frutto di un processo storico molto preciso e anche molto recente, di una ridefinizione
continua della linea di demarcazione tra natura e cultura.
Per riflettere su questo punto è essenziale riferirsi ai lavori di Norbert Elias, che ricostruiscono la
storia dell’Occidente nei termini di un continuo processo di spostamento della linea che demarca i
comportamenti accettati da quelli non accettati, quelli normali da quelli abnormi, e che in sostanza
accentua progressivamente gli elementi di controllo sui sentimenti, le emozioni, le scariche
pulsionali e i contatti fisici diretti tra gli esseri umani. Secondo Elias, attraverso le diverse epoche
storiche si sono formate barriere sia istituzionali che psicologiche contro la manifestazione
immediata dei sentimenti, contro i contatti fisici che non rientrino in sfere ben determinate come
quella della sessualità, dello sport o di rituali sociali estremamente controllati (il bacio, la stretta di
mano, etc.); ed è cambiato molto l’atteggiamento nei confronti della violenza. In un volume tradotto
in italiano col titolo La civiltà delle buone maniere, Elias confronta ad esempio le manifestazioni
dell’aggressività nelle moderne società occidentali con quelle che caratterizzavano il Medioevo.
Nelle prime, l’aggressività risulta fortemente controllata e attenuata, persino in contesti come la
guerra:
essa è stata condizionata, pur nel mezzo dell’azione bellica, dalla più avanzata divisione delle
funzioni, dal più accentuato legame tra i singoli individui, dalla maggiore dipendenza degli uni
dagli altri e di tutti dall’apparato tecnico; è stata limitata e smussata da un’infinità di regole e divieti
che sono diventati auto-costrizioni (dunque sono stati interiorizzati). Si è pertanto trasformata,
raffinata e civilizzata come tutte le altre forme di piacere; e soltanto nel sogno o in singole
esplosioni, che registriamo come fenomeni patologici, si riaffaccia in parte con la sua forza
immediata e scatenata (Elias 1988: 346).
Per il Medioevo, al contrario, Elias documenta il piacere di uccidere e torturare come
manifestazione di potere, e la presenza dei valori della violenza nel codice cavalleresco, che noi
associamo di solito a valori di altro tipo. E traccia un profilo psicologico dell’uomo medioevale
come dominato da sentimenti contrastanti ma fortissimi, da esplosioni improvvise di gioia e
allegria, dalla facilità di infiammarsi in reazioni di odio e aggressività:
Gli impulsi, le emozioni si manifestavano in modo più libero, più scoperto e più diretto di quanto
sarebbe avvenuto in seguito. Siamo soltanto noi, divenuti più moderati, più misurati e più
calcolatori, noi che nella nostra economia pulsionale abbiamo interiorizzato in misura assai
maggiore come auto-costrizioni i tabù sociali, a considerare contraddittoria - ad esempio - la grande
devozione religiosa e le manifestazioni di aggressività e di assoluta crudeltà. Nella società
medioevale, chi non sapeva amare o odiare con tutte le sue forze era destinato all’emarginazione
sociale: così come, in società successive (p.es nella vita di corte delle grandi monarchie), vi sarà
destinato chi non sarà in grado di dominare le sue passioni e celare i suoi affetti, dimostrandosi così
«civile» (Ibid.: 358).
Questi mutamenti sono legati per Elias all’affermarsi di un potere centrale (virtualmente assente nel
Medioevo) che assume il monopolio della violenza e della sopraffazione fisica, non consentendo
più ai singoli individui di esercitarla (salvo a poche persone delegate a tal scopo, come il boia, il
poliziotto, il soldato; o salvo situazioni controllate come i rituali e lo sport; ma anche nei rituali e
nello sport si assiste a un processo di progressiva civilizzazione o «sublimazione», in cui la violenza
è simbolizzata più che realmente agita).
Violenza è dunque di per sé una categoria astratta: vi sono comportamenti violenti e concezioni di
ciò che è violenza che mutano socialmente e storicamente. Ciò che è normale oppure patologico e
deviante, ciò che ha bisogno o meno di una spiegazione, cambia a seconda dei concreti contesti
culturali. Ma allora, quello che può sembrare l’insorgere di una violenza incontrollata e naturale, è
spesso di fatto un comportamento governato da regole culturalmente e socialmente approvate.
Vorrei precisare che questo punto di vista non equivale affatto all’affermazione di un assoluto
relativismo culturale. E’ del tutto evidente, come già detto, che le scelte culturali hanno luogo
all’interno di limiti stabiliti dalla “natura”, e che possono esser descritti ad esempio in termini
biologici, etologici o psicologici. Ma occorre distinguere tra tipi diversi di problemi. Una cosa è il
problema delle cause o dell’origine dell’aggressività umana, che non può esser risolto senza il
riferimento alle caratteristiche zoologiche ed etologiche della specie homo sapiens; altra cosa è il
problema della comprensione del significato di pratiche violente all’interno di specifici contesti
storici e culturali, rispetto al quale la spiegazione naturalistica è quasi sempre di per sé irrilevante.
3. Il controllo sociale della violenza.
Ora, l’antropologia culturale è interessata per l’appunto al modo in cui gli istinti, le pulsioni, la
dotazione biologica dell’uomo è plasmata all’interno di ogni singola cultura. Per la verità, come ho
già detto, la violenza non è mai stato un soggetto centrale e cruciale nei dibattiti antopologici: sia
nel senso che raramente si è trovata al centro di grandi elaborazioni teoriche (con almeno
un’eccezione importante, su cui tornerò), sia nel senso che pochi contributi etnografici si sono
soffermati a fondo sul problema delle diverse sensibilità alla violenza e dei diversi codici di
manifestazione dell’aggressività presenti in specifiche culture (per delle recenti eccezioni si vedano
i saggi raccolti in Riches 1986 ed Heritier 1997). Tuttavia, questi problemi sono spesso implicati
nelle discussioni sui sistemi sociali e politici, sulla struttura dell’ethos o dei valori, sui rituali e sulla
religione.
In modo particolare, l’attenzione degli antropologi si è appuntato sulle modalità del controllo
sociale della violenza. L’antropologia sociale e politica classica è partita spesso dal presupposto
hobbesiano di un originario homo homini lupus: la società e le sue istituzioni, per esistere, hanno
bisogno che sia ridotto e controllato il potenziale di aggressività e violenza che ciascun individuo
porta dentro di sé, in virtù della sua costituzione biologica. Gli animali, come ci insegna l’etologia,
possiedono meccanismi di controllo e ritualizzazione degli istinti aggressivi verso i loro simili,
senza i quali sarebbe messa in pericolo forse la stessa sopravvivenza della specie, e in ogni caso la
vita sociale, l’unità del branco etc. L’uomo sembra non possedere in modo naturale simili impulsi
inibitori: dev’esser dunque la società, tramite le sue istituzioni, a fornirli. Si deve trattare di
istituzioni che consentono all’individuo di «scaricare» le sue pulsioni aggressive, incanalandole
però in direzioni che non danneggino l’ordine e la stabilità della società stessa.
Queste istituzioni potrebbero esser classificate a seconda della loro prossimità alla violenza fisica
vera e propria. Ad esempio, all’estremo più violento sta probabilmente l’istituzione della cosiddetta
«faida di sangue», presente in modo più o meno formalizzato tra molti popoli di agricoltori e
allevatori, in particolare quelli con una struttura sociale segmentaria. La faida consiste - almeno in
apparenza - nel diritto-dovere di vendicare una uccisione attraverso un’altra uccisione, secondo il
principio della legge del taglione. In realtà si tratta di una istituzione molto complessa, tipica di
società in cui manca un potere giudiziario centrale, e che stabilisce regole per la risoluzione dei
conflitti tra lignaggi che sono aperti da un omicidio. In sostanza, la tradizione accetta che i membri
di un lignaggio (gruppo di parentela) cerchino di vendicare la morte di uno di loro uccidendo
l’assassino o un membro del lignaggio dell’assassino: la seconda uccisione ristabilirebbe un
equilibrio sociale che era stato infranto dalla prima. Ma, di fatto, la vendetta non ristabilisce mai
l’equilibrio: il gruppo che la subisce tende a interpretarla come un’offesa ulteriormente squilibrante
che deve a sua volta esser vendicata, e così via - potenzialmente ad infinitum. L’istituzione della
faida consiste allora nell’apertura di una serie di trattative e contrattazioni tra i due lignaggi rivali,
con lo scopo di risolvere il «debito» possibilmente senza spargimento ulteriore di sangue, e
comunque evitando il dilagare a macchia d’olio del conflitto.
La più classica descrizione del sistema è quella contenuta in una famosa monografia etnografica
dell’inglese E.E.Evans-Pritchard, a proposito della popolazione nilotica dei Nuer (1940 ). Tra di
essi esiste una figura politica specifica, il cosiddetto «capo dalla pelle di leopardo», che non ha un
potere reale ma svolge il delicato compito di mediare nelle faide, convincendo ad esempio la parte
lesa ad accettare un compenso di tipo economico, o comunque un qualche compromesso che ponga
fine definitivamente e senza strascichi alla disputa. A noi occidentali moderni questa sembra una
strana forma di giustizia. In realtà non si tratta affatto della punizione di un crimine, come noi la
intendiamo, ma di un riequilibrio tra due segmenti sociali, che è stato rotto dal primo atto di
violenza e che dev’essere in qualche modo ripristinato. Se non si ripristina l’equilibrio, il principio
della vendetta potrebbe dilagare fino ad investire l’intera comunità.
Questo ci sembra strano, perché siamo abituati alla gestione delle sanzioni da parte del potere
centrale, e al fatto che un assassinio è un crimine eminentemente pubblico, anche se lede interessi
privati. Ma a molti popoli africani questi concezione della giustizia è estranea: a loro è sembrato
molto strano, al contrario, vedere gli amministratori coloniali imprigionare ed eventualmente
giustiziare un omicida, senza preoccuparsi del compenso da dare al gruppo che ha perso un
membro. Questa è una punizione che non risolve il problema dell’equilibrio; laddove un compenso
o persino una vendetta omicida, che non colpisca però l’autore del primo delitto, è considerata
perfettamente soddisfacente. In alcune società, come i Berberi del Nordafrica, un rigoroso principio
di equivalenza stabiliva che la faida dovesse colpire una persona dello stesso rango sociale di quella
uccisa. Cosicché, se un uomo di un gruppo uccide una donna di un altro gruppo, la vendetta si
appunterà su una donna del gruppo dell’assassino, non sull’uomo colpevole (Beattie 1964: 246. In
questa ricerca di equilibrio conta il danno subito dal soggetto-gruppo, non dall’individuo come
soggetto di diritti; inoltre, non si fa nessuna distinzione tra omicidio volontario e involontario,
premeditato o colposo.
La faida di sangue è solo un esempio. Vi sono molte altre istituzioni di regolazione della violenza
che non la vietano ma si limitano a circoscriverla. Anche la storia occidentale ne conosce: basti
pensare al duello. Fra le istituzioni che più si allontanano dall’esercizio reale della violenza per
proporne una rappresentazione ritualizzata, che può però produrre effetti catartici, si può citare lo
sport. Lo stesso Elias considera lo sport moderno come una sorta di sublimazione degli istinti
aggressivi e conflittuali, che si afferma con il procedere del processo di civilizzazione - e dunque
con l’aumento dell’autocontrollo e delle inibizioni alla diretta manifestazione degli impulsi violenti.
Questo processo di controllo della violenza è sicuramente centrale nella genesi dello sport moderno;
ma riconoscere questo non vuol dire accreditare la tesi che lo sport è semplicemente una valvola di
sfogo per la «belva che è in noi». Le cose sono molto più complesse. Come chiave di comprensione
del tifo calcistico, la tesi della scarica pulsionale è assai semplicistica e banale. Il calcio è un
universo simbolico nei cui termini i tifosi possono esprimere aspetti della loro identità e relazionarsi
agli altri in modi non consentiti nella normale vita quotidiana - modi che implicano e legittimano
anche una certa dose di aggressività e violenza. Ma non c’è motivo di dire che il calcio è
socialmente utile perché scarica violenza e incanala i conflitti in direzioni sostanzialmente innocue:
potremmo altrettanto bene affermare che crea nuovi conflitti e nuove occasioni di violenza (si
vedano in proposito Dal Lago 1990, Roversi 1992 e, per una sintesi del dibattito, Dei 1992).
Tornando alla tradizione classica degli studi antropologici, l’istituzione di controllo della
conflittualità che più ha attratto il loro interesse è probabilmente la stregoneria. La stregoneria è un
insieme di credenze e pratiche sociali largamente diffuso in molte culture tradizionali di tutto il
mondo, e che come ben sappiamo ha svolto un ruolo di primo piano nella stessa storia della civiltà
occidentale. Possiamo definirla, sul piano delle rappresentazioni, come la credenza nel potere di
alcuni individui di nuocere ad altri per mezzo di poteri magici. Questi poteri, posseduti come dote
naturale o appresi attraverso un apprendistato magico, risultano in attacchi violenti di tipo personale
in grado di produrre fallimenti nella vita economica e sociale, disgrazie, malattie, morte. Sul piano
delle pratiche sociali, la stregoneria consiste in un sistema di accuse: in altre parole, essa si
manifesta socialmente quando qualcuno viene accusato di praticarla e di aver provocato tramite essa
danni particolari a particolari persone. Queste accuse seguono invariabilmente i canali dell’invidia
e della conflittualità sociale, manifestandosi ad esempio nei rapporti di vicinato, in quelli di
concorrenza economica, e così via.
In apparenza, l’insorgere delle accuse di stregoneria provoca liti e conflitti che non avrebbero di per
sé ragione di essere: a uno sguardo superficiale, ci troviamo di fronte a credenze superstiziose che
minacciano arbitrariamente rapporti sociali i quali, senza di esse, si manterrebbero tranquilli e
pacifici. In realtà, l’opinione prevalente tra gli studiosi è che la stregoneria rappresenti proprio un
sistema di risoluzione della conflittualità interna a un gruppo sociale, che ne consente l’espressione
ma permette al tempo stesso di “scaricarla” e neutralizzarne gli effetti disgreganti attraverso
comportamenti socialmente riconosciuti e legittimati. E’ ancora una volta all’opera di EvansPritchard che possiamo rivolgerci in cerca di esempi: il suo studio pionieristico sulla popolazione
africana degli Azande (1937) costituisce la più classica formulazione di questa tesi, oltre che una
insuperata rappresentazione etnografica delle credenze nella stregoneria e delle relative pratiche
divinatorie.
La tesi di Evans-Pritchard è che tali credenze siano al contempo un modo intellettualmente
soddisfacente di spiegare la sfortuna e di dare un senso all’insorgere del male, da un lato, e
dall’altro un modo di esprimere i sentimenti più negativi e distruttivi legati alla vita sociale (i timori
e le ansie, così come l’odio e le tendenze aggressive). Il linguaggio della stregoneria consentirebbe
di dare un ordine e un significato a esperienze oscure e a pulsioni disgreganti, per le quali non vi
sarebbe altrimenti alcun orizzonte di risoluzione. Non sono le rappresentazioni magiche, di per sé, a
creare conflitti: esse vanno per così dire a riempire canali conflittuali già presenti, almeno
potenzialmente, plasmandoli in modo da esser socialmente riconosciuti e, se possibile, risolti e
superati. Le pratiche divinatorie che gli Azande seguono per scoprire la presenza della stregoneria, e
per accusare qualcuno di averla esercitata (volontariamente o anche solo involontariamente),
permettono che il conflitto si manifesti apertamente senza sfociare nella violenza aperta e diretta, e
lasciano sempre aperte modalità di risoluzione contrattata e pacifica.
Su un piano un po’ diverso, si potrebbero citare molte altre istituzioni che hanno, almeno in
apparenza, una funzione catartica o di «valvola di sfogo». Tra di esse:
- le feste annuali, di cui il caso più noto è forse quello dei Saturnali romani, nelle quali si sprigiona
la carica di aggressività e di furore distruttivo che è stata repressa nel corso di un intero anno secondo il principio semel in anno licet insanire. Il Carnevale e il Capodanno moderni conservano
qualcosa di queste feste antiche o tradizionali - con la caduta dei freni inibitori, delle regole di
convenienza sociale, degli stutus socialmente acquisiti, e con i rituali di inversione sociale e
sessuale, etc.
- Il cordoglio in occasione del lutto. In molte culture i rituali funerari implicano manifestazioni di
violenza e furore, fino a giungere al cannibalismo rituale, alla licenziosità sessuale, a manifestazioni
agonistiche (si pensi ai funerali di Patroclo nell’Iliade, o all’istituzione del pianto rituale in molte
culture popolari dell’Europa meridionale; v. De Martino 1958 per uno studio classico di questi
fenomeni);
- i riti di iniziazione, attraverso i quali in molte società arcaiche si media ritualmente l’ingresso di
un giovane nel mondo adulto. Essi implicano spesso una decostruzione della personalità sociale del
giovane, che per così dire deve rinselvatichire prima di diventare uomo a tutti gli effetti: per cui,
durante i riti iniziatici, si incoraggia l’esplosione del furore distruttivo, con comportamenti da
animale da preda, attacchi indiscriminati rivolti contro tutti e così via (per un’analisi recente v.
Bloch 1997).
Questi sono tutti esempi di comportamenti violenti accettati e persino incoraggiati e codificati dalla
società e dalla cultura. Possiamo pensare a tali istituzioni come a recinti protetti in cui la naturale
aggressività degli individui può manifestarsi liberamente, senza mettere in pericolo il tessuto delle
relazioni sociali. O forse, più produttivamente, possiamo pensarle come modi di plasmazione
culturale dell’aggressività, in cui la violenza funziona da materiale significante nell’espressione di
codici, valori, status sociali.
Ora, possiamo chiederci, questi esempi tipici di società tradizionali ci dicono qualcosa sulle
manifestazioni della violenza nella società occidentale contemporanea? Già all’inizio degli anni ’60
Ernesto De Martino, uno dei padri fondatori degli studi antropologici italiani, esplorava
l’accostamento tra fenomeni come i riti di iniziazione o le feste di rovesciamento simbolico e le
pratiche violente eminentemente moderne che cominciavano allora a intravedersi nella subcultura
giovanile - l’azione delle bande di teppisti, le esplosioni di furore di gruppo etc. Egli notava però
come in tutti i fenomeni tradizionali l’esplosione del furore sia seguita, in modo rigidamente
codificato, da un superamento, da quella che lui chiamava una reintegrazione dell’ordine culturale.
L’apparente infrazione delle regole serviva in definitiva a ripristinarle con maggior forza; laddove
nei fenomeni del teppismo giovanile contemporaneo questo momento di reintegrazione sembra
mancare, e le manifestazioni di violenza sembrano seguire semplicemente la direttrice anti-sociale e
anti-culturale per eccellenza del freudiano istinto di morte.
L'accostamento proposto da De Martino (1962) fra riti di iniziazione, Saturnali e teppismo giovanile
è molto interessante e meriterebbe di esser ripreso, anche a proposito degli innumerevoli episodi
che la cronaca non manca quotidianamente di segnalarci: è un approccio interessante e correttivo
rispetto a certe semplificazioni e letture psicologiche che di questi fatti ci vengono proposte. Si
pensi a quanto ha circolato lo slogan delle «teste vuote» a proposito dei lanciatori di sassi sulle
autostrade, o degli incidenti in auto dopo la discoteca e così via. Nella prospettiva che ci propone
De Martino quelle teste sono piene, fin troppo piene, per così dire, perché riproducono valori e
schemi comportamentali che sono profondamente radicati nella cultura tradizionale (naturalmente,
una tale osservazione non mira in alcun modo a giustificare quei comportamenti, bensì a
comprenderli sulla base di un codice culturale piuttosto che su un presupposto di imbecillità). Mi
pare semmai dubbio attribuire un carattere totalmente asociale alla violenza delle bande giovanili,
dei frequentatori delle discoteche o dei tifosi del calcio. Forse il problema è che non riusciamo a
capire i nuovi codici attraverso cui la cultura giovanile si esprime, e le particolari modalità di
reintegrazione che in essi operano; non vi è reintegrazione possibile solo in quei casi in cui il furore
distruttivo o autodistruttivo assume forme irreversibili, come nella tossicodipendenza.
4. La violenza come fondazione della società.
Molti studi antropologici mettono dunque l’accento sulle forme di controllo sociale della violenza,
elaborando varianti della teoria politica hobbesiana: è come se gli impulsi aggressivi e violenti
fossero un ingombrante fardello che gli individui si portano dietro, e che è compito delle istituzioni
comunitarie e della cultura condivisa smussare, attenuare e neutralizzare. Come a dire che violenti
sono gli individui, per una sorta di imperfezione costituzionale, ma non le società. Vi sono però
anche altri punti di vista, per certi versi contrapposti, secondo i quali la società e la cultura non sono
così innocenti, e fondano anzi la loro presa sugli individui proprio sulla gestione della violenza.
Vorrei brevemente discutere tre autori, peraltro molto noti, che esemplificano con efficacia questa
prospettiva: Frazer, Freud e Girard. Per tutti e tre questi pensatori la civiltà contemporanea, fondata
sulla rimozione della violenza fisica, è una crosta sottile che nasconde una ben più profonda
costituzione selvaggia: non solo nel senso che gli individui sono in ultima analisi delle belve, che
l’uomo è ancora quello che faceva la posta al mammuth, come dice Leroi-Gourhan, ma nel senso
che le stesse istituzioni civili si fondano su un atto originario di violenza, senza il quale non
sarebbero possibili. E che in fin dei conti, dunque, la violenza è la «verità» della società civilizzata,
che le istituzioni moderne cercano di nascondere ma che riemerge negli interstizi della civiltà.
James G. Frazer è uno dei più famosi antropologi della scuola evoluzionista britannica; studioso di
formazione e di stampo ottocentesco, è tuttavia autore di uno dei libri che ha più influenzato la
cultura del ventesimo secolo e in particolare i movimenti modernisti, Il ramo d’oro. Si tratta di uno
studio monumentale sulle credenze e pratiche magiche e religiose diffuse tra i popoli che allora si
dicevano primitivi o selvaggi, nonché nelle culture classiche e nel folklore rurale europeo. Per
quanto pensato come trattato scientifico, Il ramo d’oro è costruito narrativamente come tentativo di
spiegare una istituzione culturale documentata da alcuni autori classici: la regola di successione
tramite duello del “re del bosco”, custode del tempio di Diana presso il lago di Nemi. Chi sfida e
uccide in duello il re del bosco gli subentra nella carica, finché non sarà a sua volta sfidato e ucciso
da qualcuno più giovane e più forte di lui. Frazer ritiene che questa cruenta regola di successione sia
volta a garantire il rinnovamento del ruolo di re o sacerdote al momento del declino della forza
fisica della persona che lo ricopre. Ciò lo porta alla scoperta di un tratto culturale caratterizzante, a
suo parere, l’intero mondo antico, le culture «primitive» e tutte le civiltà agricole: il tema mitico di
un dio, rappresentante della vegetazione, che muore e risorge, a simboleggiare la decadenza e la
rinascita del mondo vegetale e dunque delle risorse alimentari. A ciò è connessa la pratica di
uccidere ritualmente rappresentanti umani dello spirito della vegetazione, al fine di promuovere
magicamente la crescita del raccolto, e molte analoghe pratiche che hanno comunque tutte al centro
il sacrificio umano perpetrato per il benessere dell’intera comunità.
Il Ramo d’oro ha una struttura estremamente complessa, che non è qui il caso di tentare di
sintetizzare (mi permetto di rimandare a Dei 1998 per un’analisi più approfondita). Il suo filo
conduttore esplicito sono le credenze magiche e religiose, presentate come superstizioni basate su
errori intellettivi; ma il tema che domina in modo ossessivo il libro è quello del sacrificio umano,
sia che ad esser ucciso sia un re divino al declino della sua gioventù, come in alcune tradizioni
africane; oppure uno straniero che si trova a passare per i campi al momento del raccolto del grano,
come nelle tradizioni del Mediterraneo antico e nel mito greco di Litierse; un capro espiatorio, su
cui sono riversati i peccati accumulati dall’intera comunità; una ragazza addestrata e preparata,
come nei sacrifici aztechi - e così via. Il benessere della comunità si fonda su questi atti di violenza
subiti da singoli individui. E, ciò che più conta in Frazer, la cultura attuale porta il segno di questa
violenza originaria, appena sotto la superficie di innocenza e civiltà.
A leggere Frazer, si è colpiti dal fatto che moltissimi elementi della nostra cultura vengono
risemantizzati, per così dire, e rivelano sinistre e inquietanti profondità. Le feste contadine, i giochi
dei bambini, alcuni innocenti modi di dire, ci appaiono come sopravvivenze di antiche pratiche
sacrificali, nelle quali era in gioco la morte di un uomo per il bene dell’intera società. E per quanto
Frazer sia un pensatore vigorosamente razionalista e un convinto sostenitore del progresso
scientifico, la sua opera è intessuta di metafore che mostrano la debolezza e la fragilità del proceso
di civilizzazione. Quest’ultimo è rappresentato come la superficie del mare in continuo movimento,
sotto la quale si estende l’immota profondità degli abissi; come una striscia sottile di terra sotto la
quale romba un vulcano; o come un pallido cerchio di luce circondato dalle tenebre della notte. Il
vulcano, le tenebre, gli abissi sono le strutture invarianti del pensiero magico-religioso e delle
connesse pratiche di sacrificio cruento: dalla lettura del Ramo d’oro, esse appaiono come una sorta
di essenza originaria e autentica della cultura umana, che nessun progresso e nessuna scienza
riescono in definitiva a scalfire, e che anzi si ripresentano nelle modernità sotto nuove vesti. Sarà
questa idea di una essenza selvaggia che informa la stessa civiltà moderna ad affascinare il pensiero
e la letteratura modernista, che coniugherà spesso in questa chiave l’antropologia frazeriana con la
psicoanalisi.
Freud è naturalmente un autore essenziale per il problema della violenza, prima di tutto in relazione
alla nozione di pulsione di morte, cui gli stessi storici hanno talvolta fatto ricorso di fronte allo
“scandalo” dei massacri e dei genocidi. Qui interessa per la parte più propriamente antropologica
del suo lavoro, quella di Totem e tabù, dove ci racconta una specie di mito su una violenza
originaria che dei figli archetipici, per così dire, avrebbero commesso su un padre archetipico, e che
avrebbe dato origine alla religione e alla civiltà stessa. Il mito è questo (costruito a partire da varie
fonti antropologiche ma assolutamente fantasioso).
[Nell'orda primitiva] vi è solo un padre prepotente, geloso, che tiene per sé tutte le femmine e
scaccia i figli via via che crescono. Un certo giorno i fratelli scacciati si riunirono, abbatterono il
padre e lo divorarono, ponendo fine così all'orda paterna [...] Che essi abbiano anche divorato il
padre ucciso, è cosa ovvia trattandosi di selvaggi cannibali. Il progenitore violento era stato senza
dubbio il modello invidiato e temuto da ciascun membro della schiera dei fratelli. A questo punto
essi realizzarono, divorandolo, l'identificazione con il padre, ognuno si appropriò di una parte della
sua forza. Il pasto totemico, forse la prima festa dell'umanità, sarebbe la ripetizione e la
commemorazione di questa memoranda azione criminosa, che segnò l'inizio di tante cose: le
organizzazioni sociali, le restrizioni morali e la religione (Freud 1913: 193-4).
Dopo il parricidio, nessuno dei fratelli può prendere il posto del padre, perché ciascuno lo
impedisce all'altro. La loro vita psichica, caratterizzata dall'ambivalenza (come nel caso dei
bambini e dei nevrotici, non manca di ricordarci Freud), è invasa dal rimorso e dal senso di colpa.
Quelli che erano stati i divieti imposti dal padre, i fratelli li interiorizzano sotto forma di coscienza
morale, fondando nientemeno che la società, l'etica e la religione:
Morto, il padre divenne più forte di quanto fosse stato da vivo [...] Ciò che prima egli aveva
impedito con la sua esistenza, i figli se lo proibirono ora spontaneamente nella situazione psichica
dell'«obbedienza retrospettiva», che conosciamo così bene attraverso la psicoanalisi. Revocarono il
loro atto dichiarando proibita l'uccisione del sostituto paterno, il totem, e rinunciarono ai suoi frutti,
interdicendosi le donne che erano diventate disponibili. In questo modo, prendendo le mosse dalla
coscienza di colpa del figlio, crearono i due tabù fondamentali del totemismo, che proprio perciò
dovevano coincidere con i due desideri rimossi del complesso edipico (Ibid.: 195; corsivo
nell'originale).
Questa la storia raccontata da Freud. La «coscienza di colpa del figlio», come la definisce, è per lui
il fondamento psicologico di tutte le religioni successive; così come la figura del padre, per il
tramite del totem, è la base di ogni concezione di Dio.
Non ci interessa tanto, in questo mito, la spiegazione di istituti culturali quali il totemismo e
l’esogamia, quanto il fatto che Freud faccia derivare dalla violenza bruta del parricidio primordiale
le principali funzioni sociali: la struttura sociale, il cui nucleo risiede nelle regole esogamiche; la
religione, di cui il totemismo rappresenta appunto il nucleo; e l’etica, l’interiorizzazione dei divieti,
che in definitiva è la condizione di quello che Elias chiama il processo di civilizzazione.
Di più : per Freud, la storia del parricidio primordiale, che egli presenta come punto nodale
dell’evoluzione culturale, si ripresenta in qualche modo sul piano ontogenetico, nell’evoluzione
psicologica di ciascun individuo (perlomeno degli individui maschi, perché com’è noto la
psicologia freudiana è modellata su una soggettività di genere maschile, anche se molte delle sue
pazienti erano donne). Il tema del parricidio primordiale è cioè il nucleo del complesso edipico,
anche se si tratta naturalmente di un parricidio immaginato e rappresentato. Cosicché, in definitiva,
il desiderio e la violenza originaria stanno alla base della costituzione psicologica di ciascuno di noi
- sono la «verità» che si nasconde dietro gli istituti civili della religione, della famiglia, della
morale.
Il francese René Girard è autore molto più recente di Frazer e Freud. Ha raggiunto una certa
celebrità negli anni ’70, con un libro dal titolo La violenza e il sacro. Per quanto ci riguarda, è
autore importante perché è di fatto l’unico antropologo (anche se sulla sua definizione come
antropologo si potrebbe discutere) che tematizza in modo diretto la violenza, ponendola al centro di
un affresco teorico affascinante seppur altamente speculativo. Girard rilegge Frazer e Freud, è
colpito dalle loro storie che pongono la morte violenta all’origine della società; tuttavia, rifiuta le
rispettive teorie che legano la violenza originaria alla magia, per Frazer, e all’ambivalenza della
situazione edipica per Freud. Dal suo punto di vista, è la pratica del sacrificio l’atto cruento su cui si
fonda la società civile. Il sacrificio, atto violento, è per lui tuttavia l’unico argine che la società
riesce a porre al dilagare incontrollato di una violenza disgregante e distruttrice.
Secondo Girard, il rischio radicale che ogni società umana si trova a dover fronteggiare, fin dalle
origini, è quello della disgregazione sotto la spinta dell’aggressività reciproca degli individui, che si
espanderebbe come un contagio sulla base di quel principio basilare che è la vendetta. La faida di
sangue, discussa prima, è il punto di partenza della stessa riflessione di Girard (anche se la sua
interpretazione di questo istituto non è probabilmente molto corretta sul piano etnologico): la faida
di sangue allude ad una catena di vendette (secondo il principio per cui un atto di violenza chiede
una risposta riequilibratrice) che giungerebbe a investire da ultimo l’intero corpo sociale. A questo
rischio Girard dà il nome di violenza essenziale: una società primitiva, una società che non
possiede alcun sistema giudiziario, è esposta [...] alla escalation della vendetta, all’annullamento
puro e semplice cui d’ora in poi daremo il nome di violenza essenziale: si vede perciò costretta ad
adottare nei confronti di questa violenza certi atteggiamenti per noi incomprensibili. Se non
riusciamo a capire è perché noi non sappiamo assolutamente nulla della violenza essenziale,
nemmeno che esista, e perché gli stessi popoli primitivi conoscono tale violenza solo in forma quasi
del tutto disumanizzata, ossia sotto le parvenze parzialmente ingannevoli del sacro (Girard 1972:
51).
La risposta della cultura alla propagazione indefinita della violenza consiste nel compiere un atto di
violenza che non crei squilibri nel corpo sociale e che non richieda dunque ulteriori passi di
vendetta e rappresaglia. E questo atto è il sacrificio, compiuto in sostanza dall’intera comunità, in
accordo, su un unico individuo che svolge la funzione di capro espiatorio. Il sacrificio è dunque un
atto di unanimità violenta, che placa per così dire le esigenze aggressive purificando la società (e
purificare significa eliminare la catena perversa della violenza).
Questa è una sintesi molto schematica. Girard dà corpo alla sua tesi attraverso un percorso
all’interno della mitologia e in particolare della tragedia greca, nella quale legge l’espressione del
timore della «crisi sacrificale», come la chiama. Egli sostiene che senza il presupposto della
violenza essenziale noi non riusciamo a capire nulla della cultura antica, che si aggrega tutta attorno
al superamento di questo rischio; non capiamo nulla del sacro e della religione, che sono per così
dire il precipitato ideologico dell’unanimità violenta (e che, come per Frazer e Freud, si fondano
dunque su un atto di violenza originaria); e non capiamo nulla della tragedia greca, che sta poi
all’origine della stessa letteratura moderna, così come non capiamo una parte importante dell’etica
delle società moderne.
D’altra parte, dice Girard, se non ci rendiamo conto di ciò è perché la cultura tende a dissimulare
queste sue operazioni, e a nascondere allo sguardo proprio quel nucleo di violenza essenziale che è
suo compito neutralizzare. Per comprendere questo nesso civiltà-violenza occorre calarsi in qualche
modo nella costituzione esistenziale dell’uomo arcaico, e seguire le tracce della crisi sacrificale
dentro i documenti classici, etnologici e folklorici. Il che apre un programma di studio e di
interpretazione praticamente illimitato.
Tutti questi autori considerano la violenza non semplicemente come un residuo che sarebbe
desiderabile eliminare, ma come una forza costitutiva che è incastonata nelle fondamenta stesse
della civiltà. La loro idea è che, quanto più dissimuliamo o tentiamo di ignorare questo ingombrante
fardello, tanto più difficilmente possiamo liberarcene. Un superamento reale della violenza deve
passare, a loro avviso, attraverso la consapevolezza di questo nesso originario. Cosicché la società
non avrebbe bisogno di buoni propositi, enunciazioni di principi morali, etc., che nascondono
sempre più il nucleo terribile della violenza invece che risolverlo; avrebbe semmai bisogno di una
sorta di psicoterapia, che porti pienamente alla coscienza quel groviglio inestricabile di violenza,
desiderio, magia, e solo così lo risolva pienamente. Per tutti e tre, evidentemente, le scienze umane
possono svolgere una funzione importante in questa direzione.
5. Osservazioni conclusive
Sarebbe difficile a questo punto stringere il ragionamento ed arrivare ad una sintesi delle posizioni
teoriche esaminate. Come ho detto all’inizio, sono scettico sulla possibilità e sull’opportunità di
interrogare l’antropologia in cerca di una teoria generale della violenza, che possa essere applicata
alle singole manifestazioni storiche di essa - per quanto ritenga ineludibile, vale la pena ripeterlo, il
problema dell’intreccio tra dimensioni storiche e antropologiche, o se si vuole tra logica dell’evento
e logica dei modelli culturali, che la comprensione del nostro tempo così spesso ci pone. Non si può
pensare questo intreccio come una semplice questione di divisione del lavoro: cosicchè l’approccio
universalista dell’antropologo inizierebbe laddove si ferma l’approccio individuante dello storico, e
viceversa. Le due discipline (nonché le altre, come psicoanalisi, sociologia, etologia) devono
interagire a tutti i livelli, senza il timore né di sporcarsi le mani con la fattualità empirica né di
misurarsi con problemi filosofici, astrazioni teoretiche, suggestioni interpretative.
Nel comune sforzo di comprensione, ogni disciplina porterà naturalmente il patrimonio di idee,
concetti, strumenti e metodi che le viene dalla propria tradizione intellettuale. Concludo, dunque,
cercando di enucleare alcune delle peculiarità (beninteso, non esclusive) dell’approccio
antropologico.
a) In primo luogo, l’interpretazione antropologica passa attraverso la soggettività degli attori sociali.
Per così dire, l’antropologia è una interpretazione di interpretazioni - si esercita cioè sulle modalità
in cui individui o gruppi umani costruiscono un proprio universo morale, danno senso al mondo e
alla storia. Per esser ancora più precisi, si esercita sulle pratiche sociali attraverso cui questo
“senso” viene negoziato, contrattato, sostenuto, modificato - con motivazioni che sono sempre, in
senso lato, politiche, che hanno cioè a che fare con il potere e la sua gestione. Mi sembra degno di
nota il fatto che gli storici contemporaneisti che più si sono interessati all’antropologia sono proprio
quelli che con maggior forza si sono posti il problema della soggettività degli attori sociali. Per
quanto riguarda il tema dei massacri o dei campi di concentramento e di sterminio, oltre agli autori
italiani già citati in precedenza, si possono ricordare gli studi di Christopher Browning ( 1992) e
Daniel Goldhagen (1996), che, pur da prospettive assai diverse, si sono posti l’obiettivo di
comprendere il punto di vista soggettivo dei massacratori, finendo entrambi su un terreno di
riflessione squisitamente antropologico.
b) Come conseguenza di quanto appena detto, nello studio di eventi storici l’antropologia ha a che
fare prevalentemente con discorsi, o meglio con racconti - vale a dire, con elaborazioni della
memoria nelle quali l’esperienza vissuta dei protagonisti viene forgiata in forma narrativa. La storia
di vita e la testimonianza narrativa, soprattutto orale, non è per l’antropologia una fonte come tante
altre, utile per ottenere dati che potrebbero esser ottenuti anche in altro modo. E’ invece oggetto di
interesse in sé, in quanto crogiuolo, per così dire, in cui si forgia il senso culturale della storia.
c) L’antropologia è interessata al modo in cui specifiche pratiche contribuiscono alla
determinazione di un ordine culturale. Per quanto riguarda la violenza, importante è capire qual è il
suo significato culturale, quali valori la muovono, quali sono i suoi usi sociali - e non tanto
considerarla come un residuo, ciò che rimane una volta che si sono allentati i vincoli della civiltà e
della cultura e che è emersa la “belva che è in noi”. L’approccio antropologico può servire a
sviluppare sensibilità verso il linguaggio simbolico della violenza, abituando a leggere ciò che
sembra o si presenta come esplosione incontrollata di furore come, invece, una configurazione
ordinata di comportamenti che quasi sempre risponde a un codice culturalmente appreso; abituando
a chiedersi se atti violenti apparentemente analoghi abbiano lo stesso significato all’interno di
contesti culturali diversi; abituando a riflettere su come il confine stesso tra comportamento violento
e non violento venga costantemente ridisegnato nel corso della storia, in relazione a strategie in
senso lato politiche dei gruppi sociali.
d) La pratica del confronto con la diversità porta talvolta gli antropologi ad accostarsi a certe epoche
storiche come se fossero culture altre. Ciò può risultare fuorviante: ma può anche essere un
correttivo rispetto al presupposto di certa storiografia tradizionale, che pone come soggetto di ogni
evento una astratta individualità razionale piuttosto che soggettività plasmate da contesti di
differenze culturali. Il comportamento degli esecutori di massacri e genocidi può ad esempio
risultare incomprensibile se commisurato ai criteri di un generico agire razionale ( o ai criteri che
appartengono all’attuale cultura dello storico): in questo caso, l’intelligenza storiografica dovrà
usare un metodo antropologico, mirando a ricostruire il contesto socio-culturale “altro” in cui quel
comportamento possa esser ragionevolmente collocato. E’ l’operazione tentata da Goldhagen a
proposito della società tedesca che ha prodotto il nazismo e il progetto della soluzione finale. Lo
stesso evento della Shoah, egli afferma, “ci impone di mettere in discussione il presupposto
dell’affinità tra quella società e la nostra” e di “guardare alla Germania con gli occhi
dell’antropologo che studi un popolo di cui si sa poco” (Goldhagen 1996: 30). Scopriamo così che
si tratta di una società dominata da modelli cognitivi radicalmente diversi da quelli oggi diffusi nel
mondo occidentale, e in particolare da un antisemitismo talmente diffuso da risultare un vero e
proprio assioma indiscusso, una base della più elementare visione del mondo, un “luogo comune
che passava praticamente inosservato” (Ibid.: 34). Per inciso, l’analisi di Goldhagen è un po’ troppo
semplicistica, e fa un uso improprio e banalizzante di concetti antropologici come quello di
“modello cognitivo” (v. Hinton 1998). E’ dubbio che si possa considerare il nazismo come una
cultura radicalmente altra in senso antropologico; e, più in generale, la relativizzazione radicale dei
contesti culturali è operazione sempre rischiosa e da affrontare con estrema cautela. Tuttavia, è
anche un terreno su cui è talvolta necessario spingersi di fronte allo “scandalo” di eventi storici che
sembrano sfidare la stessa nostra idea di umanità.
e) Per restare a Goldhagen, il suo approccio per così dire distanziante al nazismo coglie con lucidità
almeno un aspetto importante del metodo antropologico. Egli si rende conto che per capire il punto
di vista dei “volenterosi carnefici di Hitler”, i tedeschi comuni che sono stati zelanti esecutori
materiali dei massacri, occorre studiare non solo il loro comportamento nel corso della guerra e dei
massacri stessi, ma anche e soprattutto la loro vita quotidiana, le loro routines, gli aspetti più banali
e ordinari della loro esistenza. Goldhagen enuncia con chiarezza questo principio metodologico,
anche se non riesce poi a svolgerlo completamente - cosicché, nell’architettura complessiva del suo
fortunato e discusso libro, lo studio della vita quotidiana degli esecutori resta in secondo piano
(Goldhagen 1996: 276sgg.). In effetti, è peculiarità dello sguardo antropologico il concentrarsi sulle
pratiche comuni più che su quelle estreme e straordinarie, sulle routines più che sugli eventi
eccezionali. Suo obiettivo è cogliere i livelli più profondi della costituzione culturale degli individui
e dei gruppi, che si manifestano per l’appunto nelle pratiche o nelle idee più banali e più scontate:
anzi, proprio le idee o le azioni così scontate da non esser neppure notate dai loro attori stessi, sono
quelle che più interessano gli antropologi. E’ anche vero, all’inverso, che in certe circostanze gli
eventi estremi possono esser rivelatori di aspetti della costituzione culturale ordinaria che
normalmente non si riesce a cogliere: è l’idea sviluppata ad esempio da alcuni studiosi della vita nei
lager, come il già citato Primo Levi o, più di recente, Tzvetan Todorov (1991), il quale cerca di
ricavare un’etica delle virtù e dei vizi quotidiani dalle esperienze-limite dell’esistenza nei campi di
concentramento nazisti e sovietici. I due approcci sono probabilmente complementari: come ripeto,
è però peculiare dell’antropologia la tendenza a discostarsi dal fatto esemplare (su cui di solito si
concentar invece lo storico), per immergersi nei dettagli apparentemente opachi e insignificanti
della quotidianità.
Riferimenti bibliografici
Beattie, John
1964 Other Cultures, London, Routledge and Kegan Paul [trad.it. Uomini diversi da noi, Bari,
Laterza, 1972
Bloch, M.
1997 “La «consumazione» dei giovani presso gli Zafimaniry del Madagascar”, in Heritier 1997:
144-57
Browning, C.R.
1992 Ordinary Man. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, New York,
Harper Collins [trad.it. Uomini comuni. Polizia tedesca e «soluzione finale» in Polonia, Torino,
Einaudi, 1995]
Clastres, P.
1997 Archeologie de la violence, Paris, Éditions de l’Aube [trad.it. Archeologia della violenza,
Roma, Meltemi, 1998]
Dal Lago, Alessandro
1990 Descrizione di una battaglia. I rituali del calcio, Bologna, Il Mulino
Dei, F.
1992 “Il calcio: una prospettiva antropologica”, in Ossimori. Periodico di antropologia e scienze
umane, 1: 7-31
1998 La discesa agli inferi. James J. Frazer e la cultura del Novecento, Lecce, Argo.
De Martino, E.
1958 Morte e pianto rituale nel mondo antico, Torino, Einaudi
1962 Furore simbolo valore, Milano, Il Saggiatore
Elias, N.
1988 La civiltà delle buone maniere, trad.it. Bologna, Il Mulino
Evans-Pritchard, E.E.
1937
Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, Oxford, Clarendon Press [trad. it.
Stregoneria, oracoli e magia tra gli Azande, Milano, Angeli, 1976]
1940 The Nuer: a Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic
People, London, Oxford University Press [trad.it. I Nuer : un’anarchia ordinata, Milano, Angeli,
1975]
Frazer, J.G.
1011-15 The Golden Bough. A study in Magic and Religion, 12 voll., London, MacMillan [trad.it.
dell’edizione ridotta Il ramo d’oro, Torino, Boringhieri, 1989]
Freud, S.
1913 Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen in Seelenleben del Wilden und der Neuirotiker
[trad. it. Totem e tabù, Torino, Boringhieri, 1969]
Girard, R.
1972
La Violence et le sacré, Paris, Éditions Bernard Grasset [trad.it. La violenza e il sacro,
Milano, Adelphi, 1980]
Goldhagen, D.J.
1996 Hitler’s Willing Exexutioners. Ordinary Germans and the Holocaust, New York, A. Knopf
[trad.it. I volenterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l’olocausto, Milano, Mondadori, 1997]
Heritier, F. (a cura di)
1997 Sulla violenza, Roma, Meltemi
Hinton, A. L.
1998
“Why did the Nazis kill? Anthropology, genocide and the Goldhagen controversy”,
Anthropology Today, 14 (5) : 9-15
Leroi-Gourhan, A.
1964-5 Le geste et las parole, 2 voll., Paris, Albin Michel [trad.it. Il gesto e la parola, Torino,
Einaudi, 1977]
Levi, P.
1986 I sommersi e i salvati, Torino, Einaudi
Paggi, L.
1996 “Presentazione”, in L. Paggi (a cura di), Storia e memoria di un massacro ordinario, Roma,
Manifestolibri: 7-14
Ranzato, G.
1997 Il linciaggio di Carretta, Roma 1944. Violenza politica e ordinaria violenza, Milano, Il
Saggiatore
Riches, D. (ed.)
1986 The Anthropology of Violence, Oxford, Blackwell
Roversi, Antonio
1992 Calcio, tifo e violenza. Il teppismo calcistico in Italia, Bologna, Il Mulino
Todorov, T.
1991 Face a l’extrême, Paris, Seuil [trad.it. Di fronte all’estremo, Milano, Garzanti, 1992]