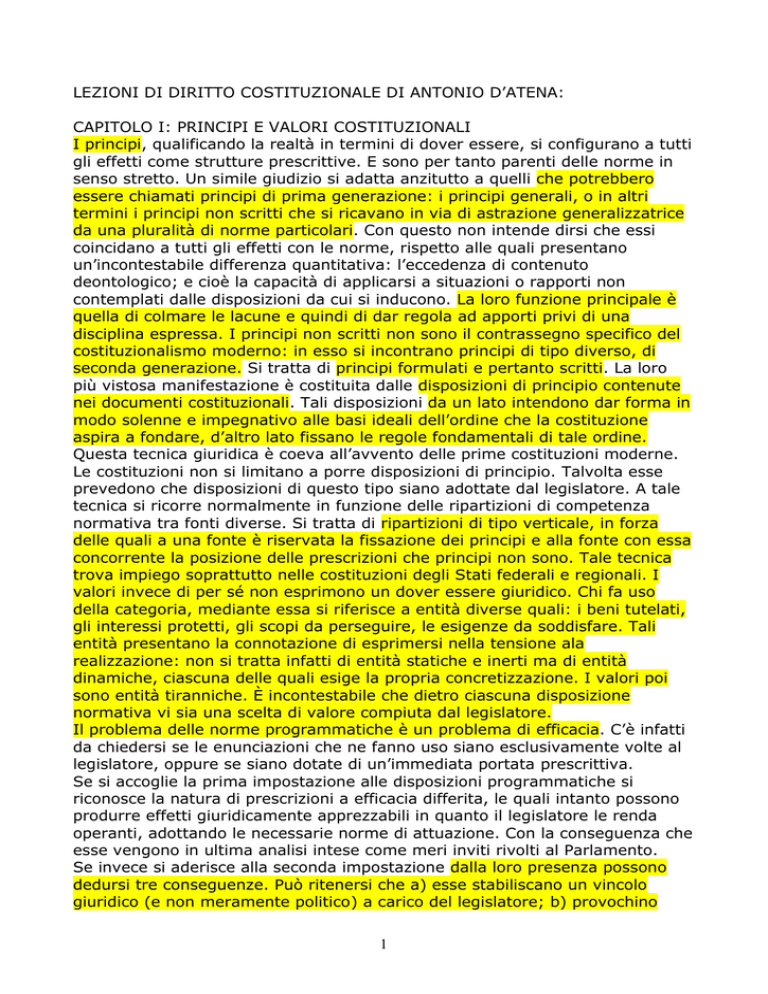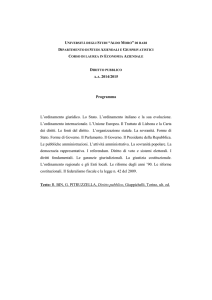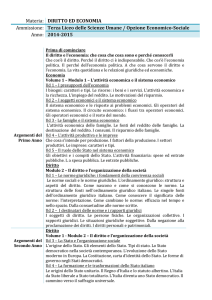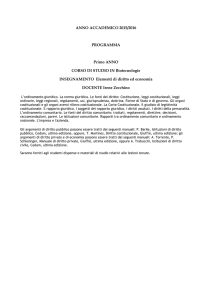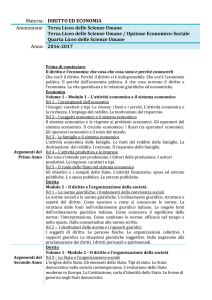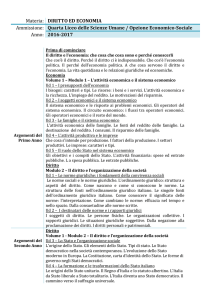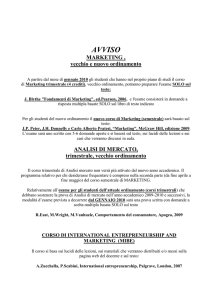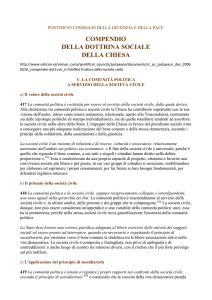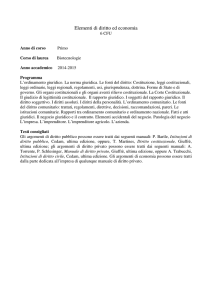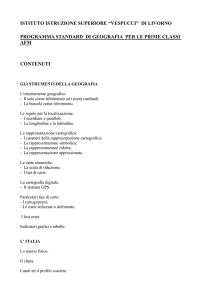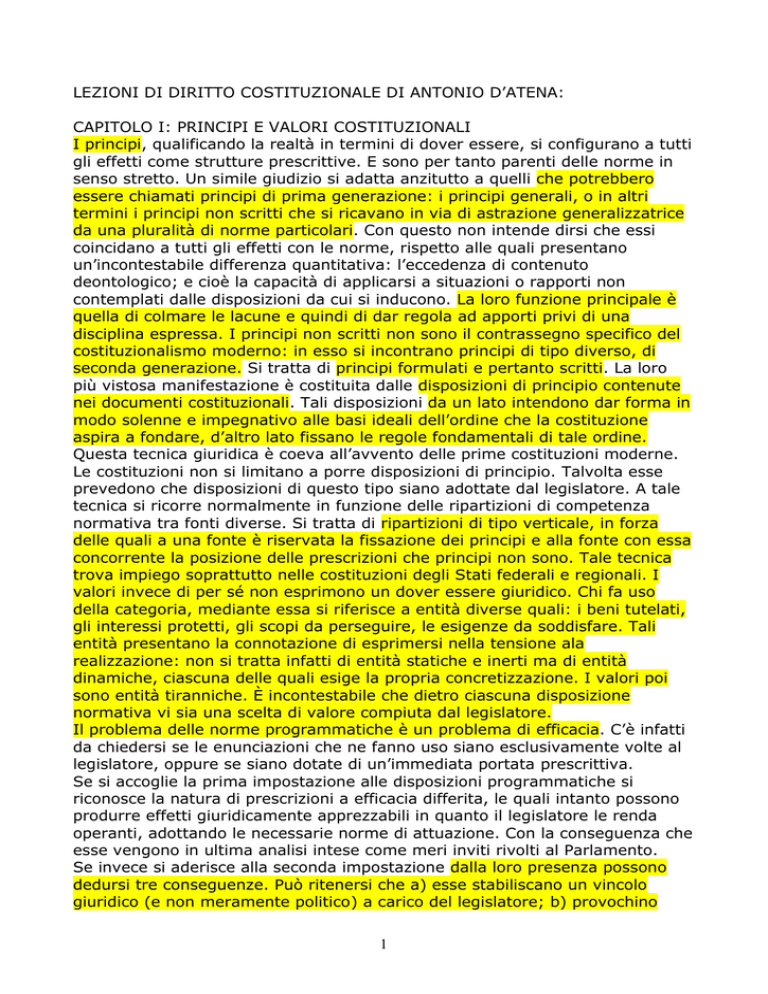
LEZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE DI ANTONIO D’ATENA:
CAPITOLO I: PRINCIPI E VALORI COSTITUZIONALI
I principi, qualificando la realtà in termini di dover essere, si configurano a tutti
gli effetti come strutture prescrittive. E sono per tanto parenti delle norme in
senso stretto. Un simile giudizio si adatta anzitutto a quelli che potrebbero
essere chiamati principi di prima generazione: i principi generali, o in altri
termini i principi non scritti che si ricavano in via di astrazione generalizzatrice
da una pluralità di norme particolari. Con questo non intende dirsi che essi
coincidano a tutti gli effetti con le norme, rispetto alle quali presentano
un’incontestabile differenza quantitativa: l’eccedenza di contenuto
deontologico; e cioè la capacità di applicarsi a situazioni o rapporti non
contemplati dalle disposizioni da cui si inducono. La loro funzione principale è
quella di colmare le lacune e quindi di dar regola ad apporti privi di una
disciplina espressa. I principi non scritti non sono il contrassegno specifico del
costituzionalismo moderno: in esso si incontrano principi di tipo diverso, di
seconda generazione. Si tratta di principi formulati e pertanto scritti. La loro
più vistosa manifestazione è costituita dalle disposizioni di principio contenute
nei documenti costituzionali. Tali disposizioni da un lato intendono dar forma in
modo solenne e impegnativo alle basi ideali dell’ordine che la costituzione
aspira a fondare, d’altro lato fissano le regole fondamentali di tale ordine.
Questa tecnica giuridica è coeva all’avvento delle prime costituzioni moderne.
Le costituzioni non si limitano a porre disposizioni di principio. Talvolta esse
prevedono che disposizioni di questo tipo siano adottate dal legislatore. A tale
tecnica si ricorre normalmente in funzione delle ripartizioni di competenza
normativa tra fonti diverse. Si tratta di ripartizioni di tipo verticale, in forza
delle quali a una fonte è riservata la fissazione dei principi e alla fonte con essa
concorrente la posizione delle prescrizioni che principi non sono. Tale tecnica
trova impiego soprattutto nelle costituzioni degli Stati federali e regionali. I
valori invece di per sé non esprimono un dover essere giuridico. Chi fa uso
della categoria, mediante essa si riferisce a entità diverse quali: i beni tutelati,
gli interessi protetti, gli scopi da perseguire, le esigenze da soddisfare. Tali
entità presentano la connotazione di esprimersi nella tensione ala
realizzazione: non si tratta infatti di entità statiche e inerti ma di entità
dinamiche, ciascuna delle quali esige la propria concretizzazione. I valori poi
sono entità tiranniche. È incontestabile che dietro ciascuna disposizione
normativa vi sia una scelta di valore compiuta dal legislatore.
Il problema delle norme programmatiche è un problema di efficacia. C’è infatti
da chiedersi se le enunciazioni che ne fanno uso siano esclusivamente volte al
legislatore, oppure se siano dotate di un’immediata portata prescrittiva.
Se si accoglie la prima impostazione alle disposizioni programmatiche si
riconosce la natura di prescrizioni a efficacia differita, le quali intanto possono
produrre effetti giuridicamente apprezzabili in quanto il legislatore le renda
operanti, adottando le necessarie norme di attuazione. Con la conseguenza che
esse vengono in ultima analisi intese come meri inviti rivolti al Parlamento.
Se invece si aderisce alla seconda impostazione dalla loro presenza possono
dedursi tre conseguenze. Può ritenersi che a) esse stabiliscano un vincolo
giuridico (e non meramente politico) a carico del legislatore; b) provochino
1
l’illegittimità costituzionale delle norme gerarchicamente subordinate con esse
incompatibili; c) concorrano alla determinazione generale dei principi
dell’ordinamento, utilizzabili sia per il superamento delle lacune sia in sede di
interpretazione sistematica... è quest’ultima la lettura affermatasi in Italia per
le disposizioni programmatiche della Costituzione.
La Costituzione non risolve tutte le possibili tensioni tra valori.
Per questo la dottrina indica due strade: la prima è quella della necessaria
mediazione legislativa, alla stregua della quale si ritiene che le priorità vadano
stabilite dal legislatore con autonoma decisione politica; la seconda è costituita
dalla tesi secondo cui l’assetto pluralistico dei valori postulerebbe un metavalore: quello del mantenimento dell’equilibrio tra i valori stessi, in virtù del
quale nessuno dei valori giustificherebbe il pieno sacrificio dei valori con esso
concorrenti. Su queste basi la tecnica privilegiata è individuata nel
bilanciamento (o nel contemperamento) tra i valori, che andrebbe effettuato
dal giudice sulla base dei criteri di ragionevolezza.
Ciascuna delle due tesi contiene un fondo di verità. In certi casi l’insurrogabilità
dell’intervento del legislatore non può essere messa in discussione (diritti a
prestazione). Quello che è dubbio è che all’organo legislativo possa riconoscersi
un ruolo privilegiato, ai fini della risoluzione della generalità dei conflitti
assiologici presenti nella Costituzione.
CAPITOLO II: IL PRINCIPIO DEMOCRATICO
La liberal-democrazia costituisce la forma specifica che la democrazia tende ad
assumere agli albori del terzo millennio. La più rilevante caratteristica di tale
modello può essere ravvisata nel suo carattere composito.
Si rileva che le odierne democrazie poggiano su un fondo comune di regole e
meccanismi quali: a) il parlamentarismo (cioè l’esistenza di istanze
rappresentative); b) la garanzia delle libertà; c) la concezione che ravvisa
nell’opposizione non un gruppo, ma una posizione astratta che tocca a questo
o quel partito, senza predestinazioni o esclusioni; d) l’esistenza di meccanismi
che pongano la maggioranza in condizione di governare.
Non mancano infine elencazioni in forma di catalogo degli ingredienti delle
liberal democrazie contemporanee, tra i quali figurano il suffragio universale, il
principio maggioritario, il principio dell’alternanza del potere, il pluralismo
dell’informazione, la garanzia delle libertà, l’eguaglianza delle opportunità.
Iniziando dall’ispirazione democratica può rilevarsi che essa trova espressione
in due regole-base, le quali identificano le coordinate minime di ogni
democrazia.
La prima regola è costituita dal principio di organizzazione in forza del quale le
decisioni devono essere direttamente o indirettamente ricondotte a scelte
popolari. La seconda è rappresentata dal principio maggioritario, secondo cui
criterio essenziale di imputazione delle decisioni allo stato è la convergenza
sulle stesse del consenso della maggioranza. Il comune valore su cui tale
regole si fondano è costituito dall’eguaglianza dei cittadini, da qui l’universalità
del suffragio; e da qui ancora il principio dell’uguaglianza del voto (i voti si
contano, non si pesano).
Le democrazie contemporanee si presentano sempre come democrazie
rappresentative, ma percorse dalla tensione verso la democrazia diretta, nei
2
confronti della quale affiora ricorrentemente una sorta di complesso di
inferiorità. La configurazione della democrazia rappresentativa come
democrazia incompiuta non tiene conto di due dati essenziali: anzitutto
dell’ineliminabile tasso di utopicità della democrazia diretta; poi deve rilevarsi
che nei sistemi democratico-rappresentativi è presente un elemento
assolutamente estraneo alla democrazia diretta: la responsabilità, nella forma
di responsabilità politica dei rappresentati nei confronti del corpo elettorale
(possibilità di alternativa dell’opposizione; raffreddamento e razionalizzazione).
La democrazia rappresentativa rispetto alla diretta non si presenta come un
minus ma come un aliud.
Quanto al principio maggioritario, nelle liberal democrazie intrattiene una
relazione dialettica con il principio che potrebbe denominarsi minoritario. E
infatti per scongiurare l’eventualità che “la maggioranza ha sempre ragione” il
principio maggioritario risulta temperato da regole rivolte a bilanciarlo: come la
sottrazione della scelta democratica all’operatività della norma base in cui
prende corpo; e come i principi e gli istituti rivolti ad assicurare la possibilità
dell’alternanza al potere (la possibilità cioè che le minoranze di oggi possano
diventare le maggioranze di domani). Ci si riferisce innanzitutto al principio
della temporaneità delle cariche elettive e al riconoscimento alle opposizioni di
un complesso minimo e irriducibile di garanzie e di diritti.
In forza del principio della divisione dei poteri, proprio dello Stato di diritto,
nell’ambito degli apparati pubblici si distinguono due circuiti eterogenei.
Il primo è il circuito democratico rappresentativo, al quale appartengono gli
organi la cui investitura sia direttamente o indirettamente riconducibile a una
scelta del popolo.
Il secondo circuito è sottratto alla logica democratico-rappresentativa.
Nell’ambito di esso la preposizione all’ufficio non è il frutto di una decisione
politica, ma l’effetto di meccanismi diversi tra i quali fa spicco la regola del
concorso, rivolta a una selezione di tipo tecnico-attitudinale.
I valori che presiedono al circuito non democratico sono costituiti: a)
dall’indipendenza o dall’imparzialità dei titolari degli organi; b) dalla tecnicità
nell’esercizio dei compiti loro affidati, la quale, nella Costituzione italiana, trova
espressione nel principio del buon andamento dell’amministrazione.
La seconda tecnica di separazione ha a oggetto il potere nella sua componente
obiettiva, il quale risulta scomposto in funzioni. A Crisafulli va il merito di aver
dimostrato che tale scomposizione trova la propria chiave di volta nella
contrapposizione tra la predeterminazione degli interessi pubblici e il loro
immediato soddisfacimento, o in altre parole, tra il momento del disporre in via
tendenzialmente generale e astratta, e il momento dell’individuale e concreto
provvedere; il primo proprio e caratteristico degli atti normativi in senso
stretto, il secondo invece degli atti pubblici che normativi non sono. E su tali
basi il potere di disporre è appannaggio degli organi appartenenti al circuito
democratico-rappresentativo, quello di provvedere agli organi sganciati da tale
circuito.
Per completare il quadro deve ricordarsi che nelle liberal-democrazie il
contemperamento delle ragioni della democrazia e le ragioni della tutela
individuale è assicurato dal principio di legalità, in forza del quale gli atti
individuali e concreti debbono trovare il loro fondamento in regole generali e
3
astratte; regole che non devono limitarsi ad attribuire agli organi
dell’amministrazione e della giurisdizione il potere di decidere, ma devono
prefigurare il contenuto della decisione, fissando i parametri generali cui
questa deve ispirarsi. Il principio di legalità si converte così nel principio del
giusto procedimento.
CAPITOLO III: FEDERALISMO E REGIONALISMO
Il modello francese è il modello dell’ordinamento unitario centralizzato, il quale
trova espressione nel principio dell’unità e dell’indivisibilità dello Stato. Tale
principio fa la sua apparizione con la Costituzione del 1791.
Il principio dell’unità e dell’indivisibilità nella sua versione originaria, trovava la
propria traduzione storica in ordinamenti fortemente centralizzati, retti da
norma che non riconoscevano significative forme di autonomia territoriale. Le
articolazioni organizzative periferiche mediante le quali il potere pubblico
esercitava il controllo sul territorio si presentavano infatti come diramazioni di
un sistema unitario legato al centro da vincoli di subordinazione gerarchica.
Completamente diverso è il modello statunitense. In base ad esso lo Stato non
presenta i caratteri di un’entità monolitica una e indivisibile, ma quelli di
un’entità complessa, pluralisticamente articolata: si tratta di uno Stato
complesso, in quanto costituito a propria volta da Stati. Questo avvenne per le
differenze delle varie situazioni storiche. Negli Stati Uniti, a differenza della
Francia, l’unificazione nazionale non aveva preceduto l’avvento dello Stato
moderno, ma è praticamente coincisa con esso (e con la Costituzione che l’ha
sanzionato, quella del 1787). Anteriormente esistevano tredici autorità
sovrane: le tredici ex colonie che avevano proclamato la propria indipendenza
nel 1776. tra il 1771 e il 1781 poi ci fu passaggio intermedio costituito dalla
costituzione di una Confederazione, che si presentava come un’unione
internazionale, rivolta a creare una salda lega di amicizia per la difesa e il
benessere comuni. In base all’atto costitutivo alla Confederazione spettava
l’esercizio di alcune competenze nell’interesse di tutti gli stati membri mentre
questi ultimi mantenevano un rapporto esclusivo con i rispettivi cittadini. La
Confederazione pertanto si presentava come un’associazione di Stati, i cui
cittadini non erano i cittadini, persone fisiche degli Stati, ma gli Stati stessi.
La vicenda americana ha fatto scuola in tutto il mondo: in Svizzera fu
dapprima creata la Confederazione dei Cantoni (1815) e successivamente la
Federazione (1848); in Germania nel 1815 nacque la Confederazione, mentre
nel 1867 fece la sua prima apparizione lo Stato federale.
Anche in Italia, come in Germania, l’unificazione nazionale è stato un frutto
tardivo, essendosi realizzata nella seconda metà del secolo scorso. E anche in
Italia esistevano le condizioni per la creazione di un ordinamento federale. Ci si
riferisce alla presenza di Stati preunitari. Tuttavia la storia ha seguito un
diverso corso. L’unificazione è avvenuta attraverso una serie di annessioni
territoriali al Regno di Sardegna ed ha trovato espressione in un modello di
ordinamento amministrativo direttamente derivato dalla tradizione francese. Si
tratta del modello napoleonico dello Stato unitario centralizzato, il quale ha
favorito il fenomeno qualificato della piemontesizazzione dell’Italia.
Nell’anno 1931 fanno la loro apparizione le regioni, che sono state inventate
dalla Costituzione della Repubblica spagnola. E sono state inventate per venire
4
incontro alle esigenze autonomistiche di alcune etnie con tradizioni popolari
differenziate e talora, addirittura con lingua propria. La soluzione accolta dalla
Costituzione del 1931 presentava caratteri di assoluta originalità. Il
regionalismo spagnolo fu spazzato via dal franchismo che ripristinò lo Stato
unitario centralizzato. Tuttavia il seme era stato gettato. E fu raccolto
dall’Assemblea costituente italiana, la quale tra il 1946 e il 1947 ha riesumato
il tipo istituzionale dello Stato regionale, rompendo con la tradizione
centralistica pregressa.
Anzitutto per ragioni politiche contingenti: mediante la soluzione regionale si
diede infatti una risposta alle tensioni autonomistiche che si erano sviluppate in
alcuni territori. I motivi furono anche altri: le diversità morfologiche, nonché
culturali e sociali davano luogo a un’eterogeneità per la quale sembrava
assurdo che, con riferimento a certi oggetti identificati dalla Costituzione
(agricoltura, urbanistica) la disciplina dovesse essere uniforme. Altro motivo fu
poi il consolidamento della riconquistata democrazia: si ricordi la diffusa
convinzione che l’articolazione regionale del potere costituisse un efficace
antidoto nei confronti di involuzioni autoritarie; e poi nello sviluppo di ambiti
istituzionale di dimensione infrastatuale si ravvisava un decisivo fattore di
promozione della partecipazione delle popolazioni interessate alla decisione che
ne toccavano più da vicino la vita. Un’ultima ragione dell’opzione regionalistica
della nostra Costituente può essere ravvisata nella riforma dello Stato: si
riteneva che la creazione di una solida rete di poteri locali potesse contribuire
efficacemente al superamento di taluni mali della nostra organizzazione
pubblica.
La soluzione italiana restò per circa un ventennio un caso isolato. Dagli anni
settanta in Spagna si è avviato un processo di decentramento che ha trovato
espressione nella creazione delle 19 comunità autonome; e in Portogallo i
territori insulari delle Azzorre e della Madera si costituirono in regioni
autonome. In Belgio poi alla nascita dello Stato federale si è giunti non
attraverso un processo di aggregazione ma di decentramento.
Gli ordinamenti federali e regionali presentano tre punti in comune: a)
esistenza di livelli territoriali di Governo in posizione intermedia tra lo Stato
centrale e gli enti minori di base, come i Comuni e le Province; b) questi livelli
intermedi dispongono di competenze garantite dalla Costituzione; c) tali
competenze comprendono anche la legislazione (policentrismo legislativo).
Le diversità provengono in massima parte dalla diversità dei processi storici di
formazione: mentre gli Stati membri di una Federazione tendono a conservare
tutte le funzioni tipiche di uno Stato (legislativa, esecutiva e giudiziaria), le
Regioni dispongono delle sole funzioni loro attribuite dallo Stato (in genere non
è compresa la giurisdizione).
Nello Stato federale le competenze enumerate sono di regola quelle della
Federazione con la conseguenza che gli Stati membri sono titolari di una
competenza generale; nei sistemi regionali la soluzione è opposta.
Negli Stati federali esiste sempre una seconda Camera rappresentativa degli
Stati membri, che invece non esiste negli Stati regionali o non si differenzia
dalla prima.
5
CAPITOLO IV: IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’
La scoperta del principio di sussidiarietà è stata una scoperta tardiva, la quale
è coincisa con l’elaborazione e con l’introduzione dell’art. 3 del Trattato di
Maastricht.
Il principio di sussidiarietà è giunto sino a noi lungo tre filoni fondamentali:
1. la dottrina sociale della Chiesa, che fonda la sussidiarietà sul primato
etico della persona rispetto allo Stato;
2. il pensiero liberale, che pone al centro della sua elaborazione la libertà
individuale. Secondo questa versione della sussidiarietà i diretti
interventi dello Stato in economia si giustificano solo se il mercato non è
in grado di operare efficacemente;
3. la riflessione sul federalismo: il potere tanto più è concentrato, tanto più
è pericoloso. Da qui la diffusa interpretazione del federalismo come
tecnica di divisione verticale del potere.
Il principio di sussidiarietà è un principio relazionale, il quale ha a oggetto i
rapporti tra entità diverse: tra i diversi livelli territoriali di Governo (Stato,
regioni, province e comuni), tra gli enti territoriali e gli enti funzionali (come le
Università degli studi), tra la statualità e la società civile.
Elemento costitutivo del principio è la decisione di preferenza che ne è alla
base: una decisione in favore degli ambiti più vicini agli interessati. Alla
stregua del principio di sussidiarietà, infatti, l’intervento dell’ambito meno
vicino si giustifica solo se quello vicino non sia adeguato. La maggiore o minore
adeguatezza non va misurata in termini esclusivamente economici o di
efficienza. Inoltre l’ambito preferito va preferito anche a parità di condizioni.
L’art. 3B del Trattato di Maastricht stabilisce che la CE è legittimata a
intervenire nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano
essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri (dispositivo dinamico). Vi
sono anche altri modi attraverso cui il principio di sussidiarietà può emergere a
livello di riconoscimento normativo.
1. norme che si limitano a enunciare il principio;
2. dispositivi statici: la preferenza accordata al livello minore trova
espressione in una riserva di competenza in suo favore (art.8 Cost).
disposizioni del genere regolano il rapporto tra Stato e formazioni sociali
parziali, facendo leva sulla preferenza accordata a queste ultime.
Ci si chiede se i dispositivi dinamici fissino condizioni giustiziabili oppure se
riconoscano al livello superiore la competenza della competenza. Chi si colloca
nella seconda prospettiva sostiene che l’art. 3B del Trattato di Maastricht altro
non faccia che attribuire alla Comunità europea il potere di sostituirsi agli Stati
in base ad una decisione politica in concreto insindacabile (e quindi di
esercitare nei loro confronti la competenza della competenza).
Nell’esperienza italiana della sussidiarietà possono distinguersi quattro fasi:
1. la prima è la fase costituente: i costituenti italiani, al pari di quelli
tedeschi, pur non facendo uso della parola “sussidiarietà” hanno adottato
una serie di soluzioni ispirate al principio corrispondente. Il quale quindi
si presenta come un principio non scritto.
2. nella seconda fase i germi della sussidiarietà presenti nella Costituzione
sono stati sistematicamente soffocati.
6
3. perché si assista alla riemersione del principio, deve attendersi la fine
degli anni 80. La prima manifestazione è costituita dalla Carta europea
dell’autonomia locale firmata a Strasburgo. Essa nel preambolo rileva che
il livello locale è quello in cui la partecipazione democratica dei cittadini
trova la propria espressione più diretta (sussidiarietà verticale).
4. la quarta fase ha inizio alla fine degli anni 90. e trova la sua espressione
più esplicita nella prima legge Bassanini n° 59/1997, che dà una lettura
estensiva del principio di sussidiarietà. Non si limita ai rapporti tra i
diversi livelli territoriali di governo ma utilizza anche con riferimento alle
relazioni tra gli enti territoriali e gli enti dotati di autonomia funzionale. A
tale impostazione possono ricondursi due previsioni: a) l’esclusione dal
processo di riallocazione delle funzioni alle Regioni e agli enti locali, dei
compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle
università degli studi; b) la precisazione che il principio di sussidiarietà
comporti l’attribuzione delle responsabilità pubbliche alla autorità
territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini. Contro le teorie
che semplificano i principi introdotti dalla legge Bassanini, che si pongono
esclusivamente di fronte al dilemma “pubblico sì-pubblico no”, questa
legge espone un’altra questione, quella del “pubblico come”. È, infatti,
ragionevole ritenere che in un sistema che accolga il principio di
sussidiarietà orizzontale si richieda anche una graduazione attentamente
calibrata delle azioni che lo stesso pubblico è legittimato a porre in
essere, per rapportarsi sussidiariamente al privato: potendosi ammettere
il ricorso a mezzi più forti e intrusivi solo nei casi e negli ambiti in cui una
strumentazione soft non sarebbe adeguata. (l’Unione Europea deve
graduare gli atti da utilizzare: ricorrendo ad atti vincolanti solo quando
quelli non vincolanti non siano sufficienti; preferendo le direttive rispetto
ai regolamenti). La graduazione non deve riguardare solo gli atti, quanto
anche gli attori: lo Stato deve esibire ai settori della società civile il volto
meno estraneo e intrusivo.
CAPITOLO V: COSTITUZIONE E AUTORITA’ INDIPENDENTI
La Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
istituita con legge 146/1990, consente di cogliere un paradosso. Tali autorità
da un lato costituiscono un corpo estraneo rispetto all’impianto generale
delineato nella Costituzione; dall’altro trovano proprio nella Costituzione le
proprie più profonde ragioni giustificatrici.
La Commissione di garanzia condivide con le altre autorità di garanzia
l’indipendenza rispetto al Governo: non solo non è tenuta a rispettare le
direttive governative, ma è altresì sottratta al controllo del circuito
democratico-rappresentativo.
Quanto alle sue competenze la Commissione è chiamata e valutare da un lato
gli atti, dall’altro i comportamenti: essa interviene sia nel momento di
formazione degli standard di condotta, sia in quello di applicazione degli
standard stessi ai fini dell’irrogazione delle sanzioni collettive ai soggetti che se
ne discostino (anomalia rispetto al principio di separazione che presiede alla
distribuzione delle funzioni tra i diversi apparati pubblici). La Commissione, non
7
solo non si trova in contrasto con il sistema costituzionale ma trova proprio in
esso la sua giustificazione più profonda. La nostra Costituzione non è retta da
un corpo unitario e omogeneo di principi ispiratori. È infatti incontestabile che
nel settore dei servizi pubblici essenziali, l’esercizio di un diritto
costituzionalmente garantito, il diritto di sciopero, può entrare in rotta di
collisione con altri diritti, anch’essi costituzionalmente garantiti: con quei diritti
che i servizi pubblici sono chiamati a soddisfare o tutelare. In questa materia,
ha fatto la sua prima apparizione, il criterio del contemperamento, come
criterio di composizione dei conflitti tra diritti di rango costituzionale.
Fondamentale può considerarsi una sentenza del Mortati (1969) secondo cui la
disciplina costituzionale fissava il parametro generale, riconoscendo i diritti in
conflitto e prescrivendone il contemperamento mentre il giudice doveva calare
tale parametro nello specifico del caso sottoposto al suo giudizio.
Con la legge 146/1990 si fa uso di una tecnica normativa di tipo misto: la
legge ricorre a un limitato numero di norme materiali, come le norme sul
preavviso e sulla durata degli scioperi, e quelle che in modo tassativo indicano
direttamente le prestazioni indispensabili dovute nell’ambito di questo o quel
servizio. Per il resto la legge ricorre a prescrizioni di tipo strumentale, affidando
l’individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero
a tre tipi di norme: a) norme finalistiche (prescrizioni rivolte a indirizzare
l’attività di individuazione delle prestazioni indispensabili); b) norme
procedimentali (demandano ad accordi tra le parti sociali la fissazione degli
standard di comportamento); c) norme organizzative (quelle riferentisi alla
Commissione stessa).
La Commissione non solo valuta gli accordi ma ne promuove la formazione e
ne fornisce l’interpretazione. La Commissione inoltre, in difetto di accordi
idonei, delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili
da garantire in caso di sciopero. Ciò significa che la Commissione funge da
catalizzatore del processo: interagendo con le parti, favorendo l’emersione
delle esigenze da soddisfare, governando la sperimentazione degli assetti
raggiunti. Perché questo sia possibile la Commissione deve avere una solida
legittimazione presso i soggetti con cui interloquisce. Per effetto della legge
127/1997 la Commissione è stata dotata di autonomia contabile.
La Commissione sullo sciopero è il solo organo di garanzia per i cui componenti
non è previsto un impegno esclusivo. Essa inoltre non dispone di un organico
dei propri uffici. Infine i suoi componenti sono confermabili.
CAPITOLO VI: L’AUTONOMIA UNIVERSITARIA
L’assimilazione dell’autonomia alla libertà risale alla tradizione liberale, alla
quale si deve l’idea che l’autonomia sia per un gruppo organizzato, quello che
la libertà è per il singolo. Innanzitutto le libertà non possono considerarsi
prerogativa esclusiva dei singoli: esse infatti possono essere riconosciute a
soggetti collettivi. Né è vero che l’autonomia sia propria solo dei soggetti
collettivi (autonomia privata). Poi tra autonomia e libertà sussistono due
differenza di ordine qualitativo: a) mentre la libertà consiste in una pretesa,
l’autonomia consiste in un potere giuridico o in un complesso di potei giuridici;
b) mentre la libertà si presenta come un valore assoluto (o finale), l’autonomia
è un valore tipicamente strumentale. Questo carattere strumentale è evidente
8
con riferimento all’autonomia universitaria, la quale trova la principale ratio del
proprio riconoscimento nella garanzia delle libertà di ricerca e di insegnamento.
Essa non è genericamente rivolta a realizzare il principio del decentramento
(art. 5 Cost) o quello del buon andamento dell’Amministrazione (art. 97), ma a
creare le condizioni più favorevoli all’esplicazione delle due libertà contemplate
nel primo comma della disposizione che la prevede (art. 33).
L’Università non è preordinata a trasmettere conoscenze codificate, ma è
chiamata a promuovere il progresso della scienza.
I problemi di tale autonomia attengono tanto al versante esterno (rapporto tra
ente autonomo e Stato) quanto a quello interno (organizzazione dell’ente
autonomo).
Sul versante esterno la disciplina costituzionale è scarna, limitandosi a
prevedere che le Università hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalla legge dello Stato, affidando la garanzia dell’autonomia allo
strumento della riserva di legge, da ritenersi assoluta e relativa al tempo
stesso. Assoluta nei confronti dell’Esecutivo (disciplina sottratta a fonti
regolamentari eteronome); necessariamente relativa nei confronti delle fonti di
autonomia: non potendo la legge dello Stato dettare una legge così penetrante
e dettagliata da espropriare la potestà normativa delle Università di
apprezzabili spazi di autodeterminazione. È ragionevole ritenere che la
disciplina posta dal legislatore ordinario debba essere una disciplina di tipo
generale, rivolta a fissare le linee dell’autonomia, non con riferimento a questa
o quella istituzione universitaria, ma avendo riguardo a tutte le istituzioni di tal
tipo.
Dal combinato disposto del primo e dell’ultimo comma dell’art. 33 risultano
alcuni corollari:
1. I poteri di autonomia legislativamente attribuiti alle Università non
possono vulnerare le libertà riconosciute ai singoli dal comma 1 dell’art.
33.
2. Le ragioni dell’autonomia non possono ritenersi soddisfatte se le
Università sono considerate come strutture monolitiche: sembra
indiscutibile che, nella ripartizione delle competenze tra i diversi livelli
organizzativi, la legge generale e gli atti di autonomia dagli stessi
contemplati siano tenuti a trarre le necessarie conseguenze dalle
differenze qualitative e strutturali sussistenti tra i centri e gli organi
enucleatisi nell’ambito dell’Università. Il proprium del sistema
universitario è quello di un sistema composito nel quale coesistono sfere
distinte, che vanno distintamente garantite:
Anzitutto la sfera del singolo, la cui libertà non può essere
vulnerata dall’organizzazione in cui si inserisce;
In secondo luogo la sfera dei collegi di tipo partecipativo, che deve
essere garantita nei confronti degli organi monocratici elettivi e dei
collegi di maggior estensione;
In terzo luogo la sfera degli organi centrali di Ateneo, chiamati a
soddisfare interessi generali, la cui dimensione trascende quella dei
livelli particolari, e che deve essere assistita da garanzie destinate
a valere soprattutto all’esterno (nei confronti dello Stato).
9
3. La tutela giurisdizionale costituisce il necessario complemento di ogni
autonomia garantita.
I problemi che si pongono in ambito universitario dipendono dal fatto che
ciascuna università costituisce un unico ente e che le articolazioni
organizzative operanti all’interno di tale ente non si ritengono dotate di
personalità giuridica.
L’attuazione legislativa dell’art. 33 ultimo comma è stata avviata da due leggi:
l. n. 168/1989 e l. n. 341/1990.
La legge 168 afferma che le Università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi
statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino
espresso riferimento. Tale norma quindi, non solo esclude, in maniera di
autonomia universitaria, diritto di cittadinanza ai regolamenti dell’esecutivo,
ma dice anche che non ogni legge dello Stato si applicano all’Università, ma
solo quelle che l’università espressamente contemplino.
Completamente diversa è la filosofia che traspare dalla legge n. 341, la quale,
non solo apre decisamente alle fonti regolamentari, ma attinge all’intero
campionario offerto in materia, dall’ordinamento: abilitando a incidere
direttamente o indirettamente, sull’autonomia universitaria, sia i regolamenti
governativi e ministeriali, sia quelli di tipo diverso. Ed è incontestabile
l’incompatibilità di questa scelta con la riserva assoluta di legge di cui all’art.
33 ultimo comma.
L’unico controllo previsto dalla legge 168 sugli statuti e i regolamenti di Ateneo
è un controllo ministeriale il cui momento comminatorio è rappresentato dalla
semplice richiesta di riesame: in caso di esito negativo del controllo, infatti, il
Ministro non ha il potere di annullare l’atto controllato, ma deve limitarsi a
rinviarlo all’Università, alla quale spetta l’ultima parola. Quanto al parametro si
tratta sia di un controllo di legittimità (parametro normativo), sia di merito
(canone extra normativo).
La legge n. 341 non ha modificato, nelle sue linee generali, questo disegno.
Essa tuttavia, per una categoria di regolamenti di Ateneo, i regolamenti
didattici) ha demandato al Ministro un tipo di controllo gravemente lesivo
dell’autonomia universitaria: il controllo per approvazione. Si tratta anche in
questo caso di un controllo di legittimità e di merito. A differenza però del
controllo con richiesta di riesame, esso mette nelle mani dell’organo cui è
affidato un potere di veto assoluto: infatti, in caso di mancata approvazione
ministeriale, l’Università manca della possibilità di adottare unilateralmente il
regolamento. In conseguenza di ciò o si rassegna a rinunziare al proprio
regolamento didattico o aderisce alle richieste ministeriali.
Le scelte operate dalla legge 341 e la successiva legge Bassanini 2 (127/1997)
sono lungi dal potersi considerare soddisfacenti: non solo per l’introduzione del
controllo suddetto, ma anche per la previsione di un sistema di competenze
normative che non sembra corrispondere alla logica che informa il paradigma
costituzionale. Tale sistema si articola in tre livelli: a) quello della normativa
nazionale; b) quello della normativa di Ateneo; c) quello della normativa
dettata dai Consigli delle strutture didattiche. La prima riserva che tale
articolazione giustifica riguarda il livello nazionale, anzitutto per l’atto
normativa prescelto: il regolamento ministeriale, il quale non soddisfa la
riserva assoluta di legge. La normativa vigente prevede che i regolamenti
10
ministeriali si limitino a definire i criteri generali cui debbono attenersi le fonti
di autonomia. Attualmente poi, tra i regolamenti didattici d’Ateneo e quelli
delle strutture si è stabilito un riparto di competenze maggiormente rispettoso
delle prerogative delle seconde: al regolamento d’Ateneo sono state affidate le
determinazioni più generali, mentre a quelle dei Corsi di studio le scelte più
particolari.
CAPITOLO VII: TEORIA DELLE FONTI NEL PENSIERO DI VEZIO CRISAFULLI
L’intera ricerca crisafulliana sulle fonti del diritto è una ricerca sui confini del
fenomeno normativo. Il primo confine è quello tra diritto e fatto (ordine
deontologico e ordine esistenziale): per Santi Romano il fatto normativo non è
tale perché così qualificato da altra norma ma perché intrinsecamente
normativo.
Il secondo confine viene da Crisafulli ricercato all’interno della categoria degli
atti giuridici, alla quale riconduce gli atti normativi. Elemento comune a tutti gli
atti giuridici è la loro natura di strutture deontologiche: espressive cioè di un
dover essere. All’interno della categoria degli atti giuridici vanno per lui distinti
gli atti normativi in senso stretto, i quali, diversamente dagli altri, sono
costitutivi del diritto oggettivo. La chiave di volta è rappresentata dalla
contrapposizione tra il momento del disporre, in via tendenzialmente generale
e astratta (atti normativi in senso stretto), e il momento del provvedere, caso
per caso e in concreto (atti giuridici che normativi non sono). Il passaggio
successivo è costituito dal richiamo al principio di legalità: il quale, nella
ricostruzione da lui offerta, non implica soltanto la soggezione
dell’Amministrazione alla legge, quanto l’esigenza che tra il momento
normativo e il momento applicativo sussista un necessario scarto, soltanto in
tal modo essendo possibile la comparazione del primo al secondo.
Crisafulli ravvisa nel principio di legalità il più efficace antidoto contro l’arbitrio.
La sua opera non si limita a fissare i confini (esterni) del fenomeno normativo.
Essa si rivolge a individuare una pluralità di altre linee di demarcazione
(interne) lungo due filoni di ricerca:
1. il sistema delle fonti (macrocosmo). L’avvento della Costituzione rigida
decreta il tramonto del principio della supremazia della legge. Tale novità
non si risolve nell’aggiunta di una nuova forma legale (la forma
costituzionale) e quindi di un terzo livello gerarchico ai due preesistenti,
ma dissolve dall’interno lo stesso sistema gerarchico solitamente ripetuto
e insegnato. Crisafulli poi dimostra che il sistema positivo mette in
discussione il rapporto tra la forza e la forma degli atti: in quanto in più
casi la relazione gerarchica si stabilisce su basi sostanziali, o in altri
termini, in funzione del contenuto normativo, anziché del procedimento
formativo. Egli ritiene che da criterio ordinatore esclusivo non possa
neppure fungere il criterio della competenza: nella generalità dei casi
opererebbe in combinazione con altri criteri (e in particolare con il criterio
gerarchico). La revisione di Crisafulli è più radicale: mettendo in
discussione la stessa idea che il sistema si configuri come un universo
retto da equilibri fissi, in cui dalla collocazione di ogni singola fonte,
possa meccanicamente dedursi l’intero spettro dei rapporti dalla stessa
intrattenuti con tutte le altre.
11
2. l’atto in sé considerato (microcosmo). L’indagine sull’atto è un’analisi di
tipo strutturale, rivolta a scomporre il fenomeno nei suoi elementi
costitutivi. Gli elementi portati in luce dall’analisi crisafulliana sono:
l’atto. Il punto di partenza dell’intera riflessione è la riconduzione
dell’atto-fonte alla categoria generale degli atti giuridici; da qui la
configurazione dell’atto-fonte come atto di volontà,
istituzionalmente rivolto a porre norme giuridiche.
la disposizione: possono essere definite come enunciati linguistici
grammaticalmente e sintatticamente unitari e compiuti. La
definizione viene da lui ulteriormente precisata con l’avvertenza
che non tutti gli enunciati dotati di tali caratteristiche possono
qualificarsi disposizioni in senso stretto: ad aversi disposizione
infatti si richiede che l’enunciato esprima una volontà prescrittivi,
ancorché non necessariamente coincidente con la volontà storica
dei suoi autori.
la norma: la nozione contenutistica delle disposizioni non comporta
la loro piena e totale identificazione con le norme. La sua
speculazione è alimentata dall’esame delle figure di confine: a)
norme senza disposizioni (principi generali non formulati e norme
create dall’ordine di esecuzione); b) disposizioni linguisticamente
inscindibili, espressive di una pluralità di norme, che possono
essere reciprocamente compatibili o incompatibili; c) disposizioni
meramente ripetitive; d) disposizioni meramente abrogative.
L’accoglimento di queste premesse non poteva non portarlo a una decisiva
valorizzazione del ruolo creativo della giurisprudenza, la quale adempie a una
funzione di chiusura del sistema: conferendo a esso, nel momento
dell’applicazione, quell’univocità e quella coerenza di cui è intrinsecamente
privo. È infatti alla giurisdizione che l’ordinamento assegna la funzione di
accertare , in relazione alle singole controversie concrete, la consistenza del
diritto oggettivo: onde la tendenziale risoluzione della norma vera nella norma
vivente. Nei moderni ordinamenti statali si considera vera la norma
determinata nel suo significato dall’autorità giudiziaria di grado più elevato.
CAPITOLO VIII: LE PUBBLICAZIONI NORMATIVE
Una pubblicità, sia pure minima, è coessenziale alla struttura stessa delle fonti
normative. Le pubblicazioni normative presenti negli ordinamenti costituzionali
contemporanei non soddisfano solo esigenze proprie dell’ordinamento (perché
l’ordinamento valga in fatto occorrono mezzi di comunicazione tra i soggetti
produttori di diritto obiettivo e coloro che sono tenuti a eseguirne le
determinazioni), ma adempiono anche a una funzione garantistica (istituiscono
un nesso tra obbligatorietà delle norme e la diffusione della loro conoscenza
all’interno della comunità). L’evento cui tale svolta è riconducibile è individuato
nell’istituzione del primo periodico ufficiale: il Bulletin des lois de la République,
avvenuta in Francia nel corso della rivoluzione (1791).
Attraverso le moderne pubblicazioni normative l’ordinamento rende pubblico il
tenore letterale delle sue fonti. Essendo concepite in funzione della collettività
si differenziano dai meccanismi rivolti a produrre uno stato di conoscibilità
particolare (notificazioni).
12
I diritti positivi contemporanei tendono a distinguere la pubblicazione degli atti
normativi da altre forme di pubblicità (diretta o indiretta) degli stessi quali:
l’ammissione del pubblico alle sedute parlamentari, la promulgazione, il
deposito degli originali in archivi pubblici.
La pubblicazione in senso stretto è caratterizzata da un connotato positivo, in
quanto attraverso essa, l’ordinamento non si limita a consentire la conoscenza
dei propri precetti, ma predispone dei congegni rivolti a favorirla.
Con riferimento alla rilevanza giuridica, le pubblicazioni normative si
distinguono in pubblicazioni legali e di fatto.
Tra le pubblicazioni giuridicamente rilevanti vi sono quelle cosiddette
necessarie, non perché obbligatorie per gli organi cui sono demandate ma
perché la loro effettuazione rappresenta l’insopprimibile presupposto
dell’entrata in vigore degli atti cui si riferiscono. Tra le pubblicazioni, legali, ma
non necessarie rientrano tanto gli adempimenti pubblicitari (pubblicazione
legale di norme consuetudinarie), quanto gli adempimenti che, pur se
astrattamente idonei a condizionare l’entrata in vigore, siano posti, dal diritto
positivo, in condizione di non spiegare alcuna incidenza su esso (pubblicazione
di norme poste da fonti-atto).
Un tipo particolare di pubblicazione non necessaria è rappresentato dalla
ripubblicazione (attività pubblicitarie relative ad atti normativi i quali abbiano
già formato oggetto di una pubblicazione necessaria). L’ipotesi comune è
quella dei testi unici meramente compilativi, i quali, lungi dal rinnovare la fonte
dei precetti in essi contenuti, si limitano ad agevolarne la lettura.
La conoscibilità pubblica che le pubblicazioni normative sono suscettibili di
realizzare non presenta i caratteri di una costante, ma quelli di una variabile,
strettamente condizionata dal modo d’essere degli adempimenti pubblicitari
utilizzati.
Mentre alcuni di tali adempimenti sono rivolti a realizzare una situazione di
conoscibilità di tipo eminentemente preventivo (notorietà), altri appaiono
preordinati ad assicurare la durevole ostensibilità e la materiale inalterabilità
del proprio oggetto (certezza).
Nell’esperienza contemporanea è privilegiata la seconda funzione. (Certezza
derivante dai fogli legali perché si sostanziano in forme rappresentative
suscettibili di permanere nel tempo e si incarnano in una pluralità di esemplari
identici).
Passando a considerare la certezza della data della pubblicazione necessaria
essa può essere assicurata dal foglio legale (ordinamento italiano: la
certificazione del momento in cui la pubblicazione si è perfezionata è offerta
dallo stesso periodico preordinato a realizzarla), o da adempimenti diversi
(ordinamenti che, secondo il modello francese, fanno decorrere gli effetti della
pubblicazione dall’arrivo del foglio legale nei capoluoghi di provincia).
La funzione di certezza non esclude la funzione di notorietà. Pubblicazioni di
natura complessa: comprendono, oltre all’inserzione nel foglio legale,
operazioni divulgative locali, nella forma di affissioni, pubbliche letture ecc., e
subordinano all’effettuazioni di tali operazioni l’entrata in vigore degli atti
normativi (codice albertino). Poi la funzione di notorietà può essere perseguita
anche da pubblicazioni di natura non complessa : ciò accade quando, per
effetto di una previsione positiva, tali pubblicazioni non possano produrre
13
l’effetto dell’entrata in vigore degli atti che ne formano l’oggetto se non dopo
un intervallo temporale (vacatio legis) insopprimibile, o comunque non
riducibile oltre un certo limite.
Alla tesi secondo cui la pubblicazione costituirebbe parte integrante del
procedimento legislativo, fa riscontro la diversa teoria secondo cui il
procedimento legislativo si perfezionerebbe anteriormente alla pubblicazione,
la quale rivestirebbe una posizione meramente accessoria e servente. Dagli
arti. 70 e 73 Cost, si desume che la pubblicazione, pur condizionando l’entrata
in vigore degli atti legislativi, non costituisce esercizio della funzione che in tali
atti si esprime (la quale rappresenta un’esclusiva parlamentare).
CAPITOLO IX: L’ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO INTERNO AL DIRITTO
INTERNAZIONALE
Le dottrine dualistiche muovono da due presupposti fondamentali:
a) il presupposto della separazione tra l’ordinamento internazionale e gli
ordinamenti nazionali; da che si deduce che l’immissione nello Stato di valori
normativi di ascendenza internazionale, sia possibile in quanto lo Stato si apra
a essi, richiamandoli nel proprio ordinamento;
b) il presupposto della diversità strutturale delle norme espresse da tali
ordinamenti; da che si argomenta che tale richiamo non si risolva in una
recezione, in una mera novazione della fonte. Per questo è stata creata la
categoria dell’adattamento del diritto interno al diritto internazionale.
Infatti alla recezione si opporrebbe la tritura delle norme: le norme
internazionali vengono a esistenza in un ordinamento in cui l’elemento
personale è costituito da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il processo mediante il quale gli Stati si appropriano di regole di ascendenza
internazionale è denominato, dalla dottrina tedesca, trasformazione del diritto
internazionale in diritto statale.
In dottrina si distinguono due tipi di strumenti di adattamento:
1. procedimento ordinario: trova impiego quando lo Stato, in via
legislativa o regolamentare, formula direttamente le norme che
ritiene necessarie a conformare l’ordinamento interno alle esigenze
derivanti da un accordo o da una consuetudine internazionale;
2. procedimenti speciali: ordine di esecuzione e dispositivo automatico
di adattamento. Mediante essi i due ordinamento sono posti in
comunicazione.
L’ordine di esecuzione consiste in un atto normativo nazionale, il quale, anziché
formulare direttamente le norme che pone, le individua per relationem,
facendo rinvio a un accordo internazionale (piena e intera esecuzione è data al
trattato…). Esso è comunemente adottato in forma legislativa o regolamentare.
Scopo ed effetto di tale atto è l’immissione nell’ordinamento statale delle
norme necessarie all’esecuzione del trattato cui accede. L’ordine di esecuzione
può conseguire l’obiettivo in funzione del quale è adottato in quanto l’accordo
cui si riferisce sia suscettibile di essere immediatamente adottato (prescrizioni
self executing). Qualora le clausole pattizie, rivestendo carattere non self
executing, richiedano per poter essere concretamente applicate, l’emanazione
di norme di attuazione, la mera adozione dell’ordine di esecuzione non può
considerarsi sufficiente. Essendo rivolto a porre norme di tipo interindividuale
14
l’ordine di esecuzione non può appropriarsi delle prescrizioni pattizie
(indirizzate agli Stati), ma deve trasformarle in regole strutturalmente
omogenee a quelle del sistema cui appartiene. L’ordine di esecuzione va
annoverato tra le fonti-atto eccezionalmente produttive di diritto non scritto. È
vero che l’accordo cui esso accede, prendendo corpo in un testo, riveste forma
scritta. Tuttavia gli enunciati di cui tale testo si compone esprimono i precetti
internazionali e non le norme di adattamento, le quali mancano di
un’autonoma formulazione e vanno concretamente individuate dall’interprete.
Mentre l’ordine di esecuzione ha a oggetto gli atti, singolarmente considerati, il
dispositivo di adattamento automatico procede alla nazionalizzazione delle fonti
internazionali, riconoscendo a queste l’idoneità a produrre norme interne di
adattamento. Esso pertanto opera come un trasformatore permanente, in virtù
del quale il diritto dello Stato è posto in condizione di tener dietro all’incessante
ricambio normativo che si verifica nell’ordinamento internazionale; e di
appropriarsi delle regole che in questo, di volta in volta, vengono a esistenza.
Nella Costituzione italiana a take funzione adempie l’art. 10 comma 1, ai sensi
del quale “l’ordinamento si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute”. È opinione pressoché pacifica che la disposizione si
riferisca esclusivamente alle consuetudini internazionali generali (l’accordo è
inidoneo a creare a norme generali, poi l’adattamento alle norme patrizie
richiede il ricorso ad altri procedimenti: ordine di esecuzione o procedimento
ordinario).
In mancanza di chiare indicazioni positive problemi si pongono a proposito
della collocazione gerarchica delle norme di adattamento al diritto
internazionale generale. Incontroverso è che esse prevalgono sulle leggi
ordinarie e sugli atti a queste equiparate. Dubbia è invece la loro posizione nei
confronti delle norme costituzionali. In dottrina e in giurisprudenza si afferma
alternativamente che: a) prevalenze delle norme di adattamento (Quadri); b)
prevalenza della Costituzione (La Pergola); c) quella dei principi fondamentali
dell’ordinamento costituzionale dello Stato (corte costituzionale). Tra queste
solo la prima tesi appare da respingere.
15