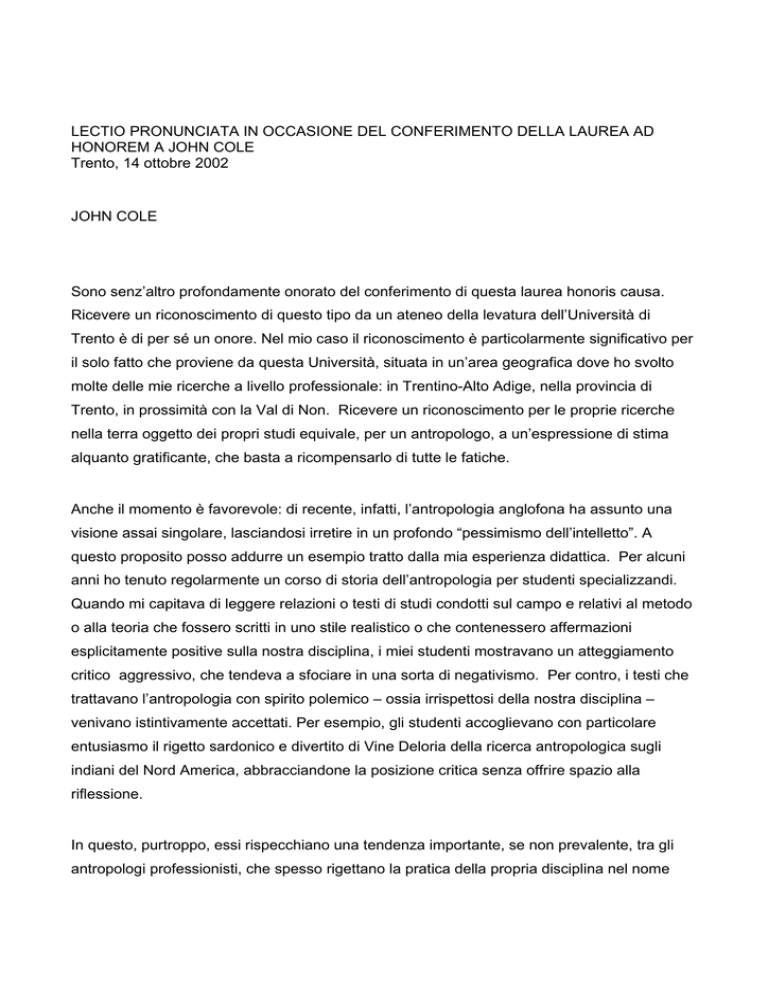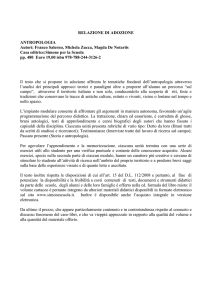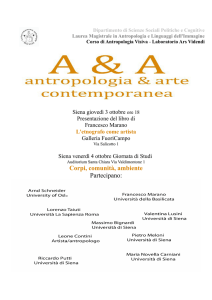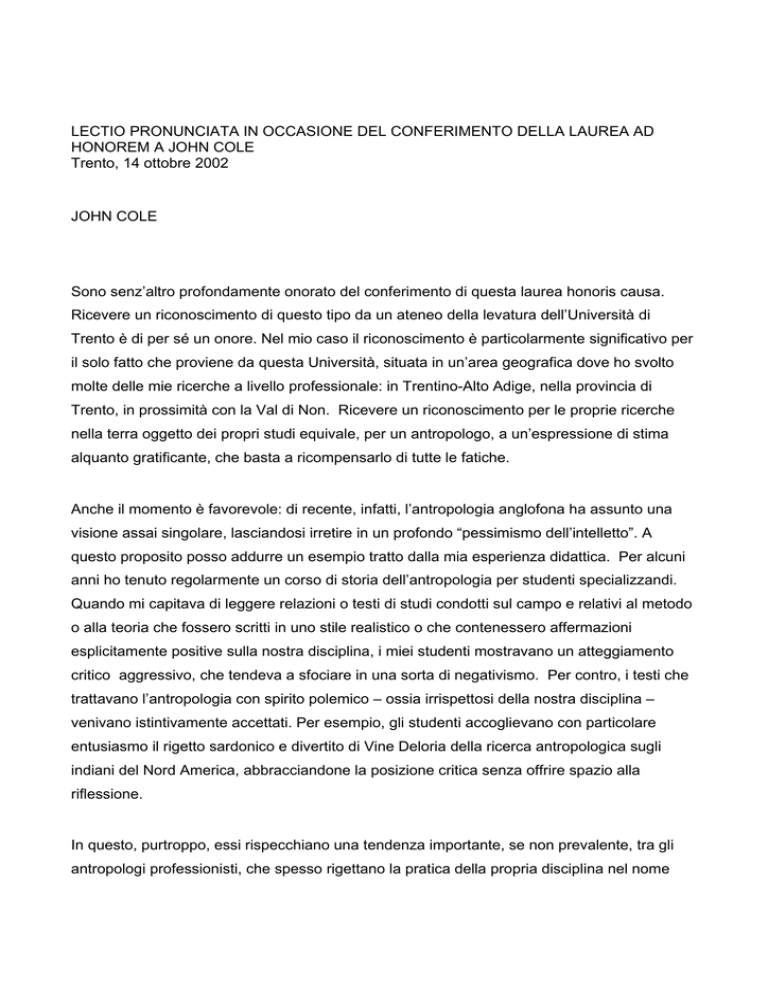
LECTIO PRONUNCIATA IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA LAUREA AD
HONOREM A JOHN COLE
Trento, 14 ottobre 2002
JOHN COLE
Sono senz’altro profondamente onorato del conferimento di questa laurea honoris causa.
Ricevere un riconoscimento di questo tipo da un ateneo della levatura dell’Università di
Trento è di per sé un onore. Nel mio caso il riconoscimento è particolarmente significativo per
il solo fatto che proviene da questa Università, situata in un’area geografica dove ho svolto
molte delle mie ricerche a livello professionale: in Trentino-Alto Adige, nella provincia di
Trento, in prossimità con la Val di Non. Ricevere un riconoscimento per le proprie ricerche
nella terra oggetto dei propri studi equivale, per un antropologo, a un’espressione di stima
alquanto gratificante, che basta a ricompensarlo di tutte le fatiche.
Anche il momento è favorevole: di recente, infatti, l’antropologia anglofona ha assunto una
visione assai singolare, lasciandosi irretire in un profondo “pessimismo dell’intelletto”. A
questo proposito posso addurre un esempio tratto dalla mia esperienza didattica. Per alcuni
anni ho tenuto regolarmente un corso di storia dell’antropologia per studenti specializzandi.
Quando mi capitava di leggere relazioni o testi di studi condotti sul campo e relativi al metodo
o alla teoria che fossero scritti in uno stile realistico o che contenessero affermazioni
esplicitamente positive sulla nostra disciplina, i miei studenti mostravano un atteggiamento
critico aggressivo, che tendeva a sfociare in una sorta di negativismo. Per contro, i testi che
trattavano l’antropologia con spirito polemico – ossia irrispettosi della nostra disciplina –
venivano istintivamente accettati. Per esempio, gli studenti accoglievano con particolare
entusiasmo il rigetto sardonico e divertito di Vine Deloria della ricerca antropologica sugli
indiani del Nord America, abbracciandone la posizione critica senza offrire spazio alla
riflessione.
In questo, purtroppo, essi rispecchiano una tendenza importante, se non prevalente, tra gli
antropologi professionisti, che spesso rigettano la pratica della propria disciplina nel nome
della riflessività e della decostruzione. Se, da un lato, a essere chiamata in causa è
l’antropologia tutta, dall’altro lato, alcuni studiosi in particolare tendono a essere presi di mira
e condannati. Vi sono colleghi, infatti, che ripudiano l’antropologia cosiddetta “modernista” del
passato e si accaniscono contro quegli studiosi che considerano come i professionisti dell’età
moderna. Il loro bersaglio sono antropologi famosi dello stampo di Margaret Mead e
Bronislaw Malinowski, tra i viventi, e di Napoleon Chagnon. Forse avete avuto modo di
imbattervi nelle critiche a questi studiosi durante le vostre letture, per esempio nei recenti
articoli del Times Literary Supplement.
Talvolta questi attacchi assumono toni anche violenti, come dimostrano i veri e propri
isterismi ai danni di Napoleon Chagnon e del compianto James V. Neal. I quali sono stati
diffamati sia nell’opera Darkness in El Dorado sia, nei mesi successivi alla sua
pubblicazione, in Internet, nel corso di pubbliche conferenze o da parte della stampa. Tale
offensiva è culminata in una convulsa conferenza di massa, l’assemblea annuale della
American Anthropology Association, tenutasi a San Francisco nel novembre 2000, in
occasione della quale i due studiosi sono stati apertamente condannati. Un collega europeo
che si trovava tra il pubblico mi ha confidato di essersi rammentato di taluni testi che
descrivevano la caccia alle streghe di Salem nel Massachusetts.
Questi comportamenti sono un’efficace cartina al tornasole della crisi in cui versa
l’antropologia moderna. Personalmente ritengo che, in un certo senso, questa crisi possa
essere considerata fisiologica. Sia l’antropologia sia le scienze sociali in generale hanno
continuato a proclamarsi discipline in crisi, perlomeno negli ultimi trent’anni. Basti pensare,
per esempio, all’opera di Alvin Gouldner del 1970, The Coming Crisis in Western Sociology.
In passato, tuttavia, gli studiosi che, come Gouldner, lanciavano grida d’allarme sapevano
anche proporre una soluzione ai problemi individuati. Al contrario, coloro che oggi lamentano
la crisi disperano di trovare una soluzione, da un lato, oppure, dall’altro lato, annunciano
senza mezzi termini la morte dell’antropologia.
Tanto rumore per nulla? Purtroppo, non è così. Per quanto sgradevoli siano diventati gli
atteggiamenti di taluni colleghi, non varrebbe la pena preoccuparsene, se fossero confinati
alla discussione accademica. L’attacco mosso all’antropologia, invece, non proviene soltanto
dal suo interno, bensì da soggetti appartenenti alle culture che abbiamo studiato e dai loro
paladini occidentali, dai colleghi esperti in altre discipline, da eminenti personaggi pubblici.
Durante la sua campagna per le elezioni presidenziali Bob Dole utilizzò come arma a suo
parere ideale per diffamare il proprio rivale l’accusa di avere idee simili a “quelle che
potrebbero essere concepite in una facoltà di sociologia”, per dirla con le sue parole. I politici
e i commentatori del centrodestra mettono costantemente in ridicolo l’antropologia e le altre
scienze sociali, accusandole, tra le altre cose, di “minare le tradizioni e i valori del capitalismo
democratico”. Verrebbe da pensare che, negli Stati Uniti, questi attacchi alla nostra disciplina
rappresentino un punto del programma politico dell’estremismo di destra.
Anche altri, però, pur essendo politicamente meno motivati, proclamano il declino
dell’antropologia, adducendo al fatto che la nostra è ormai una disciplina priva di un oggetto
di studio, dal momento che i cosiddetti “primitivi” o le cosiddette “popolazioni tribali”, che in
passato hanno offerto materia di indagine all’antropologo, sono oggi cittadini di nazioni,
partecipi dell’economia globale, destinatari del flusso di informazioni a livello mondiale.
L’insigne sociologo della SUNY-Binghamton, Immanual Wallerstein, è tra coloro che
sostengono che l’antropologia, priva ormai di legittimità intellettuale, è una scienza
agonizzante, ridotta a una sorta di sociologia di secondo ordine.
Tutto ciò ha un effetto di disturbo sull’attuale pratica antropologica.
Il mio desiderio, oggi, è quello di offrire alcune riflessioni su queste curiose passioni e sulla
loro origine.
Prima, tuttavia, vorrei fare una digressione e spendere qualche parola sui possibili
fraintendimenti a cui può dare adito il mio uso del termine “antropologia”. A questo termine
non riconosco il significato che gli viene conferito nella maggior parte dei paesi europei; né
ritengo che l’antropologia coincida esattamente con l’“etnologia”, benché le due discipline
mostrino una certa affinità e coesistano in una serie di organizzazioni internazionali.
Ovviamente, l’“antropologia” esiste anche in Europa, dove, tuttavia, è intesa nell’accezione di
antropologia fisica o biologica usata nell’America del Nord o in Gran Bretagna. (Spero sia
chiaro a tutti che io non sono particolarmente interessato ai resti di ossa!) Di recente anche in
Europa più di uno studioso ha cominciato a definirsi antropologo sociale o culturale.
Si potrebbe trascorrere anche un’ora o due a tentare di distinguere i diversi usi dei termini
antropologia, antropologia sociale, antropologia culturale, etnologia, etnologia d’oltreoceano,
etnografia e così via.
Oggi mi limiterò a utilizzare il termine “antropologia” nel senso di antropologia culturale e
sociale, così come essa viene intesa nell’America del Nord e in Gran Bretagna nonché in tutti
i paesi da questi culturalmente influenzati. È evidente che l’antropologia sociale esiste anche
in Francia; tuttavia, nonostante i numerosi agganci con l’uso anglofono, non intendo farvi
riferimento in questa occasione. Mi riferirò invece all’“etnologia” secondo l’accezione in uso
nella gran parte dei paesi europei.
Le due discipline sono nate nel corso del XIX secolo in paesi diversi, con alcune rare
eccezioni. L’antropologia, per usare l’espressione di un collega canadese, è “figlia
dell’imperialismo”. Essa infatti si è evoluta soprattutto nelle nazioni che hanno creato enormi
imperi nei territori d’oltremare o, come è accaduto per il Canada, il Messico e gli Stati Uniti,
che hanno costituito tali imperi entro i propri confini, alle spese delle popolazioni indigene.
Come ha affermato l’etnologo svedese Orvar Lofgren, gli antropologi sono numerosissimi in
Olanda e sono ben rappresentati anche nell’America del Nord, in Gran Bretagna, Francia e
Svezia.
A giustificare la nascita di questa scienza è stata la sua utilità nell’aiutare gli occidentali a
interagire con le popolazioni stanziate in diverse regioni del mondo a scopi commerciali,
missionari, di conquista o di governo.
L’etnologia, invece, si è diffusa soprattutto negli Stati emersi nel corso del XIX secolo, tra cui
l’Italia e la Germania, oltre che in tutti i paesi nati dalla disgregazione dei grandi imperi
dell’Europa centrale e orientale. Il suo obiettivo era quello di contribuire allo sviluppo e alla
definizione delle caratteristiche culturali delle singole nazioni.
In parte, quindi, le due scienze, antropologia ed etnologia, condividono lo stesso campo
d’indagine, perlomeno in maniera sufficiente da consentire il dialogo. E, tuttavia, avendo
“missioni” diverse, esse hanno avuto fulcri d’interesse tendenzialmente diversi: l’una
concentrandosi sui fenomeni sociali, anche a livello economico e politico, l’altra rivolgendosi
più frequentemente allo studio di oggetti materiali, pratiche e convinzioni folcloristiche.
Alcuni paesi, ossia Italia e Germania, sono nati come Stati nel XIX secolo e, pur essendosi
gettati nella mischia con un certo ritardo, hanno ambito anch’essi a diventare imperi coloniali.
È per questo motivo che in questi Stati hanno preso piede sia l’etnologia che l’antropologia (in
Germania la prima è detta Volkskunde, ossia studio del popolo – “Volk” [germanico] – la
seconda Volkerkunde, ossia studio delle [numerose] popolazioni).
Questa, beninteso, è una semplificazione estrema di una realtà molto più complessa, di cui
tuttavia voglio approfittare per esporre due concetti tra loro interrelati. Il primo è che la
formazione di una disciplina dell’antropologia non è inevitabile. Questa scienza, cioè, è il
prodotto di un particolare insieme di circostanze verificatesi in una determinata epoca storica.
Il secondo è che, una volta venute meno tali circostanze, la sopravvivenza dell’antropologia è
diventata problematica.
Dunque.
Talvolta gli antropologi rivendicano per la propria disciplina un’origine che sprofonderebbe le
proprie radici nella Grecia del V secolo a. C.: Erodoto è il “padre della storia”, ma è altresì
riconosciuto come “padre dell’antropologia”. Vero è che, nell’arco dei secoli, vi sono stati altri
insigni commentatori della vita degli stranieri. E, tuttavia, le origini dell’antropologia come
disciplina accademica risalgono al XIX e alla creazione del moderno sistema universitario.
Nell’ambito della divisione del lavoro a livello accademico, essa derivò da un’economia
politica per così dire primitiva. Discipline quali l’economia, la sociologia, le scienze politiche e
la psicologia si ripartirono lo studio della civiltà occidentale moderna; l’ambito degli studi
orientali si sviluppò per indagare le civiltà non europee nel “vicino” e nel “lontano Oriente”.
(Tra parentesi, una delle stranezze della cultura nordamericana è che, per raggiungere
l’Estremo Oriente, occorre viaggiare in direzione ovest.) All’antropologia rimasero gli avanzi,
ossia “le popolazioni stanziate in regioni arretrate”, i “selvaggi” e i “barbari” primitivi, come
venivano chiamati dalle scienze sociali ottocentesche.
L’antropologia, dunque, emerse in un periodo in cui le potenze europee stavano consolidando
il proprio controllo sulle rispettive colonie. La problematica cardine attorno alla quale iniziò a
organizzarsi fu il grado di interrelazione tra i diversi aspetti biologici, culturali e linguistici. Si
trattava di una questione pratica cara alle potenze coloniali europee, su cui gravava “il
fardello dell’uomo bianco”. I bilanci richiesti dalla ricerca antropologica si giustificavano con
l’utilità di questa disciplina, la quale semplificava gli scambi commerciali, facilitava il
proselitismo religioso, agevolava il processo di conquista e il controllo governativo. Essa
assolveva a questi compiti analizzando la natura delle società primitive prima della conquista
europea. Gli studi antropologici, infatti, venivano condotti quasi esclusivamente nelle colonie
o nelle riserve o ancora nell’“entroterra” dei paesi colonizzatori, nel cosiddetto “mondo
sottosopra” e nell’America del Nord.
L’antropologia si affermò, in tal modo, tra le scienze dell’“uomo” (da quanto mi risulta, le
donne furono scoperte soltanto negli anni 1960), abbracciandone l’impegno all’obiettivismo e
al positivismo. E, se negli anni vennero a formarsi diverse tradizioni intellettuali, questi
obiettivi continuarono a caratterizzare l’antropologia anche nel secondo dopoguerra.
Dopodiché… tutto cambiò!
I cambiamenti iniziarono con il processo di decolonizzazione successivo alla seconda guerra
mondiale. “Indipendenza” significò che le ex colonie cessarono di essere territori amministrati
e assursero allo stato di paesi indipendenti, i cui abitanti divennero cittadini di Stati politici,
responsabili (perlomeno all’apparenza) del controllo della propria economia, della propria
politica e della propria società. Questa novità ebbe un profondo impatto sulla prassi
antropologica, per tre motivi principali.
In primo luogo, dal momento in cui queste società acquistarono una propria dinamica, esse
vennero assorbite nel campo di indagine delle altre scienze sociali. Tutti (economisti, studiosi
di scienze politiche, sociologi) cominciarono a proporre progetti interessanti. E, per
conseguenza, gli antropologi persero la propria esclusiva conoscenza di queste popolazioni.
Essi furono costretti, tra le altre cose, a condividere e a reclamare le risorse necessarie per
effettuare le proprie ricerche.
In secondo luogo, con la comparsa sulla scena delle popolazioni indigene, gli antropologi si
videro obbligati a giustificare i loro progetti, inglobando anche gli interessi e le questioni care
alle popolazioni locali. L’accesso dei ricercatori ai nuovi paesi doveva essere negoziato e
considerato accettabile agli occhi dei potenziali individui oggetto di studio. Non di rado gli
antropologi vennero considerati persone non gradite.
Infine, la ricerca antropologica fu sottoposta alla critica locale. La legittimità dell’obiettivo
antropologico di voler analizzare la natura della società intonsa, qual era nell’epoca
precedente il contatto con la cultura europea, fu quasi universalmente rigettata. Oggetto di
un’analoga condanna fu la cecità con cui l’antropologia aveva trattato in precedenza i
fenomeni del colonialismo e dell’imperialismo. L’antropologo fu accusato d’essere uno
strumento dell’imperialismo occidentale.
Molti antropologi si addolorarono di fronte a queste critiche, sia pur in maniera diversa.
Qualcuno, ovviamente, le rigettò in toto, invocando l’obiettività della propria disciplina. Altri
avviarono un dialogo con i propri oppositori, nel sincero tentativo di rendere l’antropologia una
scienza veramente intersoggettiva.
Nel frattempo, altri tasselli vennero ad aggiungersi al mosaico, rendendolo ancor più
complesso. Tra questi vi fu l’ampliamento della materia di studio dell’antropologia. Via via che
altri studiosi iniziavano a interessarsi a quello che tradizionalmente era stato il nostro piccolo
campo di indagine, gli antropologi cominciarono a rivolgere il proprio sguardo verso nuovi
orizzonti. Aggiungere alla materia di studio la società contadina fu un primo, semplice passo:
perlopiù si trattò di prendere in considerazione le istituzioni di origine non locale, come lo
Stato, i mercati nazionali, la chiesa e le scuole. Altrettanto spontaneo e semplice fu includere
nell’oggetto di studio le diverse “sottoclassi” presenti nelle nostre culture. Tra noi vi fu anche
chi rispose alle critiche mosse da Laura Nader (secondo cui gli antropologi si limiterebbero a
studiare i più deboli), raccogliendo il suo famoso invito ad “alzare il tiro” della ricerca. Fu così
che iniziammo ad ampliare i nostri orizzonti e a individuare il modo per studiare le élite della
società.
La guerra fredda partorì un’altra complessità: l’antropologia fu chiamata a partecipare alle
attività di stampo bellico. Di questo si ebbe un primo sentore già durante la seconda guerra
mondiale, quando gli antropologi capitanati da Ruth Benedict intrapresero una serie di “studi
a distanza” di nemici e alleati. Finanziati dal governo statunitense, essi avevano il compito di
esaminare le caratteristiche culturali che avrebbero potuto rivelarsi utili alle iniziative militari.
Durante la guerra fredda gli antropologi vennero contattati da enti addetti allo scambio, quali
Fulbright e IREX, per avviare le proprie ricerche nei paesi del blocco sovietico. Inoltre, gli
organi statali, tra cui la CIA, reclutavano gli antropologi per portare avanti le ricerche nell’Asia
sud-orientale, in America latina e altrove. In tal caso, si trattava perlopiù di ricerche
clandestine.
Uno dei risultati di questo allargamento dell’oggetto di studio fu l’impossibilità di continuare a
definire l’antropologia unanimemente sulla base del suo oggetto di studio, come succedeva
invece nel XIX e nella prima metà del XX secolo. Come ho sottolineato poc’anzi, in quei
decenni l’antropologia veniva comunemente associata ai “popoli primitivi”, sui quali poteva
rivendicare una certa esclusività di ricerca. Negli ultimi decenni del XX secolo si cominciò a
discutere da più parti in merito alla natura di tale disciplina, senza che tuttavia fosse possibile
trovare un punto di accordo. Qualche anno fa la American Anthropology Association lanciò
un’iniziativa per arrivare a una definizione comune di antropologia. Questo tentativo, tuttavia,
protrattosi per un anno, non portò alcun frutto, ma si limitò a constatare la perdita, da parte di
questa scienza, di un’identità definita. Come ebbe modo di sottolineare Eric Wolf: “Si fanno
tante divisioni e suddivisioni e alla fine la si chiama antropologia”.
Oggi, dunque, all’alba del XXI secolo, l’antropologia si trova schierata in difesa: la destra
politica dubita della sua dimensione critica e l’accusa di minare i suoi valori e le sue
convinzioni, riducendola nella migliore delle ipotesi a mero strumento della politica liberale. Il
centro, a essere sinceri, non sembra molto interessato ad essa. Al contrario: nei cosiddetti
“studi culturali” presenta questa disciplina una versione un po’ slavata, che tende a ignorarne
gli aspetti più sconvenienti. La sinistra, negli Stati Uniti, tende a diffidare dell’antropologia
intesa come istituzione, preferendo far proseliti tra molti dei suoi praticanti.
E lei, l’antropologia, si mostra profondamente lacerata. Oggi ho messo in luce soltanto un
aspetto forse irrilevante di questa spaccatura, ossia la strana introversione che finisce per
disconoscere la missione originale di questa disciplina e a diffamarne sia i primi
rappresentanti sia i contemporanei che a tale missione vogliono rimanere fedeli.
Note e bibliografia
Il titolo inglese (“Wicked cool anthropology”) intende creare un’ironica ambiguità sfruttando la
polisemia di due termini: (a) l’aggettivo “wicked”, che tradizionalmente significa malvagio,
malefico, dannoso o cattivo, ma che, sul finire del XX secolo, ha acquisito l’ulteriore
significato di eccellente, come nell’espressione “He plays a wicked game of tennis” (Gioca a
tennis in maniera straordinaria); e l’aggettivo (b) “cool”, che in questo contesto può significare
“eccellente, di prima classe” e, nel contempo, “superiore o alla moda”.
The Culture Cult: Designer Tribalism and other Essays, di Roger Sandall (Oxford: Westview
Press, 2002)
Darkness in El Dorado: how scientists and journalists devastated the Amazon, di Patrick
Tierney (New York, Norton Press, 2000).
Gouldner, Alvin W. The Coming Crisis in Western Sociology (Basic Books, Boston 1970)
Negli Stati Uniti l’“antropologia” indaga i fenomeni culturali, biologici, archeologici e linguistici,
nonché le interazioni tra tali fenomeni. In questa sede, tuttavia, utilizzo il termine in un senso
più ristretto, intendendo con esso semplicemente l’antropologia culturale e sociale.
L’aggettivo inglese “dis” o “dissed” significa “irrispettoso”. Si tratta di un’altra parola
colloquiale, se non gergale, diffusasi alla fine del XX secolo.