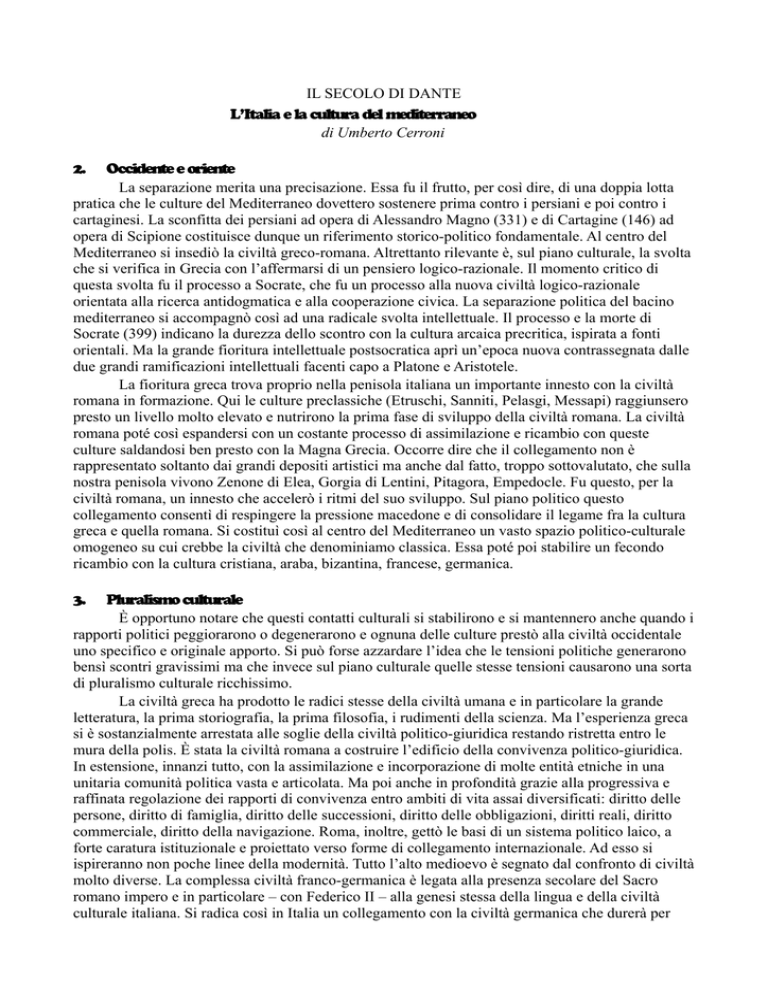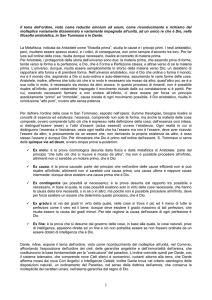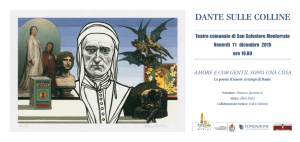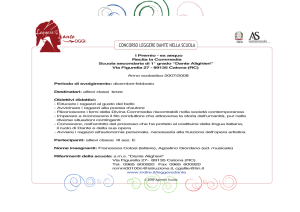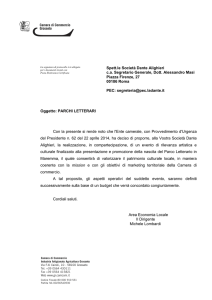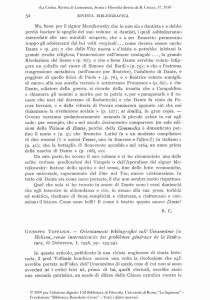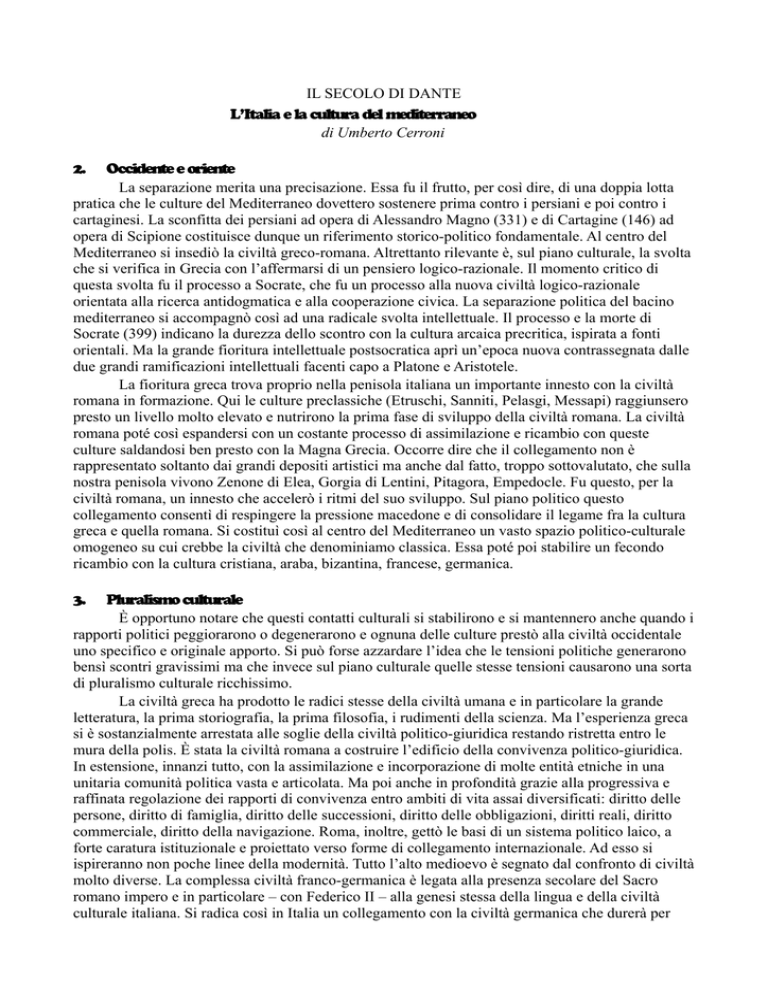
IL SECOLO DI DANTE
L’Italia e la cultura del mediterraneo
di Umberto Cerroni
2.
Occidente e oriente
La separazione merita una precisazione. Essa fu il frutto, per così dire, di una doppia lotta
pratica che le culture del Mediterraneo dovettero sostenere prima contro i persiani e poi contro i
cartaginesi. La sconfitta dei persiani ad opera di Alessandro Magno (331) e di Cartagine (146) ad
opera di Scipione costituisce dunque un riferimento storico-politico fondamentale. Al centro del
Mediterraneo si insediò la civiltà greco-romana. Altrettanto rilevante è, sul piano culturale, la svolta
che si verifica in Grecia con l’affermarsi di un pensiero logico-razionale. Il momento critico di
questa svolta fu il processo a Socrate, che fu un processo alla nuova civiltà logico-razionale
orientata alla ricerca antidogmatica e alla cooperazione civica. La separazione politica del bacino
mediterraneo si accompagnò così ad una radicale svolta intellettuale. Il processo e la morte di
Socrate (399) indicano la durezza dello scontro con la cultura arcaica precritica, ispirata a fonti
orientali. Ma la grande fioritura intellettuale postsocratica aprì un’epoca nuova contrassegnata dalle
due grandi ramificazioni intellettuali facenti capo a Platone e Aristotele.
La fioritura greca trova proprio nella penisola italiana un importante innesto con la civiltà
romana in formazione. Qui le culture preclassiche (Etruschi, Sanniti, Pelasgi, Messapi) raggiunsero
presto un livello molto elevato e nutrirono la prima fase di sviluppo della civiltà romana. La civiltà
romana poté così espandersi con un costante processo di assimilazione e ricambio con queste
culture saldandosi ben presto con la Magna Grecia. Occorre dire che il collegamento non è
rappresentato soltanto dai grandi depositi artistici ma anche dal fatto, troppo sottovalutato, che sulla
nostra penisola vivono Zenone di Elea, Gorgia di Lentini, Pitagora, Empedocle. Fu questo, per la
civiltà romana, un innesto che accelerò i ritmi del suo sviluppo. Sul piano politico questo
collegamento consentì di respingere la pressione macedone e di consolidare il legame fra la cultura
greca e quella romana. Si costituì così al centro del Mediterraneo un vasto spazio politico-culturale
omogeneo su cui crebbe la civiltà che denominiamo classica. Essa poté poi stabilire un fecondo
ricambio con la cultura cristiana, araba, bizantina, francese, germanica.
3.
Pluralismo culturale
È opportuno notare che questi contatti culturali si stabilirono e si mantennero anche quando i
rapporti politici peggiorarono o degenerarono e ognuna delle culture prestò alla civiltà occidentale
uno specifico e originale apporto. Si può forse azzardare l’idea che le tensioni politiche generarono
bensì scontri gravissimi ma che invece sul piano culturale quelle stesse tensioni causarono una sorta
di pluralismo culturale ricchissimo.
La civiltà greca ha prodotto le radici stesse della civiltà umana e in particolare la grande
letteratura, la prima storiografia, la prima filosofia, i rudimenti della scienza. Ma l’esperienza greca
si è sostanzialmente arrestata alle soglie della civiltà politico-giuridica restando ristretta entro le
mura della polis. È stata la civiltà romana a costruire l’edificio della convivenza politico-giuridica.
In estensione, innanzi tutto, con la assimilazione e incorporazione di molte entità etniche in una
unitaria comunità politica vasta e articolata. Ma poi anche in profondità grazie alla progressiva e
raffinata regolazione dei rapporti di convivenza entro ambiti di vita assai diversificati: diritto delle
persone, diritto di famiglia, diritto delle successioni, diritto delle obbligazioni, diritti reali, diritto
commerciale, diritto della navigazione. Roma, inoltre, gettò le basi di un sistema politico laico, a
forte caratura istituzionale e proiettato verso forme di collegamento internazionale. Ad esso si
ispireranno non poche linee della modernità. Tutto l’alto medioevo è segnato dal confronto di civiltà
molto diverse. La complessa civiltà franco-germanica è legata alla presenza secolare del Sacro
romano impero e in particolare – con Federico II – alla genesi stessa della lingua e della civiltà
culturale italiana. Si radica così in Italia un collegamento con la civiltà germanica che durerà per
secoli. I normanni portano in Italia gli elementi di una struttura statale unitaria e centralistica che
avrà sviluppo con Federico II. Ma nello scontro con la Chiesa Federico II – re, poeta e legislatore
italiano – non riuscì a completare l’unificazione della penisola e la costruzione di una sovranità
politica nazionale, che ebbe invece successo in Francia. Ciò non impedì tuttavia un precoce
sviluppo della cultura italiana e la nascita di un pensiero politico molto importante.
4.
Cristianesimo e laicità
Il basso medioevo passa sotto il segno di un confronto crescente tra la civiltà cristiana e
quella laica in formazione. Una prima fase di questo confronto vede il primato della Chiesa di
Roma. Esso poggia su una netta egemonia intellettuale basata sui Vangeli e sulla teologia, sulla
precoce costruzione al centro della penisola italiana di uno Stato teocratico, assoluto, centralizzato e
su una concezione monistica di politica, morale e religione. Da questo primato della chiesa
scaturisce, dopo la conversione delle genti germaniche, la imponente esperienza del Sacro romano
impero, durata fino al 1806. Essa influenza potentemente la cultura politica di Italia, Austria,
Spagna, Germania. Francia e Inghilterra resteranno fuori da questa esperienza grazie alla precoce
crescita di uno Stato laico che rivendica la totale sovranità politica del territorio nazionale.
Nel XII-XIII secolo la cultura cattolica subisce una crisi profonda dovuta a due fatti
rilevantissimi. Il primo è dato dallo scontro con l’impero guidato prima da Federico I, poi, da
Enrico IV e infine da Federico II. In questo contesto entra in crisi la struttura monistica che
dominava la politica e cultura sotto il primato teologico. La crisi politica si accompagna a una forte
crisi intellettuale determinata dalla diffusione del pensiero aristotelico ad opera della cultura araba e
dalla diffusione del pensiero averroista. La teoria averroista delle due verità getta le basi della
autonomia della scienza e della politica nei confronti della fede e della teologia. Dante ne trae la
conseguenza della pari dignità di potere politico e potere religioso, Marsilio ne ricava l’idea della
centralità del popolo e Bartolo quella della piena sovranità della città. Machiavelli completerà la
teorizzazione della autonomia laica della politica. Mentre nell’Occidente il cristianesimo si apre con
Alberto Magno e Tommaso d’Aquino ad un teologismo razionale e accetta di convivere con la
cultura laica, nelle coste meridionali del Mediterraneo il razionalismo averroista viene del tutto
sconfitto. Sulle sponde europee del Mediterraneo si svolge il processo di formazione degli Stati
nazionali, mentre su quelle meridionali dilaga il dispotismo imperiale ottomano.
5. La civiltà laica moderna
I più rilevanti sviluppi politico-istituzionali della modernità la formazione di Stati nazionali
laici e le prime forme di condizionamento dal basso della sovranità politica si hanno in Francia e in
Inghilterra e cioè nei due grandi Paesi che non fanno parte del Sacro romano impero. Le dinastie
regali svolgono in questi due paesi un’importante funzione laica e unificatrice che non trova
riscontri in Italia e nel mondo germanico. Inoltre le due rivoluzioni inglesi del XVII secolo e la
rivoluzione francese del XVIII costituiscono con la rivoluzione olandese e con quella americana gli
eventi decisivi per la civiltà politica moderna.
Nel Mediterraneo, invece, la civiltà laica moderna si costituisce con difficoltà. Un filone
umanistico-rinascimentale (Dante, Marsilio, Bartolo, Galilei, Cartesio) elabora bensì l’autonomia
della politica e della scienza. Ma le nazioni inglobate nel Sacro romano impero restano a lungo
sotto l’influenza della commistione culturale di politica e religione patrocinata dalla Chiesa di
Roma. In particolare l’Italia non riesce a costituire tempestivamente lo Stato nazionale unitario
essendo spezzata a metà della penisola dallo Stato pontificio e imbrigliata nelle contese fra Chiesa e
Impero. Il tema della sovranità politica laica resta rinchiuso nel frantumato sistema dei principati
territoriali germanici e delle esperienze comunali italiane, irrigidite dalle divisioni corporative e
dalle divisioni etnico-regionali. Ciò determina un isolamento della cultura moderna e la nascita di
tendenze politiche localistiche. Le riforme politiche moderne arriveranno in Italia e in Germania
con le campagne napoleoniche: si collegheranno perciò a sottili strati intellettuali ma si
scontreranno con movimenti populisti antidemocratici e clericali legati alle tradizioni arcaiche del
sangue, della terra e di una religiosità a forti contenuti magici.
Il progetto di Gregorio VII fu quello di rivendicare indipendenza e sovranità alla
Chiesa e al Papato. Innocenzo III, che succedette a Celestino III, portò a termine il
programma. Dopo di lui la teocrazia pontificia va declinando naturalmente.
INNOCENZO III: figlio di Trasmondo, de’ conti di Segna, dottissimo in
giurisprudenza per gli studi fatti in Roma, Bologna e Parigi, viene eletto (?) a trentasette
anni. Ricostituisce il dominio temporale della Chiesa.
FEDERICO II: Dante nel Convivio lo chiama “hierico grande2, cioè “gran letterato”; e
nel trattato De vulgari eloquentia, cercano per quale motivo ciò che veniva scritto in
lingua italiana, si diceva scritto in lingua siciliana, afferma che ciò aveva avuto origine
dai tempi di Federico e di Manfredi, re di Sicilia liberali e cortesi, amavano radunare a
corte tutti i maggiori ingegni di quell’epoca.
Ricordano Malespini dice che Federico fu uomo ardito e franco, di grande valore e
scienza, di senno naturale savissimo; che conobbe la lingua latina, il tedesco, il francese,
il greco e il saracino; che fu copioso, largo e cortese.
Tutti dicono che Federico fu fiero persecutore della Chiesa: eppure, per ingraziarsela,
Federico aveva stabilito sanzioni severissime contro gli eretici e, in particolare contro i
patari, ai quali sembra che avesse diretto la condanna destinata, nell’Inferno, agi
ipocriti.
I dissidi con la Chiesa iniziarono perché i prelati non vollero mostrargli il conto
dell’amministrazione del regno tenuta nella minor età di Federico. E perché bandì dal
suo stato gli ordini dei francescani e dei domenicani, venne dichiarato eretico (Inf. XIII
75). (Eretico e non scomunicato).
A Federico II succede il figlio Corrado IV, già scomunicato dal papa Innocenzo IV,
che muore a 26 anni. A lui succede Manfredi (incoronato re di Sicilia nel 1258) , figlio
naturale di Federico, che governa in nome di Corradino, figlio di Corrado.Manfredi fa
sposare la figlia Costanza a re Pietro III d’Aragona.
Nel 1266 Carlo d’Angiò sbaraglia e uccide Manfredi a Benevento.
Clemente IV scomunica anche Corradino perché assume il titolo di re di Sicilia. Nel
1268 con la sconfitta di Tagliacozzo, viene catturato da Carlo e decapitato.
Fine della dinastia.
Carlo I d’Angiò viene incoronato nel 1266 re delle due Sicilie (per farsi perdonare,
andò a mangiare la zuppa sulla tomba di Corradino). Perse la Sicilia nel 1282, ma la sua
casa vi regnò sino al 1382. Morì nel 1285.
Il figlio Carlo II viene incoronato da Nicolò IV, nel 1289, re delle due Sicilie e di
Gerusalemme. Maritò la figlia per una grossa somma di denaro ad Azzo VIII marchese
di Ferrara. Fu, nel complesso, un buon principe (non amato da Dante): morì nel 1309.
Suo figlio, Carlo Martello, re d’Ungheria, morì prima del padre: tutto quindi andò al
fratello terzogenito Roberto. Nel 1309, Roberto si trasferì alla corte pontificia
d’Avignone e ottenne da Clemente V il possesso del regno di Napoli.
Carlo II, per ottenere la libertà, dovette lasciare in ostaggio al re Alfonso i tre figli Luigi,
Roberto e Giovanni, che restarono prigionieri sino al 1295. Roberto si fece amici
diversi Catalani che lo seguirono quando tornò in Italia: a loro, avidid di denaro,
Roberto affidò incarichi di governo.
Roberto fu savio reggitore di popoli e grande sostenitore delle lettere; oratore, filosofo,
medico, versato nelle materie teologiche. Aveva ordinato una grande biblioteca,
affidandone la cura a Paolo da Perugia, uno dei maggiori dotti del tempo.. Alla società
dei politici preferiva quella dei sapienti e dei preti. Fu obbligato a Clemente V,
Giovanni XXII e a Benedetto XII.
Dante aborre Roberto. Non sappiamo se l’avesse conosciuto quando andò ambasciatore
a Napoli (presso Carlo II) nel 1298. L’aborrì sempre perché lo ritenne usurpatore al
figlio di suo fratello primogenito (Par. IX 1-6); perché riteneva che congiurasse coi papi
Francesi, istigando i guelfi con l’obiettivo d’impadronirsi dell’Italia. Petrarca lo elogiò:
forse con Petrarca siamo in altra epoca rispetto a Dante.(Foscolo)
Nel 1828 morì Carlo, unico figlio di Roberto; la figlia di questi, Giovanna, fu data in
sposa ad Andre, figlio di Carlo Umberto re d’Ungheria. Roberto morì nel 1343.
PIETRO III il grande fu incoronato re d’Aragona, a Saragozza, nel 1276. Manfredi gli
dette in moglie la figlia Costanza. Martino IV lo scomunica nel 1283 e gli toglie anche
i diritti sul regno d’Aragona, investendo Carlo di Valois. Muore nel 1285: i suoi figli
sono gli unici “eredi” della casa di Svevia.
Niccolò III, su istigazione di Giovanni da Procida, aveva offerto – su richiesta di
Costanza – a Pietro l’investitura del regno di Puglia e Sicilia. Ma il 30 marzo 1282
scoppiano i Vespri Siciliani e periscono 4000 Francesi.
A Pietro III succede il figlio Alfonso III , che muore senza figli nel 1291.
Da FELICE TOCCO, Le correnti del pensiero filosofico nel secolo XIII, in Arte, scienza
e fede ai tempi di Dante.
Cit. Par. XII 10 sgg.
Le due ghirlande di “fulgori vivi e lucenti” sono formate da ventiquattro spiriti. Il
cerchio interno s’impernia su S. Tommaso che loda S. Francesco; il cerchio esterno
degli altri dodici su S. Bonaventura che loda S. Domenico. Accanto a S. Tommaso è il
suo Maestro Alberto Magno da un lato e Sigieri dall’altro: tutti e tre aristotelici che
cercarono di mettere in forma sistematica il sapere del loro tempo, come – molto prima
di loro – aveva cercato di fare il venerabile Veda. A questa sistemazione lavorarono
Graziano per le leggi canoniche; Pier Lombardo per le dottrine scolastiche; Orosio e
Isidoro per i fatti storici e linguistici; lo Pseudo Dionigi l’Areopagita per le essenze
angeliche e gli stessi attributi della divinità. Simbolo di questa sapienza ordinatrice è
Salomone; e “ministro” per l’Occidente è Severino Boezio, il quale, traducendo molte
opere di Aristotele, salvò la cultura occidentale dalla rovina che stava per travolgerla. In
questo cerchio di ordinatori c’è Isidoro (?) di S. Vittore, distaccato da Ugo, suo maestro,
che fa parte del cerchio esterno, quello dei mistici. Ugo è a capo di quella corrente
mistica che con l’abate di Chiaravalle, si oppone alla teologia ragionatrice di Roscellino
e di Abelardo, e Riccardo di S. Vittore ne svolge le dottrine avvalendosi di suddivisioni
peripatetiche come , prdi Platone con Aristotele, e della sapienza e tradizione ellenica
con l’orientale.
Oggi, che sappiamo come Dionigi non sia l’Areopagita, capiamo come sia stato giusto
metterlo insieme a Boezio: entrambi appartengono a qull’indirizzo neoplatonico, che è
un eclettismo non sempre ben riuscito ma di lui, Dionigi.
Il perno del cerchio esteriore è Bonaventura, che ebbe i suoi precursori in Rabano
mauro (VIII secolo) e in Ugo di S. Vittore (XII secolo) , che è un eclettismo non sempre
ben riuscito ma di lui, Dionigi. Di Rabano ricordiamo che i suoi commenti alla Bibbia e,
sopra tutto ai profeti, sono tolti in gran parte da S. Agostino, e il De visione Dei è il
modello dell’Itinerarium mentis in Deo.
Accanto a questo filosofi Dante mette Anselmo d’Aosta, che si oppone, come i mistici,
a Roscellino, come più tardi farà Duns Scoto a S. Tommaso. E’ ovvio che con
Bonaventura vadano i due frati minori Illuminato e Agostino, i primi a mettersi su
quella via che il Serafico percorse tutta. Altresì è chiaro come a questi frati si
accompagnino i profeti e gli oratori: la visione mistica apre la via alla profetica, quale
ebbero Natan e Gioacchino, e solo l’eloquenza di un Giovanni Grisostomo è capace di
impennare le ali per sì alti voli. Ed è naturale che vi entri anche Donato, perché
all’eloquenza va unita anche l’efficacia del dire e la purità del dettato.
E’ più difficile spiegare come, tra i mistici trovi posto quel Pietro detto il “Comestore” e
“Mangiatore” per la quantità di libri divorati. L’autore della Historia Scolastica (una
stori dell’Antico e del Nuovo Testamento) accompagna le sue pagine sempre con un
commento o una interpretazione allegorica secondo il costume dei mistici. Inoltre
Pietro, dell’ordine agostiniano degli Eremitani, cancelliere della cattedrale di Parigi e
professore di teologia nell’Università, rinunziò dopo il 1167 a tutti i suoi uffici,
ritirandosi nel convento di S. Vittore, dove, se Ugo era già morto dal 1141, poté trovare
il suo successore Riccardo, che morì dopo cinque anni.
Maggiori sono le difficoltà per comprendere la collocazione di Pietro Ispano, papa sotto
il nome di Giovanni XXI, che scrisse un trattato logico sulle orme dell Psello e dettò
parecchie opere di medicina. La spiegazione potrebbe essere la seguente.
La filosofia aristotelica, guardata nel XII secolo con sospetto dai mistici, appariva
ancora più pericolosa nel secolo XIII, quando si conobbero i libri “fisici” e “metafisici”
di Aristotele, e si diffusero i commentari degli arabi.. E’ noto come un decreto del 1210
vietasse la lettura di quelle opere nell’Università di Parigi, e se Gregorio IX nel 1231
acconsentì a sopprimere il divieto, fu solo a patto che una commissione di dotti
correggesse le dottrine più pericolose: commissione che, in realtà, non si riunì mai e il
divieto rimase.
L’insegnamento di Alberto Magno e di Tommaso d’Aquino ell’Università rinfocolò le
ire destate dalla diffusione dell’averroismo, così che una lettera papale del 18 gennaio
1277 ingiunse a Stefano Tempier, vescovo di parigi, di vegliare sull’insegnamento
universitario. A tale lettera, il 7 marzo 1277, seguì una condanna di 219 proposizioni
quasi tutte averroistiche e alcune di Tommaso. Questo papa è Giovanni XXI,
neoplatonico che sospettava dell’averroismo.
Dante entra a pié pari nella disputa fra aristotelismo e misticismo: ma non si lascia
condizionare eccessivamente da quest’ultimo: tanto che, per l’ultimo tratto non sceglie
S. Bonaventura, ma S. Bernardo. Insomma: Dante attribuisce valore alla via pratica e
alla volontà (‘l velle).
Le dottrine di S. Bonaventura risalgono a Ugo e Riccardo di S. Vittore (cfr. Juan), e più
indietro, a Plotino e a S. Agostino. Plotino distingueva tre gradi nella conoscenza
umana:
- la percezione sensibile (fallace e menzognera);
- il pensiero discorsivo (che può giungere solo alla congettura o a una verosimile
probabilità);
- il pensiero speculativo (che, con lo sguardo dell’aquila, può giungere sino alla luce
divina).
Agostino si appropria di questa teoria della conoscenza e, da buon platonico, aggiunge:
“La verità sfuggente del mondo sensibile io la ritrovo solo che voglia ripiegarmi su di
me: poiché di tutto posso dubitate, fuorché di me dubitante”. Ma solo nell’estasi la
mente umana, dimenticandosi di sé, si confonde con quella divina. A questa dottrina ben
poco aggiunge Ugo di S. Vittore, che ripete i tre gradi (cogitatio, meditatio,
contemplatio), ma aggiunge che le nostre forze non sarebbero sufficienti, se la grazia di
Dio non intervenisse in ragione, occhio della contemplazione. Per colpa del peccato
l’occhio della ragione di annebbiò, quello della contemplazione venne perso del tutto.
La grazia redentrice ha ripristinato il primo stato.
Riccardo (“ a considerar fu più che viro”) va oltre: attribuisce alla grazia divina il
compito di creare di sana pianta le forze venute meno dell’uomo. Riccardo sdoppia le
tappe del viaggio: e lo imiterà S. Bonaventura. Ma l’indirizzo mistico non riesce a
soddisfare la sete di sapere, che si era fatto più vivo col diffondersi della filosofia araba.
In questo periodo prendono vigore gli indirizzi intellettualistici che hanno la loro guida
nel “maestro di color che sanno”.
Ma le traduzioni creano qualche problema, e il nodo cruciale riguarda l’intelletto
Aristotele distingue in attivo e passivo.
Nel secolo XIII vi sono tre interpretazioni:
1.
Alessandro d’Afrodisia e Avicenna. L’intelletto agente è Dio stesso che
accende nel nostro spirito la scintilla del sapere. Posizione condivisa dal francescano
Ruggiero Bacone (che forse Dante non conobbe poiché non ne fa menzione).
2.
Averroè. Potenza e atto non sono due entità separate.
3.
Tommaso sostiene che l’intelletto è tante quante sono le anime e presta loro,
per così dire, la loro immortalità.
Le grandi correnti filosofiche del Duecento sono 4:
a.
Neoplatonica o agostiniana che abbraccia le dottrine realistiche, così come le
mistiche;
b.
Aristotelica che fa capo ad Avicenna e si avvicina alla precedente;
c.
Aristotelica-averroistica che si attiene fedelmente al testo aristotelico;
d.
Aristotelica-tomistica, che non teme di allontanarsi da Aristotele quando lo
richieda la fede.
- Negli anni in cui Dante scrive la Commedia, il concilio di Vienna 1 condanna la teoria
platonica, sostenuta con efficaci ragioni dal capo degli spirituali francescani, Pier di
Giovanni Ulivi. Insomma: non ci possono essere più anime. Dante schiva l’argomento:
“che un’anima sovr’altra in noi s’accenda”.
- Concetto d’individuazione. Sia Tommaso che Dante ritengono (aristotelicamente)
che la differenza tra gli individui sia data dalla materia, mentre la forma è uguale per
tutti (Par. XIII 67 sgg.). Quindi le anime slegate dal corpo non avrebbero individualità:
tesi negata decisamente dai platonici, e che divideva non solo i francescani dai
domenicani, ma i domenicani fra loro. Tanto che il 7 marzo 1277, il domenicano
Kilwardby, arcivescovo di Canterbury, vietava ai professori di sostenere le tesi
tomistiche.
- L’eternità del mondo. I neoplatonici, richiamandosi al Timeo e alla dottrina cristiana
la negavano. Alcuni aristotelici la ammettevano senza ombra di dubbio, altri, come
Tommaso, sostenevano che la creazione dal nulla non si può dimostrare per
ragionamento, poiché non si dimostra se non ciò che è necessario, e del contingente si
può avere prova di fatto e non di ragione.
In tutto questo le varie sette religiose si azzannano fra loro.
Come si pone Dante di fronte alla cultura filosofica del suo secolo?
Ma come d’animal….. organo assunto (Purg.) Il savio è Averroè, che separa dall’anima
l’intelletto attivo e quello possibile. Si evince qui che Dante si tiene vicino a Tommaso.
Vedi anche la dottrina dell’unicità dell’anima (Purg. XXV, 61 sgg.).
Nel sinedrio del IV canto chi tiene il primo posto e a cui tutti fanno onore è Aristotele.
Le opere di platone sono quasi sconosciute e Dante, al di fuori del Timeo, che lo ritiene
testo puerile (Par. IV 49 sgg.).
E non pare avere troppa ammirazione per Agostino, che non trova posto nella ghirlanda
dei mistici. Lo colloca tra i fondatori di ordini religiosi e lo pospone a S. Francesco e a
S. Benedetto. E’ vero che nel XIII del Par. si espone una teorica delle idee che sembra
1 Il decreto del concilio stabilisce che sustantia animae rationalis sive intellectivae vere ac per se humani corporis sit
forma.
ricordare Agostino: ma è da far risalire piuttosto a Filone Alessandrino, ed era divenuta
comune a tutte le scuole.
Anche sulla dottrina dell’universale ante rem (in Dio) e in re (nelle cose), Dante è vicino
a Tommaso poiché non ammette nell’anima nessuna intuizione primitiva delle idee
(L’anima semplicetta….). L’anima non è disgiunta dall’intelletto.
Ma se crititca gli averroisti mette in Paradiso Sigieri di Brabante e ne fa tessere l’elogio
a S. Tommaso che, pure, lo aveva avversato (Questi… invidiosi veri).
Dopo le pubblicazioni di Baumker e Mandonnet, non vi è dubbio che fosse uno schietto
averroista.
Come credente ammette la creazione dal nulla, l’immortalità dell’anima e accoglie la
dottrina del libero arbitrio.
Come filosofo nega la creazione dal nulla, nega l’immortalità dell’anima (intelleto
unico), rifiuta la dottrina del libero arbitrio.
Insomma: nelle università parigine si insegnava la dottrina della doppia verità, in virtù
della distinzione fra scienza e fede sostenuta da Averroè. Contro le peoposiziooni
aristoteliche il vescovo di Parigi procede il 10 dicembre 1270 (l’anno in cui Sigieri
aveva pubblicato il De anima intellectiva) bocciando 13 tesi su 15, e contro di lui
Tommaso scrive il celebre opuscolo contro l’unità dell’intelletto. (Cfr. ChatelainDenifle, Chartularium univ. Paris.). / anni più tardi (7 marzo 1277) condanna 219 tesi.
In seguito alla condanna Simone du Val il 23 ottobre 1277 cita in tribunale i suoi maestri
Sigieri di Brabante e bernier di Nivelles per aver gravemente peccato contro
l’ortodossia. Sigieri si appella alla corte di Roma e cerca di raggiungere Papa Martino
IV a Orvieto ( dove risiedeva). Ma viene pugnalato dal suo segretario come conferma il
racconto del fiore (Mastro sighier non andò guari lieto / A ghiado il fe’ morire a gran
dolore / Nella corte di Roma, ad Orbiviedo). L’animosità fratesca armò la mano del suo
assassino ed egli ebbe lunga e dolorosa agonia. La pietà di Dante tiene conto anche
degli attacchi fatti a Tommaso sia a Parigi che a Oxford: egli sta con Tommaso e non
con gli integralisti.
Non è allineati coi mistici, ma li tiene in gran conto (Anselmo, Ugo e Riccardo di S.
Vittore) e colloca fra loro anche Gioacchino.
Vediamo le rappresentazioni artistiche
La prima è nella Chiesa di S. Caterina a Pisa, opera del Traini, allievo dell’Orcagna.
Rappresenta S. tommaso sul cui capo si adunano i raggi che muovono dal Cristo, dai
suoi Apostoli e dai maggiori filosofi dell’antichità (P. e A.). Ai suoi piedi è sdraiato
l’incredulo Avverroè con turbante in testa e barba nera.
Lo stesso motivo si ripete nel Cappellone degli Spagnuoli nella Chiesa di Santa Maria
Novella a Firenze, in un celebre affresco dove Tommaso è rappresentato in trono,
circondato da rappresentanti delle scienze e delle arti. Come domati e confusi stanno ai
suoi piedi i capi dell’eresia e dell’incredulità: Ario, Sabellio e Averroè. Questi è seduto
al modo orientale con una gamba che passa orizzontalmente sotto l’altra; il braccio
destro, appoggiato col gomito su un libro che gli serve da sgabello, si ripiega verso
l’alto per accogliere il capo pensoso, mentre la mano sinistra tocca il sommo della
gamba rilevata.
Una terza rappresentazione pittorica è in un affresco di Santa Maria sopra Minerva in
Roma, di Filippino Lippi. Anche qui Tommaso è seduto in trono circondato dalle 4
virtù. Nella sinistra regge un libro in cui è scritto: Sapientia sapientium perdam. Con la
destra addita il rappresentante della filosofia incredula, steso ai suoi piedi, che stringe
convulsamente l’estremi di un fregio dove è scritto: Sapientia vincit malitiam.Sullo
sgabello del trono si legge: Divo Thome ob prostatam impietatem. E sullo zoccolo:
Infirmatae sunt contra eos linguae eorum.2
Ma Dante non si adegua a questa intolleranza. Come Giusto de’ Menabuoi che, nella
Cappella di S. Agostino nella Chiesa degli Eremitani di Padova, raffigura Averroè tra il
maestro Alberto di padova, discepolo di Egidio, e il beato Giovanni da Bologna.
Né va dimenticato che l’Università di padova, da Pietro d’Abano in poi, fu centro
dell’averroismo. Anche Democrito, che “il mondo a caso pone” è nell’onorevole
consesso: ne resta escluso solo Epicuro, che libera dalle paure dell’oltretomba per dare
libero corso al “talento”.Questa è la concezione più diffusa all’epoca di dante che vi
caccia, per questo, Federico II e il Cardinale Ubaldini.
Ma al di fuori di questo dante rispetta tutte le filosofie che, se sono mosse dall’amore
per il vero, devono essere tutte rispettate. E questo rientra nella mentalità dell’epoca più
di quanto non si creda.
GIULIANA NUVOLI
2 Questo affresco è di Andrea da Firenze, non del Gaddi cui il Vasari lo aveva attribuito.
La descrizione degli affreschi è in Crowe Cavalcaselle, History of painting in Italy, vol. I, p. 372.
Dante e l’Islam*
Per millenni il Mediterraneo è stato il luogo nel quale popoli, lingue, culture e credenze si sono
incontrate e scontrate con profitto reciproco. La strada maestra verso l’Oriente la apre san
Girolamoi, creando la mappa dei luoghi da visitare in Terrasanta, in un itinerario relativamente
sicuro, che attira folle sempre più grandi di pellegrini. E non sono in pochi a restare: in
particolare tra il IX e l’XI secolo ci troviamo di fronte a flussi migratori di disperati, nobili
spiantati e avventurieri, che cercano una migliore qualità di vita. Perché l’Oriente – in questi
secoli – è più ricco e più colto.
A fronte di un Carlo Magno che a malapena sa leggere, c’è il raffinato califfo Harun al Rashidii,
il cui periodo di governo è considerato il più splendido della storia islamica. E, mentre
l’Occidente cristiano, come scrive Rodolfo il Glabroiii, comincia a costruire basiliche in numero
tale che “si sarebbe detto che il mondo, come scrollandosi e liberandosi dalla vecchiaia (…) si
riveste di un fulgido manto di chiese", l’Oriente musulmano impara a fabbricare la carta (793),
scopre i segreti della chimica (800 ca.), codifica l’astrologia (810 ca.) costruisce osservatori
astronomici (829), studia l’ottica e l’acustica (850 ca.), indaga la precessione degli equinozi
(900 ca.), si occupa di medicina (915 ca.), dà inizio alla storiografia (950 ca.), elabora i
fondamenti della trigonometria (990 ca.) e, nell’anno Mille, un medico, conosciuto in Occidente
col nome di Abulcasis o Albucasisiv, scrive una vasta enciclopedia medica in trenta volumi
tradotta in latino da Gerardo da Cremona, che costitusce per secoli il miglior testo di chirurgia e
di tecnica operatoria.
Poi arrivano le crociate, uno scempio lungo due secoli (1095- 1291)v. Le armi falliscono
l’obiettivo di riconquistare Gerusalemme e addomesticare l’Islam, ma danno vita al
tentativo di mettere in atto una conversione pacifica: ed ecco che francescani e
domenicani si mettono studiare a fondo la lingua e la cultura araba, per condurre con
successo la loro catechesi.
_________________________
* In Atti del Convegno Milano da leggere. Leggere l’altro, a cura di B. Peroni, Milano 2007.
Fra coloro che si spingono oltremare c’è Francesco d’Assisivi è da questo pertugio
affatto ortodosso, che entreremo nel mondo dei rapporti fra Dante e l’Islam.
Nel 1219, dopo due tentativi andati a vuoto (nel 1211 e nel 1213), Francesco parte con
frate Illuminato per la Siria, avendo frate Elia come ministrovii. Siamo al volgere della
quinta crociata e a Damietta, dove giunge, convivono in una tregua provvisoria arabi e
cristiani.
Scrive Dante (Par. XI, 100-105):
E poi che, per la sete del martìro,
nella presenza del Soldan superba
predicò Cristo e li altri che ‘l seguiro,
e per trovare a conversione acerba
troppo la gente, per non stare indarno,
redissi al frutto dell’italica erba.
Dante ci racconta che Francesco va alla splendida (superba) corte del Soldano, che
trova la gente impreparata ad accogliere la parola di Cristo e torna in Italia. Viaggio
inutile? Pericoloso? No. Avversato? Sì: dalle autorità ecclesiastiche.
Giacomo da Vitry nella VI epistola ad familiares, narra che Francesco "uomo semplice e
illetterato, ma caro a Dio e agli uomini, venuto nell'esercito cristiano, accampato davanti
a Damiata, in terra d'Egitto, volle recarsi intrepido e munito solo dello scudo della fede,
nell'accampamento del sultano d'Egitto. Ai saraceni che l'avevano fatto prigioniero
lungo il tragitto, egli ripeteva: “Sono cristiano: conducetemi dal vostro signore".
Francesco viene ricevuto con cortesia da Mâlik al-Kâmil (nipote del Saladino) che si
dimostra persona aperta alla reciprocità del dialogo (Assisi conserva ancora i doni
offerti a Francesco) e che, come racconta ancora Giacomo da Vitry, “per alcuni giorni
ascoltava con grandissima attenzione lui che predicava la fede di Cristo” alla corte e a
lui medesimo.viii
Francesco già nella prima stesura della Regola inserisce un capitolo specifico relativo ai
frati che "per divina ispirazione vorranno andare fra i Saraceni e altri infedeli". Essi
dovranno essere presenza e segno discreto all'interno di un contesto culturale e religioso
completamente diverso ("non facciano liti o dispute, ma siano soggetti a ogni creatura
umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani”); e la loro esistenza evangelica
dovrà avere la forma della fraternità "cortese". Francesco manda i suoi frati inter
Saracenos a condizione che non si comportino come stranieri, ma che vivano con e
come la gente. I documenti papali, quando parlavano dei musulmani, li chiamavano
"cani" o "gente cattiva"; egli è invece convinto che il dialogo sia possibile solo nel
rispetto dell'altro.
Francesco ha una mano tesa a Oriente, verso l’Islam e l’altra a Occidente, alla Provenza
dove erano in molti a condividere le sue nozze mistiche con la Povertà: i poveri di
Lione, i seguaci di Pietro Valdo, i Catari, i Patarini, gli Albigesi. Proprio quella
Provenza cui erano arrivati, risalendo da sud-ovest, gli Arabi.
Le traduzioni
Per trasmettere e diffondere il sapere è necessaria la conoscenza della lingua del
destinatario: i predicatori hanno bisogno di impararla, mentre gli studiosi possono
avvalersi di traduzioni, a patto che esse rispecchino fedelmente l’originale.
Antesignano della moderna traduzione (quella letterale del testo) è Severino Boezio,
dopo il quale essa diventa la norma per le opere scientifiche e filosofiche. Il desiderio di
Boezio di un “trasferimento del sapere” (translatio studii) dal greco al latino nel sesto
secolo, non si realizzò per la sua morte precoce e dalla mancanza di successori
immediati: ma la sua aspirazione venne ripresa e ampiamente soddisfatta a partire
proprio dal IX secolo. In Europa si torna a leggere Aristotele e Platone grazie alle
traduzioni che ne fecero i musulmani, soprattutto tra l'800 e il 900, presso la Casa della
scienza voluta dal Califfo Al Ma'amun a Bagdad. Portati verso Oriente dalle armate di
Alessandro il Grande o da sette cristiane come i Nestoriani, i testi dell'ellenismo furono
conosciuti prima nella loro versione siriaca o persiana, quindi tradotti in arabo, la lingua
di un popolo che si estendeva dall'Iran all'Andalusia. Ma i musulmani non erano
semplici conservatori del sapere greco: furono geniali lettori e traduttori che, entrando
in contatto anche con la scienza indiana e cinese, elaborarono una scienza nuova, con un
forte taglio sperimentale.
Se consideriamo la cultura dell’Europa e del Mediterraneo negli ultimi duemila anni, possiamo
individuare tre momenti nevralgici:
1.
il primo si verifica nel IX secolo, ed è relativo all’importazione di opere scientifiche in
Bagdad;
2.
il secondo è relativo alla traduzione di testi scientifici dal greco all’arabo nel dodicesimo e
nel tredicesimo secolo, con un percorso inverso e pressoché speculare al precedente;
3.
il terzo è relativo alla rivoluzione scientifica nell’Europa del XVII secolo.
Ovviamente, in questa sede ci interessa il secondo.
C’erano tre aree principali in cui i latini venivano considerati particolarmente carenti:
- la prima era la matematica (e in particolare la geometria) e l’astronomia. Queste erano
due delle sette arti liberali che avevano formato la struttura dell’educazione ix, mentre le
altre cinque arti liberali erano ben rappresentate, soprattutto grazie alle traduzioni di
Boezio, che aveva cercato di offrire ai lettori latini un curriculum completo di studi
greci.x
- La seconda area era la fisica. In questo caso abbiamo a che vedere con una materia che non
faceva parte delle sette arti liberali, ma che era entrata nel curriculum filosofico nell’antica
Alessandria, e che continuava a essere insegnata nel mondo islamico, in particolare a Bisanzio.
- La terza area lacunosa era la medicina. In questa materia il maestro era stato Galeno: ma i
latini si trovano di fronte i risultati di una traduzione di studio che aveva assorbito nuovi
elementi da altre culture (in particolare da quelle indiana e persiana) sviluppando e modificando
il sapere degli antichi.
Il movimento di traduzione prende il via dopo la riconquista di Toledo, il cuore della Spagna
islamica (1085), l’occupazione normanna della Sicilia, con la sua popolazione greca e di lingua
araba (1072–91), e la caduta di Antiochia che aveva rivelato le culture islamica e greca del
Mediterraneo orientale (1098).
Nel 1140, l’ultimo discendente dei Banu Hudxi, Abu Jafar Amad III ayf al-Dawla, permuta la
sua proprietà di Rueda de Jalón con una casa nel quartiere della cattedrale di Toledo. Il quartiere
della cattedrale e il quartiere franco ad esso adiacente, sono i soli distretti in cui gli stranieri e il
sapere latino siano dominanti, così prende l’avvio una intensa traduzione delle opere di autorità
greche e arabe dall’arabo. Stiamo parlando di una causa prossima, naturalmente, perché ci
troviamo di fronte non tanto a un trasferimento di sapere, quanto piuttosto a un sapere che
pretende di essere internazionale, secondo l’immagine utilizzata da Adelardo di Bath, nelle
Quaestiones naturales: il mondo è come un corpo in cui alle differenti parti sono state assegnate
funzioni diverse; così parti del mondo diverse sono ricche in discipline differenti e ciò “che
l’anima (del mondo) è incapace di provocare in una singola zona del mondo, la genera nella sua
totalità”.
Nella prima metà del XIII secolo (e in particolare fra il 1225 e il 1250) gli scambi eruditi si
intensificano, e i mondi ebraico e islamico condividono con la cristianità un sapere comune
sulla scienza e sulla filosofia; si forma, in altre parole, una comunità di studiosi che trascende i
confini politici e linguistici, un fenomeno dovuto, senza dubbio, anche al successo dei traduttori
che innalzano il sapere scientifico dei singoli gruppi linguistici, sino a far loro raggiungere lo
stesso livello di eccellenza.xii
Con la morte di Federico II (1250), lo stupor mundi, splendido rappresentante della sintesi fra
cultura musulmana e cristiana, il testimone passa idealmente a un altro Staufen, per parte di
madre, Alfonso X il Savio, che sale al trono nel 1252, due anni dopo. Re di Castiglia e di Leon,
Alfonso tenta una cultura di sintesi nella quale entrano alla pari, ingredienti musulmani, cristiani
ed ebrei. Toledo, nel frattempo, resta luogo di attrazione irresistibile per studiosi, e la corte di
Alfonso luogo d’incontro di intellettuali cosmopoliti.
Alla corte di Alfonso, alla fine degli anni Cinquanta, arriva anche Brunetto Latini, che
soggiorna a lungo a Oviedo (Castiglia), e lì intrattiene stretti rapporti con intellettuali e
traduttori, tra i quali c’è Bonaventura da Siena, il traduttore del Liber Scalae Maometti. E’ da
dimostrare che sia stato inviato dai suoi compatrioti ad Alfonso X re di Castiglia, perché venisse
in aiuto dei Guelfi in Italia; comunque la sua famiglia è costretta all'esilio e, nel 1260, bandita
da Firenze. Brunetto si rifugia in Francia, dove dimora per sette anni tra Montpellier e Parigi,
coltivando le lettere e intrattenendo, con gli uomini più distinti di questa città, relazioni di viva
amicizia.
Poi, nel 1273, rientra in Firenze e qui incontra l’adolescente Dante. Brunetto è maestro di
grande fascino che reca con sé sapere e testi di varia e stratificata derivazione. Quali Dante
conosce? Difficile a dirsi, al di fuori di testi ch’egli esplicitamente indica di aver letto. Come
fare allora per districarsi nel mare delle possibili fonti, nella vastità dei tributi possibili? Si può
solo procedere a piccoli cauti passi, ma senza il timore della scoperta inattesa.
Proveremo a indicare, almeno a grandi linee, quali probabili elementi della cultura e letteratura
araba siano presenti nelle opere di Dante.
La messe di elementi ci impone di ordinarli almeno in tre categorie generalissime:
1.
i contenuti dei testi;
2.
la lingua dei testi;
3.
il sistema filosofico-teologico.
1. Per quanto riguarda la categoria dei contenuti e della forma del contenuto dei testi, è utile
partire da un volume ormai celebre, anche tra i non specialisti: Dante e l’Islam. L’escatologia
islamica nella Divina Commedia di Miguel Asìn Palaciosxiii, uscito nel 1919. Palacios non è il
primo a formulare ipotesi di contatto tra la letteratura araba e Dante, il primo era stato un abate
spagnolo, Juan Andrès, nel 1782: ma Palacios ha il merito di riaprire, con forza, la questione.
Palacios inizia a fare le prime congetture su possibili infiltrazioni arabe nella Divina Commedia
mentre studia il filosofo musulmano Ibn Masarraxiv: esse si riferiscono, in particolare, all’ascesa
di Dante e Beatrice attraverso le sfere celesti. L’ipotesi si rafforza durante la lettura della
Futuhat del grande sufixv di Murcia Ibn ‘Arabi.
Tra la Commedia e la Futuhat risulta subito evidente una simile scrittura allegoricaxvi e,
nelle sue linee generali l’architettura dell’Inferno dantesco sembra essere un calco di
quello musulmanoxvii: entrambi appaiono come un gigantesco imbuto o tronco
rovesciato, con balze circolari che gradualmente scendono verso il centro della terra,
con un intensificarsi della pena mano a mano che si avanza nel cammino. In entrambi i
testi è regola generale una legge di correlazione (o contrappasso) fra i peccati e i loro
castighi; simili sono le forme di alcuni tormenti e medesima è la localizzazione
dell’inferno: Gerusalemme.
Palacios ha davanti a sé una messe pressoché sterminata di isra (viaggio notturno) e
miraj (ascensione): e con mossa coraggiosa (anche se filologicamente discutibile) fonde
le due forme marrativexviii. Nel Corano esistono due riferimenti all’isra - o viaggio
notturno di Maometto- (Sura 17:1 e Sura 53:5)xix: contaminate da alcuni detti (hâdit), e
dai relativi commenti, queste leggende ispirarono il miraj o l’ascensione al cielo così
come la conosciamo. La versione più antica risale al IX secolo, ma la letteratura
sull’ascesi di Maometto raggiunge il suo culmine dopo il XII secolo.
Palacios prende in esame tre cicli narrativi.xx
- Una prima versione molto antica racconta che una notte Maometto viene svegliato
dall’Angelo Gabriele e portato a Gerusalemme, dove prega Allah insieme ad Abramo,
Mosè, e Gesù; poi ascende fino al Loto del limite, che si trova alla destra del Trono di
Dio.xxi
- In una seconda versione del miraj, coeva alla precedente, si aggiunge l’episodio
dell’incontro di Maometto, nel Terzo Cielo, con un Angelo gigantesco e terribile,
guardiano dell’abisso infernale. E’ solo grazie all’intervento di Gabriele che l’angeloguardiano mostra a Maometto i Sette Piani dell’Inferno elencando le categorie dei
dannati e i diversi supplizi cui sono destinati.
- Una terza versione, più complessa, mostra maggiori analogie con l’opera dantesca,
non solo per l’itinerario celeste e infernale, ma ancor più per certe immagini simboliche.
Il gigantesco gallo incontrato dal Profeta, ad esempio, è paragonato all’aquila vista da
Dante nel cielo di Giovexxii; simili sono i cerchi concentrici degli angeli che, ordinati
gerarchicamente, ruotano attorno al Trono divino. Analogie sorprendenti, secondo
Palacios, riguardano anche fenomeni legati allla psicologia del personaggio protagonista
del viaggio: sia Maometto che Dante, ad esempio, quando si trovano dinanzi alla luce
divina, sentono la vista offuscata e temono di diventare ciechi; e, come Maometto,
anche Dante si sente incapace di descrivere quella visione e in seguito ricorda solo una
specie di “sospensione” dell’animo.xxiii
Palacios, insomma, mette insieme pezzi variegati e di natura diversa, procedendo talora
per induzione, sì da prestare il fianco a critiche feroci, come quelle mosse dalla Società
Dantescaxxiv, in particolare da D’Ancona e D’Ovidio “i quali – egli commenta con
amarezza - accettavano come modelli della Divina Commedia i suoi precursori classici e
cristiani, pur confessando che tali modelli erano abbozzi poveri e grossolani; del pari
affermano che anche i modelli islamici sono poveri, rozzi, e insignificanti; ma subito
dopo li sostituiscono con altri modelli cristiano – classici che distano dalla Commedia
ben più di quelli islamici”xxv. Tra questi almeno un altro è degno di essere ricordato e
mostra la validità dell’affermazione di Palacios: è L’epistola del perdono del poeta
siriano Abu l-‘Ala al-Ma’arri che, dimenticata, è tornata alla luce proprio grazie alla
segnalazione dell’arabista spagnolo.
Nel secondo dopoguerra, grazie agli studi e alle scoperte di Muñoz Sendino e di
Cerulli, le teorie di Palacios tornano d’attualità, in virtù anche del ritrovamento, presso
la Biblioteca Bodleiana di Oxford e la Nazionale di Parigi, di due codici contenenti,
rispettivamente, una versione francese (Livre de l’Eschiele Mahomet) e una latina
(Liber Scalae Machometi) del viaggio di Maometto. La leggenda quindi girava; era
leggibile, pertanto utilizzabile.
Nel Libro della Scala di Maometto viene raccontato il viaggio del profeta
nell’Oltretomba accompagnato dall’Arcangelo Gabriele: esso fu tradotto dall’arabo in
latino, a Toledo, alla corte di Alfonso X il Savio, da Buonaventura da Siena., ed è
verosimile che Brunetto, tornando a Firenze, l’abbia portato con séxxvi
Le analogie sono serrate e puntuali: Maometto protagonista del viaggio è come Dante,
autore esso stesso della leggenda. Entrambi i viaggi cominciano di notte, e al risveglio
del protagonista da un profondo sonno. Prima di giungere all’Inferno un lupo e un leone
sbarrano il passo al pellegrino, come il leone e la lupa danteschi. Virgilio, che si
presenta al poeta come guida per ordine celeste, ha il suo corrispettivo in Gabriele che
con le stesse motivazioni si presenta a Maometto. Interessanti sono anche le simiglianze
relative all’ingresso alla città di Dite: l’approssimarsi dell’Inferno si annuncia con
tumulto e vampate di fuoco e, alle porte, guardiani severi sbarrano il passo al
viaggiatore per impedire che essi entrino nella città del dolore: solo quando è chiaro che
Dio vuole così, le porte si aprono.
Interessanti risultano anche le analogie con le Malebolge.
Palacios aveva intuito che, ad esempio proprio nel caso della pena comminata a
Maometto, ci fossero particolari descrittivi di “chiara ascendenza musulmana.” Lo
stesso supplizio di Maometto e di suo genero Alì, è presente in molte leggende
dell’Inferno islamico: “Percorrono lo spazio che separa due cerchi infernali lanciando
maledizioni e levando lamenti, gli uni inciampando nei propri intestini, gli altri
vomitando sangue e marciume”. xxvii
2. Ma, come nota anche Maria Corti, quando ci si trova di fronte a un preciso elemento
di natura formale, questa non è più soltanto una ipotesi. Ed ecco che l’elemento
linguistico viene in soccorso: le figure retoriche, ad esempio. Nel Libro della scala c’è,
fra le altre, la metafora dei “seminatori di discordia”, e Dante la riprende puntualmente
per indicare il peccato di cui si macchiano, per Dante, Maometto e il genero Alìxxviii.
Da ricordare – ed è ancora Maria Corti, questa volta nel saggio Dante e la torre di
Babele a suggerire queste riflessioni – che, anche quando Dante parla della lingua,
sembra non ignorare testi di matrice araba. Uno per tutti valga l’esempio della
descrizione della torre di Babele, nel VII capitolo del De vulgari eloquentia: “solo a
quelli che si accordavano in un’uica operazione rimase una lingua medesima: una, per
esempio,
a
tutti
gli
architetti,
una
a
quanti
rivoltavano
massi,
una
a quanti li preparavano; e così avvenne dei singoli lavoratori”. Esito pressoché identico
a quello che si trova nelle pagine dell’Historia general di Alfonso il Savio. E come
avrebbe potuto Dante conoscerlo: ancora attraverso Brunetto Latini, naturalmente…
Curiosi e non peregrini, anche certi elementi lessicali o formule, come "Pape Satàn,
pape Satàn aleppe", il verso collocato all’inizio del Canto VII dell'Inferno, che potrebbe
rappresentare una memoria fonetica della lingua araba. Abbūd Abu Rāshid, primo
traduttore arabo della Divina Commedia (Tripoli, 1930 - 1933), interpretò questi versi
come una traslazione fonetica di una parlata araba, e li tradusse come Bāb al-shaytān.
Bāb al-shaytān. Ahlibu ("La porta di Satana. La porta di Satana. Proseguite nella
discesa").
3. Ci siamo allontanati dalla Commedia, per entrare negli spazi che appartengono alle
altre opere di Dante. Tra queste il Convivio è certo l’opera nella quale il tributo alla
cultura, e in particolare alla filosofia araba, è più evidente: Avicennaxxix, Averroèxxx,
Albumasar, Algazel, Alpetragio, Alfarabio, Alfarganixxxi.
E tra questi, i due sommi, Avicenna e Averroè, entrano nella Divina Commedia.
Genti v’eran con occhi tardi e gravi,
di grande autorità nei lor sembianti:
parlavan rado con voci soavi.
Traemmoci così da l’un de’ canti,
in loco aperto, luminoso e alto,
sì che vedere si potien tutti quanti.
Colà diritto, sopra il verde smalto,
mi fuor mostrati li spiriti magni,
che del veder in me stesso m’essalto.
(Inf. IV 112-120)
L’elenco dei filosofi si apre con Aristotele:
Poi ch’innalzai un poco più le ciglia,
vidi ‘l maestro di color che sanno
seder tra filosofica famiglia.
(Inf. IV 130-132).
Seguono Socrate, Platone e l’elenco si chiude su Avicenna e “Averoìs che il gran
comento feo” (Inf. IV 144). Significativa è la stessa disposizione dei personaggi; sei
nomi disposti in un ordine di due più quattro: due matematici e quattro medici filosofi,
nel segno di una salda continuità ideale tra episteme greca e scienza araba.xxxii La
disposizione dei quattro segue una precisa regola analogica anche dal punto di vista
storico è indiscutibile che Ippocrate stia ad Avicenna come Galeno ad Averroè. xxxiii Tutti
parte integrante di un’unica grande cultura, filosofica nel senso ampio del termine: che
sta al di sopra della distinzione tra discipline umanistiche e scientifiche
E proprio in questo Limbo, non poi troppo diverso dal Limbo musulmano, in cui solo,
in disparte. sta il Saladino, vi sono innegabili memorie del Libro della scala: nel IV
libro, Maometto riceve l’investitura di Profeta dai Profeti dell’Antico Testamento; così,
in questo IV canto Dante riceve l’investitura di Poeta dai massimi poeti dell’Antichità.
Se servisse una riprova linguistica di questa memoria, basta ricordare che il vocabolo
honor (onore) è ripetuto, in forme diverse, per tre volte nelle poche righe che narrano
l’episodio, e che esso è ripreso e variato da Dante per ben otto volte in una sessantina di
versi, dal 72 al 133: orrevol, onori, onrata, onoranza, onorate, onore, onore, onor.
Ma veniamo ai due grandi, ricordando quanto la comprensione della filosofia araba sia legata
allo studio della filosofia greca e della teologia durante i primi tempi del cristianesimo, gli
ultimi secoli dell’Impero romano e la contemporanea civiltà di Bisanzio. Sì che non è possibile
leggere anche i testi di Avicenna e Averroè, senza passare attraverso la lettura di Sant’Agostino
o di Giovanni Filipono, che fu il primo a unire insieme la filosofia aristotelica e la teologia
cristiana.
Avicennaxxxiv è noto per due scritti di carattere medico-filosofico, il Canone e il Libro della
guarigione. Il primo è un’enciclopedia medica che riprende i principi di Ippocrate e Galeno e li
uniforma alle teorie biologiche di Aristotele: tradotto in Occidente già nel sec. XI, il Canone
resta fino al sec. XVI uno dei principali testi nelle facoltà di medicina. Il Libro della guarigione,
invece, costituisce una summa filosofica dell’aristotelismo che ha importanti riflessi in ambito
teologico, sia nel mondo musulmano che in quello latino. Come per Aristotele, anche per
Avicenna, la realtà è il risultato di un processo emanativo che parte da Dio, il Sommo Bene, e si
sviluppa in dieci Intelligenze celesti a Lui sottostanti che per Avicenna sono entità angeliche; la
decima Intelligenza è il principio formativo delle anime umane e del mondo sublunare: e non è
chi non veda l’assoluta somiglianza con l’ordinamento e la natura dei cieli danteschixxxv.
L’altro è Averroèxxxvi, famoso per il triplice commento ad Aristotele, che gli vale il titolo di “gran
commentatore”.xxxvii
Averroè respinge la teoria avicenniana della derivazione del mondo per emanazione; confuta la
psicologia di Avicenna non ritenendola conforme allo spirito di Aristotele e colloca al centro
della sua speculazione i rapporti tra filosofia e religione. Punto cruciale della filosofia di
Averroè, dicevamo, è il rapporto tra fede e filosofia, cui assegna due verità distinte ed
inconciliabili. Con abbondanti citazioni coraniche, egli dimostra che non solo l’Islam permette
la Filosofia, ma ne incoraggia addirittura la pratica. Per il Corano compito dell’uomo è
conoscere gli esseri esistenti in quanto creati da Dio – e cos’è la Filosofia se non lo studio della
totalità degli esseri? Il primo e decisivo passo è compiuto; si presenta ora una obiezione: se la
Filosofia è pratica incoraggiata dalla stessa Legge – si intende “Legge coranica”, la Shari’a –,
per quale motivo essa ha portato a conflitti ed eresie? Averroé sostiene che questi problemi
siano stati soltanto degli “accidenti”; la vera “essenza” filosofica non ha nulla di conflittuale con
la fede e l’ortodossia. Sono “accidenti” causati da un uso improprio della Filosofia, o meglio, da
un uso illecito della filosofia da parte di alcuni; infatti essa non è per tutti gli uomini. L’uomo,
l’uomo vero e “più perfetto”, svilupperà la caratteristica che gli è propria, la razionalità,
conducendo una bios theoretikos. Anche gli uomini non illuminati dalla ragione, seguendo il
Corano, possono arrivare alla Verità: Dio, sommamente buono, non potrebbe permettere la
creazione di uomini che, per natura, non possono raggiungere la felicità. A ogni modo,
aggiunge, la Scrittura è fondamentale anche per i Filosofi: essa infatti nasconde, sotto la
superficie dei discorsi, del significante, verità che si possono raggiungere solo con la
allegorizzazione. Insomma, la Legge è uno scrigno di verità che si dischiude – anche e
massimamente – al Filosofo, che ne possiede la chiave. Un’operazione che Dante comprende
benissimo, e che mette in atto: solo che parla di allegoria di Poeti che, nel suo caso, è
esattamente la stessa cosa.
Ma Averroé si spinge sino a una conseguenza pericolosa: nel momento in cui la ricerca
razionale dovesse risultare in contrasto con la Scrittura, fatto salvo per casi particolari, quella
che andrebbe sottoposta ad interpretazione allegorica non è la prima, ma quest’ultima, la
Scrittura.
Averroè è seduttivo; il suo Commento è un miracolo di intelligenza; le sue indicazioni
affascinano sopra tutti i giovani.
Il XIII secolo ha bisogno di Aristotele, delle sue analisi, delle sue intuizioni, del suo sistema; ma
Aristotele è pericoloso: il pensiero sembra non aver confini. Ad aristotelizzare troppo non si
rischia soltanto l'allontanamento o l'espulsione, si rischia la vita. La fede deve essere salda e non
vacillare; il dubbio è corrosivo, ed è figlio del diavolo: nulla salus extra ecclesiam. Così la
Chiesa dà il via al progetto di controllo indiscriminato della cultura. Innocenzo III, eletto papa
nel 1198, incarica nel 1215 il legato pontificio di pubblicare a Parigi un'ordinanza che stabilisce
il curriculum delle facoltà delle arti e di teologia. Alla sua morte gli succede Onorio III, che
poco prima di morire concede altri riconoscimenti all'ateneo parigino; finalmente, nel 1231, il
suo successore Gregorio IX compie l'opera, estendendo all'università di Parigi il privilegio
pontificio di riconoscere la validità legale dei diplomi da essa erogati. Il baricentro del fervore
intellettuale si è spostato, in questi anni, da Toledo a Parigi; il ventennio dal 1230 al 1250
sembra scorrere in una operosità intellettuale: il ricambio di maestri e discepoli è intenso e
incessante, le idee circolano, la quantità di ingegni è elevatissima. Ma la presenza di Aristotele
non è più solo fondamentale: sta diventando ingombrante. E, proprio in quel 1231 segnato
dall'approvazione pontificia, lo stesso Gregorio IX diffonde una lettera che invoca la revisione
delle dottrine di Aristotele. Appena un anno prima, a Parigi, avevano cominciato a circolare gli
scritti di Averroè che, partendo da Aristotele, si sforzava di definire con la massima precisione i
rapporti tra la filosofia e la teologia, cercando di salvaguardare l'autonomia della prima.
L'operazione suscita ammirazione, e fa seguaci. E iniziano a emergere differenze fondamentali
fra l'Islam e il Cristianesimo, che hanno implicazioni non solo confessionali: non esistono, ad
esempio, due teorie antagonistiche del potere spirituale e del potere temporale, come accade
invece nell'Europa dell'epoca, che vede la dura opposizione fra le pretese del papa e quelle
dell'imperatore. L'Islam rappresenta il pericolo della ricerca, della discussione, delle domande:
quasi un ottavo del Corano, cioè settecentocinquanta versetti, esorta ”i credenti a studiare la
natura, a riflettere, a fare l'uso migliore della ragione nella ricerca del Supremo e a fare
dell'acquisizione della conoscenza parte integrante della vita comunitaria”xxxviii.
Presto gli eventi precipitano: nel 1245, all'università di Tolosa (fondata nel 1229) viene
interdetto l'insegnamento di Aristotele; nel 1256 Alberto Magno scrive il De unitate intellectus
contra Averroem, in cui attacca il sistema di pensiero del Commentatore, mentre a Parigi Sigieri
di Brabante e Boezio di Dacia sono i protagonisti dell'aristotelismo radicale e si attirano
l'accusa di filopaganesimo. Gli scontri avvengono a suon di libelli e durano per i dieci anni
successivi, mentre la Santa Inquisizione (fondata nel 1232) prepara un’operazione in grande
stile. Nel 1263 Urbano IV rinnova i divieti promulgati da Gregorio IX nel 1231; finché, nel
1267, il ministro generale dei francescani Bonaventura da Bagnorea, denuncia a tre riprese - e
con violenza - il pericolo incombente del nuovo paganesimo propugnato da "molti maestri
parigini". I maestri e gli studenti dello studium parigino se ne infischia: l'entusiasmo suscitato
dalla lettura di Aristotele e dai commenti dei maestri arabi è sempre alto. Tre anni dopo, nel
1270, scende in campo anche Tommaso d'Aquino con un opuscolo dal titolo quasi identico a
quello del suo maestro Alberto Magno: De unitate intellectus contra averroistas, che
rappresenterà il testo cardine della controversia sull'averroismo. Con parole dure e dirette
Tommaso sostiene che Averroè è «non tanto peripatetico, quanto piuttosto corruttore della
filosofia peripatetica», ed estende questa accusa a tutti i suoi discepoli, prendendo di mira, in
particolare, uno di essi che non nomina, ma che sfida a rispondergli: si tratta di Sigieri di
Brabante, che raccoglie la sfida e replica al De unitate. con un De intellectu, oggi perduto.
L'accusa di eresia incombe sull’intera Facoltà delle Arti: il 10 dicembre 1270 Etienne Tempier,
vescovo di Parigi, emette una condanna senza appello dell'aristotelismo eterodosso,
stigmatizzando tredici "errori" ispirati alla diabolica filosofia pagana. Il conflitto non è soltanto
dottrinale o ideologico: è una lotta di potere; così scoppiano scontri violenti e sollevazioni fra
gli studenti della facoltà delle arti — i filosofi — e quelli della facoltà di teologia, legati anche
all'elezione del nuovo rettore. Nonostante l'ostilità sempre più palpabile, Parigi resta il fulcro
dell'aristotelismo eterodosso, i cui seguaci non voglio rinunciare ad un pensiero autonomo e
lottano disperatamente contro la dilagante e ossessiva presenza del pensiero cristiano. Di lì a
poco tempo, il 2 settembre 1276, viene emanato un altro decreto contro l'insegnamento occulto
delle dottrine aristoteliche; meno di tre mesi dopo, il 23 novembre, Sigieri di Brabante è
convocato dall'Inquisitore per render conto dei suoi comportamenti e dei suoi scritti; agli inizi
dell'anno nuovo, il 18 gennaio 1277, il pontefice Giovanni XXI indirizza una durissima lettera
al vescovo di Parigi, Tempier, che riunisce in fretta una commissione di teologi, che in tre
settimane conduce un'inchiesta frettolosa e non documentata sui testi giudicati "sospetti". Il 7
marzo 1277 viene reso pubblico il decreto che condanna gli errori riscontrati e scomunica tutti
coloro che ne sono stati partecipi: chi li ha insegnati, chi li ha ascoltati, chi li ha commentati, chi
li ha diffusi. Tutti dovranno presentarsi entro sette giorni al vescovo o al suo cancelliere, per
ricevere una pena proporzionata alla colpa.
Il decreto del 7 marzo 1277 è formalmente circoscritto all’Università di Parigi, ma l’eco si
propaga per tutto l’Occidente e segna la crisi del sapere e degli strumenti di conoscenza
cristiani, messi in difficoltà dal fascinoso irrompere del sapere pagano. E che questo evento si
produca proprio nella capitale di quella Francia considerata come la figlia diletta e primogenita
della Chiesa, significa che la filosofia intende sostenere la propria indipendenza nei confronti di
una teologia che produce sempre meno sapere, ma che pretende sempre più potere.
I due campioni dell’“audace” aristotelismo radicale sono Boezio di Dacia e Sigieri di Brabante,
maestri della Facoltà delle Arti di Parigi, di fatto una vera e propria "facoltà di filosofia ",
sancita dagli statuti del 1252 e del 1255. Accusati di esser sostenitori della cosiddetta "dottrina
della doppia verità", tale per cui la fede e la ragione portano a due diverse verità, in realtà
Sigieri e Boezio sono convinti che la verità sia unica, raggiungibile sia dalla fede sia dalla
ragione e che, in caso di disaccordo fra le due, la preminenza spetti in ogni caso alla fede.
Prendendo a modello il decimo libro dell’Etica Nicomachea di Aristotele, entrambi sostengono
che la massima felicità per l’uomo risieda nella vita contemplativa e teoretica: per essere
davvero felice sulla terra in cui si trova viator, l’uomo deve esercitare il più possibile le proprie
doti intellettuali, prima fra tutte la scienza dimostrativa. Dall’esercizio del pensiero scaturisce
una felicità irresistibile, superiore ad ogni altra. Qualche volta, a ogni modo, la filosofia, intesa
come dimostrazione a partire da premesse, può pervenire a conclusioni contrastanti con le verità
di fede: in questo caso – pur ribadendo l’assoluta egemonia della fede - Boezio ritiene che le
verità di ragioni debbano comunque essere enunciate, anche se contrastanti con la rivelazione.
In questo modo rivendica l’assoluta libertà di filosofare. Lo misero a tacere.
La condanna del 1277 inizialmente diretta solo contro gli "aristotelici radicali" della
facoltà delle Arti, subito trova eco e diffusione (a partire dallo scambio di Correctoria
tra francescani e domenicani) negli ambienti teologici trasformandosi in uno strumento
generale a disposizione dai "guardiani dell'ortodossia" per reprimere ogni forma di
dissenso; perde la sua portata locale e sopravvive al passare del tempo, tanto da essere
ancora utilizzata in pieno XVII secolo (vedi Tommaso Campanella e vedi Galileo
Galilei).
Dante cresce e si forma in questo clima potentemente conflittuale tra un sapere aperto e
cosmopolita, e un sapere cattolico che pretende di riempire tutti gli spazi lasciati liberi
dalla ragione, e anche quelli che alla ragione appartengono di diritto.
Torniamo, adesso, alla Commedia.
Vi sono quattro canti, il X, l’XI, il XII e il XIII nei quali confluisce quanto sinora detto.
Siamo nel quarto cielo, quello del Sole, dove sono collocati gli spiriti sapienti (Quattro:
un numero che torna in modo compostamente rituale proprio a partire dal IV canto
dell’Inferno, quello degli spiriti sapienti).
Dante incontra in questo cielo due corone di beati, ognuna delle quali è composta da 12
anime. Nella prima Tommaso d’Aquino presenta gli undici beati che gli fanno
compagnia; essi sono: Alberto Magno, Francesco Graziano, Pietro Lombardo,
Salomone, Dionigi l’Aeropagita, Mario Vittorino, Severino Boezio, Isidoro di Siviglia,
il Venerabile Beda, Riccardo di San Vittore e chiude l’elenco Sigieri di Brabante.
Nella seconda Bonaventura da Bagnoregio presenta i frati Illuminato e Augustino,
Ugo di San Vittore, Pietro Mangiadore, Pietro Ispano, Crisostomo, Anselmo, Brisso,
Donato, Rabano Mauro e per ultimo viene Gioacchino da Fiore.
I due elenchi sono compositi ed eterogenei: hanno re ebrei (Salomone) e umili fraticelli
(Illuminato); un papa che era studioso di medicina (Pietro Iaspano), interpreti della
bibbia, traduttori tra cui spicca Boezio, ma – quello che sorprende – ognuno dei due
elenchi si chiude su un personaggio scomodo: Sigieri di Brabante e Gioacchino da
Fiore.
Che significa questa posizione forte, in chiusura? Significa che Dante riconosce i
potenti debiti contratti con loro, da un lato, e, dall’altro, che intende – in modo
definitivo e autorevole – riabilitare la loro memoria.
Sigieri, col rogo di Stefano Tempier, era di fatto scomparso dalla scena parigina, e
Gioacchino era stato messo sotto osservazione per eccesso di vicinanza ai catari: la
Chiesa li aveva accusati di diversità e Dante li colloca nel luogo dei beati autorevoli per
intelletto.
E non si dimentica neppure dell’altro maestro parigino, di Boezio di Dacia, che
qualcuno ha sostenuto abbia utilizzato in un luogo cruciale della Commedia, quel XXVI
canto in cui vi è l’elogio più famoso al mondo del desiderio di conoscenzaxxxix. Tutto
averroista il De summo bono di Boezio indica con assoluta chiarezza quale sia la strada
che l’uomo deve seguire: quella della conoscenza che porta alla contemplazione della
verità, del sommo bene. Era la strada del filosofo che Averroè aveva tracciato e che
Dante, da poeta, intraprende. Considerans ripete Boezio in anafora negli ultimi quattro
capoversi; e Dante: Considerate la vostra semenza. Valutate e scegliete. E Dante ha
scelto. Scelto una sapere cosmopolita; scelto un universo in cui c’è uno spazio adeguato
per ogni uomo di buona volontà.
i Sofronio Eusebio Girolamo (Stridone, Dalmazia 347 - Betlemme settembre 420). Per gli itinerari verso
e nella Terra Santa, cfr: John Wilkinson, Jerusalem pilgrims before the Crusades, Warminster, Aris
&Phillips Ltd., 1977; Jean Richiard, Croisée, missionaires et voyageurs les perspectives orientales du
monde latin medieval, London, Variorum Reprints, 1983; Franca Mian, gerusalemme città santa. Oriente
e pellegrini d’Oriente (secc. I-IX/XI), Rimini, Il Cerchio, 1988.
ii
Hārūn al-Rashīd (766 - 809) fu il quinto e più famoso della dinastia Abbasside di Bagdad. Governò dal
786 all’809; la sua fama è immortalata, fra l’altro, ne Le mille e una notte.
Per i suoi rapporti con l’Occidente e, in particolare con Carlo Magno, cfr. Giosuè Musca, Carlo Magno e
Harun Al-Rashid, Bari, edizioni Dedalo, 1996.
iii Rodolfo il Glabro ( 985 – 1047). Monaco cluniacense, fu allievo di Guglielmo da Volpiano
iv Il suo vero nome era Abu’l-Qasim az Zahrawi-Kalaf ibn-‘Abbas at Tasrif (vissuto tra 936-1009/13); fu
importante – tra l’altro - per osservazioni originali sulle malattie dell’orecchio e della gola, e sulla relativa
tecnica operatoria.
v Le crociate avvengono nei seguenti anni: I 1095-1142; II 144-1187; III 1187- 1197; IV 1202- 1204; V
1217- 1221; VI 1225 -1247; VII 1248 – 1269; VIII 1270 – 1291.
vi Assisi 1182-1226.
vii Lo seguì subito dopo un gruppo di cinque frati che, partiti dal Portogallo, sarebbero poi stati
martirizzati a Marrakech.
viii ”Per dies aliquot ipsum sibi et suis Christi fidem praedicantem attentissime audivit”. L’incontro,
riportato da numerose fonti francescane, ha lasciato tracce prima nel capitolo 16 della Regola non bollata
(del 1221) e successivamente, anche se con minore efficacia, nel capitolo 12 della Bollata (1223). A ogni
modo già nel XII secolo il rabbino Beniamino di Tutela, nei suoi Itineraria, ci aveva lasciato
testimonianza degli amichevoli rapporti tra cristiani e musulmani, descrivendo con dovizia di particolari
sia contatti di tipo commerciale (Montpellier, Costantinopoli, Alessandria), che semplici ambascerie
presso le corti del levante.
ix Il pioniere del movimento di traduzione del dodicesimo secolo, Adelardo di Bath (ca. 1080- 1160),
dedicò un testo alla descrizione delle sette arti liberali (il suo De Eodem et Diverso), e realizzò anche la
prima traduzione degli Elementi di Euclide dall’arabo.
Stefano il filosofo, lavorando ad Antiochia all’inizio del XII secolo, denunciava la scarsa conoscenza
della geometria tra i latini, e Giovanni di Salisbury (1110 ca. – Chartres 1180) pensava che l’unico luogo
dove lo studio era stato fiorente fosse la Spagna (islamica).
x Severino Boezio (Roma 480 – Pavia 524). Per quanto riguarda l’astronomia, in particolare, non è
sopravvissuta nessuna traduzione di Boezio, ma i latini erano consapevoli che il più importante testo
greco fosse l’Almagesto di Tolomeo, ed è proprio per questo libro che si dice che Gerardo da Cremona si
recasse a Toledo. Per la geometria Boezio aveva tradotto solo una piccola parte degli Elementi di Euclide.
Per i traduttori che intendessero rifondare lo studio di Euclide, Tolomeo, Aristotele e Galeno era
necessario ricorrere ai centri del sapere greci e arabi. I greci bizantini avevano preservato i testi antichi
senza sostanziali alterazioni. Tra i greci, perciò, i Latini cercavano e potevano trovare le loro copie
dell’Almagesto di Tolomeo, dei Libri naturales di Aristotele, e delle opere di Galeno.
xi I Banu Hud furono una dinastia locale di emiri che governarono Lleida, Saragossa e altre città dal
1039 al 1110. ; e il 7 marzo 1277 viene reso pubblico il decreto, risultato di un'infelice iniziativa del solito
vescovo
xii
Cfr. Charles Burnett, Medio Evo, quando l'Occidente voleva imparare dall'Oriente. Relazione
tenuta in occasione della conferenza Al di là di Orientalismo e Occidentalismo, organizzata da ResetDialogues on Civilizations al Cairo d’ Egitto, dal 4 al 6 marzo 2006.
xiii Miguel Asìn Palacios, La escatología musulmana en la Divina Commedia. Historia y critica de una
polémica, Madrid 1919 (trad. it. Dante e l’Islam. L’escatologia islamica nella Divina Commedia, Milano,
Il Saggiatore, 2005).
xiv Ibn Masarra (Cordova 883- 931).
xv I sufi erano "quelli della veranda", i compagni del Profeta Muhammad che avevano lasciato tutto pur
di vivere quanto più vicino al Profeta Risiedevano sotto una veranda fuori della casa di Aisha.
Quando il Profeta usciva erano i primi ad incontrarlo, quando riceveva un dono lo divideva con loro.
Vivevano senza possedere nulla ed in continui digiuni e devozioni. "Suf" vuol dire lana. I Sufi dei primi
secoli erano asceti che vivevano nei deserti vestiti di una lunga tunica di lana, loro unica proprietà,
insieme al secchiello per l'acqua. Questa tunica era ovviamente logora e rattoppata. Queste toppe, cento
come i nomi di Allah menzionati nel Corano, in epoca più tarda divennero colorate, fino a diventare il
"costume" tipico del "Dervish" (poverello) del medioevo.
xvi
Si veda la bella sintesi fatta da Asìn Palacios nel IV capitolo: Adattamenti, principalmente allegorico
mistici della leggenda, op. cit. p. 86.
xvii
Ivi, pp. 116-117.
xviii
Riguardo a questo aspetto, determinante fu l’apporto dei pensatori Sufi, in particolare del murciano Ibn
Arabi. Aspetto che vedremo più avanti. Ad ogni modo Asìn Palacios già ne parla a proposito della
redazione B del ciclo II (ivi, p. 31).
xix
Ivi, p. 3.
xx
Ivi, p. 15.
xxi
Il Corano, Cura e traduzione di Hamza Roberto Piccardo, G.T.E. Newton, Roma 1996.
xxii
Ivi, p. 60. cfr. Giordano Berti, Dante Alighieri, in I mondi ultraterreni, Milano, Mondatori, 1998, p. 4.
xxiii
Ivi, p. 62.
xxiv
In particolare si veda M. Asìn Palacios, op. cit. par. I, Storia di una Polemica, anno 1920, p. 541.
xxv
Ivi, p. 542.
xxvi
La presenza nel nostro paese del Libro della Scala è attestata, fra gli altri, da una esplicita citazione nel
Dittamondo (1350-60) di Fazio degli Uberti..
xxvii
M. Asìn Palacios, op. cit. p. 162.
xxviii
Ricordo il significato della collocazione di Maometto, condannato più che come fondatore di un’altra
religione o di una nuova eresia, come seminatore di discordie, insieme a personaggi di varia natura come
Fra' Dolcino, Pier da Medicina, Mosca de' Lamberti, e Bertrand de Born: “La sua colpa è quella di aver
dato origine a guerre tra gli uomini, infrangendo con la violenza il legame di fratellanza che li dovrebbe
legare.”
xxix
Avicenna è presente in Convivio II, 13, 14; III 14; IV 21; Inf. IV 143
xxx
Averroè è presente in Convivio IV 13; Monarchia I 3; Questio V, XVIII; Inf. IV 144; Purg. XXV 63.
xxxi
Ad Alfargani è da far risalire la teoria sulle macchie lunari.
xxxii
Alessandro Raffi, estratto di una relazione seminariale tenuta presso il Monastero del Corvo Ameglia
(SP), 5 dic. 2004, in occasione degli Stati Generali del Centro Lunigianese di Studi Danteschi per la
preparazione delle celebrazioni dantesche del 2006, p. 2.
xxxiii
Ibidem, p. 2.
xxxiv
Avicenna, nome latinizzato di Abu Ali al-Husain ibn-Sina (Afshana, presso Buhara, 980 - Hamadan 1037).
xxxv
Ma il pensiero di Avicenna è accolto rettificato da S. Tommaso d’Aquino, che elimina ogni idea
emanatista; basta leggere il Convivio dantesco – specie il trattato II°, IV-VI.
xxxvi
Averroè, il filosofo arabo-andaluso Abul Walid Mohammad Ibn Rushd (Cordoba 1126 – Marrakesh,
Marocco 1198). Verso il 1195 i dottori della legge lo condannano all’esilio per le sue dottrine, salvo
riabilitarlo poco prima della morte.
xxxvii
Le origini e la diffusione dell’averroismo latino risalgono alle traduzioni latine dei Commenti fatte da
Michele Scoto, probabilmente durante il suo soggiorno a Palermo alla corte di Federico II.
xxxviii
Abdus Salam, La scienza e l'Islam, intervista rilasciata l’11 maggio 1991, ora in Le rotte della filosofia,
Milano, Paravia, 2000. Salam (Jhang Maghiana 1926 - Trieste 1996), fisico pakistano, fu Premio Nobel
per la fisica nel 1979.
xxxix
In realtà non esiste un preciso riscontro testuale fra il XXVI dell’Inferno e il De summo bono, e non si
può parlare, quindi di derivazione. E’, piuttosto, presente, una non dubitabile convergenza di tesi.