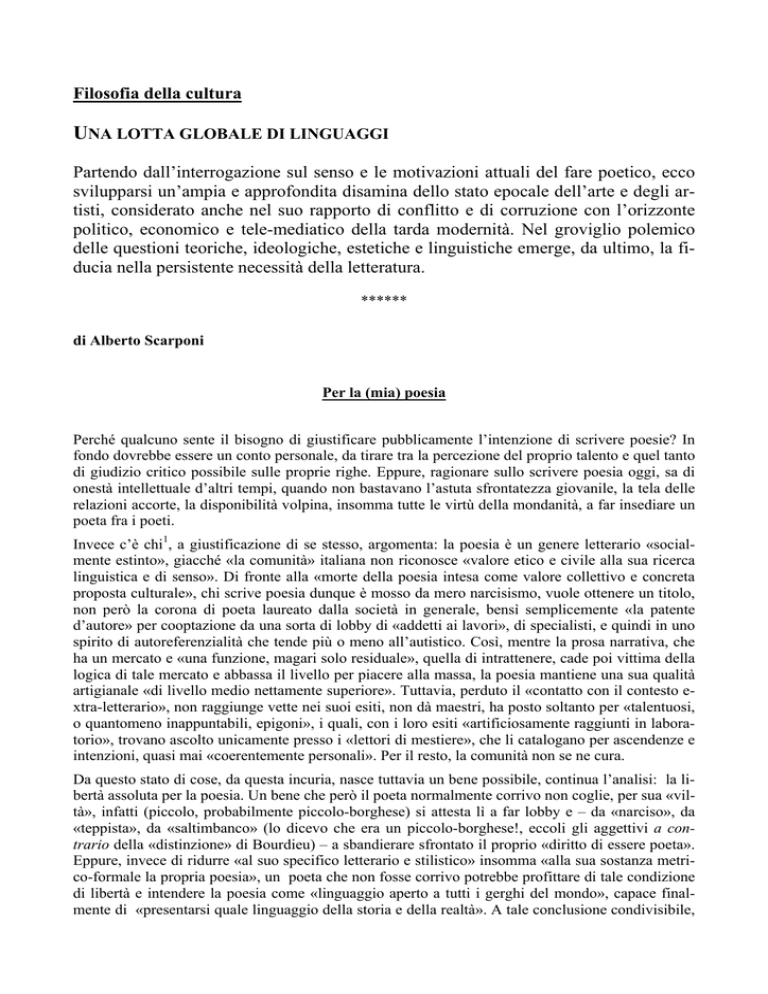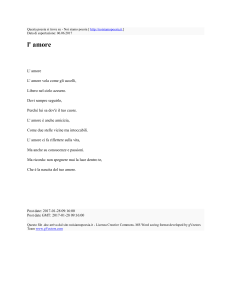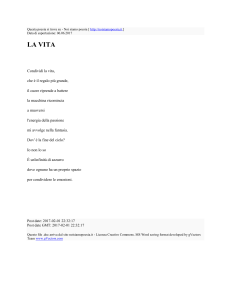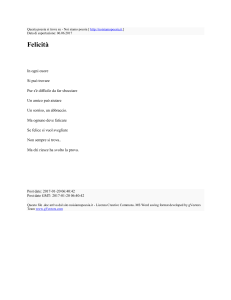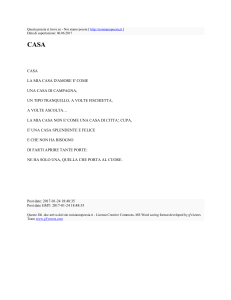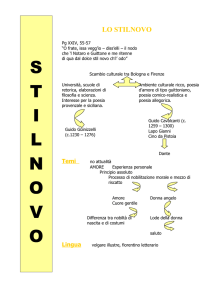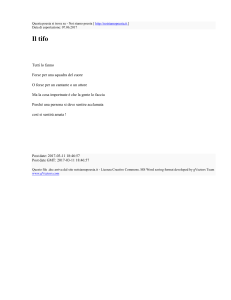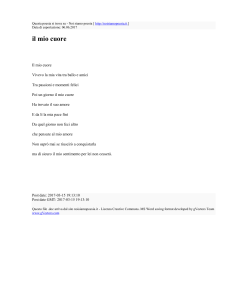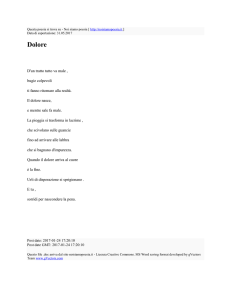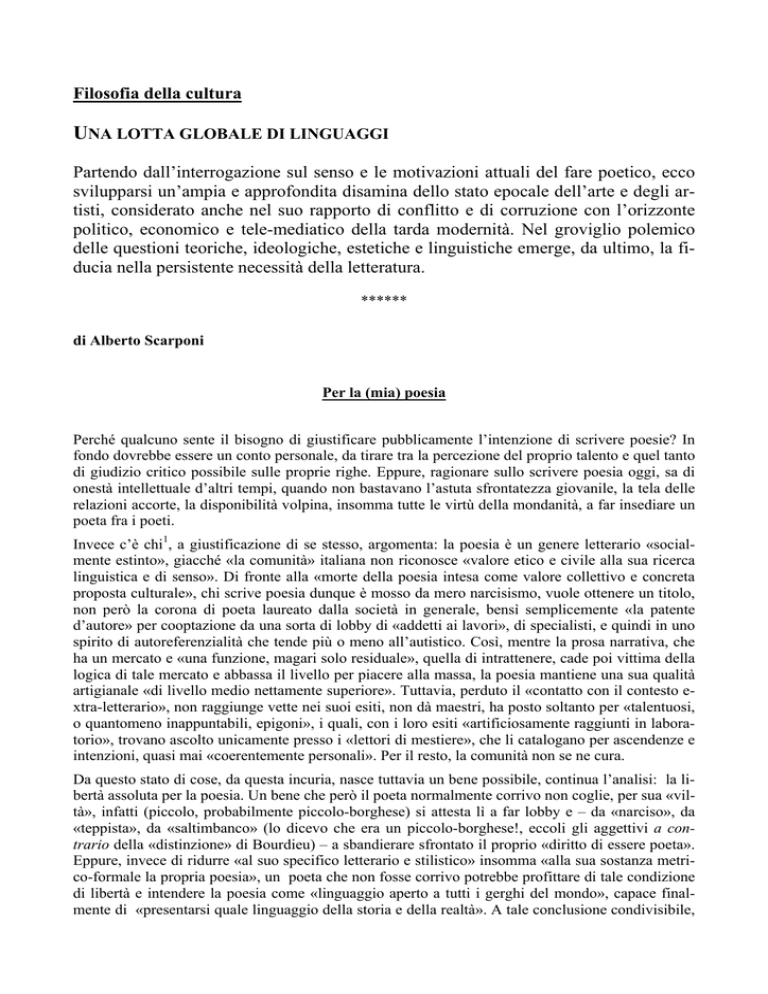
Filosofia della cultura
UNA LOTTA GLOBALE DI LINGUAGGI
Partendo dall’interrogazione sul senso e le motivazioni attuali del fare poetico, ecco
svilupparsi un’ampia e approfondita disamina dello stato epocale dell’arte e degli artisti, considerato anche nel suo rapporto di conflitto e di corruzione con l’orizzonte
politico, economico e tele-mediatico della tarda modernità. Nel groviglio polemico
delle questioni teoriche, ideologiche, estetiche e linguistiche emerge, da ultimo, la fiducia nella persistente necessità della letteratura.
******
di Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
Perché qualcuno sente il bisogno di giustificare pubblicamente l’intenzione di scrivere poesie? In
fondo dovrebbe essere un conto personale, da tirare tra la percezione del proprio talento e quel tanto
di giudizio critico possibile sulle proprie righe. Eppure, ragionare sullo scrivere poesia oggi, sa di
onestà intellettuale d’altri tempi, quando non bastavano l’astuta sfrontatezza giovanile, la tela delle
relazioni accorte, la disponibilità volpina, insomma tutte le virtù della mondanità, a far insediare un
poeta fra i poeti.
Invece c’è chi1, a giustificazione di se stesso, argomenta: la poesia è un genere letterario «socialmente estinto», giacché «la comunità» italiana non riconosce «valore etico e civile alla sua ricerca
linguistica e di senso». Di fronte alla «morte della poesia intesa come valore collettivo e concreta
proposta culturale», chi scrive poesia dunque è mosso da mero narcisismo, vuole ottenere un titolo,
non però la corona di poeta laureato dalla società in generale, bensì semplicemente «la patente
d’autore» per cooptazione da una sorta di lobby di «addetti ai lavori», di specialisti, e quindi in uno
spirito di autoreferenzialità che tende più o meno all’autistico. Così, mentre la prosa narrativa, che
ha un mercato e «una funzione, magari solo residuale», quella di intrattenere, cade poi vittima della
logica di tale mercato e abbassa il livello per piacere alla massa, la poesia mantiene una sua qualità
artigianale «di livello medio nettamente superiore». Tuttavia, perduto il «contatto con il contesto extra-letterario», non raggiunge vette nei suoi esiti, non dà maestri, ha posto soltanto per «talentuosi,
o quantomeno inappuntabili, epigoni», i quali, con i loro esiti «artificiosamente raggiunti in laboratorio», trovano ascolto unicamente presso i «lettori di mestiere», che li catalogano per ascendenze e
intenzioni, quasi mai «coerentemente personali». Per il resto, la comunità non se ne cura.
Da questo stato di cose, da questa incuria, nasce tuttavia un bene possibile, continua l’analisi: la libertà assoluta per la poesia. Un bene che però il poeta normalmente corrivo non coglie, per sua «viltà», infatti (piccolo, probabilmente piccolo-borghese) si attesta lì a far lobby e – da «narciso», da
«teppista», da «saltimbanco» (lo dicevo che era un piccolo-borghese!, eccoli gli aggettivi a contrario della «distinzione» di Bourdieu) – a sbandierare sfrontato il proprio «diritto di essere poeta».
Eppure, invece di ridurre «al suo specifico letterario e stilistico» insomma «alla sua sostanza metrico-formale la propria poesia», un poeta che non fosse corrivo potrebbe profittare di tale condizione
di libertà e intendere la poesia come «linguaggio aperto a tutti i gerghi del mondo», capace finalmente di «presentarsi quale linguaggio della storia e della realtà». A tale conclusione condivisibile,
Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
2
tuttavia, si aggiunge una precisazione che a me pare (ma posso sbagliarmi) in qualche modo deviante, verso la politica: la poesia potrebbe presentarsi quale linguaggio «della critica radicale della storia e della realtà, della ridefinizione puntuale della storia e della realtà», dal punto di vista, aveva già
detto prima, di quell’«irriducibile umanista», che il poeta è in quanto «disperato intellettuale verosimilmente in conflitto, invece che in accordo, col proprio tempo».
Che fare?
Lo spunto è buono per ragionare di conseguenza. L’abbreviata analisi fenomenologica ritengo infatti colga nel segno e l’indicazione del bene possibile per me è esatta e senz’altro acuta: il tramonto di
«una civiltà letteraria, con i vincoli, le gerarchie e le ostruzioni che la compongono» offre – per ora,
sembra, di preferenza alla poesia – una condizione di libera operatività letteraria, che può diventare,
se uno vuole, autonomo lavoro sul linguaggio, in presa diretta con il sito del reale. Dopodiché (e già
l’ho segnalato con qualche mia interferenza, questa per esempio, informatica, sul rapporto fra linguaggio e realtà) cominciano i distinguo, i bivi, i problemi e il bello della riflessione per me.
Nel decidere che fare, dovrei intanto distinguere il senso di gaia festa anarchica da cui sembrano
trarre alimento molti, il poeta dello sballo o quello dell’ironia minimale o quello dell’insensatezza o
quello dell’aspro stil post o ognuno che narciso, teppista, saltimbanco, vada poeticamente disubbidendo a un padre che non c’è più (si licet: quando il gatto manca, i topi ballano), dovrei distinguere
questo dalla libertà di lavorare live sul linguaggio, cioè senza più la mediazione della politica,
dell’economia e dell’etica istituzionalizzata ossia della religione. E, tanto per completezza, di questa morte del padre, a mia impressione, sono effetto, come deriva deterministica, non libera, anche
le autoamorevolezze solipsistiche sul pronome impennacchiato e sul suo smarrimento e sul suo corpo e sulle sue straniate, negate, quanto preziose, emozioni, di molta scrittura giovane ambosessi.
La novità
È nuovo tutto questo? Dice: no, in letteratura nulla è mai nuovo. Mossa oratoria che, a mio avviso,
lascia il tempo che trova, il nuovo esiste qui come dappertutto, naturalmente si tratta di vedere in
concreto. E per ogni cosa il concreto comincia ovviamente con la sua condizione di esistenza, che
per l’appunto quanto alla letteratura sta e si forma in perpetuo nel contesto. Ora, se vedo bene, il
contesto è mutato. L’unitario mondo della Bildung, dove centrale era un uomo-idea-regolativa, organico alla comunità umanistica (non alla comunità umana concreta e tutta), e dove a questa idea
regolativa apparteneva il bisogno sociale di una letteratura, di un’arte, di una cultura in genere, come suo medium di esplicitazione assiologica, non c’è più, se non nella mente dolce delle maestrine
e nella sensibilità attardata delle «signore mie!». Tutto ciò si è trasformato nel multiplo mondo della
Kritik decostruttiva, dove nuovo soggetto storico2 è la persona empirica, oramai partner multiverso
della società planetaria, l’atomo ora finalmente generato dal processo storico, soggetto cui appartiene il bisogno di un medium adatto a esplicare la propria azione dialettica, intellettiva e pratica, a tutto campo. Allora il nuovo c’è per la letteratura ed è radicale. Il nuovo sta, a dirla così, nel contesto e
nel suo soggetto: la società di massa planetaria e l’individuo3.
Combinando a modo mio le analisi di Lukács e di Bourdieu, posso azzardare che la società di massa
ha una struttura inedita. In schema: mentre finora la società umana è stata plasmata dalle forme collettive (Lukács: attinenti all’uomo gregario) di politica, economia (Marx: economia politica) e religione come etica istituzionalizzata, ciascuna operante sul terreno materiale con la propria logica,
sul terreno ideologico invece con i mezzi della persuasione forniti dalla cultura in veste ancillare (filosofia e storia per la politica, scienza per l’economia, arte per l’etica-religione), oggi la società umana è plasmata dalla multiforme cultura (Lukács: attinente all’uomo individuo), divenuta
anch’essa campo (Bourdieu) autonomo, in dialettica con i campi, nel moderno già autonomi, della
politica, dell’economia, dell’etica-religione. Questa autonomia aggiunta della cultura apre una nuo-
Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
3
va realtà, cioè una nuova dialettica, e quindi spiazza l’azione degli altri campi, che in risposta si
chiudono nel proprio particolarismo conservatore, rivendicando all’estremo l’ordine pubblico (per
ogni campo ciò che fuoriesce dalla propria logica viene ritradotto in questione di ordine pubblico: di
rispetto della legalità per la politica, di rispetto del contratto per l’economia, di rispetto del comandamento per l’etica-religione, ma anche, ora, di rispetto della libertà per la cultura). Non occorre rilevare come si abbia di fatto una reciproca indifferenza di ogni campo per i contenuti-valori di tutti
gli altri: la politica legalizza qualsiasi cosa (l’antieconomico, l’immorale, l’irragionevole) se non
turba il suo ordine, l’economia compravende qualsiasi cosa (il politico, il religioso, il culturale e il
loro inverso) se produce l’ordine del profitto, l’etico-religioso sacralizza qualsiasi cosa (la guerra, lo
sfruttamento, l’illibertà e il loro inverso) se serve ad affermare la propria logica, la cultura parla di
qualsiasi cosa (di politica e di illegalità, di ricchezza e di povertà, di etica e di cinismo) purché porti
acqua al proprio mulino critico.
A me sembra un buon ritratto della realtà. Se lo cose stessero così, la letteratura si troverebbe in una
condizione affatto nuova. Io credo in effetti che le cose stiano così e che la letteratura stessa ne venga messa in discussione almeno, senza andare sul drastico, per i suoi comportamenti tradizionali.
Intanto, come pare chiaro, non può più avere l’attitudine umanistica consona all’uomo astratto della
Bildung. Questa idealità – a parte il suo persistente uso da parte dell’intrattenimento evasivo e perciò manipolatorio cui si dedica l’umano, troppo umano lialare di questa o di quello, a vantaggio
dell’ordine pubblico politico-economico-etico istituzionale – non ha più funzione. Nella società di
massa, liberale e quantitativa, le tre vecchie autonomie funzionano benissimo da sé con la rispettiva
legge bronzea del proprio specifico e non abbisognano di ancelle generalizzanti, come prima
nell’antichità classica, nel medioevo, nel moderno, quando in Europa dalla dialettica servo-padrone
venivano bastevoli soddisfazioni per tutti. L’impegno artistico, letterario, è mosso, beninteso, secondo la propria natura, anche ora dalla logica dell’anthropos, ma come sempre vede l’anthropos
nella figura tangibile con cui esso storicamente si presenta. Oggi è persona empirica spiritualmente
ricca di corpo, sensibilità, psiche, intelletto, emotività contestualizzati in uno spazio ormai totale,
solo geografico, e quindi (teoricamente) aperto, tutto fruibile ed edificabile, eppure minacciato in
primo luogo dalla limitatrice volontà di potenza delle tre logiche principali, più la propria, tutte in
lotta per il loro singolo monopolio su tutto. Ciascuno dei quali monopoli produrrebbe una specifica
catastrofe generale.
La politica lasciata a sé, senza freni dialettici, ci ha già fatto vedere Auschwitz, al che abbiamo addirittura dubitato che si potesse ancora poetare, dunque vivere nella comprensione (possibile) di noi
stessi, e per altro verso ci ha anche fatto chiedere nientemeno se il cambiamento sia poi possibile; il
monopolio dell’economia, lo vediamo, funesta ogni giorno la nostra la vita con il tuo tentativo elegante, e talora pacchiano, di credere alla «fine della storia», di eternare, in exempla globali e/o strapaesani, un morto presente fatto di orrido vacuo, di guerre liberali, di armi intelligenti, di morti invisibili, di imperterrite statistiche da paura; l’etica-religione estrema poi è minaccia, lo diciamo tutti,
che dio ne scampi: vizi privati, pubbliche virtù, dominio fosco, morti fulgide, cavilli, pianti, mistica
sadomaso, sorrisi e ipocrisie, il giusto rimandato letteralmente alle calende greche.
Il pensiero unico, la mancanza di senso dell’altro (degli altri pezzi di realtà antropologica, in questo
caso) e la conseguente volontà di dominio totale non dovrei attribuirli alla cultura, così povera e nuda, priva di armi e persino di armature, così, diciamolo, debole in un mondo di forti, e di per sé propensa piuttosto alla oraziana mediocritas, che aurea e paziente tutto comprende. Questa immagine
della cultura, soprattutto letteraria, mi deriva però dal tempo del suo ruolo ancillare, ai comandi della religione, della politica, dell’economia. Nell’assetto attuale, o che ora va cominciando, la sua emancipazione mi sembra sia stata qualche volta euforica, così essa può aver mancato del senso delle
cose, del contatto con i propri limiti, ed è partita per la tangente della logica fantastica, che è la logica sua propria, ma che per essere utile all’anthropos e produttiva d’arte deve misurarsi con il mondo, non può considerarsi logica unica. Secondo me, il monopolio della immaginazione produce mostri, è sonno, la veglia (La veglia di Finnegan?) invece si misura e si dà misura: la sua misura, che
Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
4
da fuori può anche sembrare – quanto più l’intenzione è artistica tanto più – incomprensibile dismisura, mentre sta solo snocciolando problemi che con altri occhi nemmeno si vedono (come
d’altronde accade nel campo rispettivo a ognuna della sfere suddette; il compito sarà costruire tolleranza e democrazia tra le sfere).
Quanto alla cultura, all’arte in specie, il punto da studiare è la libertà in cui si trova. Le sue abitudini
ancillari sono ora deprezzate dal disinteresse che politica, economia, etica-religione mostrano verso
di essa, cioè, devo precisare a scanso di equivoci, dal loro disinteresse verso il suo linguaggio e
dunque verso i problemi antropici che lo rendono necessario. Ciascuno degli altri campi interviene
in campo culturale solo se un fenomeno (un film, un libro, una ricerca scientifica, uno spettacolo,
una struttura, una teoria, un discorso) ha ripercussioni sul piano dell’ordine pubblico suo proprio: o
del consenso politico o dell’assetto di potere economico o del controllo etico. Altrimenti lo abbandona lì, quel fenomeno, come ubbia filosofica, astrusità scientista, dilettantismo teologico, insomma
come irrilevante poesia.
Anche se poi, sul piano sociologico, mai come nella società di massa le persone di cultura hanno
avuto di fatto tanta importanza politica, nella loro veste di opinion makers o almeno di testimonials,
tanta importanza economica come produttori e figure della pubblicità, ma anche nella loro funzione
istituzionale formativa (delle cosiddette risorse umane per le imprese), infine tanta importanza etico-religiosa, per la loro perturbante autonomia critica possibile, che costringe i teologi di professione a improbe ginnastiche mentali. Ciò perché il tessuto connettivo della società di massa, persino
nelle sue versioni totalitarie e persino quando il suo controllo viene garantito da potenti servizi segreti incontrollabili, è sempre alla fine – mi pare chiaro – composto di consenso, di adesione della
massa, oltre che per interesse materiale, anche per nesso ideologico, visceralità carismatica e/o persuasione argomentativa. I filosofi, gli scienziati, gli esperti vi diventano vuoti opinionisti politici,
economici, etici (i tanti consiglieri dell’anima). Fuori da tali ruoli, dove sono maschere prive di sostanza specifica e del suo corrispettivo linguistico, paradossalmente le persone di cultura a quegli
occhi sembrano inutili.
In pratica, dico, è semplicemente una lotta di linguaggi. Sembra poco a prima vista, ma si tratta di
una questione epocale al cui centro sta la cultura, con l’arte, e in specie la poesia, in primo piano.
L’autonomia infatti ricompone in un tesoro unico, all’interno del campo cultura, la molteplicità delle conoscenze, tra cui nuova quella antropica che deve elaborarsi quale comprensione di una nuova
realtà. La comprensione cioè soltanto culturale, multipla, fluida, non più essiccata a seconda dei
campi in cultura politica o economica o etico-religiosa. Ma tale processo elaborativo sconvolge la
divisione dei poteri del moderno e può farsi solo con la lotta. Perché: (1) i singoli campi hanno nella
cultura in loro possesso e nel rispettivo linguaggio un necessario mezzo di costruzione di sé, di crescita e di adeguamento vitale; (2) ciascun campo è capace di intendere il linguaggio degli altri soltanto in traduzione, ma tutto quanto sia stato tradotto viene poi considerato parte del proprio orizzonte; (3) i tre campi più antichi, politica, economia ed etica-religione, si sono costituiti non soltanto come punti di vista, ma anche come poteri materiali, quindi l’intrusione di un nuovo campo appare loro una vera minaccia esistenziale. Poiché tuttavia il nuovo arrivato non sembra rivendicare
parti della risorsa potere (o almeno finora non l’ha fatto), sarà sufficiente fingere che non esista e
sottoporlo semplicemente al solito costante lavoro di traduzione linguistica.
Il mondo televisto
La cultura diventa uno spettro, e si aggira anch’essa per l’Europa minacciosamente, ma ha un lato
debole, è cosa fungibile. La politica ne trae infatti i suoi opinionisti, l’economia i suoi pubblicitari e
intrattenitori, l’etica istituzionale i suoi consiglieri dell’anima. Con qualche inconveniente qua e là,
tuttavia le strutture linguistiche restano in salda coerenza con il passato. Un esempio concreto di
questa lotta? La questione televisiva. Vi si intrecciano attivamente, almeno in Italia, la pretesa politica, quella economica e quella etica. Lo sviluppo tecnologico (la cultura) apre nuove strade, però
Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
5
politica ed economia vengono a trovarsi in disaccordo sulla scelta da fare. La prima ha bisogno della cosiddetta tv generalista, la seconda vuole la pay tv Il conflitto ha grande peso nella società di
massa, che è costitutivamente innervata da correnti comunicative collettive. Io direi che si tratta
dunque di una società in sé mediatica quanto a strutture e accentuatamente linguistica quanto a dinamiche.
Un esperto, Carlo Freccero4, mi ha chiarito il movimento di base: «In una società mediatica si può
parlare solo di qualcosa che può essere condiviso e la tv generalista è il luogo della condivisione», il
non-luogo, se si vuole, dove l’evento accade in presenza di tutti. Ecco allora i grandi eventi televisivi, talora reali talora fittizi, ma in ogni caso punti simbolici forti. Infatti «è la tv generalista a dettare
i modelli sociali contemporanei». Essa «crea maggioranza», di qui il suo potere politico, etico ed
economico.
Ne traggo la conclusione che si tratta anche di un potere linguistico, più esattamente letterario, che
promuove un tipo di linguaggio con due assi portanti, la realtà come riferimento e la velocità come
procedura. Facile leggerne l’ideologia: la nostra esperienza del mondo è certa e immediata, comunicabile senza la mediazione del dubbio. Tale contenuto ideologico è del tutto refrattario alle aperture del pensiero critico e al suo linguaggio multistrato. La realtà infatti qui compare, in soggettiva
direbbe un narratologo, cioè come mito e non come effettivo oggetto di un lavoro conoscitivo. È solo l’argomento retorico da cui trae energia, non la scoperta, l’alèteia, aristotelica, ma il persuadere
del sofista, il quale si rivolgeva al destinatario del suo discorso soltanto perché condividesse con la
maggioranza sentimenti e opinioni, indipendentemente dalla loro verità Nella società di massa, potremmo dire, siamo tornati alla sofistica, dove appunto stare con la maggioranza è aver ragione,
perché la realtà è un fatto e nessuno che sia ragionevole può negare che il fatto sia anche la verità,
che sia cioè la realtà conosciuta. E quanto maggiore è quantitativamente un fatto, tanto più è verità.
(Il pensiero critico, io penso, si domanda invece come mai un qualcosa diviene un fatto e un altro
qualcosa no. L’arte e la letteratura, io penso, lavorano su questo, esclusivamente su questo)
Il grande evento mediatico dei funerali del papa, per esempio, comunica che la sua morte è un fatto
e importantissimo, giacché nessuno può negare la verità evidente dei sentimenti della folla dei telespettatori e delle opinioni dei fedeli presenti sulla scena. I mondiali di calcio sono un fatto, pur artificiale, e nessuno può negare i sentimenti di appartenenza competitiva dei milioni di telespettatori e
la verità delle loro opinioni, serie come diventano seri i giochi, una volta che ne siano state accettate
le regole, tanto da potervi costruire sopra e attorno una realtà economica, la quale a sua volta retroagisce sul valore di verità dell’evento.
Per tale via, infine, la realtà diviene un reality, un fatto televisivo. Il quale «nasce in America come
gioco duro sulle psicologie», come espediente performativo (dunque ludico) e iperrealistico (dunque irreale) di una letteratura televisiva scritta per la pay tv, che ha di mira la risposta economica del
mercato, in Italia invece entra come stile narrativo nel contesto politico della persuasione della massa tramite la tv generalista, la quale adotta allora, congruamente, un linguaggio apparentemente realistico da «minimo comun denominatore», elementare. Il reality, da finzione narrativa, si trasforma
in persuasiva realtà narrata.
La questione dunque, ne deduco, non è né di contenuti, che con la loro platitude eccitano le parti
basse del gusto, come di solito si polemizza da parte delle persone dal palato fino, né di genere narrativo che, con la sua apoteosi naturalistica del fatto informe contro la libera immaginazione, afferma e difende l’esistente contro l’apertura utopica. È, ragiono, propriamente una questione di linguaggio. Quel che nel contesto generalista italiano viene prodotto tramite la povertà linguistica estrema, nel contesto pay americano viene a sua volta prodotto tramite la finzione iperrealistica: là la
realtà è sostituita da una narrazione, qua da un gioco. La realtà, troppo squallida e coercitiva e inaccettabile e banale, va vissuta, dice l’ideologia, fuori dalla quotidianità, dove si presenta eccezione
trasfigurata – tramite la vacanza del lavoro conoscitivo – in festa o gran discorso oppure in gioco
veristico a effetto, in esperienza circense, che mira al brivido in sé. Il linguaggio della letteratura
Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
6
televisiva esistente, generalista e pay, aggiunge l’esperto, dappertutto nell’occidente è
«l’espressione del mondo di oggi dominato da un liberalismo che ha nell’individuo il suo centro. La
realtà non è più fuori, nella società, ma dentro di noi, nel nostro narcisismo, nelle nostre paure, nei
sentimenti». A questo depauperamento della ricchezza del mondo ristretta nell’orizzonte minimo
dell’individuo borghese i reality italiani aggiungono un’ulteriore disattenzione verso la realtà, nel
senso che qui per giunta «il posto dell’introspezione è stato occupato da un unico sentimento.
L’amore in tutte le sue declinazioni», con la conseguenza ulteriormente manipolatoria che ogni discorso in proposito diventa gossip.
È un discorso davvero interessante per me questo di chi, da dentro una forma del campo cultura, rivendica un linguaggio che plasmi se stesso per la realtà reale e non per quella manipolata a visione
politica o per quella confezionata a prodotto economico. Ancora all’interno del suo tema l’esperto
Freccero denuncia en passant che alla tv generalista italiana addirittura «manca uno dei suoi linguaggi fondamentali», quello della tv verità. Ora, già il reportage e l’inchiesta alludono a un cambio
di registro linguistico, dalla persuasione della politica o dall’indifferenza dell’economia si passerebbe alla critica prodotta dall’informazione veritiera. Non siamo ancora all’arte e alla scienza, tantomeno alla completezza della letteratura (che a me pare la più completa delle arti), ma il verso è
quello. Quelle due egemonie, pur in lotta, non ammettono scivolamenti verso linguaggi incontrollabili perché costruiti su logiche diverse dalle loro. Cum grano salis, naturalmente, giacché da abili
paguri ambedue, se serve, si insediano nel guscio scientifico, artistico o letterario, lo svuotano della
sua vita interna e se ne vestono per i propri fini. Così, ad esempio, il campo economico accetta, se
dà profitto, anche l’inchiesta, il reportage e persino l’opera d’arte, ma appunto confezionati in prodotto editoriale o artistico e, finché dura la domanda creata con il marketing, è anche meglio se
vengono confezionati in prodotto seriale, viste le potenzialità economiche della «riproducibilità tecnica».
La microelettronica ci ha immerso ultimativamente in questo riscontro elementare di Walter Benjamin (dico: i grandi sono grandi perché parlano, in pratica, solo di fatti elementari) e ci costringe a
intendere che, se il campo cultura, sotto forma di prodotto artistico o editoriale, si è spogliato di sé,
è divenuto un corpo economico, ed è dunque un re nudo senza rimedio, bisogna o accettare che non
sia più re o, che è lo stesso, giocare al come se, fingere di crederci solo perché lui e i suoi accoliti
recitano quella commedia, oppure pretendere che lo dimostri davvero con quello che, nudo com’è,
gli resta: il suo discorso.
La questione linguistica
Discorso? Discorso del campo cultura? Va bene, allora mi sembra di vedere che le domande siano
tre: (1) chi (2) come e (3) perché parla o, più ampiamente, si esprime? Il che cosa, va da sé, non
dovrebbe entrarci nel ragionamento, in quanto la novità storica è appunto il libero articolarsi del
pensiero nel campo cultura, a partire dalla scelta del tema, del suo orizzonte e, se si vuole, del suo
contenuto ideologico in uno dei due sensi marxiani, quello secondo cui le idee hanno sempre un
punto di vista partigiano, trasformatore o conservatore della realtà, non evidentemente nell’altro,
dove le ideologie conservatrici compaiono sempre come falsificazione mentale della realtà (e viceversa, quando una ideologia manipola la conoscenza del reale, checché dica di sé, è conservatrice di
ciò che non conosce), mentre le ideologie trasformatrici hanno sempre bisogno di conoscere ciò che
vogliono trasformare, pena condotte controfattuali, errori e deliri
Poiché so che metodologicamente è la meta a darmi l’inizio, parto dal terzo problema. Perché parla
chiunque oggi prenda la parola in campo culturale e in specie artistico? La risposta è semplice: per
conoscere (o, se sta manipolando, per dar a credere di voler conoscere) la realtà qua talis, la cui conoscenza corrente è invece mediata, pur legittimamente nel loro senso, dai grandi dispositivi della
politica, dell’economia o dell’etica-religione. Qui non mi paiono una obiezione la complessità
dell’oggetto da conoscere e la pluralità degli approcci possibili e necessari, anzi il groviglio delle
Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
7
dimensioni reali (tanto da far dubitare del concetto stesso di realtà unica, fra possibile ed effettiva,
vera e falsa, virtuale e onirica, tattile e psichica, visibile e invisibile, utopica e immaginaria, scientifica e metafisica, micro e macro, quotidana e quadridimensionale, locale e globale, eccetera eccetera), dunque le molte dimensioni della realtà e la dinamica indeterminante degli sguardi su di esse
producono, a mio avviso, piuttosto una gerarchia dei linguaggi in uso, dove politica, economia ed
etica-religione esibiscono, con le loro mire tutte governamentali, una povertà linguistica davvero estrema, che oggi temo sia sul serio preoccupante, mentre una superiore capacità di linguaggio appartiene certamente all’informazione, quando è vera volontà di far sapere, più in alto ancora metterei lo spirito di ricerca delle scienze, aperto a ogni innovazione linguistica motivata, sebbene specialisticamente, e altrettanto vale per la filosofia sul suo terreno razionalizzante, ma in vetta stanno indiscutibili, così la vedo io, la duttilità linguistica, l’invenzione espressiva, la fantasia strutturante, la
sovranità semiotica, l’intuizione immaginativa delle arti, con i loro linguaggi totali così adeguati al
complesso e al plurale.
Quanto al secondo problema, il come, dal riferimento alla realtà non ritengo deducibile l’opzione
stilistica del realismo, che resta una fra le mille vie possibili per chi si incammini verso quella meta.
Piuttosto a me sembra che sia stata la sudditanza retorica al linguaggio persuasorio della politica (le
cose stanno così, altro che chiacchiere! questa è la realtà! e dunque abbiamo ragione noi) a far
scambiare un tipo di naturalismo (il nudo, positivistico, minuziosamente mimetico rispecchiamento
linguistico del fenomeno culturale ed emotivo che si voleva propagandare) con il realismo in genere
(che invece mantiene sempre, in tutte le sue varianti, una distanza critica, linguistica, fra narratore e
mondo rappresentato), così come d’altra parte la sudditanza all’economia, la dipendenza dal mercato, può aver messo a frutto qualche altro genere di naturalismo, ma talora anche l’antinaturalismo
di maniera, in cerca del caso editoriale o della bizzarria ipervisibile o magari dello scandalo artistico
di per sé, una volta assunta come moda la rottura linguistica con la tradizione, che è faccenda di
tutt’altro significato e peso. Gli stili dunque mi si presentano tutti possibili nella ricerca della realtà
antropica, tutti efficaci: quando producono conoscenza o le sue premesse possibili o le sue conseguenze di comprensione, le strade sono aperte, la scelta è libera
Epperò c’è, preliminare, un punto di metodo su cui devo riflettere bene. Dire o agire? Questo è il
problema: il modo. È un secolo insomma che non si fa che dire che non basta dire, bisogna fare. A
parte i filosofi che, scoperta la dialettica, si sono accorti che «l’effetto reagisce sulla causa e il loro
rapporto si rovescia, l’effetto facendosi causa della causa, che diviene effetto pur rimanendo causa»,
per cui «la prassi che aveva come principio il soggetto e termine l'oggetto, si rovescia, tornando
dall’oggetto (principio) al soggetto (termine)»5, a parte dunque il conseguente «rovesciamento della
prassi» del dire, giacché dire è un fatto pratico, per cui chi parla fa un discorso, ma essendo il discorso causa dell’azione discorsiva del soggetto del discorso e il soggetto effetto di quel discorso,
lui che parla è modificato da quanto dice, e lui a sua volta modifica l’oggetto di cui parla, ma questo
secondo oggetto modificato è a sua volta la causa del discorso che è la causa dell’uomo che parla…
eccetera eccetera, a parte questo filosofare, dico, da cui la utilitaristica, vetero-materialistica, pragmatica e dunque irrazionale gente della società di massa facilmente deduce che è più opportuno fare
subito quello che si vuol fare piuttosto che attardarsi per le vie traverse del dire, è lungo tutto il Novecento che l’azione impera anche nelle arti e lettere. E per tante ragioni: perché le forme del dire
cominciano a non concludere un granché e occorre trasformarle nel senso dell’efficacia; perché
l’oggetto, cioè il mondo, ha bisogno di un nuovo linguaggio per essere conosciuto ed espresso e
quindi occorre distruggere quello vecchio e distruggere si può solo agendo; perché si è stanchi di
parole e si vuol passare ai fatti; perché il soggetto, l’artista, oltre a sentire se stesso come un oggetto
sconosciuto, è a quel punto meno un artigiano (nella letteratura un letterato) orgoglioso del suo mestiere e più un intellettuale che nella società di massa in fieri cerca di collegarsi in maniera adeguata, icastica, spettacolare al nuovo pubblico, come per lunghi secoli e attraverso molti stili letterari
ma soprattutto artistici la chiesa ha insegnato che si fa con la semplice «gente»; e probabilmente per
Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
8
molte altre ragioni. Di fatto oggi uno che voglia scendere in campo, sit venia verbo, nel campo cultura, deve fare i conti con questa, ormai, tradizione dell’azionismo artistico.
È questa la strada? Questa è la strada per entrare in rapporto diretto con la vita, certamente. Ma anche con il fatto antropico? con la marxiana umanità sociale? A me pare che la vita in corsivo somigli tanto alla società borghese, con il suo orizzonte problematicissimo, ricchissimo di tensioni forti e
di sviluppi grandi (anche quello della morte della società o quello della fine della vita sul pianeta o
quello dell’homo totus animal, antipsicanalitico, positivistico, se è per questo), un orizzonte colmo
di esigenze, di domande, di utopie, ma con risposte impotenti, enigmatiche, spesso affidate alla lirica del gesto precario, magari provocatorio, o forse alla lirica della brava ignavia, ma a fil di logica
risposte tutte situate dentro l’alveo della immotivata speranza religiosa, cioè della rinuncia
all’azione in questo mondo. Un’azione che rinuncia all’azione mi torna paradossale, però Non è una
cosa da anime belle? Un po’ è così, in fondo, mi sembra. Se l’arte può essere solo uno stridìo nichilista nella vita in corsivo, allora, quando si riveste di utopia, confina con lo show romantico del rigoletto che ride fuori e patisce dentro, mentre il duca comanda e fotte, quando invece dice di essere
quello che è e, regina, si denuda seducente nel suo scicchissimo nihil, beh confina con lo show gratuito della diva che fa i capricci. In ambedue i casi l’arte dà a vedere di aver accettato la società dello spettacolo6, o da sconfitta o da partecipe, ma a conti fatti, se un conto è possibile, rimettendoci. E
anche quando ne rifiuta il vuoto, e vuole battagliera riempirlo di vita, riesce a farlo solo attivando
un corto circuito, arte uguale vita Dove poi la cosa si estremizza nasce l’artista star (nelle sue varie
incarnazioni e sfumature italiane, riterrei di classificare così per esempio Gabriele d’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Curzio Malaparte, Pier Paolo Pasolini, Carmelo Bene), ma così anche,
insomma vorrei dire, questa cosa desinit in piscem, perché l’opera della star riceve valore, e per
principio non si sa se giustamente o no, soltanto dal riconoscimento (dal consenso spesso scandalizzato) che la società porta all’autore per ragioni tutt’altro che critiche. Pura arte relazionale, in tutta
la sua assurdità, anche se, certo, non lo si può negare, in tutta la sua efficacia azionistica, a volte con
l’apertura epocale di nuovi piani estetici. Qualcosa di buono lo si trova sempre nella vita.
Secondo me l’azionismo nell’arte e nella letteratura è servito e molto, nel lungo periodo, forse tutto
il Novecento, in cui è occorso negare qualcosa, dalla tradizione in sé al principio del canone, dalla
sclerosi formale alla censura tematica, dalla sudditanza verso la politica e/o l’economia e/o la religione alla tendenza gerontocratica del sistema cooptativo e infine, quando è stato necessario, soprattutto è servito a combattere il costume conservatore della cultura non ancora consapevole di essere
diventata un campo autonomo. La refrattarietà estetica del sistema tradizionale all’innovazione, anche semplicemente tecnica, indicava che bisognava svecchiare, in una parola, il linguaggio, ma anche l’assetto complessivo costruitosi lungo i secoli come funzione di una società elitaria, suddivisa
in comparti nazionali, poco comunicativa e fornita di strumenti ancora meravigliosamente rudimentali.
Prima di tutto l’azionismo artistico rivela, e lo fa ancora oggi, che è cambiato l’individuo dell’arte.
Per restare alla letteratura, anzi alla poesia, e parlare così, alla grossa, Novalis e Leopardi sono salde
identità umane della Bildung che esplorano universi sconosciuti della modernità, il mondo psichico
notturno e la radicale condizione antimetafisica dell’umano; Rimbaud è già altro, è una «persona
empirica», terrestre, in azione, concretamente in cerca di sé, che si sperimenta persino nella sensibiltà materiale, senza parametri, non è un io compatto che esplora territori, geografici o spirituali,
va, il suo orizzonte è ormai planetario, è tutto il territorio Successivamente, la negazione artistica e
letteraria si articola in azioni che distruggono con i fatti, o almeno vogliono distruggere, consuetudini, convenzioni, parametri, regole (persino quelle grammaticali, di ogni grammatica), confini,
scoprendo oggettivamente e affermando talora teoricamente che l’arte è una, sinestetica, al di là del
suo specificarsi in azioni visive, sonore, verbali comunque combinate e quali che siano i mezzi che
usa per giungere a espressione, ed è liberamente a disposizione della «persona empirica», potenzialmente incondizionata, soggetto della nuova epoca come anthropos che crea e fruisce liberamente.
Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
9
La performance, per dire, dice questo. È un mezzo azzeccatissimo di spiazzamento. Ma forse dice
solo questo. Non costruisce, forse. Se un suo eroe, Jeff Nuttall, precisava che «la performance art
non significa niente», intendendo – immagino – che significa solo se stessa e non questo o quel
progetto politico o ideologico, vuol dire che alludeva all’autonomia del campo cultura, ma anche
che dopo il tempo della ribellione, imparato tutto l’immenso nuovo che la guerra ci ha fatto conoscere e inventare (si sa, lo sforzo bellico è una potentissima leva per lo sviluppo delle forze produttive), nel tempo post, che è luogo di scelte operative, di progettazione e di lavoro, decisivo diventa
il linguaggio, lo strumento vitale del campo cultura. Un linguaggio che significa solo se stesso forse
si rivelerà ancora produttivo, tanto più che sembra esserci molto da inventare sul piano del virtuale
(essendo che il naturalismo della body art più di tanto non può dare, salvo pensare il suicidio artistico come un atto costruttivo), ma il linguaggio è la cultura proprio per il fatto che non è la realtà, la
dice semplicemente. La stessa performance è un evento e in quanto tale suggestiona, certo, ma per
significare qualcosa di diverso da un gioco deve essere appunto detta, almeno con una didascalia
(meglio se con un discorso critico). Il paradosso e il pericolo della cultura è che deve parlarsi addosso, altrimenti non esiste come cultura (o arte) ma solo come uno dei tanti insignificanti fatti della
vita
Il linguaggio dunque. E così siamo, conclusivamente, al primo dei problemi: chi parla. Chi parla?
Infatti, dice, si tratta di un dispositivo che, come tutti i dispositivi oggi, non produce più soggettivazione7 Nella fase odierna sono vani i discorsi sull’«uso corretto» di tali strumenti di governamentalità, perché, se (come ha spiegato Foucault) ogni dispositivo produce il suo soggetto adeguato, – che
oggi, chiarisce Agamben, è il non-soggetto, cioè, interpreto io, la Unperson dei tedeschi, la nonpersona senza storia e senza prospettiva, ma legata come Prometeo alla roccia muta del presente fattuale, événementiel, alla cronaca, anzi di un presente che non esiste più, negato com’è dal futuro sistematico, sensibile, sempre imminente, sempre già qui, – «è del tutto impossibile che il soggetto
del dispositivo lo usi nel “modo giusto”». È un circolo chiuso, che nel suo meccanicismo semplicemente aspetta la «catastrofe». L’origine del clinamen, se così si può dire, resta misteriosa anche in
questa versione: verrà da fuori, lo produrrà chi, sottraendosi al determinismo dei dispositivi (a forza
di volontà, suppongo), li profanerà, ossia con un atto di espropriazione restituirà «all’uso comune…
ciò che è stato catturato e separato in essi» a fini governamentali, il che significherà né più né meno
che portare alla luce l’Ingovernabile.
Forse. Per uscire dalla escatologia, sempre fascinosa e sempre impossibile, io proporrei però di pensare il possibile e cioè: pensare che nel campo cultura autonomo, e nell’arte in specie, soprattutto
nell’arte poetica, il dispositivo linguaggio produca sempre e soltanto soggetti, e nel suo metodo tendenzialmente soggetti critici, proprio perché non vi sono in esso, essendo autonomo, fini di governamentalità, ma solo di conoscenza. Dove naturalmente conoscere e lo stesso comprendere significano altro che razionalizzare, sappiamo (dopo la ribellione, nel post ormai lo sappiamo che conoscere e tanto più comprendere è complicato). Così, il nuovo di questa fase sarebbe che la poesia è
necessaria, mi sembra. Comunque io ci proverei a dirlo e a farla
1
Prendo a documento uno scritto, La colpa e la scommessa, che Antonio Tricomi ha premesso alla pubblicazione online di alcune sue
poesie nella rivista Le reti di Dedalus, nell’estate 2006.
2
Vedi György Lukács, Per l’ontologia dell’essere sociale, trad. it. e cura di Alberto Scarponi, Roma, Editori Riuniti, I, 1976, II1 e
II2, 1981.
3
L’«uomo generico» dice Lukács, intendendo con questa espressione l’essere umano divenuto ciò che è secondo la sua specie
(l’espressione «divieni ciò che sei» è di Goethe), io lo chiamerei uomo antropico, un individuo formatosi oggi, che è più o meno
l’opposto dell’individuo supposto originario dal grande racconto borghese.
4
In una intervista al settimanale L’Espresso, 7 settembre 2006.
Alberto Scarponi
Per la (mia) poesia
10
5
Così Giovanni Gentile nel 1899 nel libro La filosofia di Marx, dove fra l’altro pubblica per la prima volta le marxiane Tesi su Feuerbach (stese nella primavera del 1845), poi famose anche perché l’undicesima dice: «I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo; si tratta di trasformarlo». Lenin apprezzò il libro di Gentile e su quel concetto disse e fece la rivoluzione, anche se
forse avrebbe fatto meglio a pensarci un po’ prima di farla, come del resto gli consigliava la sua amica Rosa Luxemburg. Fra parentesi: non è diventata famosa invece la decima delle undici Tesi, quella che dice: «Il punto di vista del vecchio materialismo è la
società borghese, il punto di vista del materialismo nuovo è la società umana o l’umanità sociale».
6
È’ questo, sono convinto, che Guy Debord capì: «Il movimento dell’arte moderna può essere considerato come una dequalificazione permanente della forza-lavoro intellettuale da parte dei creatori», trovo citato sul web; «Questa dissoluzione… dopo parecchio
tempo si trova ad essere la verità prima del modernismo occidentale. La liberazione delle forme artistiche ha significato dappertutto
la loro riduzione a nulla. Si può applicare all’insieme dell’espressione moderna quel che W. Weidlé scriveva nel 1947 nel numero 2
dei Cahiers de la Pléiade a proposito di Finnegan’s Wake: “Questa Summa smisurata delle più allettanti contorsioni verbali, questa
Arte poetica in diecimila lezioni non è una creazione dell’arte: è l’autopsia del suo cadavere”».
7
Cfr. Giorgio Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Roma, Nottetempo, 2006.