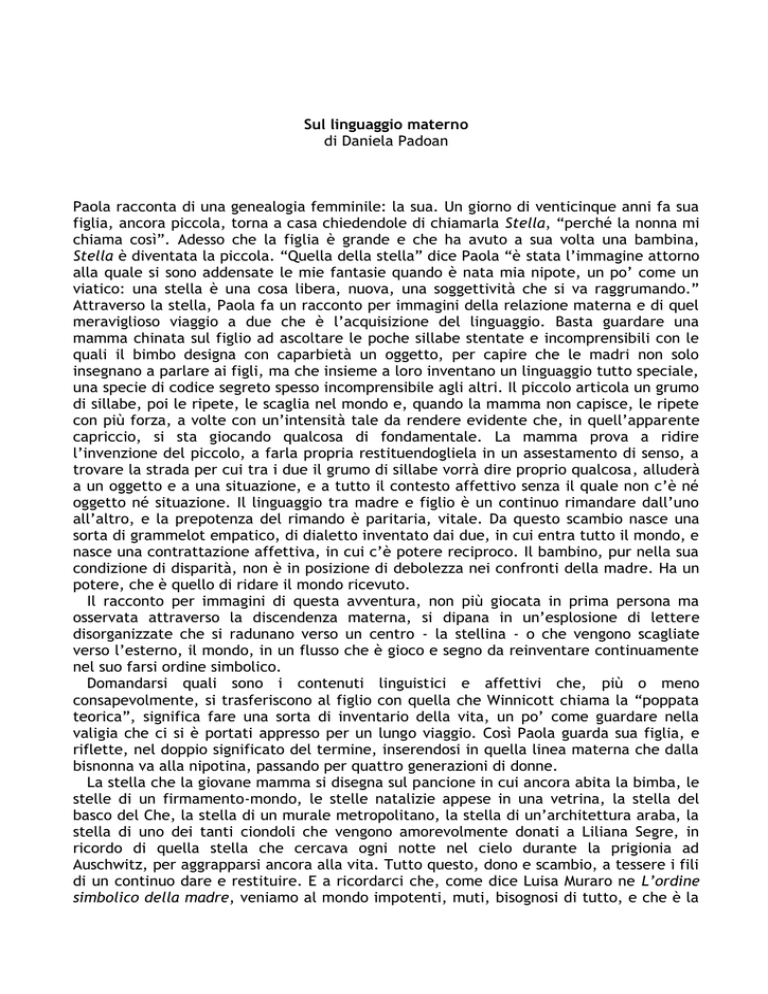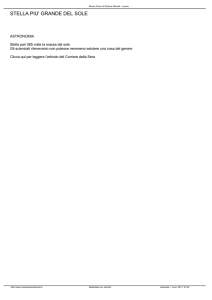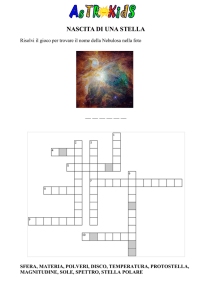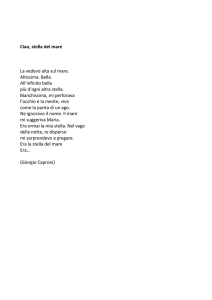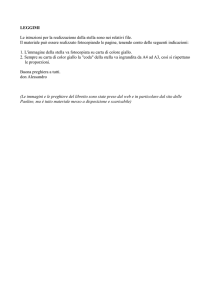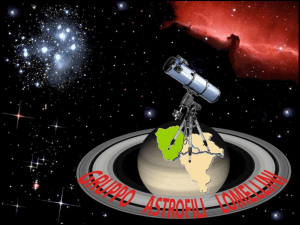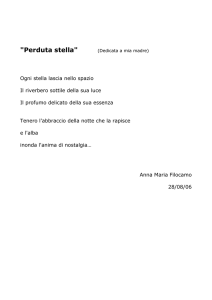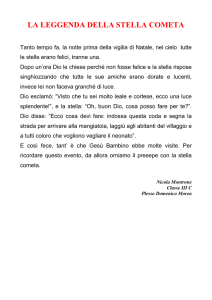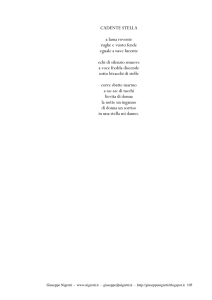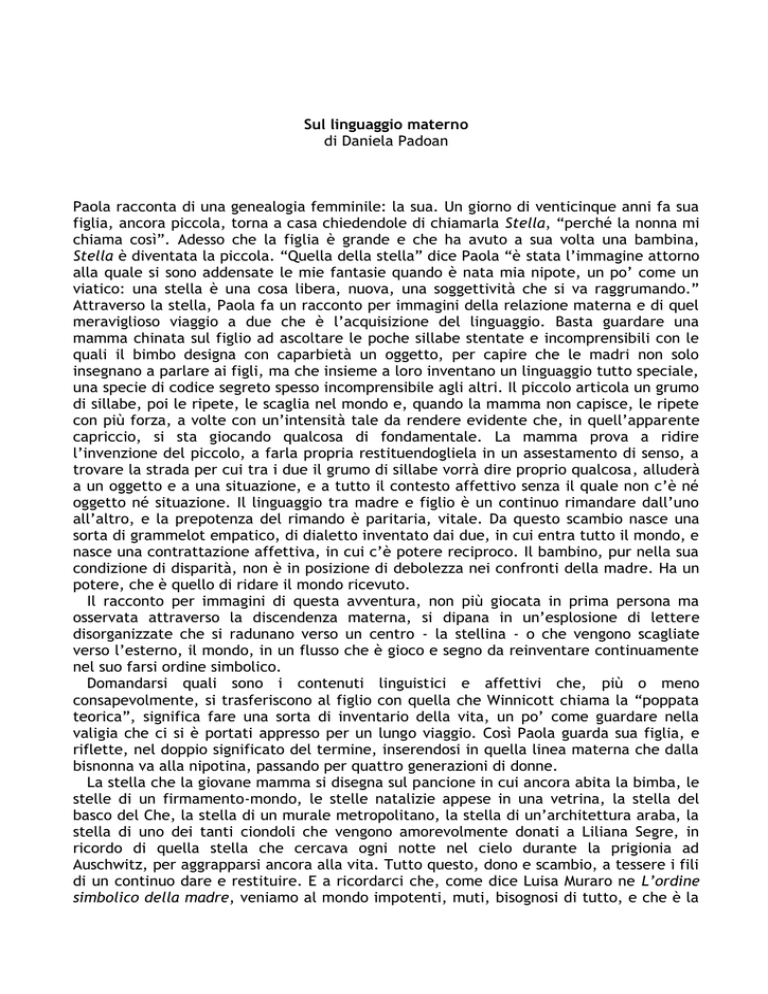
Sul linguaggio materno
di Daniela Padoan
Paola racconta di una genealogia femminile: la sua. Un giorno di venticinque anni fa sua
figlia, ancora piccola, torna a casa chiedendole di chiamarla Stella, “perché la nonna mi
chiama così”. Adesso che la figlia è grande e che ha avuto a sua volta una bambina,
Stella è diventata la piccola. “Quella della stella” dice Paola “è stata l’immagine attorno
alla quale si sono addensate le mie fantasie quando è nata mia nipote, un po’ come un
viatico: una stella è una cosa libera, nuova, una soggettività che si va raggrumando.”
Attraverso la stella, Paola fa un racconto per immagini della relazione materna e di quel
meraviglioso viaggio a due che è l’acquisizione del linguaggio. Basta guardare una
mamma chinata sul figlio ad ascoltare le poche sillabe stentate e incomprensibili con le
quali il bimbo designa con caparbietà un oggetto, per capire che le madri non solo
insegnano a parlare ai figli, ma che insieme a loro inventano un linguaggio tutto speciale,
una specie di codice segreto spesso incomprensibile agli altri. Il piccolo articola un grumo
di sillabe, poi le ripete, le scaglia nel mondo e, quando la mamma non capisce, le ripete
con più forza, a volte con un’intensità tale da rendere evidente che, in quell’apparente
capriccio, si sta giocando qualcosa di fondamentale. La mamma prova a ridire
l’invenzione del piccolo, a farla propria restituendogliela in un assestamento di senso, a
trovare la strada per cui tra i due il grumo di sillabe vorrà dire proprio qualcosa, alluderà
a un oggetto e a una situazione, e a tutto il contesto affettivo senza il quale non c’è né
oggetto né situazione. Il linguaggio tra madre e figlio è un continuo rimandare dall’uno
all’altro, e la prepotenza del rimando è paritaria, vitale. Da questo scambio nasce una
sorta di grammelot empatico, di dialetto inventato dai due, in cui entra tutto il mondo, e
nasce una contrattazione affettiva, in cui c’è potere reciproco. Il bambino, pur nella sua
condizione di disparità, non è in posizione di debolezza nei confronti della madre. Ha un
potere, che è quello di ridare il mondo ricevuto.
Il racconto per immagini di questa avventura, non più giocata in prima persona ma
osservata attraverso la discendenza materna, si dipana in un’esplosione di lettere
disorganizzate che si radunano verso un centro - la stellina - o che vengono scagliate
verso l’esterno, il mondo, in un flusso che è gioco e segno da reinventare continuamente
nel suo farsi ordine simbolico.
Domandarsi quali sono i contenuti linguistici e affettivi che, più o meno
consapevolmente, si trasferiscono al figlio con quella che Winnicott chiama la “poppata
teorica”, significa fare una sorta di inventario della vita, un po’ come guardare nella
valigia che ci si è portati appresso per un lungo viaggio. Così Paola guarda sua figlia, e
riflette, nel doppio significato del termine, inserendosi in quella linea materna che dalla
bisnonna va alla nipotina, passando per quattro generazioni di donne.
La stella che la giovane mamma si disegna sul pancione in cui ancora abita la bimba, le
stelle di un firmamento-mondo, le stelle natalizie appese in una vetrina, la stella del
basco del Che, la stella di un murale metropolitano, la stella di un’architettura araba, la
stella di uno dei tanti ciondoli che vengono amorevolmente donati a Liliana Segre, in
ricordo di quella stella che cercava ogni notte nel cielo durante la prigionia ad
Auschwitz, per aggrapparsi ancora alla vita. Tutto questo, dono e scambio, a tessere i fili
di un continuo dare e restituire. E a ricordarci che, come dice Luisa Muraro ne L’ordine
simbolico della madre, veniamo al mondo impotenti, muti, bisognosi di tutto, e che è la
relazione materna a metterci in condizione di esistere e di parlare, di scambiare
significati.
Tutto questo è il mondo che va verso la stellina, ma da quel centro che cosa viene
restituito alla madre, nell’esplosione di letterine? Uno spiazzamento, una possibilità di
guardare se stesse e la propria vita attraverso gli occhi di quel nuovo essere che deve
riorganizzare tutti i significati, sperimentarli, dare nome al mondo e, riconoscendolo,
farsene riconoscere. Uno scambio affettivo in cui si apprende e si insegna riuscendo a
coniugare l’invenzione con la necessità di appartenenza sociale e con la consapevolezza
del diritto all’affermazione di sé anche per chi è posto in condizione di disparità. In
questo chinarsi sul figlio mettendo in gioco le proprie capacità affettive e intellettive, in
una tensione che privilegia lo scambio, c’è un protagonismo femminile che, giocato
anche al di fuori del ruolo propriamente materno, può mutarsi in un grande potere di
comunicazione politica. Un sapere dell’altro che sa accogliere la disparità senza farla
diventare sopraffazione, che cerca lo spiazzamento dato dallo sguardo dell’altro come un
ampliamento di percezione e di intelligenza.
Ma, se la madre sa insegnare ordine simbolico, il legame tra cosa e parola, la fiducia
nella mediazione del linguaggio, da che le viene questa facoltà? E ne perde l’uso, la
pratica, la legittimazione, quando i figli si staccano per consegnarsi all’ordine
patriarcale? Quando, secondo Lacan, con l’accettazione del nome del padre, il bambino
divenuto soggetto entra contemporaneamente nell’ordine del simbolo e del linguaggio?
Che ne è, fuori dalla possibilità di dirsi, di questo sapere del simbolico, di tutti i
pappa/gatto/carota, della “lingua della nutrice” come già la chiama Dante, del
“linguaggio psicotico” come lo definisce Jakobson, che si instaura tra madre e figlio? Che
fine fa questa competenza non più agita – o mai agita, per chi non ha avuto figli –
quando, come ogni talento reso muto, viene ributtata nell’indifferenziato?
C’è un uso politico della competenza materna che si trova nella storia e nella
testimonianza delle Madri argentine di Plaza de Mayo, visibile nella forza che è venuta
loro dal parlare a nome di un figlio scomparso, di una pluralità di figli rivendicati alla
vita. In loro c’è un desiderio di parlare per dare voce all’altro, un prendere la parola per
mettere l’altro in condizione di essere.
Questa idea del materno come invenzione politica si sta facendo strada in molte parti
del mondo: tra le madri Saharawi, nella posizione delle madri israeliane, così come nella
lettera inviata da un gruppo di madri napoletane alla mamma di Carlo Giuliani, che si
concludeva con una frase di Luce Irigaray: "Noi mettiamo al mondo qualcosa di diverso
dai figli, generiamo qualcosa che non è il bambino, ma amore, desiderio, linguaggio,
arte, società, politica, religione.”
Di Daniela Padoan
tratto da:
Paola Mattioli -Tre storie
a cura di Antonio Ria
Edizioni Le Ricerche, Lugano 2003