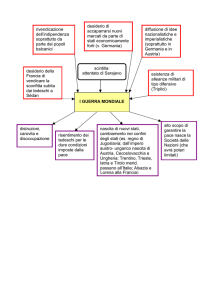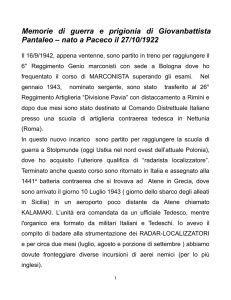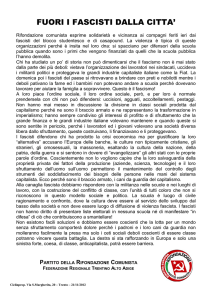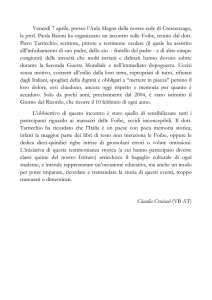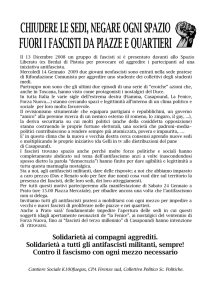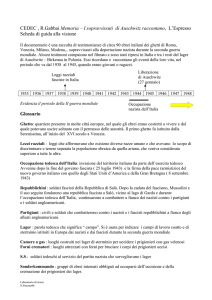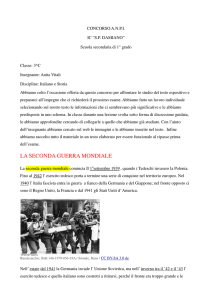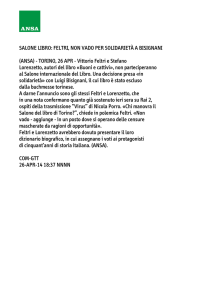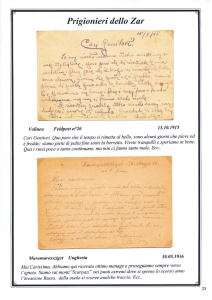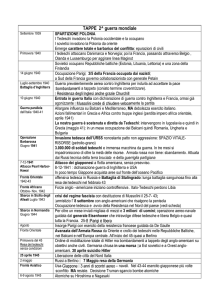unità
8
L’Italia nella seconda
guerra mondiale
Riferimenti storiografici
1
Nel riquadro Benito Mussolini e Adolf Hitler salutano la folla nel corso
di una parata militare in Germania.
Sommario
1
2
3
4
Le carenze strutturali delle forze armate
italiane
Il rancio del soldato italiano
I comunisti italiani in URSS e la questione
dei prigionieri
I fascisti di Salò di fronte ai partigiani
e alla guerra civile
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
5
6
7
8
Il proclama di Alexander
Le motivazioni del comportamento delle
truppe tedesche verso gli italiani
Il campo di concentramento di Arbe
La vicenda delle foibe: un inquietante
nodo storiografico
1
Le carenze strutturali delle forze armate
italiane
UNITÀ 8
Lo storico inglese MacGregor Knox è uno specialista di storia militare che ha studiato in modo dettagliato il Regio esercito durante la seconda guerra mondiale. A suo giudizio, la disfatta
fu l’inevitabile conseguenza della combinazione di due fattori:
le errate valutazioni politiche di Mussolini e la meschinità dei vertici militari, accusati da Knox di incompetenza, provincialismo,
ottuso attaccamento al passato e connivenza con la venalità della grande industria. La sua impietosa conclusione è che «il fallimento militare dell’Italia fascista fu innanzitutto il fallimento della cultura militare e delle istituzioni militari italiane».
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
2
Resta fuori questione che le armi e i weapon systems [l’apparato bellico, n.d.r.] italiani erano i meno efficaci, i meno numerosi e i più costosi prodotti nei principali paesi belligeranti della seconda guerra mondiale.
L’acciaio italiano costava il quadruplo rispetto al prezzo
del mercato internazionale. Secondo una stima autorevole, le nuove corazzate della classe Littorio consegnate alla marina a partire dal 1940 furono pagate il
doppio di quanto sarebbero costate se fossero state
costruite nei cantieri francesi, certo non i più economici
del mondo. E in settori quali progettazione di macchine belliche, metallurgia, tecnica della catena di montaggio, macchine utensili, strumenti di precisione, elettronica per le comunicazioni, radiolocalizzatori e
ecogoniometri, l’industria italiana entrò in guerra – e in
grande misura rimase sempre – in una condizione di
ostinata e provinciale arretratezza. Ricerca e controllo
di qualità in settori chiave quale quello dei mezzi corazzati erano a un livello rudimentale o del tutto assenti;
le piastre bullonate del primo carro armato medio FIATAnsaldo che vide un ampio impiego in guerra,
l’M13/1940, si frantumavano come vetro. La progettazione di veicoli e carri armati era un’attività che dipendeva dalla genialità individuale e dalla sperimentazione
condotta a tastoni da dei singoli progettisti, anziché da
un lavoro di squadra; all’Ansaldo un solo uomo progettò
tutti i carri armati e i mezzi corazzati italiani dal 1933 al
1943. Non sorprende dunque che non riuscì mai a costruire un carro armato soddisfacente. Nonostante la
cattura e il trasferimento in Italia a scopo di studio – nel
1941-42 – di un T-34 sovietico, il miglior carro armato
medio di tutta la guerra, il prodotto più affidabile della
FIAT-Ansaldo fu un semovente alquanto robusto con un
obice da 75 mm a bassa velocità iniziale. Peraltro il
complesso industriale non tollerò la competizione di
macchine straniere di gran lunga migliori quali il carro
medio che la Skoda offrì nel 1941. La FIAT-Ansaldo riuscì clandestinamente a impedire la produzione in Italia
del Panzer III o IV, di cui la Germania – e Hitler in persona – offrì in diverse occasioni i progetti, il brevetto e
finanche i macchinari per costruirlo.
Sebbene la produzione di velivoli fosse oligopolistica più che monopolistica, il reparto aviazione FIAT si distinse per aver progettato e venduto all’aeronautica
forse il peggior monoplano da caccia della seconda
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
guerra mondiale, il FIAT G50. La raffinatezza aerodinamica evidente, ad esempio, nello Zero nipponico – un
aereo che, benché montasse un motore simile al G50 e
al Macchi MC200, era equipaggiato con due cannoncini
da 20 mm anziché con le inutili mitragliatrici degli apparecchi italiani – era pressoché assente. Analogamente, fino al 1942-43 l’industria non riuscì a produrre
un efficiente aereo da assalto al suolo: quelli con cui l’aeronautica entrò in guerra erano un pericolo più per l’equipaggio che per il nemico. La progettazione di motori
avio era incentrata su copie e derivazioni di motori stranieri brevettati negli anni venti e nei primi anni trenta. L’incapacità dell’industria petrolifera statale e parastatale di
produrre carburanti ad alto numero di ottani o lubrificanti
che non rovinassero i motori contribuì anch’essa a frenare l’innovazione. Tutti i tentativi di progettare l’affidabile motore da 1500 CV necessario ad alimentare i caccia monoposto da 650 km/h e armati di cannoncini
fallirono miseramente. L’azienda Piaggio falsificò impunemente i risultati di una prova di omologazione di un
suo motore dopo essere entrata nel mirino perché i
motori si fermavano regolarmente in volo. L’aeronautica
portò la questione all’attenzione di Mussolini, ma la
Piaggio continuò a produrre motori talmente inaffidabili
da risultare pericolosi. Lo stesso rappresentante dell’aeronautica distaccato presso la Piaggio, preso di
petto, affermò seraficamente che i tecnici addetti al
controllo di qualità dell’aeronautica erano eccessivamente severi: «Ma non avete ancora capito che tanto la
guerra la fanno i tedeschi?». […]
Per l’esercito, l’elemento decisivo della guerra era la
superiorità numerica, un’ottica solo in apparenza corroborata [confermata, n.d.r.] dall’esperienza del 1915-18.
Sul finire del primo conflitto mondiale il regio esercito
aveva acquisito un buon numero di macchine da guerra,
ma i suoi vertici avevano sempre rifiutato una realtà che
l’alto comando tedesco aveva invece accettato già a
metà del 1916: la guerra era diventata una guerra di
macchine. Alla fiducia nella volontà umana si affiancava
la fede nel numero; e forse entrambe contribuirono a far
sì che l’esercito tollerasse fino al 1939 di vedersi consegnare i carri armati leggeri L3 da 3,5 tonnellate della FIATAnsaldo, facilmente perforabili dal fuoco delle mitragliatrici e che in un’occasione vennero distrutti da abissini
armati di pietre. […] Malgrado le sue gravi inefficienze, la
FIAT-Ansaldo godette sempre della tolleranza dell’esercito. E sebbene l’ultimo capo di stato maggiore del periodo prebellico, Pariani, avesse correttamente previsto
già nel 1936-37 che il centro di gravità strategico dell’imminente guerra italiana sarebbe stato un’avanzata su
Suez, progettò di combattere tale guerra principalmente
con la fanteria autotrasportata. Il primo carro armato
medio italiano, il pessimo M11/39, aveva il cannone praticamente inservibile perché collocato in casamatta anziché sulla torretta girevole, una soluzione evidentemente
dettata dall’incapacità di progettare torrette con cannoni
o dalla presunta necessità di ridurre la larghezza del veicolo per adattarlo alle strade italiane. Uno dei pochi generali italiani con esperienza di comando di unità corazzate in combattimento, Ettore Bastico, fu evidentemente
così intimidito dall’opposizione dei suoi colleghi alla
nuova arma che durante una riunione di generali superiori indetta nel novembre del 1937 per discutere del futuro dei mezzi corazzati, convenne che «il carro è un
mezzo potente che non dobbiamo disconoscere, ma
non gridiamogli osanna. L’osanna riserviamolo per il
fante e per il mulo». L’innovazione fu sempre vista con
sospetto, in quanto significava scompaginare una struttura di forze che rifletteva una concezione bellica profondamente radicata nell’esercito e serviva al meglio gli interessi del corpo ufficiali. La cosa davvero straordinaria
è quanto poco e quanto lentamente le dure lezioni della
guerra scalfirono la venerazione dell’esercito per la fanteria e per i muli.
M.G. KNOX, Alleati di Hitler. Le regie forze armate, il regime
fascista e la guerra del 1940-1943, Garzanti, Milano 2002,
pp. 52-54, 61-65, trad. it. S. MINUCCI e dell’autore
UNITÀ 8
Che atteggiamento tenne l’industria pesante italiana nei confronti dei suggerimenti o dei modelli di carro armato che le
veniva offerto di copiare o di produrre?
Quali conseguenze provocava la diffusa convinzione che «tanto la guerra la fanno i tedeschi»?
Qual era la principale differenza di mentalità tra generali tedeschi e autorità militari italiane?
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
3
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
2
Il rancio del soldato italiano
UNITÀ 8
L’efficienza di un esercito non si misura solo dalle armi che
utilizza. Anche il vitto è un parametro importantissimo per valutare la modernità di un apparato militare, oltre a essere un fattore determinante del morale dei soldati. Dotati di un equipaggiamento scarso e inadeguato, i soldati italiani furono trattati
peggio dei militari di tutti gli altri eserciti anche a questo elementare livello, mentre gli ufficiali difesero fino all’ultimo i propri privilegi legati al grado.
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
4
Il vitto dei soldati merita una trattazione a parte per
un’importanza che non occorre sottolineare, anche se
spesso sottovalutata dagli studi (non certo dalla memorialistica). Ci offre una testimonianza impietosa dei ritardi
dell’esercito, qui il regime fascista c’entra poco, salvo per
le crescenti difficoltà di approvvigionamento. «Il rancio di
mezzogiorno era di solito brodo di carne con un po’ di
pasta ed un pezzetto di lesso; la sera c’era il minestrone;
poche rare volte la pastasciutta… alla domenica c’era anche un po’ di vino» (1938). Dalla fine dell’Ottocento alla
seconda guerra mondiale, la razione giornaliera dell’esercito aveva quattro componenti base: pane di buona
qualità; carne bovina fresca o congelata (carne con
l’osso, quindi con una percentuale di scarto, nel 1915-18
la razione era di 375 grammi di carne in piedi, ossia calcolata sull’animale vivo); pasta (maccheroni, i tubi della
memorialistica) o riso due volte alla settimana; infine patate e legumi per il minestrone serale. […] Un vitto per un
paese povero, agli inizi del secolo per i contadini e gli operai mangiare pane bianco e carne tutti i giorni era un
lusso, malgrado la bassa qualità tradizionale delle cucine
militari. Nel 1940 la razione era sufficiente in caserma e
nelle retrovie, non però al fronte, come attestano tutte le
memorie e le testimonianze dei reduci. Al fronte, in tutti i
teatri di guerra, la fame era garantita.
Possiamo indicare due ragioni di fondo. Gli alti comandi che parlavano di guerra di rapido corso non avevano pensato a modernizzare un sistema di vettovagliamento adeguato ai fronti statici della prima guerra
mondiale, quando si provvedeva alle truppe con forni e
cucine nelle retrovie. Nulla fu fatto per migliorare i forni
Weiss per la panificazione che si erano dimostrati pesanti e poco mobili già in Etiopia: dovevano restare così
lontano dal fronte che spesso in Albania il pane arrivava
vecchio e ammuffito. Sembra poi incredibile, ma è documentato, l’esercito non disponeva di cucine mobili
(i primi esemplari entrarono in servizio nel 1943 e, in
omaggio alla tradizione, funzionavano a legna anziché a
nafta o benzina più reperibili), ma contava ancora sulle
casse di cottura di fine Ottocento e sulle gloriose marmitte da campo modello 1855. Ossia il rancio veniva avviato al fronte da cucine nelle retrovie, si può immaginare
con quali fatiche e ritardi se le truppe erano in movimento o su posizioni difficilmente raggiungibili, dove arrivava un pastone tiepido eppure prezioso, date le circostanze. Le cucine poi si riducevano a cucinieri poco
addestrati, agli attrezzi e a grandi marmitte appese a
strutture precarie da rinnovare ad ogni spostamento,
con fuoco a legna da reperire sul posto; problemi piccoli in condizioni normali, non facili da risolvere durante
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
gli spostamenti o in regioni prive di legna come la Libia.
Inoltre, in tre anni di guerra su fronti diversi questo sistema non fu modificato con una modernizzazione delle
attrezzature e il decentramento della preparazione del
rancio, dove possibile o necessario, o la distribuzione di
fornelli ai reparti. I soldati si arrangiavano accendendo
fuochi sotto le gavette quando potevano, rubacchiando
viveri qua e là, ma avrebbero meritato di meglio.
L’altro problema di fondo era la desolante insufficienza dei generi di integrazione al rancio. L’immagine
del soldato inglese che si prepara il breakfast abbrustolendo il bacon e poi si concede una tazza di the è
un po’ troppo idilliaca in contrapposto al soldato italiano che inzuppa il pane nella brodaglia di un caffè,
però inquadra il problema. Il rancio rimane lo stesso
dalle caserme al fronte, peggiora inevitabilmente di
qualità e regolarità in momenti in cui le truppe sono sottoposte alle fatiche e tensioni del combattimento. La
razione di Albania prevede la distribuzione eventuale di
un bicchierino di cognac (3 cl) oppure 50 grammi di
marmellata oppure 25 di cioccolato, con un cenno
alla possibilità di una distribuzione continuativa per
periodi eccezionali. Manca la concezione che il soldato
al fronte debba avere un vitto più ricco e curato, garantito anche in caso di collasso dei rifornimenti. La razione di riserva si riduceva a 400 grammi di galletta e
una scatoletta di carne, a volte la scadente minestra
Chiarizia in scatola; molti reparti in Albania (e poi in
Africa settentrionale) non ebbero di meglio per settimane. Un confronto con la razione K del soldato americano (tutto il necessario per 24 ore salvo l’acqua in
una sola confezione: scatolette varie, minestra liofilizzata, caffè in polvere, gallette, fornellino a meta [tavolette combustibili, n.d.r.], sigarette, fiammiferi, carta
igienica eccetera) è umiliante, segna il confine non tra
due eserciti, ma tra due civiltà. […]
In tutti gli eserciti si distingueva tra mensa ufficiali,
mensa sottufficiali e rancio dei soldati, in tempo di pace
e in guerra nelle retrovie, con ovvie varianti. Al fronte però
il vitto era uguale per tutti, salvo che per le forze armate
italiane che conservarono fino al crollo il privilegio di una
mensa a parte, più ricca e curata, per gli ufficiali e per i
sottufficiali. La memorialistica di Libia attesta sia lo stupore degli italiani quando vedevano Rommel pranzare
con pane nero e marmellata, sia il piacere degli ufficiali tedeschi invitati alla mensa dei colleghi italiani, dove pastasciutta e vino erano garantiti (ovviamente non durante i combattimenti). Per i soldati, dovunque, soltanto
la gavetta o le razioni a secco. MacGregor Knox ha trovato le risposte dei comandi della II armata in Jugoslavia a un sondaggio sull’abolizione delle mense privilegiate, promosso nell’estate 1941 dallo stato maggiore
dell’esercito su richiesta di Mussolini. «Gran parte dei comandanti si disse favorevole per motivi logistici più che
di leadership. Ma “la massa degli ufficiali” si dimostrò palesemente poco entusiasta. Un comandante di corpo
d’armata sostenne che gli ufficiali fossero semplicemente incapaci di svolgere le loro funzioni nutrendosi con
il rancio normale dei soldati: “La mensa ristora e mette
l’ufficiale nelle condizioni fisiche e di spirito per ben assolvere il suo non facile compito. Una differenziazione, ai
fini del morale degli ufficiali, ci deve assolutamente essere”. La soppressione delle mense da campo per ufficiali avrebbe inoltre potuto produrre una “eccessiva dimestichezza e conseguente diminuzione di prestigio”,
nonché una perdita di “affiatamento e cameratismo” tra
gli ufficiali dei reparti. Infine il nuovo sistema, se esteso
alla vita di guarnigione, avrebbe potuto condurre a “diminuzioni della già tenue autorevolezza dei giovani su-
balterni, conseguente dalla soppressione di distinzioni
formali”. La tenacia con cui il corpo ufficiali difese tali “distinzioni formali” lascia ben intendere la misura dei propri dubbi sulla sua stessa capacità di comando». Una pagina triste, un esercito vecchio che non riusciva ad
assicurare un rancio sufficiente alle truppe e cercava di
garantire il prestigio degli ufficiali con privilegi di casta ottocenteschi anziché selezione e addestramento.
G. ROCHAT, Le guerre italiane 1935-1943, Einaudi,
Torino 2005, pp. 280-285
UNITÀ 8
Qual era, da un punto di vista logistico, la principale differenza tra le due guerre mondiali?
Come era composto normalmente il rancio di base dei soldati semplici?
Che cosa nascondeva, secondo MacGregor Knox, la tenacia con cui il corpo ufficiali difese la differenziazione delle mense?
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
5
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
3
I comunisti italiani in URSS e la questione
dei prigionieri
UNITÀ 8
Nei primi mesi del 1943, subito dopo la tragedia della ritirata dell’ARMIR, due dirigenti comunisti italiani in Russia – Vincenzo Bianco e Palmiro Togliatti – si scambiarono alcune lettere sulla questione delle durissime condizioni in cui si trovavano i prigionieri nei campi sovietici. Conoscendo in anticipo la posizione
di Stalin, Togliatti respinse la richiesta di intervenire presso le autorità russe per ottenere un miglioramento della situazione.
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
6
All’inizio del 1943, subito dopo la disfatta dell’esercito
italiano sul fronte del Don, Bianco ebbe l’incarico di organizzare il lavoro politico tra i prigionieri di guerra italiani,
creando le scuole politiche e il giornale per i prigionieri.
Questo ruolo lo portava spesso a visitare i lager e quindi
ad avere un’idea chiara sullo stato fisico e psicologico in
cui si trovavano i prigionieri italiani. Ciò risulta anche
dalla ben nota lettera che Bianco inviò a Togliatti il 31
gennaio 1943, e che, tra le altre cose, affrontava il problema dei prigionieri: «Ti pongo una questione molto
delicata di carattere politico molto grande. Penso che bisogna trovare una via, un mezzo per cercare, con le dovute forme, con il dovuto tatto politico, di porre il problema, affinché non abbia a registrarsi il caso che i
prigionieri di guerra muoiano in massa come ciò è già avvenuto. Non mi dilungo, tu mi comprendi, perciò lascio
a te di trovare la forma per farlo…».
Bianco chiedeva dunque a Togliatti di intervenire, e
appellandosi al «tatto politico» dimostrava di essere
consapevole della reazione che avrebbe potuto avere
Stalin a una simile interferenza da parte del segretario del
Komintern. La visione staliniana della politica non ammetteva alcun atteggiamento indipendente né autorizzava intromissioni politiche, anche da parte di altri esponenti comunisti, soprattutto in una fase della guerra
così critica. La risposta di Togliatti a Bianco, del 15 febbraio-3 marzo 1943, rivela il clima di tensione che si respirava nell’URSS in quegli anni e svela la mancanza di libertà d’azione, di capacità propositiva di fronte al potere
staliniano, nonché la completa aderenza ai canoni del
comunismo internazionale. La richiesta di Bianco, sostanzialmente, rappresentava una deviazione, che nel
gergo staliniano era chiamata umanesimo astratto, oppure «il tentativo di porre gli interessi nazionali al di sopra di quelli di classe». Secondo Togliatti, che aveva imparato la lezione durante tutti quegli anni di esperienza
e di vita nell’URSS, Bianco era troppo sentimentale e con
i suoi ragionamenti filantropici si discostava dalla posizione assunta dalla leadership staliniana.
Scriveva dunque Togliatti: «L’altra questione sulla
quale sono in disaccordo con te è quella del trattamento
dei prigionieri. Non sono per niente feroce, come tu sai.
Sono umanitario quanto te. O quanto può esserlo una
dama della Croce Rossa. La nostra posizione di principio
rispetto agli eserciti che hanno invaso l’Unione Sovietica,
è stata definita da Stalin, e non vi è più niente da dire.
Nella pratica, però, se un buon numero di prigionieri morirà in conseguenza delle dure condizioni di fatto, non ci
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
trovo assolutamente niente da dire. Anzi. E ti spiego il perché. Non c’è dubbio che il popolo italiano è stato avvelenato dalla ideologia imperialista e brigantesca del fascismo. Non nella stessa misura che il popolo tedesco,
ma in misura considerevole. Il veleno è penetrato tra i contadini, tra gli operai, non parliamo della piccola borghesia e degli intellettuali, è penetrato nel popolo, insomma.
Il fatto che per migliaia e migliaia di famiglie la guerra di
Mussolini, e soprattutto la spedizione contro la Russia, si
concludano con una tragedia, con un lutto personale, è
il migliore, è il più efficace degli antidoti. Quanto più largamente penetrerà nel popolo la convinzione che aggressione contro altri paesi significa rovina e morte per il
proprio, significa rovina e morte per ogni cittadino individualmente preso, tanto meglio sarà per l’avvenire d’Italia. I massacri di Dogali e di Adua furono uno dei freni più
potenti allo sviluppo dell’imperialismo italiano, e uno dei
più potenti stimoli allo sviluppo del movimento socialista.
Dobbiamo ottenere che la distruzione dell’Armata italiana in Russia abbia la stessa funzione oggi. In fondo, coloro che dicono ai prigionieri, come tu mi riferivi: “Nessuno
vi ha chiesto di venir qui: dunque non avete niente da lamentarvi”, dicono una cosa che è profondamente giusta,
anche se è vero che molti dei prigionieri sono venuti qui
solo perché mandati. È difficile, anzi impossibile, distinguere in un popolo chi è responsabile di una politica, da
chi non lo è, soprattutto quando non si vede nel popolo
una lotta aperta contro la politica delle classi dirigenti. T’ho
già detto: io non sostengo affatto che i prigionieri si debbano sopprimere, tanto più che possiamo servircene per
ottenere certi risultati in un altro modo; ma nelle durezze
oggettive che possono provocare la fine di molti di loro,
non riesco a vedere altro che la concreta espressione di
quella giustizia che il vecchio Hegel diceva essere immanente in tutta la storia. E ora alle questioni di lavoro».
Il rifiuto di Togliatti di prendere qualsiasi iniziativa per
salvare i prigionieri di guerra italiani, il tentativo di presentare la morte di migliaia di uomini come la giusta nemesi per aver partecipato alla guerra contro l’URSS dimostrano la totale subordinazione della dirigenza del PCI
alla politica staliniana. […] Bianco replicò seccamente
con una lettera del 20 marzo: «Non intendo aprire una
discussione né con te né con nessun altro. […] Ma
mettere una croce sulla massa dei lavoratori dei paesi
del blocco fascista, tu sai meglio di me cosa significa,
e, oltre tutto, io so benissimo che tu non la pensi così.
Ma, purtroppo, devo constatare che questa opinione è
largamente diffusa». […] Le accuse di Bianco si scontravano con una mentalità che non tollerava atteggiamenti umanitari.
M.T. GIUSTI, I prigionieri italiani in Russia,
il Mulino, Bologna 2003, pp. 53-57
Spiega l’espressione «umanesimo astratto».
Spiega l’espressione «giusta nemesi».
Per certi versi, negli anni 1943-1945, lo scontro più duro fu
quello tra partigiani e fascisti. I primi accusavano i seguaci di
Mussolini di essere dei nemici dell’Italia, al soldo dei tedeschi;
i secondi, invece, addossavano la causa della disfatta a presunti
traditori, da scovare e da eliminare.
Attardarsi nella disputa su chi abbia sparato il primo
colpo, se i fascisti o gli antifascisti, e fra questi in particolare i comunisti, non è produttivo. Su questo punto
sono corrette ma non esaurienti le considerazioni svolte
da Bocca: «È ovvio che siano gli antifascisti a muoversi
prima dei fascisti e che si muovano per primi i comunisti: tocca a essi provare con le armi che ci sono degli italiani pronti a battersi, pronti a pagare il biglietto di ritorno
alla democrazia; al neofascismo, si sa, converrebbe la
quiete interna a prova del consenso o della rassegnazione popolare». Converrebbe, certo, ma lasciando
inappagate alcune delle motivazioni di fondo che portarono il fascismo a rinascere e che lo spinsero, dal suo
stesso interno, sul terreno della guerra civile. C’era innanzi tutto da fugare il senso di frustrazione che serpeggiava tra i fascisti fin da prima del 25 luglio e che era
stato esasperato dal crollo inglorioso del regime. [...]
[La crisi generale che travagliava il popolo italiano]
era stata vissuta dai fascisti in vari modi. In quelli che non
si erano limitati a mettersi da parte il crollo poteva aver
stimolato una revisione critica del proprio passato e
dell’intero sistema del fascismo, secondo il cammino
che portava non per opportunismo a diventare, da fascisti, antifascisti. Coloro nei quali questo processo non
si era messo in moto si erano interiormente arrabbiati,
patendo senza comprendere. Dopo l’8 settembre una
parte almeno di essi non poteva perdere l’occasione,
che i tedeschi offrivano, di dimostrare, innanzi tutto a se
stessi, di essere ancora vivi. E alla domanda: come è
potuto accadere il crollo? la risposta più a portata di
mano stava nell’addossarne tutte le colpe ai traditori,
con i quali era giunto il momento di fare i conti. [...]
Non fu facile per i fascisti della RSI riconoscere l’esistenza stessa del partigianato. [...] Al di là dell’intento propagandistico, l’uso di espressioni quali banditi o, peggio
ancora, sicari al soldo del nemico manifestava il forte disagio di fronte a un fenomeno imprevisto, che si cercava
di esorcizzare attribuendone la nascita e lo sviluppo ad
agenti esterni. Questa idea era rafforzata dalla tendenza a
non voler distinguere bene, in un primo momento, i partigiani dai prigionieri evasi, soprattutto se slavi. I comunisti
e gli ebrei, legati entrambi, nella ossessionata fantasia fa-
scista, a tenebrosi e potenti organismi internazionali, ben
si prestavano a essere additati come i più diretti responsabili di un banditismo eterodiretto. L’espressione comunisti badogliani, usata soprattutto nei primi mesi per indicare i partigiani (così furono chiamati gli attentatori di via
Rasella a Roma), se da una parte mirava a comprometterli
entrambi e a squalificare gli uni accostandoli agli altri, dall’altra si presentava come la versione interna della mostruosa coalizione capitalistico-bolscevica contro la quale
combattevano il fascismo e il nazismo.
C’era nel fondo dell’atteggiamento fascista una radicata incredulità nella capacità stessa degli antifascisti di
battersi. La memoria delle troppo facili vittorie squadristiche del ’20-’21 quando la violenza fascista era organizzata, quella socialista no, la sicurezza a lungo goduta
della copertura istituzionale, il disprezzo per l’avversario
(è tipico dei fascisti chiamare bastardi, cioè razzialmente
impuri, i loro nemici) rendevano i fascisti impreparati ad
affrontare una vera guerra civile combattuta da entrambe
le parti. Una cosa era per loro sfogare il desiderio di vendetta rinnovellando le spedizioni punitive, altra cosa era
affrontare altri italiani organizzati in armi. [...]
La realtà della Vandea partigiana, come la chiamò
Mussolini, si impose perciò gradualmente ai fascisti sia del
vertice che della base, sia agli estremisti, come Almirante,
sia ai moderati, come Pini. Nel giugno 1944 Graziani, in un
memorandum a Mussolini, dovette riconoscere che «praticamente il governo della Repubblica sociale controlla, e
solo fino a un certo punto, la fascia piana a cavaliere del Po;
tutto il resto è virtualmente in mano dei cosiddetti ribelli, che
riscuotono il consenso di larghi strati della popolazione».
Una volta che si era stati costretti a prender atto del
reale stato delle cose, l’eliminazione dei ribelli non poteva
non diventare un obiettivo essenziale. Soprattutto, sarebbe stato intollerabile che anche a questo compito provvedessero soltanto i tedeschi. «Hai visto? Per far fuori i sovversivi non c’è bisogno dei tedeschi, bastiamo noi!» disse
un fascista a un camerata di fronte ai cadaveri dei partigiani
esposti a piazzale Loreto nell’agosto 1944.
I fascisti erano sempre stati afflitti dal timore di non
essere presi sul serio dagli alleati [dai tedeschi, n.d.r.]. [...]
Ora i fascisti dovevano assolutamente dimostrare che se
non erano in grado di combattere seriamente contro il
nemico esterno, potevano per lo meno, proprio in
quanto fascisti, schiacciare quello interno.
C. PAVONE, Una guerra civile. Saggio sulla moralità della Resistenza,
Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 225-227, 239-241
Spiega l’espressione «banditismo eterodiretto».
Spiega il significato che i fascisti davano all’espressione «comunisti badogliani».
Per quale ragione i fascisti erano psicologicamente impreparati ad affrontare una vera guerra civile combattuta da
entrambe le parti?
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
UNITÀ 8
I fascisti di Salò di fronte ai partigiani
e alla guerra civile
7
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
4
5
Il proclama di Alexander
UNITÀ 8
Di fronte all’appello lanciato il 13 novembre 1944 dal generale inglese Alexander, che esortava i partigiani a cessare le
operazioni su vasta scala, la reazione di molti comunisti fu rabbiosa. Numerosi militanti e dirigenti videro nel proclama una mossa degli inglesi e dei moderati italiani per togliere di mezzo la
Resistenza come forza armata e per cancellarne le aspirazioni di rinnovamento politico e sociale. Del resto, qualche settimana prima, in un documento di partito, Togliatti aveva espresso un giudizio fortemente negativo sulle prospettive che attendevano la nuova Italia liberata, al punto da ritenere preferibile per Trieste una sovranità iugoslava.
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
8
Il documento di Togliatti [del 19 ottobre 1944, n.d.r.],
se mostra fino a che punto il capo del PCI intenda valorizzare e favorire l’intesa militare e la collaborazione politica colle forze partigiane jugoslave, non è meno indicativo per il giudizio che formula sul segno reazionario
della situazione nell’Italia liberata, sull’occupazione inglese principale ostacolo a una democratizzazione che
evidentemente, nella sostanza, Togliatti intende non diversamente da Longo [Luigi Longo, dirigente comunista
a guida del movimento partigiano nell’Italia settentrionale, n.d.r.] come partecipazione attiva delle masse al
rinnovamento delle strutture di un Paese. E in novembre
sentiamo questo giudizio diffusissimo in mezzo ai resistenti del Nord, in particolare in mezzo ai combattenti
comunisti, garibaldini, alimentati dall’esasperazione crescente per la mancata avanzata degli Alleati dalla Gotica.
Barontini riferisce il 5 novembre da Bologna che si deve
temere una demoralizzazione. «Tutti si domandano: perché gli Alleati non arrivano? Vogliono far massacrare i
patrioti?». I dirigenti respingono le critiche che vengono
dalla base, temono che esse nascondano opportunismo, che siano un riflesso della propaganda nazifascista che naturalmente punta sulla eterogeneità della
Grande Alleanza per seminare sfiducia negli avversari. E
anche nei mesi successivi da parte comunista non si
parlerà di imperialismo inglese o anche angloamericano
se non in documenti riservati, nelle lettere che si scambiano i capi comunisti. Senonché, arriva come una doccia gelida il proclama di Alexander ai partigiani italiani:
uno degli episodi più rilevanti, più controversi e più gravi
di tutta la drammatica vicenda della Resistenza italiana.
Siamo al giorno 13 novembre. La Radio Italia combatte
diffonde le seguenti Nuove istruzioni del generale
Alexander ai patrioti italiani:
«La campagna estiva, iniziata l’11 maggio e condotta
senza interruzione fin dopo lo sfondamento della linea
Gotica, è finita; inizia ora la campagna invernale. In relazione all’avanzata alleata, nel periodo trascorso, era richiesta una concomitante azione dei patrioti: ora le
piogge e il fango non possono non rallentare l’avanzata
alleata, e i patrioti devono cessare la loro attività precedente per prepararsi alla nuova fase di lotta e fronteggiare un nuovo nemico, l’inverno. Questo sarà duro,
molto duro per i patrioti, a causa delle difficoltà di rifornimenti di viveri e di indumenti: le notti in cui si potrà volare saranno poche nel prossimo periodo, e ciò limiterà
pure le possibilità dei lanci; gli Alleati però faranno il pos-
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
sibile per effettuare i rifornimenti. In considerazione di
quanto sopra esposto, il generale Alexander ordina ai
patrioti italiani le istruzioni come segue:
1) cessare le operazioni organizzate su larga scala;
2) conservare le munizioni ed i materiali e tenersi
pronti a nuovi ordini;
3) attendere nuove istruzioni che verranno date a
mezzo Italia combatte o con mezzi speciali o con manifestini. Sarà cosa saggia non esporsi in azioni troppo
arrischiate; la parola d’ordine è stare in guardia, stare in
difesa;
4) approfittare però ugualmente delle occasioni favorevoli per attaccare tedeschi e fascisti;
5) continuare nella raccolta delle notizie di carattere
militare concernenti il nemico, studiarne le intenzioni, gli
spostamenti e comunicare tutto ciò a chi di dovere;
6) le predette disposizioni possono venire annullate
da ordini di azioni particolari;
7) poiché nuovi fattori potrebbero intervenire a mutare il corso della campagna invernale (spontanea ritirata
tedesca per influenza di altri fronti) i patrioti siano preparati e pronti per la prossima avanzata;
8) il generale Alexander prega i capi delle formazioni
di portare ai propri uomini le sue congratulazioni e l’espressione della sua profonda stima per la collaborazione offerta alle truppe da lui comandate durante la
campagna estiva».
È un benservito? È una messa in congedo provvisoria? Il generale Alexander non si rivolge neppure al
comando del CVL [Corpo volontari della libertà: il nome
ufficiale del movimento partigiano, adottato il 9 giugno
1944 al fine di unificare il più possibile le formazioni
nate per iniziativa dei vari partiti, n.d.r.], parla genericamente ai patrioti. […] Seguendo il filo dell’orientamento alleato, della politica churchilliana nei confronti
dell’Italia e della Resistenza italiana, il problema delle
ragioni e della natura del messaggio di Alexander non
può non contemplare il sospetto più grave già avanzato
allora dai comunisti: che esso sia determinato dalla volontà inglese di ridimensionare, se non di ridurre a proporzioni insignificanti, il movimento partigiano nell’Italia occupata dai tedeschi. […] A sottolineare le causali
politiche del messaggio di Alexander e a legarlo all’ispirazione inglese non sono stati soltanto i comunisti
bensì studiosi e politici di altra formazione i quali rilevano che esso rispecchia sostanzialmente la perdita
d’interesse militare del fronte italiano e insieme riflette
la politica delle zone d’influenza, la crescente preoccupazione inglese di dover trovarsi dinanzi a un movimento partigiano italiano troppo radicalizzato, troppo
tinto di rosso, tanto che si vuole ridurre al minimo un
rischio del genere. […] Lo ha ricordato anche, pur
dandovi la motivazione più benevola, Massimo Salvadori [storico dell’età contemporanea, n.d.r.] al momento ufficiale della Special Force: molti uomini politici
inglesi giungono alla conclusione di avere contribuito al
rafforzamento del comunismo in Jugoslavia e in Grecia
aiutando quelle resistenze. Essi temono perciò che
alla fine della guerra il potere del Nord cada «nelle
mani non già di chi è sostenuto dalla maggioranza
della popolazione ma di chi dispone di fucili e mitragliatrici».
P. SPRIANO, Storia del Partito comunista italiano. 8.
La Resistenza. Togliatti e il partito nuovo, Einaudi, Torino 1975,
pp. 439-443
UNITÀ 8
Spiega l’espressione secondo cui il proclama di Alexander riflette la politica delle zone d’influenza.
Quali erano le preoccupazioni degli inglesi rispetto all’Italia?
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
9
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
6
Le motivazioni del comportamento
delle truppe tedesche verso gli italiani
UNITÀ 8
Dopo aver esaminato i principali episodi di violenza messa in atto dalle truppe tedesche in Italia, l’autore tenta di individuare le motivazioni in virtù delle quali l’uccisione di civili divenne una pratica di assoluta normalità. In genere, le unità che
si macchiarono delle stragi più feroci avevano prestato servizio sul fronte orientale e avevano completamente accettato l’idea della superiorità razziale germanica.
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
10
Per quanto riguarda i circa 7000 militari e gli oltre 9000
civili italiani assassinati, fra cui vi furono almeno 580 bambini innocenti di età inferiore ai quattordici anni, è stato dimostrato che essi non caddero vittime della violenza nazista solo per motivi legati a una particolare situazione
storica. La spiegazione del perché toccò loro un simile destino va piuttosto ricercata nella concomitanza di vari fattori, che complessivamente fecero venir meno il rispetto per
ogni vita umana che non fosse tedesca. In ciò si concretizzò un’affinità mentale dei colpevoli con l’ideologia nazionalsocialista, di cui essi introiettarono una visione dell’uomo improntata al razzismo.
In altre parole, la convinzione di appartenere a una
razza superiore, diffusa non soltanto fra le massime autorità dello Stato nazionalsocialista, influenzò in maniera
molto sfavorevole l’atteggiamento verso la popolazione
italiana e fece sì che nei confronti di quest’ultima si scatenasse quotidianamente un razzismo sconsiderato che,
pur avendo contorni molto vaghi, era ampiamente diffuso,
profondamente radicato e facile da innescare. Spesso tale
sentimento veniva poi esacerbato dall’odio che insorgeva
nelle situazioni concrete.
Di sicuro non si trattò di un razzismo paragonabile a
quello che causò lo sterminio degli ebrei, bensì di un atteggiamento razzistico che aveva come scopo il declassamento di una nazione. Dopo l’uscita dell’Italia dalla
guerra, questa disposizione ideologica contribuì a un abbassamento della soglia degli scrupoli morali nella pratica
della tortura o addirittura dell’omicidio nei confronti degli italiani, e falciò migliaia di vite umane. Le relazioni tra tedeschi
e italiani furono all’epoca, in buona sostanza, quelle tra un
Herrenvolk [popolo di signori – n.d.r.] e uno Sklavenvolk [popolo di schiavi – n.d.r].
Quel razzismo è, a nostro avviso, la chiave di volta per
comprendere e spiegare in modo adeguato perché la
Wehrmacht, le SS e la polizia reagirono con rappresaglie
sproporzionate, e più precisamente con stragi, alla Resistenza italiana. L’ideologia razzista non costituisce tuttavia l’unico fattore che può rendere ragione del comportamento inumano delle forze armate tedesche in
Italia. Dobbiamo anche considerare la particolare mentalità degli uomini in guerra, giacché l’incombente e costante presenza della morte induce in molti soldati una
profonda indifferenza morale. [...] Là dove la morte diventa la norma o una costante eventualità, la propria vita
e quella degli altri perde di stima, rispetto e di valore. Ma
ciò vale, probabilmente, per quasi tutti gli uomini in
guerra.
Particolarità germaniche che possono spiegare gran
parte di quello che è successo tra tedeschi e italiani dopo
l’8 settembre 1943 sono invece l’indottrinamento delle
truppe con idee contrarie al diritto internazionale, la tendenza
tradizionale delle autorità militari a combattere una mentalità umanitaria che veniva considerata inconciliabile con la cosiddetta «necessità bellica» e con il «carattere peculiare» della
guerra. Non a caso, entrambi questi termini tecnici – con cui
da parte tedesca si giustificò qualsiasi atto di terrore, soprattutto nel contesto della politica d’occupazione – rimasero
senza una precisa definizione. Del resto, nell’ambiente militare tedesco hanno sempre allignato un atteggiamento relativistico nei confronti del diritto internazionale e simpatie per
una cultura di violenza, e ben da prima della Grande Guerra.
Nella seconda guerra mondiale un ulteriore elemento
per la spiegazione dell’atteggiamento dei militari tedeschi
viene offerto dall’ideale del «soldato politico»: un soldato
della Wehrmacht (e non solo delle SS, come qualcuno ha
supposto erroneamente) che si identifica con l’ideologia nazista e gli obiettivi politici del regime. A questo scopo fu inculcato nei militari il dogma dell’indissolubile unità tra il popolo, la razza e lo Stato. L’idea della comunanza di sangue
e di destino di tutti i tedeschi doveva diventare il fondamento dell’agire personale. Come abbiamo dimostrato, fu
questa una delle principali richieste delle autorità militari tedesche nel teatro di guerra italiano. Infatti, per la Wehrmacht la seconda guerra mondiale diventò sempre più, anche
in Italia, una guerra essenzialmente nazionalsocialista.
Si deve inoltre accennare al fondamentale principio di
ordine e ubbidienza proprio della vita militare, che sicuramente favorisce un indebolimento del senso di responsabilità individuale. E non c’è dubbio che le direttive criminose
emanate dal comando supremo della Wehrmacht, nonché
gli ordini per la lotta contro le «bande» impartite dal comandante superiore del Sudovest o da altri comandi, che
davano in pratica carta bianca a qualsiasi arbitrio, abbiano
facilitato il gioco omicida dei vari von Hirschfeld, von Loeben, Peiper, Reder e dei loro superiori.
Esisteva anche una stretta correlazione tra lo svolgimento delle operazioni, la costante minaccia partigiana, la
frustrazione delle truppe tedesche in continua ritirata, il quadro strategico deprimente, la vendetta, spesso condizionata dalla situazione, e la disponibilità alla violenza estrema.
In un tale scenario, nessun militare tedesco considerava
l’innocente popolazione civile italiana degna di alcun riguardo. E non dimentichiamo, infine, che numerosi soldati
e ufficiali tedeschi impiegati in Italia avevano avuto una certa
esperienza della guerra di annientamento in Russia.
G. SCHREIBER, La vendetta tedesca. 1943-1945: le rappresaglie
naziste in Italia, Milano, Mondadori, 2001, pp. 232-234.
Traduzione di M. Buttarelli
Che cosa significano le due espressioni Herrenvolk e Slavenvolk?
In che modo questi concetti influenzarono il comportamento dei soldati tedeschi in Italia?
Che cosa significa l’espressione soldato politico?
In che modo questo concetto influenzò il comportamento dei soldati tedeschi in Italia
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
Alcuni tra gli episodi più gravi della violenza compiuta dagli italiani in Jugoslavia si svolsero in Slovenia. Allorché Mussolini decise di trasformare Lubiana in una provincia italiana a
tutti gli effetti, migliaia di sloveni furono condotti nell’isola di Arbe
e internati in un campo di concentramento.
All’inizio dell’estate 1942, tra gli alti comandi militari
italiani era ormai diffusa l’idea che fosse necessario
compiere il «salto qualitativo» che avrebbe dovuto trasformare le deportazioni parziali in «sgombero totalitario» della popolazione della «Provincia di Lubiana». Anche per questo sull’isola di Rab (per gli italiani Arbe), da
poco tempo annessa all’Italia, si stava predisponendo
un enorme lager che avrebbe dovuto accogliere 16000
internati. L’occasione per la presentazione al duce dell’imponente programma di deportazione fu data dal
summit politico-militare tenutosi il 31 luglio 1942 a Gorizia. In quella occasione, parlando alla folla dal palazzo
del Comando militare, Mussolini dichiarò apertamente
guerra alla popolazione slovena, minacciandola di deportazione e di sterminio. Poco dopo il generale Robotti
riferiva agli ufficiali che il progetto era stato superiormente approvato e che, quindi, si sarebbe dovuto «allargare il più possibile la macchia d’olio del dominio italiano», avviando «tutti gli uomini validi» nel campo di
concentramento di Arbe. [...]
La realizzazione del campo di Arbe era stata intrapresa alla fine di giugno del 1942 con l’allestimento, su
un terreno paludoso in località Kampor, di una tendopoli capace di «alloggiare» 6000 internati. Altri settori
(complessivamente ne erano previsti quattro, oltre al cimitero), costituiti da baracche e capaci di accogliere altre 10000 persone, dovevano essere realizzati prima
del sopraggiungere della stagione invernale. I civili deportati ad Arbe non furono sottoposti al lavoro obbligatorio; tuttavia la fame, le pessime condizioni igienicosanitarie, il dormire sotto piccole tende a contatto col
nudo terreno e la mancanza di qualsiasi tutela internazionale, resero la loro prigionia estremamente penosa. Secondo i dati forniti dal Supersloda, dall’apertura del campo sino alla metà di dicembre del 1942,
erano già morti 502 deportati.
Il nunzio papale presso il governo italiano, Monsignor
Francesco Borgognini Duca, che pure visitò quasi tutti
i campi di internamento della penisola, per i rischi connessi ad un eventuale lungo viaggio da Roma al golfo del
Quarnaro, non si recò dagli internati di Arbe. Lo fece, invece, monsignor Giuseppe Srebrnic, vescovo della vicina isola di Veglia (Krk), che rimase estremamente impressionato da quanto visto. «Ad Arbe, nel territorio
della mia diocesi, ove all’inizio del mese di luglio 1942 si
aprì un campo di concentramento nelle condizioni più
miserabili che si possono immaginare – scriveva il prelato il 5 agosto 1943 – morirono fino al mese di aprile
dell’anno corrente, in base agli esistenti verbali, più di
1200 internati; però testimoni vivi ed oculari, che cooperavano alle seplture dei morti, affermano decisamente
che il numero dei morti per il detto periodo ammonta almeno a 3500, più verosimilmente a 4500 e più».
La storiografia jugoslava ha definito «di sterminio» il
campo fascista di Arbe; quella italiana, invece, avendolo
quasi completamente ignorato, non si è posta alcun problema di definizione. Di fatto, i deportati vi cominciarono
a morire numerosi già nell’ottobre 1942, e il tasso di
mortalità andò aumentando sino al gennaio dell’anno
successivo. Il fatto che, sin dall’inizio, vi fosse stato
predisposto un ampio terreno per le sepolture (gli internati del campo lo definirono «quinto settore»), dimostra,
ad ogni modo, che un’alta mortalità tra i prigionieri rientrava tra le previsioni dell’Esercito italiano.
Da regolamento, il vitto avrebbe dovuto garantire ad
ogni deportato 1000 calorie al giorno; di fatto, però,
esso ne offriva meno della metà. Particolarmente grave
fu la condizione delle partorienti, che molto frequentemente diedero alla luce bambini già morti. All’inizio di novembre 130 internati avevano un’età inferiore ai dieci
anni, e nel volgere di un mese il numero dei minorenni
aumentò ad alcune centinaia. La notte del 29 ottobre
1942, nel corso di un violento nubifragio, un vicino torrente inondò il campo e spazzò via moltissime tende.
Negli ultimi mesi dell’anno, tra i deportati di Arbe la
mancanza di cibo era così grave e diffusa che anche i
giovani in pieno vigore fisico subivano in poco tempo il
dimezzamento del proprio peso corporeo: centinaia di
figure scheletriche, sfinite dalla fame si trascinavano
quotidianamente per il campo nell’improbabile ricerca di
qualcosa da poter mangiare.
C. S. CAPOGRECO, «Internamento e deportazione dei civili
jugoslavi (1941-’43)», in C. DI SANTE (a cura di), I campi di
concentramento in Italia. Dall’internamento alla deportazione
(1940-1945), Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 149-151
La politica di internamento fu sconfessata da Mussolini?
Quale atteggiamento ha assunto la storiografia italiana, nei confronti del campo di Arbe?
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012
UNITÀ 8
Il campo di concentramento di Arbe
11
RIFERIMENTI STORIOGRAFICI
7
8
La vicenda delle foibe: un inquietante
nodo storiografico
UNITÀ 8
Per molti anni, i crimini compiuti dai partigiani jugoslavi in
Istria e in Venezia Giulia sono stati ignorati o minimizzati dalle
sinistre italiane. Scorretto è anche stato l’utilizzo strumentale
di questo episodio da parte dei neo-fascisti, che si servirono delle atrocità comuniste per far dimenticare le violenze commesse dagli squadristi e dall’esercito italiano a Trieste, in Istria e in
Slovenia. Quella delle foibe è una vicenda complessa: un microcosmo che riassume tutte le tragiche contraddizioni del Novecento.
L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
12
Nulla sarebbe più sbagliato del credere che delle
foibe si sia cominciato a parlare solo di recente. Al contrario, l’argomento è stato frequentissimo, non solo nella
pubblicistica [sui giornali e, più in generale, sulla stampa
destinata ad un vasto pubblico – n.d.r.], che nel corso
di un cinquantennio ha dedicato al problema un vero diluvio di interventi, ma anche nella storiografia, seppur in
misura nettamente minore. Piuttosto, c’è da chiedersi
come mai i contributi sul tema delle foibe abbiano trovato un’enorme difficoltà a uscire da ambiti molto circoscritti: essenzialmente quello locale giuliano e quello,
del tutto speciale, degli esuli giuliano-dalmati.
Per tentare una risposta, conviene partire dalla constatazione che scarso interesse a livello nazionale non è
stato suscitato solo dal dramma delle foibe ma, più in
generale, da quasi tutte le vicende legate alla storia
della frontiera orientale italiana dopo la prima guerra
mondiale. [...]
Dietro tali rimozioni incrociate sta probabilmente il
fatto che la storia del confine orientale per un verso ha
potentemente favorito la nascita di veri e propri miti politici e storiografici, per l’altro, se rigorosamente investigata, offre pure tutti gli elementi per mettere in crisi quei
medesimi miti, oramai consolidatisi nelle diverse culture
politiche del nostro paese. Ciò vale, per esempio, per il
mito del buon italiano, che può uscire alquanto ridimensionato dalla conoscenza critica delle esperienze di occupazione italiane nei territori ex jugoslavi, oppure per
quello dell’innocenza della classe dirigente italiana della
Venezia Giulia e soprattutto di Trieste nei confronti del potere germanico nel biennio 1943-1945, se si tiene conto
della rete di silenzi e complicità di cui i nazisti poterono
avvalersi per portare a compimento il loro disegno di
morte. Ma ombre tutt’altro che lievi non possono che addensarsi anche sul mito del Movimento di liberazione jugoslavo, a lungo considerato un esempio per tutti i movimenti resistenziali europei, di fronte all’osservazione
delle violenze di massa – come, appunto, quella delle
foibe – attraverso le quali esso raggiunse i suoi obiettivi,
e cioè l’indipendenza del paese, l’annessione di territori
rivendicati ai confini e la costruzione del comunismo:
passaggi tutti di un progetto rivoluzionario che avrebbe
condotto alla formazione di un regime stalinista, anche
se destinato a scontrarsi con Stalin, al quale fra l’altro va
addebitata l’espulsione degli italiani dall’Istria. [...]
Nella primavera del 1945, a venire presi di mira non
furono tanto gli elementi di etnia italiana – che potevano
venire considerati buoni e onesti italiani se aderivano all’annessione alla Jugoslavia – quanto tutti coloro che, a
prescindere dalle loro origini etniche, si sentivano politicamente italiani, vale a dire desideravano il mantenimento della sovranità italiana sulla regione. Secondo la
medesima logica vennero perseguiti pure gli sloveni e i
croati contrari al comunismo. Anche la formula rituale
pertanto, secondo la quale molte delle vittime delle foibe
furono uccise soltanto perché italiane, risulta sostanzialmente ambigua: poco fondata, specie per quanto riguarda il 1945, se riferita all’origine etnica, appare invece
molto più significativa se declinata sul piano politico, con
l’avvertenza aggiuntiva che per italiani vanno intesi non
solo e non tanto quanti riconoscevano come italiana la
loro identità nazionale (lo facevano anche i comunisti che
si battevano per la Jugoslavia socialista) quanto piuttosto coloro che volevano l’Italia, con una scelta politica
in cui preminente era la dimensione statuale.
R. PUPO-R. SPAZZALI, Foibe, Milano, Bruno Mondadori,
2003, pp. 108-113
Che cosa sono e che funzione svolgono i miti politici e storiografici? Quali di essi la vicenda delle foibe mette
in discussione?
Spiegate l’espressione: «a venire presi di mira furono [...] tutti coloro che, a prescindere dalle loro origini etniche,
si sentivano politicamente italiani».
F.M. Feltri, La torre e il pedone © SEI, 2012