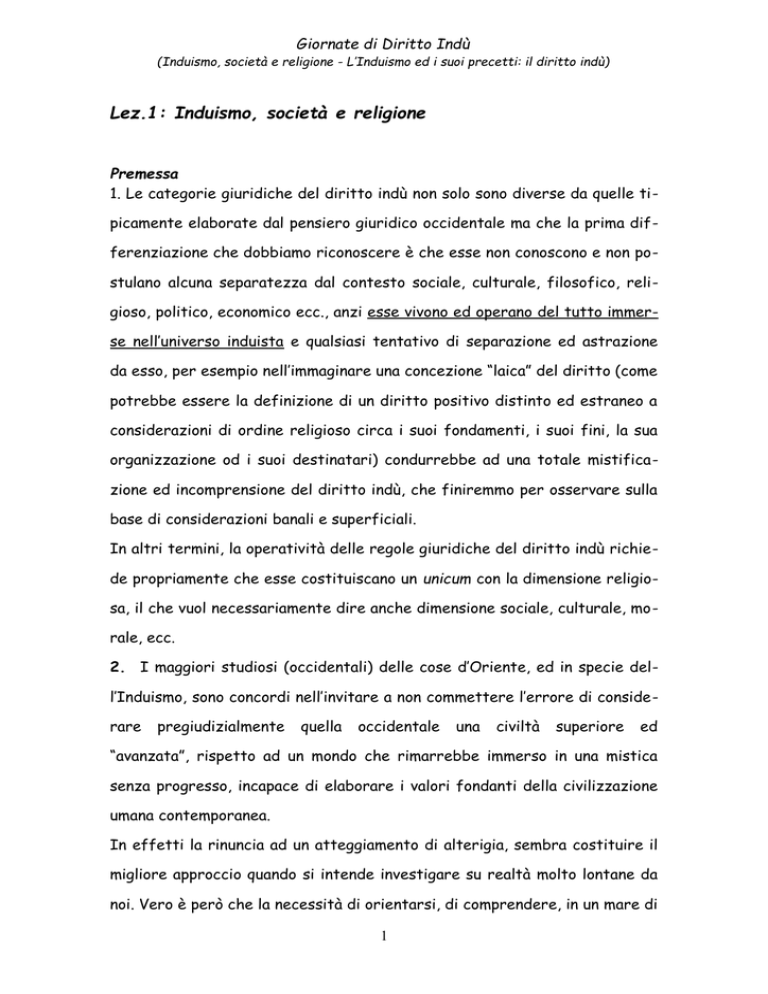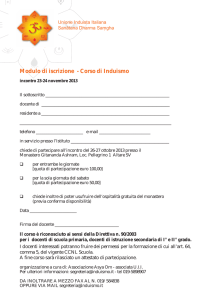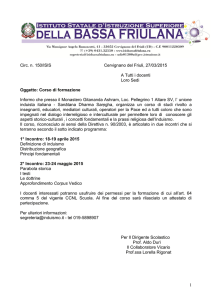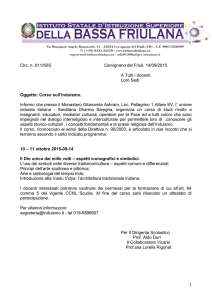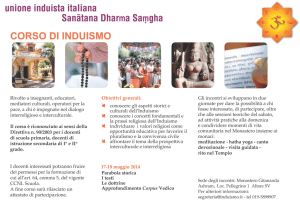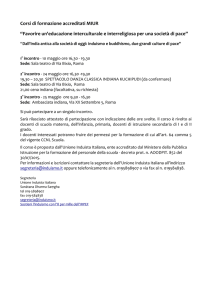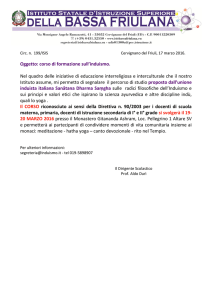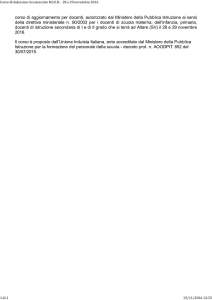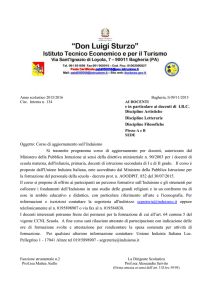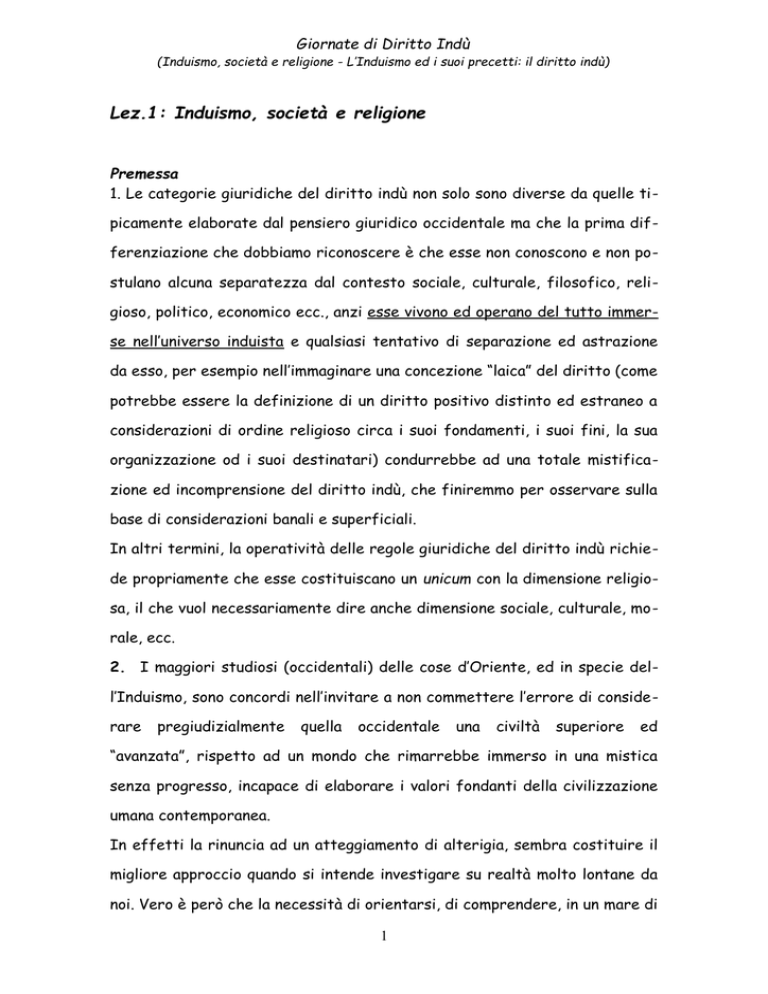
Giornate di Diritto Indù
(Induismo, società e religione - L’Induismo ed i suoi precetti: il diritto indù)
Lez.1: Induismo, società e religione
Premessa
1. Le categorie giuridiche del diritto indù non solo sono diverse da quelle tipicamente elaborate dal pensiero giuridico occidentale ma che la prima differenziazione che dobbiamo riconoscere è che esse non conoscono e non postulano alcuna separatezza dal contesto sociale, culturale, filosofico, religioso, politico, economico ecc., anzi esse vivono ed operano del tutto immerse nell’universo induista e qualsiasi tentativo di separazione ed astrazione
da esso, per esempio nell’immaginare una concezione “laica” del diritto (come
potrebbe essere la definizione di un diritto positivo distinto ed estraneo a
considerazioni di ordine religioso circa i suoi fondamenti, i suoi fini, la sua
organizzazione od i suoi destinatari) condurrebbe ad una totale mistificazione ed incomprensione del diritto indù, che finiremmo per osservare sulla
base di considerazioni banali e superficiali.
In altri termini, la operatività delle regole giuridiche del diritto indù richiede propriamente che esse costituiscano un unicum con la dimensione religiosa, il che vuol necessariamente dire anche dimensione sociale, culturale, morale, ecc.
2. I maggiori studiosi (occidentali) delle cose d’Oriente, ed in specie dell’Induismo, sono concordi nell’invitare a non commettere l’errore di considerare
pregiudizialmente
quella
occidentale
una
civiltà
superiore
ed
“avanzata”, rispetto ad un mondo che rimarrebbe immerso in una mistica
senza progresso, incapace di elaborare i valori fondanti della civilizzazione
umana contemporanea.
In effetti la rinuncia ad un atteggiamento di alterigia, sembra costituire il
migliore approccio quando si intende investigare su realtà molto lontane da
noi. Vero è però che la necessità di orientarsi, di comprendere, in un mare di
1
concezioni tanto diverse dalle nostre ci porta inevitabilmente a schematizzazioni e banalizzazioni, che impoveriscono la “qualità” di quanto andiamo osservando.
Ciò dipende, evidentemente, non tanto da una cattiva volontà quanto dalla
necessità che abbiamo di descrivere fenomeni e circostanze, e per fare ciò
non possiamo che attingere a categorie concettuali che ci sono proprie ma
che in effetti non corrispondono e non sono specularmente traducibili nei
concetti e nelle categorie che ci propone l’Oriente, vicino o lontano che sia.
Dunque, quando ci riferiamo,a “società”, “religione”, “diritto”, dovremo cercare di comprendere quale concetti racchiudano tali espressioni nell’universo induista, al fine di individuare un linguaggio “comune”, in grado di far interagire due mondi così diversi e così lontani.
Un buon metodo per evitare semplificazioni e schematizzazioni fuorvianti
può essere quello di tenere sempre una considerazione “dinamica” degli elementi che si propongono alla nostra attenzione, una considerazione cioè non
in senso “assoluto” dei diversi concetti ma una attenta osservazione della
loro, per così dire, “operatività relativa”, vista nel contesto più generale in
cui si inseriscono. Per fare un esempio, per comprendere la nozione di “diritto” e di “giuridicità” nel contesto induista non è sufficiente affidarsi alla
idea di norma giuridica che abbiamo coltivato nella civiltà giuridica occidentale ma è sempre necessario considerare come concretamente l’idea di una
“norma”, “regola” o “precetto” che dir si voglia, si inserisce nella dinamica
sociale e religiosa ed ha rilievo all’interno di questa, così da poterne apprezzare anche una definizione concettuale, teorica, ma che non resti avulsa dal
suo contesto.
Il nome
3. Diciamo subito che Induismo - con o senza H (Hinduismo) - è una
espressione estranea agli Induisti. Essa prende la sua origine da un termine
persiano con il quale si indicava la provincia orientale dell’impero achemenide, sotto Dario (dal 550 a.C al 330 a.C. circa), che a sua volta derivava dal
sanscrito “sindhu” nome generico per designare un fiume. Attraverso il greco si è passati poi al latino Indus quale nome proprio del fiume Indo. Quindi
induismo non ha nel suo etimo alcun significato religioso ma vale ad identificare, in origine, soltanto le popolazioni che abitano il bacino del fiume Indo.
Quando è stato impiegato con accezione religiosa, il termine induismo ha da
subito assunto un valore residuale, indicando piuttosto una religione tradizionale propria di quelle popolazioni dell’area indiana che non siano seguaci
delle religioni del libro – ebraismo, cristianesimo ed islamismo - e, con maggiore precisione, che non fanno riferimento ad un fondatore storico come
jainismo, buddhismo, sikhismo.
Ma come può definirsi in positivo la religione induista e come gli indiani chiamano tale religione? Una espressione largamente accettata è quella di “sanātana dharma”, che può tradursi approssimativamente come “norma immortale” o”legge imperitura” (la difficoltà, come vedremo, è la traduzione di
“dharma”).
Si tratta di una espressione mutuata da un poema epico, il Mahabharata,
(compilato in sanscrito tra il IV sec. a.e.v. ed il IV sec. e.v.), uno dei più importanti testi dell’Induismo e che in un suo paragrafo (il 12,162,4) si riferisce alla verità, satya, indicata come legge imperitura (a questo punto digressione sulle parole di Ghandi alla fine del film).
L’espressione sanātana dharma è stata utilizzata a partire dall’inizio del secolo scorso per definire dapprima uno specifico orientamento religioso e
successivamente una corrente dell’induismo contemporaneo.
Registriamo anche che si tratta di una definizione generalmente gradita in
ambito devozionale: l’Unione Induista Italiana ha definito se stessa come
“Sanātana Dharma Saňgha”, ovvero Comunità della Legge imperitura”.
Possiamo cominciare a dare una prima – insufficiente – risposta alla domanda
appena posta definendo gli Induisti come quegli Indiani, non seguaci di una
delle religioni del Libro, né di una delle religioni di origine indiana con fondatore storico o semistorico (jainismo, buddhismo, sikhismo) né di altra religione fortemente radicata in India ma di origine extraindiana (come lo zoroastrismo). Ma se a questo punto legassimo ad una origine autoctona indiana il complessivo fenomeno religioso che va sotto il nome di Induismo commetteremmo un errore poiché tale legame è invece surrettizio, introdotto
per motivi latamente politici più che religiosi da alcune correnti di pensiero.
La periodizzazione
4. Per fare un po’ d’ordine nel nostro discorso è utile richiamare una convenzionale ed accettata divisione in tre macroperiodi:
1) Periodo della religione vedica o vedismo, compresa tra il 1500 a.e.v. ed il
500 a.e.v.
2) Periodo del brahamanesimo o induismo antico, compreso tra il 500 a.e.v.
ed il 500 e.v.
3) Induismo recente o induismo tout-court, che si ritiene compreso tra il
500 e.v. ed il 1900 e.v.
Dal XIX secolo in poi l’incontro dell’induismo con la modernità (che era ovviamente avvenuto assai prima) ha prodotto mutamenti talora frenetici, che
hanno dato luogo ad etichette storiografiche e denominazioni più varie. In
realtà da tale sbizzarrirsi degli studiosi è forse lecito soltanto prendere
atto che l’induismo è in costante mutazione ed evoluzione ed è ancora pre-
maturo affermare ove si tratti di mutamenti stabili, ove effimeri, se seguano una unica direttrice o se portino l’Induismo a prendere molteplici direzioni.
I confini dell’Induismo e del diritto indù non sono coincidenti, per esempio
perché pur intendendo, correttamente il diritto indù quale ordinamento giuridico personale, proprio della comunità induista esso si applica anche alla
comunità buddista, jainista e sikhista, in quanto comunità indù (hindi). Ciò è
conseguenza delle differenti relazioni che si instaurano con gli eventi storici e contingenti in capo all’induismo inteso come religione o come esplicitazione di norme di condotta (e noteremo, in questa seconda accezione una
certa permeabilità a ciò che gli è estraneo ed a ciò che gli è successivo).
Le fonti ed i gruppi sociali
5. Per segnare, per così dire, un inizio dobbiamo fare riferimento ad un insieme di popolazioni di ceppo linguistico indoeuropeo, probabilmente giunte
in India da un centro di irradiazione non ben identificato, e responsabili dell’introduzione nel subcontinente indiano di una nuova cultura.
Rispetto alle popolazioni stanziali e agricole che costituivano il nucleo della
cosiddetta civiltà della valle dell’Indo, gli invasori indoarii, pastori nomadi,
portavano forti innovazioni tecnologiche (il cavallo, il carro da guerra, le
armi di ferro), ma soprattutto un potente strumento culturale, il corpus vedico o Veda.
Prima di accennare al Veda ed alle altre fonti è opportuno delineare chi ne
siano i destinatari.
Le persone qualificate a ricevere l’insegnamento del Veda sono i membri di
sesso maschile dei tre gruppi superiori della società indiana classica.
Tale società si struttura gerarchicamente in quattro gruppi sociali detti
colori (varna) perché ciascuno di essi viene associato a un colore simbolico:
- i sacerdoti (brāhmana, termine omofono rispetto a quello che indica i testi sacerdotali), il cui compito sociale consiste nel ricevere e trasmettere la
conoscenza (colore simbolico il bianco emblema di purezza);
- i guerrieri (ksatriya), il cui compito sociale consiste nel difendere la società dai nemici interni ed esterni (colore simbolico il rosso del sangue);
- la gente comune, cioè produttori e scambiatori di beni (la gente del popolo, i vaisya, unici produttori di ricchezza, un gruppo molto ampio che comprende agricoltori, artigiani, mercanti, banchieri), il cui compito sociale consiste nel produrre e nell’aumentare la ricchezza della società (colore simbolico il giallo delle messi e dell’oro);
- infine i servitori (śudra), il cui compito sociale consiste nel servire i tre
gruppi sociali superiori (si noti bene che sono prestatori d’opera liberi, non
schiavi; il loro colore simbolico è il nero della terra).
Tutti coloro che non rientrino in questo sistema, e sono la stragrande maggioranza della popolazione, sono definiti collettivamente come avarna, i
“senza colore” (popolazioni tribali dette “aborigeni”, adivāsin, etimologicamente “quelli che dimorano [lì] da prima”, e vari gruppi marginalizzati).
6. Il sistema dei varna, consacrato dall'infallibile validità del Rgveda nell'inno 90 del decimo libro, prende via via piede fino a diventare una vera e
propria gerarchia di segregazione, che separa possiamo dire,drammaticamente, i diversi settori della società indiana tradizionale.
Risulta chiaro dalla rivelazione vedica quale sia il dovere dei singoli varna: i
sacerdoti hanno compiti sapienziali e didattici, oltreché, ovviamente, ritualistici; i nobili guerrieri devono combattere per proteggere i sudditi e in genere usare la forza, o la sua minaccia, per garantire l'ordine (ma hanno anche il compito di studiare, donare, far compiere sacrifici, sostenendo la
classe brahmanica con varie forme di supporto economico); la gente comune,
i vaisya, attende all'allevamento del bestiame, all'agricoltura, all'artigianato
e al commercio, ma anche a doveri di studio e rituali; il compito dei servi
(sudra), infine, è dichiarato dal loro stesso nome: servire le tre classi superiori, i cui uomini costituiscono gli dvija, i “nati due volte”, cioè nati a nuova
vita dopo la cerimonia dell'iniziazione, dalla quale i servi sono esclusi.
I principali parametri segregazionistici sono costituiti da forti divieti di intercommensalità, prescrizioni dietetiche (più si sale nella scala sociale più il
vegetarianesimo diviene obbligatorio e le stese specie vegetali permesse si
riducono di varietà; chi sta più in basso è tendenzialmente onnivoro e può cibarsi anche di carne e pesce) e obblighi di sposare persone appartenenti al
proprio stesso colore. Per evitare rischi di incesto o comunque di eccessiva
endogamia, i varna endogamici vengono segmentati in "recinti delle vacche",
gotra, gruppi esogamici all’interno di ciascun varna.
Le caste vere e proprie, le jāti
7. Al sistema dei varna si sovrappone quello delle “nascite” , le jāti, che
sono gruppi sociali (numerosissimi, da due a tremila) su base occupazionale,
termine che i primi colonizzatori europei resero con “casta” (vocabolo di
origine portoghese, originariamente appartenente alla sfera semantica dell’allevamento dei cavalli), a indicare un gruppo sociale chiuso cui si appartiene per nascita, di rilevanza locale e definito su base occupazionale. Il nome
della jāti fornisce preziose informazioni non solo sull’occupazione tradizionale dei suoi membri (ma non è detto che un membro di una jāti di pescatori
faccia necessariamente il pescatore: semplicemente nel suo nome di jāti si
trova memoria dell’occupazione ancestrale da cui la jati prende nome), ma
sui possibili legami di parentela (il nome di jāti fa capire quali jāti possono
sposarsi con quella e quali no), sull’appartenenza religiosa, sull’origine etnica
(vera o presunta), sulla collocazione o sulla provenienza geografica.
Il sistema dei varna e delle jati garantisce una struttura gerarchica coesa e
coerente, e non è così rigido come potrebbe sembrare a prima vista. Se la
mobilità sociale individuale è preclusa, non vale lo stesso per quella di gruppo. Infatti, se una jāti si accorge di stare scendendo nel "borsino sociale"
(ossia principalmente se nessuno aspira più a sposare le donne di quella jāti),
può tentare migliore fortuna rifacendosi una verginità con l’emigrazione interna. Spostarsi nel subcontinente garantisce nuove possibilità di ascesa
per la jati, che manterrà nel nome il ricordo della sua provenienza geografica e potrà tentare, mediante un’accorta strategia di alleanze matrimoniali,
di ricollocarsi in una posizione più vantaggiosa nella piramide sociale.
Le caste rispondono a un'esigenza di distribuzione nell'ordine sacro. Massimamente impuri, perciò collocati al di fuori dei quattro varna, e variamente
denominati, sono quindi i fuoricasta, gli intoccabili (noi generalizzando usiamo il nome di un gruppo particolare, quello dei paria). Anche dalit (sanscrito, che significa “oppressi”). Sono coloro che discendono da rapporti sessuali nei quali la donna è di casta molto più elevata di quella dell'uomo; altri
gruppi umani condannati a questo status sono quelli dediti ad attività contaminanti, cioè connesse con la morte e con altre forme di impurità.
I fuoricasta non sono estranei al sistema: costituiscono caste anch'essi, e
adempiono a quelle funzioni necessarie e sporche che contaminerebbero gli
altri uomini, mentre per loro questo servizio infimo, ma di pubblica utilità, è
il dharma che, se seguito con dedizione, consentirà una migliore rinascita. Il
termine “intoccabili” sta a dire che il contatto con questi esseri umani contamina, e perciò va evitato. In certe regioni si credeva che contaminassero
anche solo a vederli: per evitare di farsi vedere, gli intoccabili dovevano gri dare dove stavano passando, altrimenti erano botte; in certi casi portavano
un campanellino legato a una gamba. Tutta la loro vita si doveva svolgere nella pena: dovevano vestire di stracci, mangiare in piatti rotti, ecc.
Quella dell'intoccabilità è stata ed è una tragica piaga nella storia dell'induismo, di vastissime dimensioni: più del 10% della popolazione indiana, secondo stime recenti oltre il 14%, è costituito da persone in queste condizioni (il che oggi vuol dire circa 150 milioni di persone). Quando si ammirano, le
grandi realizzazioni della spiritualità induistica, anche questo elemento va
tenuto presente per completezza di quadro. Grazie alle battaglie di Gandhi e di
altri, e al mutamento generale delle condizioni sociali, molti miglioramenti ci
sono stati, ma non dovunque e non per tutti.
Il sistema di segregazione castale è stato formalmente abolito dalla Costituzione indiana (entrata in vigore nel 1950), ma persiste nel costume, specialmente per le usanze matrimoniali; viene contrastato con politiche di antidiscriminazione (quote riservate alle classi svantaggiate nell’accesso alla
pubblica amministrazione e all’insegnamento universitario).
Bisogna però sempre tenere presente che tale sistema di aggregazione sociale costituisce un insieme di strutture così caratteristico del mondo indiano da permeare anche tradizioni non induistiche. Purtuttavia nell'induismo
conosce una tal forza pervasiva da indurre alcuni a identificarlo come componente essenziale dell'induismo stesso. Del resto, l'idea di una gerarchia di
tutti gli esseri, dal dio Brahman ai più umili, è tipica dell'induismo.
Il Veda
8. Dunque, i membri maschili dei tre gruppi superiori sono qualificati a ri-
cevere il corpus vedico.
Il Veda (etimologicamente “scienza [sacra]”) è un ampio insieme di insegnamenti, tramandati per lungo tempo oralmente e messi per iscritto solo in
tempi recenti, che si struttura in quattro raccolte e si articola su quattro
livelli.
Le raccolte (samhitā) fanno riferimento
- agli inni (Rigveda), che celebrano, talora in modo allusivo, le diverse caratteristiche mitologiche, iconografiche, rituali o teologiche delle principali
divinità;
- alle melodie cantate (Sāmaveda), che non contengono materiali originali
dal punto di vista letterario (rielaborano variamente gli inni), ma sono importanti perché contengono il più antico sistema di notazione musicale indiano
su scala eptatonica;
- alle formule sacrificali (Yajurveda), che sono conservate in due principali
recensioni, una accompagnata da glosse l’altra con il testo nudo senza glosse
(rispettivamente note come Yajurveda nero e Yajurveda bianco)
- alle formule di incantesimo (Atharvaveda), che rispondono a una tipologia
che con una terminologia un po’ datata si potrebbe indicare come magia
bianca e magia nera.
I livelli, a partire dal primo, rappresentato dalle raccolte, comprendono ulteriormente i testi sacerdotali (brāhmana), i testi della selva (āranyaka) e
gli insegnamenti esoterici (upanisad).
A ciascuno dei livelli corrisponde una diversa funzione sacerdotale: l’oblatore (hotar) che recita gli inni, il cantore (udgātar) che li canta, il sacrificatore (adhvaryu) che compie i gesti del sacrificio, e infine il responsabile dei
riti considerati privati o minori (atharìan), estraneo al culto solenne. Que-
st’ultimo consiste sostanzialmente in un rito che comporta una oblazione di
sostanze offerte in un fuoco sacrificale.
La religione vedica non conosce strutture temprali stabili; l’altare del fuoco
viene di volta in volta costruito con una minuziosa sintassi rituale, e non ap pena il rito viene ultimato, decostruito con altrettanta cautela e precisione
(alternativamente, lasciato all’opera di ricolonizzazione della foresta, alla
quale l’area sacrificale era stata strappata mediante disboscamento).
9. Il passaggio da un culto sacrificale esteriore, dispendioso e totalmente
dipendente dalla classe sacerdotale, a una concezione interiorizzata del sacrificio, in cui l’intermediazione del sacerdote non è più necessaria perché il
rito di offerta nel fuoco si è tramutato nella pratica interiore della combustione dei semi dell’ignoranza dentro il fuoco della gnosi salvifica, segna il
passaggio dalla religiosità vedica a quella hinduistica, con il tramite del
brahmanesimo inteso come necessario raccordo tra vedismo e hinduismo.
Questo passaggio è pienamente compiuto nelle upanisad, in cui l’interiorizzazione del sacrificio si completa, come culmine dell’opera di esegesi e di interpretazione simbolica del rito, messa in opera dai testi sacerdotali e da
quelli della selva.
Si è avuta una interpretazione europea, ottocentesca, del Veda, ed in particolare delle upanisad, come espressione dell’alba spirituale dell’umanità. Tale
interpretazione, di irrimediabile origine romantica, va rifiutata, in favore di
una più corretta valutazione del corpus, che rappresenta piuttosto il punto
di arrivo di una speculazione anteriore di cui si è persa traccia, e non tanto,
invece, il punto di partenza della produzione letteraria che si svilupperà
nella lingua sacra codificata dalla tradizione sacerdotale, il sanscrito.
Le altre fonti (Itihāsa e purāna,)
10. Dall’accesso al Veda, come abbiamo detto, sono dunque esclusi i maschi śudra e avarna e tutte le donne indistintamente.
A loro sono dedicati due gruppi importanti di fonti, che costituiscono insieme il patrimonio della cultura popolare indiana, per quanto siano composti in
sanscrito (samskrta), una lingua sacerdotale ed elitaria sin dal nome, che
etimologicamente vale "perfetto, completo", ma anche “artificiale” e che si
contrappone alle parlate regionali, dette pracriti (prākrta), nel senso di lingua “naturale” (e non artificiale), “volgare” (e non colta), regionale e non panindiana.
I due gruppi di fonti popolari sono l'epica, itihāsa e le antiche storie, purāna, ("antico [racconto]"), che contengono tutto quanto si desideri conoscere
in merito alla mitologia, all'agiografia, alle usanze religiose popolari (in primo luogo il pellegrinaggio ai luoghi sacri, definiti collettivamente
(tīrtha), perché almeno in origine dovevano trovarsi in siti in
“guadi”
cui i corsi
d’acqua fossero guadabili, o posti alla confluenza di due o più fiumi)
- I due poemi epici principali sono il Rāmāyana di Vālmīki, (“Viaggio di
Rama"), che narra la vicenda dell'eroe divinizzato Rāma, simbolo del monarca ideale, che traversa tutta l’India per recuperare la sposa Sītā che gli è
stata rapita dall'antidio Rāvana (ca. 24.000 strofe) e il Mahābhārata di
Vyāsa, il “grande [poema] dei discendenti di Bharata [eroe eponimo dell'India come la chiamano gli indiani, Bharata]”, che narra la guerra fratricida
che si combatte tra due stirpi di cugini primi, i cinque discendenti di Pāndu e
i cento discendenti di Dhrtarāstra (ca. 100.000 strofe), e che comprende il
più famoso poema religioso indiano in Occidente, la Bhagavadgità ("canto
del glorioso signore", in forma dì dialogo spirituale tra il guerriero Arjuna,
uno dei cinque Pāndava, e il Dio Krsna, suo auriga).
Se il Rāmāyana è il modello della letteratura ornata (kāvya) che vede in esso
il suo primo esempio (è detto ādikāvya, "poema ornato primevo"), il Mahābhārata rappresenta la summa degli insegnamenti relativi ai quattro fini dell'uomo (kāma, artha, dharma, moksa)1 dei quali diremo più avanti.
- Le antiche storie, i purāna "canonici" si dividono in 18 "grandi" e 18 “secondari” (mahāpurāna, upapurāna), ma sono molti di più (oltre duecento). Si
tratta di raccolte enciclopediche del sapere tradizionale per quanto può essere utilizzato dal popolo, quindi con taglio divulgativo anziché specialistico,
e con particolare attenzione a temi quali i racconti di miti, il potere salvifico
dei luoghi santi (con relativi miti eziologici e di fondazione) e il merito reli gioso legato a pratiche devozionali e opere pie2.
11. Nel passaggio dal Veda ai purāna si compie una fondamentale distinzione tra due diversi strumenti di insegnamento.
Il corpus vedico è ascolto, śruti (comunemente reso con “rivelazione”) un
tipo di insegnamento trasmesso prima dell'inizio del tempo dalla voce incorporea che pronuncia il Veda e udito dai "veggenti" (rsi) che lo tramanderanno alle generazioni successive: l'unico requisito per preservarlo consiste nel
trasmetterlo integralmente senza modificazioni di sorta.
Gli itihàsa, i puràna, e poi i trattati (śāstra), comportano invece una certa
cooperazione attiva da parte dell'uomo, non sono più śruti ma "memoria",
1Essi sono concentrati soprattutto in due suoi libri (sui 18 che lo compongono) detti
sapienziali (il libro della pace e il libro degli insegnamenti).
2Il più esteso, lo Skandapurāna, da solo equivale per numero di strofe al Mahābhārata.
L'elenco dei 18 mahāpurāna comprende il Brahma (o Ādi), il Padma, il Visnu, il Vāyu, il
Bhāgavata (cui i seguaci della Dea sostituiscono il Devībhāgavata), il Nārada, il Mārkandeya,
l'Agni, il Bhavisya, il Brahmavaivarta, il Linga, il Varāha, lo Skanda, il Vāmana, il Kūrma, il
Matsya, il Garuda, il Brahmānda.
smrti, insegnamenti tramandati di generazione in generazione ma che possono e anzi richiedono imperiosamente di essere adattati alle mutevoli circostanze cui è soggetta la vita umana di era in era: il requisito per preservare
la “memoria” consiste proprio nella capacità di adattarla ai mutati tempi in
cui ciascuna generazione si trova a vivere.
Le strategie di adattamento alle mutevoli condizioni di vita da un'epoca all'altra si tradurranno nella teoria e nella pratica della cosiddetta "norma
per le avversità" (āpad-dharmā), sorta di giurisprudenza emergenziale, che
detta le regole per la convivenza civile, valide per parametri morali via via
più degradati, secondo la teoria dei cicli cosmici di progressivo allentamento dei vincoli etici3.
Attenzione, non si tratta di un rilassamento della condotta, di una possibilità di deroga di non cogenza del principio, ma della possibilità di individuare
una via interpretativa ed applicativa al caso concreto che consenta di affermare, per così dire una via “induista” anche in un contesto ostile o degradato.
Le fonti “giuridiche” - Dharmaśāstra e Dharmasūtra
12. Con riferimento ad una comprensione della dimensione giuridica
dell’Induismo, e posto che tra i molteplici significati di “dharma” (azione del
sostenere) vi
è
certamente
da
comprendere quello
di
“legge”, è
indispensabile riferirsi ad esso ed alle sue fonti per “tipizzare”, per così
dire, le fonti del diritto indù, del quale più diffusamente parleremo domani.
3Si può notare che tale atteggiamento si pone in assoluto contrasto, ad esempio, con il fondamentalismo islamico il quale pone come problematica e negativa anche l’attuazione delle
prescrizioni islamiche che sia realizzata in un ambiente non radicalmente totalmente islamizzato.
Dharmaśāstra è la Denominazione sanscrita usata per indicare una serie di
manuali (śāstra) che, insieme con i più antichi Dharmasūtra (“Aforismi
sulDharma”), i commentari e i digesti, costituiscono il corpus dell'antico
diritto indiano. Dharma è termine tecnico che ha esteso la primitiva
connotazione semantica della radice dhṛ, "reggere", "mantenere saldo e
immutabile", all'indicazione dell'insieme di quanto è "stabilito ab aeterno",
dei doveri religiosi e morali assunti nella loro più ampia estensione.
Nel quadro di un'accezione che non ha mai mutato nel tempo la sua primitiva
essenza, il dharma non disgiunge mai, in substantia rerum, le due categorie
parallele di dovere morale e di fondamento religioso. Esso designa, in un
insieme quasi indiscriminato di sacro e di profano, tutti gli aspetti
dell'azione umana, indica la regola costante, la forza di coesione e di
equilibrio, la Legge che non si può violare e attraverso la quale si realizza
l'ordine stesso delle cose.
Insieme con l'artha (le attività della vita pratica e quindi anche la politica) e
il kāma (l'amore e il piacere sessuale), esso costituisce il complesso dei tre
fini, il cosiddetto trivarga, dell'esistenza umana che, armonicamente
contemperati e convenientemente perseguiti, conducono alla liberazione
(mokṣa) dalle rinascite e dal dolore dell'esistenza.
13. La
tradizione
indigena
riconosce
come
fonti
del dharma la
''rivelazione/ascolto'' (śruti), ossia l'insieme dei testi vedici in quanto
rivelati direttamente dalla divinità; la ''tradizione/memoria'' (smrti), cioè i
testi considerati opera umana e tramandati per via mnemonica; i modi di vita
praticati dalle persone virtuose e dalle persone colte; gli usi e i costumi
delle regioni, delle caste, delle famiglie (o diritto consuetudinario).
Il dharma ha dato origine a un'imponente letteratura che dalla fine del
periodo vedico (circa 6° secolo a.C.) si estende fino al 18° secolo e conta un
ragguardevole numero di opere, ricordate o frammentariamente citate dai
maggiori trattati in nostro possesso ma perdute nella loro realtà testuale.
La fase più antica di questa letteratura è rappresentata dai Dharmasūtra,
testi che rientrano nell'ambito di quei manuali ausiliari e dottrinali elaborati
per un più preciso apprendimento del rituale relativo a ciascun Veda e
facenti capo a questa o a quella scuola vedica. Sono redatti in prosa di stile
aforistico o in prosa alternata con parti versificate; in queste composizioni
gli spunti giuridici presenti in forma embrionale e sporadica nei testi vedici
più antichi hanno assunto una veste più consistente.
Superando i limiti e i particolarismi conseguenti alla loro originaria
appartenenza all'una o all'altra scuola vedica, tali testi tendono a offrire
nei confronti di alcuni temi una visione più ampia e compiuta che acquista
carattere di universalità e dunque pan indiano.
14. Gli argomenti più propriamente giuridici contenuti nei Dharmasūtra
concernono di norma le fonti del dharma e i doveri dell'uomo in fatto di
religione e di morale, considerati piuttosto in quanto norme attinenti la
famiglia che non nel quadro di categorie giuridiche inerenti i rapporti sociali
e la vita pubblica. Vi trovano già precisa definizione concettuale le teorie
delle quattro categorie/caste (varna) e dei quattro stadi della vita
(aśrama), la cui combinazione costituisce il fondamento sul quale si
organizza armonicamente la vita dell'uomo sia dal punto di vista individuale
sia da quello sociale.
Oltre alla regolamentazione relativa agli avarna, vi si trovano elencate le
pene sancite per le diverse infrazioni, i doveri e le responsabilità del
sovrano, le norme di tassazione, i prestiti, gli interessi, il pagamento dei
debiti e dei depositi, le prescrizioni sui fondamenti dell'istituto familiare, le
norme relative a matrimoni, adozioni, levirato, eredità, princìpi di
contenzioso
e
di
diritto
penale.
In
genere
non
hanno
carattere
strettamente “giuridico” e le prescrizioni in essi contenute altro non sono
che un insegnamento prescrittivo a carattere dogmatico che si fonda
sull'eterno vero della religione.
Nella forma e nella sostanza sono libri dottrinali, ma la loro dottrina è
dottrina di un imperativo che, pur senza comminare sanzioni terrene, appare
equivalente, se non superiore, a quello che è proprio della Legge.
La datazione di questi trattati è discussa: la stessa cronologia comparativa
fra i Dharmasūtra e i testi che costituiscono la fase successiva della
trattatistica giuridica, e cioè i Dharmaśāstra è problema che rimane, per
ora, insoluto. Nell'insieme, la loro composizione può essere presumibilmente
situata tra il 6° e il 2° secolo a.C.
I principali Dharmasūtra sono quelli di Gautama (ritenuto il più antico),
Apastamba, Baudhāyana, Vasiṣṭha e Visnu.
15. I Dharmaśāstra, denominati anche smrti (o dharmasmrti "Tradizione
del corpo del giure"), segnano lo stadio più avanzato della letteratura
giuridica. Sono veri e propri trattati di diritto, redatti in strofe di stile
epico in una lingua meno arcaica di quella dei Dharmasūtra e più vicina al
sanscrito classico. Lo stesso stile non è più ellittico, ma vuol essere chiaro e
facile da comprendere. L’esposizione della materia legale vi appare più ampia
e particolareggiata; vi si trovano ormai costituite le categorie-base dello
scibile giuridico e si è affermata la tendenza a sistematizzare un
insegnamento giuridico d'ordine generale, nel quale l'interesse preminente
si è spostato dal piano religioso a quello civile.
I
Dharmaśāstra
testimoniano
contemporaneamente
un
ampliamento
dell'insegnamento del dharma, tanto nel contenuto quanto nella portata,
oltre che una specializzazione che ne fa, ormai, una disciplina indipendente.
Secondo alcuni studiosi questa specializzazione, segnata dall'apparizione di
scuole indipendenti del dharma, deriverebbe, da un lato, dallo sviluppo delle
cinque scienze ausiliarie inizialmente insegnate come complemento dello
studio di un Veda, dall'altro sarebbe dovuta sia al ruolo sempre più
essenziale assunto dai brahmana nell'amministrazione della giustizia, sia
all'esigenza manifestatasi nella società post-vedica, di una legislazione che
salvaguardasse l'unità di quanti, fra la popolazione, pretendevano di
appartenere legittimamente alla tradizione brahmanica.
Il sorgere dei Dharmaśāstra sarebbe dunque dovuto alla presa di coscienza
di una discriminante comunità di cultura nei cui “modi di vita” si sarebbe
identificata una specie di “codice dell'indianità”.
Questi testi, circondati da leggende che conferiscono loro un'origine mitica,
si presentano come la parola di Brahmā, raccolta da semidei o da saggi e
trasmessa in forma abbreviata fino a noi.
Non rivelano alcun legame con una scuola vedica specifica, né alcuna
preferenza per un rituale particolare, e sembrano opere di scuole
unicamente dedicate allo studio del dharma. Pertanto, dalla loro apparizione,
le regole da essi prescritte hanno autorità per tutti gli Arii, non più soltanto
nella cerchia ristretta di questa o quell'altra scuola. Pur non trascurando le
osservanze e le pratiche religiose o rituali, essi dedicano ampio spazio alle
regole destinate all'amministrazione della giustizia che sono classificate
con metodo e studiate secondo un certo numero di rubriche.
I principali fra questi codici di leggi sono legati per affinità di princìpi
ideologici e per età con fasi particolarmente significative della cultura e con
periodi importanti della storia dell'India; essi sono uniti da strette analogie
con gli insegnamenti giuridici contenuti nel Mahābhārata, nei Purāṇa,
nei Jātaka, o nelle sezioni che l'Arthaśāstra di Kauṭilya dedica ai problemi di
ordine giuridico, e costituiscono documenti di estrema importanza per la
conoscenza della cultura e della società dell'India antica.
16. La letteratura dei Dharmaśāstra, i cui termini cronologici vanno grosso
modo dagli inizi dell'era volgare fino al 9° secolo, epoca in cui compaiono i
primi commentari a noi pervenuti, è estremamente abbondante. Il numero di
questi testi supera largamente il centinaio, ma molti di essi sono poco conosciuti o non sono noti che grazie a citazioni spesso sporadiche e frammentarie. Una dozzina soltanto sono stati fatto oggetto di commentari. I testi ritenuti più antichi sono quelli di Manu, Narada e Yājñavalkya. Di tutti, il Codice di Manu, o Mānavadharmaśāstra, è il più rinomato, diffuso e importante,
e la sua indiscussa autorità in tema di diritto gli deriva non tanto dal fatto
che esso proclama la sua origine divina e si dichiara opera di Manu, progenitore mitico della razza umana e fondatore del diritto e dell'ordine sociale,
quanto dal fatto che esso presenta una trattazione globale del dharma nella
quale s'instaura per la prima volta il processo di distinzione tra contenzioso
e penale.
Le scuole filosofiche (darśana)
17. Una ulteriore produzione letteraria oltre quella relativa ai testi rivelati o tramandati è quella relativa ai darśana, parola traducibile con “visioni” o
“punti di vista”. Si tratta di una produzione che rende conto delle diverse
scuole filosofiche. I darśana principali, secondo la tradizione sono in numero
di sei e Ciascun darśana costituisce un sistema filosofico autonomo, con una
propria epistemologia4, cosmologia, etica, metafisica e soteriologia5. Sempre
secondo la tradizione il loro studio si affronta in coppia; le scuole sono:
4= filosofia/teoria della conoscenza.
5= dottrina della salvezza, liberazione dal male comunque inteso.
- metafisica
La scuola metafisica è animata da una volontà di catalogazione della realtà e
rinvia ai due principi ultimi, principio maschile ed un principio femminile.
Questa scuola è simultaneamente dualista, pluralista e realista; individua la
vera conoscenza nel superamento dell’errore consistente nel ritenere che vi
sia un qualche coivolgimento o rapporto tra i due principi ultimi.
- ascetica (yoga)
La scuola ascetica che si indica con il termine yoga indica una forma di disciplina, una pratica meditativa. Essa assume le medesime categorie cosmologiche della scuola metafisica aggiungendovi la figura di una sorta Deus otiosus, la cui funzione è quella di offrire sostegno meditativo al praticante. La
scuola più che sulle questioni interpretative si concentra sulle pratiche posturali, respiratorie e meditative.
La pratica dello yoga porta al conseguimento di poteri soprannaturali che
però sono un ostacolo da superare in vista della perfezione interiore.
- fisica
La scuola fisica non si propone di realizzare una sintesi concettuale ma di
fornire criteri minuti e specifici di interpretazione del reale considerato
come irrinunciabilmente pluralistico. Essa descrive una fisica basata sulle
prime cinque sostanze: terra, acqua, fuoco, aria e spazio etereo; sviluppa
una teoria atomistica in cui il reale è costituito da una pluralità di unità atomiche non contigue e non estese. Meriti e demeriti (dharma e adharma) intrappola il soggetto in una rete di rinascite che vengono invece insterilita
dalla conoscenza autentica.
- logica
La scuola logica si propoen come epistemologia (teoria della conoscenza) e
come capacità di convincere l’interlocutore; individua se stessa come tenta-
tivo di inventariare il reale attraverso strumenti conoscitivi adeguati non
cosmologici.
- esegetica
La scuola di esegesi ha come oggetto specifico l’azione rituale promanante
dal Veda, in opposizione ai contenuti speculativi o conoscitivi
- mistica
La scuola mistica segue la dottrina del non dualismo assoluto. In essa solo
l’essere trionfa ed il divenire è impossibile; nulla è prodotto da se stesso o
da altro, nessuna causa è prodotta. Nulla nasce nulla viene distrutto solo
l’essere permane.
La devozione (bhakti).
17bis. Ogni tentativo di suddividere a fini didattici la civiltà indiana in
compartimenti separati è destinato a essere frustrato dalla realtà, che è
continua anziché discreta.
A questo proposito occorre notare che la distinzione tra sistemi filosofici
(darsana) e ambito devozionale è artificiosa, dal momento che tutte le
scuole del vedanta tranne (ma solo in parte) quella di Sankara sono
pienamente immerse nella dimensione devozionale.
La bhakti si configura come un rapporto di partecipazione amorosa (in
alcune scuole, apertamente o velatamente erotica) del singolo devoto (o in
alcuni casi della comunità dei fedeli) con una divinità dai tratti
marcatamente personali (non l'assoluto impersonale del vedānta sankariano).
I principi della dottrina devozionale si ritrovano nel Bhaktīsūtra (1000 e.v.)
attribuito a due personaggi mitici, cui corrispondono due diverse redazioni,
Sandilya e Nàrada.
Nella bhakti si può scorgere un percorso evolutivo, che, a partire dalla
devozione espressa nella Bhagavadgitā come uno stile di vita disciplinato in
grado di armonizzare in un percorso devozionale (bhaktimàrgà) diversi
percorsi di salvezza, principalmente quelli legati all'azione rituale, alla gnosi
salvifica e alle pratiche ascetiche (karmamàrga, jnànamàrga, yogamàrga),
giunge a configurarsi come un coinvolgimento emotivo profondo tra devoto e
divinità, in cui il devoto è disposto a sacrificarsi totalmente per amore di
Dio.
La relazione tra i due poli può assumere molte forme, identificate da un
paradigma mitico: schiavo-padrone (Hanumat-Ràma), amico-amico (ArjunaKrsna),
genitore-figlio
odiatore-odiato
(Yasodà-Krsna),
(Hiranyakasipu-Visnu).
amante-amato
Quest'ultimo
(Ràdhà-Krsna),
rappresenta
sicuramente l'esito estremo del percorso devozionale, realizzato attraverso
un odio così forte da meritare paradossalmente il favore della divinità,
compiaciuta di essere oggetto di una passione tanto intensa ed esclusiva
(dvesabhakti, devozione tramite l'odio).
Il tantrismo
17.ter Il tantrismo, che si nutre della personalizzazione della divinità e
dello spirito devozionale instaurati dalla bhakti, pur rivestendoli di nuovi
significati, è un fenomeno complesso, difficile da delimitare, dal momento
che riguarda anche il buddhismo e il jainismo e non si limita all'ambito
induistico, e investe non solo la religione ma anche la letteratura, la filosofia
(anzitutto del linguaggio), l'iconografia, la pratica devozionale e meditativa.
Dal punto di vista strettamente cultuale si può notare che il rito induistico,
l'atto di venerazione, pujā, è sostanzialmente un rito tantrico, che
sostituisce l'antico sacrificio vedico ormai completamente in decadenza o
totalmente interiorizzato e svuotato di significato dalle speculazioni
upanisadiche, che hanno reinventato il sacrificio vedico originario iyajna)
che consisteva in una pura e semplice oblazione nel fuoco, reinterpretandolo
come il sacrificio della propria ignoranza nella fiamma della conoscenza
purificatrice.
Ciò non impedisce che esistano ancora oggi sparuti gruppi nei quali il culto
sacrificale vedico viene praticato: in India il presente non sostituisce mai il
passato, ma si stratifica su di esso, senza obliterarlo del tutto mai.
La pūjā di origine tantrica, divenuta il rito principale dell'induismo, è un atto
di adorazione (templare o domestico) in cui la divinità è invitata a scendere
temporaneamente in una immagine cultuale o icona (murti) e viene riverita
come un ospite, ricevendo tutti quei sedici atti di omaggio (upacāra) che
l'ospite ottiene presentandosi nella casa di una persona dabbene: invito,
offerta di un seggio, saluto, acqua per la lavanda dei piedi impolverati, acqua
per risciacquare la bocca riarsa dalla polvere della strada, acqua da
sorseggiare, acqua mischiata con miele, lustrazione, vestizione, offerta di
profumo, di fiori, di incenso, di lampade, di cibo, prosternazione e congedo.
Il destino dell'uomo nell'universo induista
18. Di solito noi vediamo l'uomo come un «insieme» di corpo e di qualcos'altro (coscienza, anima), però non pochi esoteristi, occultisti e spiritisti e,
sul versante opposto, i materialisti la pensano diversamente.
Per gli indiani le cose sono più complesse. La Taittirìya-upanisad parla di cinque “involucri” (kosa: anche “tesori”) che, via via più sottili, nascondono il
principio autentico del nostro essere: sono fatti di cibo, di soffi vitali, di
pensiero, di coscienza e di beatitudine.
Altre concezioni molto diffuse, sviluppate soprattutto in ambiente yogico e
tantrico, distinguono - oltre allo spirito e al corpo materiale, il corpo sottile,
che, pur sempre appartenendo al mondo della natura, consta della parte
meno grossolana di questa ed è percorso da migliaia di arterie (nudi). Le più
importanti sono Ida a sinistra, Fingala a destra e Susumna al centro. Costituiscono una specie di spina dorsale non fisica: lungo la Susumna sono collocati vari cerchi (cakra) che partono dal perineo e simboleggiano stati di coscienza sempre più elevati, cui si può accedere in condizioni particolari.
L'esperienza quotidiana dell'uomo, secondo la Mandukya-upanisad, che sviluppa una breve analisi dei suoni che compongono, secondo la fonologia indiana, la sillaba sacra om, si svolge attraverso tre stati di coscienza: di veglia,
nel quale si riconosce il mondo materiale; di sogno, in cui si ha esperienza di
un mondo separato; di sonno profondo, che viene chiamato “di coscienza”
(pregna): infatti, in contrasto con quello che pensiamo comunemente, il sonno senza sogni viene ritenuto una condizione nella quale la coscienza è vigile,
come può provare per esempio il fatto che svegliandoci diciamo di non aver
sognato (dunque c'era un principio cosciente attivo, anche se privo di contatti con qualcosa di esterno da conoscere). La Mandakya parla poi di un
quarto stato per il quale le parole umane sono insufficienti, e che viene appunto chiamato il quarto: è la realtà infinita nonduale del brahman supremo.
Ma qui siamo evidentemente ben al di fuori della nostra esperienza quotidiana.
Il karman
19. Quando si muore, il corpo fisico si dissolve negli elementi di cui è
composto, mentre il corpo sottile trasmette al nascituro caratteristiche e
predisposizioni secondo il maturare del karman. Quella del karman è una
dottrina panindiana (solo i materialisti la respingono esplicitamente) ed è di
fondamentale importanza.
Originariamente karman significa azione, nel Veda l'atto rituale, poi anche i
suoi frutti, certi anche quando invisibili. Questo valore si mantiene anche in
seguito, ma diventa molto frequente l'uso di karman nel significato di «(legge di) retribuzione degli atti compiuti», come appare già dalla Brhad-aranyaka-upanisad, dove Yajnavalkya, insistendo sulla segretezza della dottrina
che sta per insegnare, in risposta alla domanda su dove sia l'uomo morto
dopo la dissoluzione del corpo, parla del karman, perché buoni si diventa per
azioni buone, cattivi per le cattive. È un discorso che sia pure con estrema
brevità presenta il karman come, forse, unica realtà sopravvivente, in ciò
probabilmente precedendo analoghe concezioni buddhistiche.
La dottrina del karman è strettamente connessa con l'altra, pure panindiana, del samsāra, il processo infinito del, divenire di tutta la realtà, la catena senza principio e, tranne casi speciali, senza fine delle rinascite e delle
rimorti. Il samsāra non è un meccanismo casuale, lo governa il karman. Secondo le esposizioni più mature della dottrina, le azioni sono sempre seme
che fruttifica, per lo più in altre vite. Ma in ciascuna di queste, almeno in
quelle in cui si è in grado di agire, si agirà, gettando altri semi di frutti fu turi: ecco perché il processo, a meno che non lo si tronchi liberandosi, è inesauribile.
20. Di solito si riconoscono tre fasi di sviluppo del karman: quello “cominciato” (prarabdha), che cioè, giunto a maturazione, sta già dando frutti nell'esistenza presente; quello “accumulato” (sameita), che, messo insieme nelle
vite passate, sta ancora maturando i suoi frutti; «quello in processo di accumulazione» (samcìyamana, anche àgamin, “che sta arrivando”), cioè che si semina nell'attuale esistenza e darà frutto in vite future. Il karman è di colori
diversi: nero per il malvagio; bianco per chi è virtuoso; bianco e nero quello
della gente comune, la cui attività è un misto di bene e male in varie grada-
zioni. Tutti questi tipi di karman danno frutti corrispondenti. Invece il karman dell'adepto dello yoga non è né bianco né nero, e non dà frutti. Si possono avere rinascite diversissime a seconda del karman che al momento della morte è più pronto per la piena maturazione e che, essendo più forte, dà
l'impronta dominante di predisposizioni, tendenze, tracce di memoria, che si
aggregano in vario modo e si manifestano al momento opportuno. Purtroppo,
non in tutti i tipi di esistenza si può accumulare merito spirituale come nella
vita umana, che quindi ha una posizione di assoluta centralità nel cammino
del perfezionamento interiore; ma vi si può giungere o tornare grazie allo
sviluppo di semi remoti.
Il karman, ci viene spesso detto, ha una forza insuperabile. Questa non è
necessariamente una concezione fatalistica, può portare alla rassegnazione
ma non preclude la speranza, anche se si può ammettere che, in connessione
con il sistema delle caste a cui fornisce una poderosa motivazione, non abbia
giocato a favore di un grande dinamismo nella società. In generale si può
dire che la dottrina del karman, risposta indiana al problema del determinismo e del libero arbitrio, pone un vincolo derivante dal passato per il presente, ma lascia una relativa libertà per il futuro.
Esistono alcune possibilità di alleviare o addirittura “inaridire” il karman. Ci
sono rituali di espiazione per chi si è macchiato di colpe, specie se gravi. Al cune dottrine riconoscono la possibilità di un trasferimento del merito, per
esempio da un maestro a un discepolo. In certo senso questo è il caso anche
dei riti per i defunti, " che, grazie ai vivi, ne migliorano le condizioni nell'aldilà. Nelle tradizioni dell'amor mistico Dio è superiore al karman, e può liberarne in tutto o in parte il devoto. Ma la spiritualità indiana riconosce soprattutto alle discipline ascetiche e gnostiche la capacità di annullare trionfalmente il karman, grazie alla liberazione spirituale (moksa, mukti), che ta-
lora si raggiunge soltanto alla morte (videhamukti, «liberazione senza
corpo»), altra volta invece ancora in vita (jivanmukti, «liberazione da vivente»): in quest'ultimo caso il corpo resta vivo finché permangono impulsi karmici, come la ruota del vasaio gira finché non si è esaurita la spinta.
I doveri specifici
21. Il dharma costituisce il quadro di riferimento al quale deve far capo
integralmente l'esistenza. Lo insegnano il Veda e la tradizione autorevole,
l'esempio dei buoni (e anche l'impulso verso una soddisfazione intima). Se ne
riconoscono diversi tipi, in vario gioco tra di loro.
Innanzi tutto, scendendo dal generale verso il più specifico, il dharma universale, che almeno in teoria vincola tutti gli induisti: è l'insieme di quelle
norme che costituiscono i valori etici non connessi con determinate condizioni sociali, anche se queste possono poi modificarne o ostacolarne l'attuazione.
Tra i tanti valori proposti in vari elenchi, alcuni hanno un particolare prestigio: l'autocontrollo, la purezza su tutti i piani, ma soprattutto la veridicità,
una virtù che continua antiche tradizioni indoiraniche, e che è rispetto della
fondamentale identità tra essere e verità, ma anche fedeltà alla parola
data: è così potente che il voto di verità («e ho sempre detto la verità, pos sa accadere che”...) ha una forza suprema di realizzazione.
L'altra somma virtù è la nonviolenza (ahimsa), intesa come estensione all'universale, o comunque al massimo grado di ampiezza possibile, del rispetto
per la vita, non soltanto per quella umana. È una concezione questa cui, però,
non sempre corrispose una pratica diffusa: anche la storia indiana, purtroppo, è in buona parte, come la nostra, storia di violenza anche efferata. In
terra indiana comunque, e non soltanto nell'induismo, ma anche nel buddhi-
smo e soprattutto nel jainismo, tale concezione ha avuto sviluppi che non
trovano paragone in nessun'altra parte del mondo, e che rappresentano anche dei concreti passi avanti nella direzione di un ecologismo fattivo (ospedali per animali, ecc.), di alto impegno morale. Bisogna però dire che spesso
l'ahimsa si riduce di fatto a una specie di vegetarianesimo, piuttosto che
trarre tutte le implicazioni pratiche di questo ideale.
Vi sono poi i dharma della condizione specifica, cioè le norme particolari relative a una determinata casta, a una professione, ecc. È evidente che il
brahmano non può avere gli stessi doveri di un guerriero, il commerciante
quelli di una prostituta...
Inoltre, cose vietate in una certa epoca, sono consentite in altre, o viceversa: così, per esempio, il dbarma della nostra età non può non discostarsi da
quello dell'età dell'oro, e nella sventura sono permessi comportamenti non
leciti nei tempi felici. In particolare assume grande importanza un combinato di doveri collegati alla condizione castale e alla fase di esistenza che si
sta conducendo: è il cosiddetto varnasramadharma. Questo dharma specifico può essere in contrasto anche forte con l'universale. Non è però un contrasto insanabile: anche se il dharma particolare deve prevalere, è opportuno che questo avvenga senza perdere di vista gli elementi del dharma universale che possono essere mantenuti vivi, almeno come aspirazione della
coscienza, progetto di vita futura, anche nella dedizione piena al proprio
dharma attuale.
Le fasi dell’esistenza ordinata – il sistema degli aśrama
22. Tradizionalmente, oltre che dall'appartenenza alla casta, la vita dell'uomo era regolata da un insieme di norme che scandivano i diversi periodi
dell'esistenza: il cosiddetto sistema degli aśrama. La parola ha un significa-
to originario di “sforzo”, e indica sia le fasi della vita intese come tappe
successive del perfezionamento spirituale, sia gli eremi nei quali si concludeva," secondo il modello ideale che si vedrà e anche almeno in vari casi nella
pratica effettiva, questo tipo di vita.
Le prime testimonianze, ma ancora slegate, di quelle che saranno poi le quattro tappe dell'esistenza ordinata, risalgono già al periodo vedico, in particolare alle Upanisad.
Solo in seguito la quadripartizione raggiunge la completa organicità. Le fasi
sono queste:
1) brahmacarīn,”colui che pratica il brahmani”, il ragazzo delle prime tre
classi, dopo aver ricevuto l'iniziazione, va a vivere con un maestro, dal quale
viene istruito per vari anni, in cambio lavorando per lui e vivendo nella più
assoluta obbedienza e castità: se il maestro è come un padre, anzi di più,
sua moglie di conseguenza è madre, le figlie sorelle, un rapporto sessuale
con una di queste sarebbe un incesto;
2) grhastha («che sta in casa»): è la condizione in cui si entra al termine
dello studentato, dopo un'abluzione rituale: varie volte però i brahmacarin
restavano tali a vita. Il grhastha, sposo e padre, è tenuto a dedicarsi alla
continuità della famiglia, ai riti domestici, al lavoro, a un onesto interesse e
anche, eventualmente, ai piaceri dell'esistenza in questo mondo;
3) vanaprastha («che sta nella foresta»): è la fase in cui si entra quando ormai sono nati i nipotini, che assicurano la continuità futura dei riti, e può
coinvolgere entrambi i coniugi;
4) sannyāsin (“che getta via”, cioè abbandona, rinuncia): è colui che, troncato ogni residuo e pur minimo vincolo sociale, sceglie di vivere senza dimora e
senza possesso, nutrendosi di elemosine.
Questo schema è stato variamente valutato, sembrando ad alcuni una specie
di diafano schermo ideologico per giustificare con motivazioni spirituali una
pratica di abbandono e quindi, di fatto, uccisione dei vecchi, affine - ma in
forme squisite - ad altre messe in atto in altri paesi, e analoga alla pratica
del rogo delle vedove, espressione di una tragica realtà di negazione di un
autonomo valore delle donne, però ammantata di valori spirituali altissimi; i
più, e certo tutti gli studiosi induisti impegnati, vi hanno invece visto una
specie di progressivo passaggio dall'esistenza comune a una sempre maggiore immedesimazione nell'infinito, oltre i vincoli e i limiti dell'individualità
fenomenica.
Questa chiave di lettura, pur senza escludere la possibilità di sfruttamenti
devianti del sistema degli asrama, ben si accorda anche con il correlato
schema dei tre grandi gruppi (trivargā) di finalità dell'esistenza normale: il
desiderio sessuale (Marna), l'interesse (arthā), l'etica (dharma), al di sopra
dei quali si eleva l'apavarga (“fuori dai varga”), la meta della perfezione spirituale infinita.
Uomo e donna
23. Una sentenza famosissima recita: “Quando è ragazza, dipenda dal padre; dal marito quando è giovane; dai figli alla morte del marito: la donna non
sia mai indipendente”.
Questo può dare un'idea complessiva non troppo distante dalla realtà della
condizione delle donne nell'India tradizionale, anche se ci sono state differenze non irrilevanti a seconda dei tempi, dei luoghi, delle condizioni sociali.
In effetti nel periodo più antico almeno alcune donne godevano di maggiore
libertà: le Upanisad ci parlano di Gargi, che poteva permettersi di dibattere
questioni filosofiche venendo ascoltata con grande attenzione, o di Mai-
treyi, che poneva domande appassionate al marito sulla condizione successiva alla morte, ecc.
E l'epica ci attesta la liceità della libera scelta del marito da parte di alcune
principesse. Gradualmente però anche questi spazi di libertà individuale via
via si restringono: le grandi eroine indiane sono famose soprattutto per la
loro dedizione al marito.
La moglie, viene autorevolmente detto, deve adorare e servire il marito
come un dio, fosse anche il peggiore degli uomini.
Nella concezione induista il diritto-dovere della donna di partecipare al
mondo delle relazioni con la realtà sacra le deriva dal vincolo coniugale: se
questo vincolo si spezza, per esempio con la morte del marito, per la donna è
una tragedia. Col tempo si diffuse sempre più la pratica del suicidio rituale
delle vedove che, spesso volontariamente, ma non certo sempre, si immolavano sul rogo del marito (sahamarand) o qualche tempo dopo (anumarana): il
nome satī (in grafia angloindiana sutteé), con cui questa pratica è conosciuta
comunemente, significa in realtà «buona» e designa la vedova che si è uccisa
in questo modo. Una tale usanza non è ignota ad altre popolazioni antiche:
spesso il capo veniva sepolto con un accompagnamento di accoliti, mogli, cavalli, appositamente uccisi perché lo potessero servire nell'aldilà. Il loro valore sociale stava nella subordinazione, nell'essere proprietà.
Il sacrificio della vedova indiana esalta questa pratica come culmine di una
condizione esistenziale che senza il suo necessario punto di riferimento sarebbe acefala. Ci possono essere stati spesso motivi di carattere economico
che favorivano, o determinavano, il suicidio delle vedove: erano le stesse ragioni antifemminili che spingevano anche all'infanticidio, per lo più perpetrato a danno delle neonate.
24. In genere la condizione femminile era vista come troppo costosa e in
definitiva dannosa per la famiglia, anche a causa dell'estendersi della pratica della dote matrimoniale che comportava spese pesantissime. Però il motivo fondamentale che ha favorito l'affermazione del suicidio delle vedove,
pur contrastato da personalità illuminate, e soprattutto la sua esaltazione
come rito vero e proprio, fino a fare della satī una specie di santa, sta soprattutto nella negazione del valore della donna in quanto tale, e non solo
per la sua posizione di moglie e di madre (nonostante proibizioni e minacce
di condanne, il fenomeno, sia pure in minor misura, non è ancora del tutto
estinto).
La donna ha dunque una sua dimensione sacra in quanto, con dedizione e sacrificio di sé, compagna del marito in questa vita o in un altro mondo, e in
questo senso viene esaltata e santificata. Altrimenti è spesso vista come
tentatrice, pericoloso ostacolo sulla via della moralità e del perfezionamento spirituale: donne per eccellenza, bellissime ed esperte in tutte le arti
della seduzione, si possono considerare le ninfe celesti (apsaras), in certi
casi utilizzate dagli dei per indurre alcuni asceti, il calore delle cui pratiche
rischierebbe di bruciare il mondo, ad abbandonare discipline così pericolose.
Ma è quasi l'unico caso di una seduzione utile; per lo più la donna, specialmente se giovane e bella, è sentita nella gnomica, in cui si condensa una sag gezza diffusa, come una specie di mina vagante, e, spesso con un sensualissimo sguardo indietro per dire addio, si esalta il valore della rinuncia al piacere che potrebbe dare.
25. Precisazioni: Innanzitutto va rilevato che escono da questa immagine
generale, che pure rimane valida, donne che hanno preso in mano il loro destino contro i condizionamenti sociali: è il caso, talora, delle donne che hanno deciso di farsi monache buddhiste, delle quali possediamo numerose poe-
sie, o di donne come la celebre poetessa Mira Bai, che, innamorata ardente
del dio Krsna, si sentiva veramente sposata con lui, rifiutando di farsi satī
alla morte del marito.
Bisogna anche aggiungere che una particolare sacralità della donna veniva
garantita su di un altro piano, cioè quello della prostituzione sacra, traman data fino ai nostri giorni dall'istituzione delle devadāsī, letteralmente “serve di dio”, donne dedicate per i più vari motivi (tradizione familiare, offerta
di un padre devoto, donazione di qualche potente, ecc.) al servizio di un tempio per attività di danza e di prostituzione: attività un tempo stimata, anche
se non da tutti, e poi entrata in crisi (ma forse ancora non del tutto scomparsa) per gli attacchi degli esponenti (missionari, riformatori indiani, ecc.)
di una moralità sessuale ben diversa, incurante delle radici arcaiche, di culto
della fecondità e simili, di queste pratiche, anticamente diffuse in varie
parti del mondo.
La condizione della donna, pur con una grande staticità di fondo, è stata poi
vista anche in modi molto diversi in certi casi particolari. Per esempio, la
donna non è solo negativamente tentatrice, è anche colei che, magari di bassa casta, ma spesso sentita vicina con una partecipazione affettuosa, riproduce nelle pratiche tantriche, sul piano umano consacrato, la prassi del rapporto dea-dio. È colei che si configura, proprio per questa sua capacità di
eccitazione, come l'evocatrice della potenza spirituale latente, il cui risveglio è indispensabile peri accedere ai livelli più alti della coscienza. E l'ac coppiamento uomo-donna è l'immagine più icastica di questa esperienza sublime di beatitudine e di acquisizione della conoscenza suprema.
26. Talora il sogno coltivato è quello del ritorno, al di là di ogni possibile
accoppiamento, all'unità indistinta di un originario ermafroditismo: forse
così vanno lette la figura del dio metà maschio e metà femmina (Ardhanàrìsvara), le tradizioni relative agli occasionali cambiamenti di sesso, ecc.
All'altro estremo troviamo la negazione del sesso mediante la castrazione,
che può avere anch'essa una dimensione sacra, com'è avvenuto a più riprese
in varie parti del mondo (si pensi ai sacerdoti della dea Cibele, ecc.). In India questa pratica è propria dei cosiddetti hijra, che offrono alla dea il sacrificio della loro virilità, e che, paradossalmente, sono visti come artefici
della feracità dei campi, portatori di piogge fecondatrici, quasi che il loro
seme scomparso sia in realtà deposto nel terreno perché possa dare frutti
più ricchi.
Il concetto di Hijra si distingue nettamente dal concetto occidentale di
transessuale.
Descritti il più delle volte come ermafroditi, in quanto inglobano entrambe
le caratteristiche femminili e maschili, gli Hijra non sono considerati né
uomini né donne, andando a ricoprire un ruolo ben preciso nella società di cui
fanno parte.
Ogni cerimonia che scandisce gli stadi della vita dell’individuo indiano, che si
tratti della nascita di un figlio maschio o della celebrazione di un
matrimonio, vede la presenza degli Hijra, intermediari della divinità capaci
di portare prosperità e fertilità.
Nella contemporaneità la costante e disordinata urbanizzazione dell’India,
insieme alla rapida occidentalizzazione, ha comportato una perdita di
importanza del loro ruolo sacro, inducendoli a vivere di prostituzione ed
elemosina. Tuttavia un grande passo avanti dal punto di vista legale e per il
miglioramento delle loro condizioni di vita è stato fatto nell’aprile 2014 con
il riconoscimento ufficiale del Terzo Sesso dell’India da parte della Corte
Suprema Indiana.
Creature misteriose, intermediarie del divino, dispensatrici di ricchezza e fertilità, a
differenza degli ermafroditi e di altri individui affetti da disfunzioni sessuali,
gli Hijra sono generalmente individui di sesso maschile che si sottopongono, spesso in età
adulta, a castrazione. Quest’ultima, detta Nirvana,è un vero e proprio rito iniziatico
nonché dovere religioso (dharma).
Viene effettuata da una levatrice (Daima) con le lame taglienti di un rasoio e senza alcun
tipo di anestetico. L’operazione viene effettuata tra le 3 e le 4 del mattino, in quanto
momento propizio di passaggio dalle tenebre alla luce del giorno. Segue dunque
l’iniziazione religiosa del neofita, introdotto dall’Hijra più anziano – o guru – con una puja
(offerta rituale) a Bahuchara Mata, la dea protettrice degli Hijra.
Le ore che seguono la castrazione sono le più critiche, perché l’emorragia provocata
dall’evirazione non viene in alcun modo arginata: si crede, infatti, che il sangue simboleggi
la mascolinità dell’uomo che abbandona il corpo. Al contrario, viene inserito un piccolo
bastoncino nell’uretra per evitare la sutura della ferita e soltanto l’applicazione di olio
caldo sulla lesione ne scongiura l’infezione.
Il nuovo nato, divenuto ufficialmente un Hijra consacrato a Bahuchara Mata, prenderà
un nome iniziatico femminile, sarà addestrato alla danza e al canto, e riceverà
insegnamenti religiosi dal proprio Guru (maestro nella tradizione indiana), essendo a tutti
gli effetti un discepolo, o chela, votato al celibato.