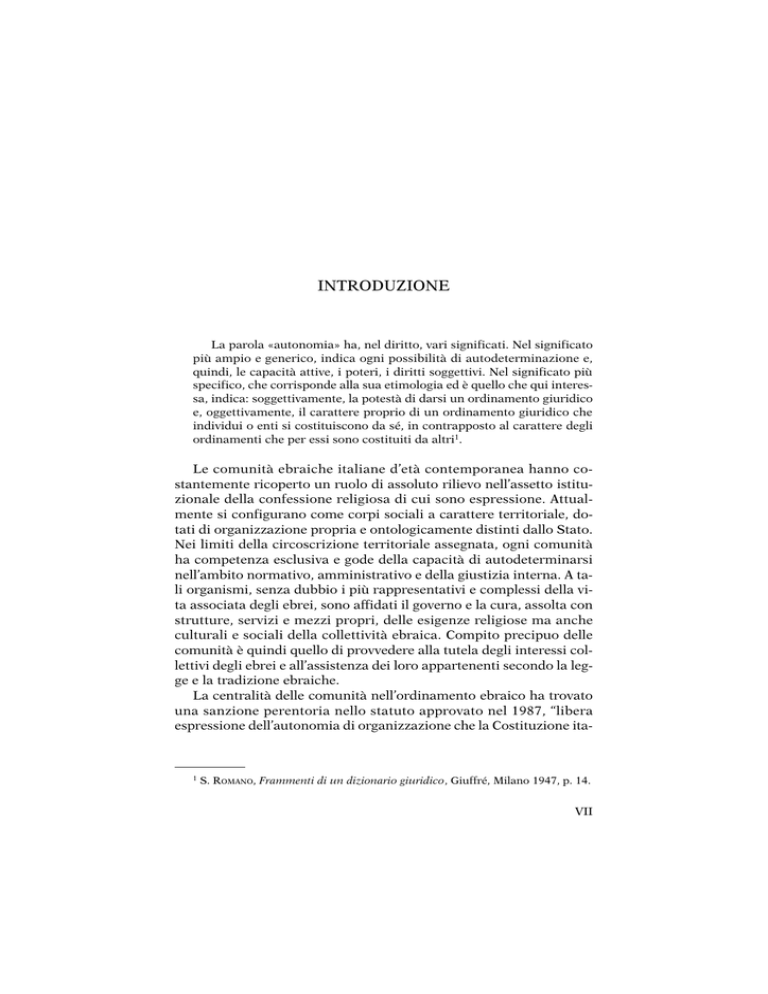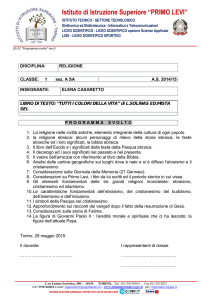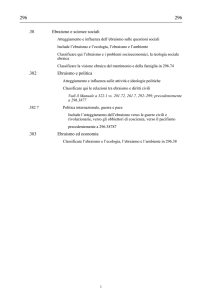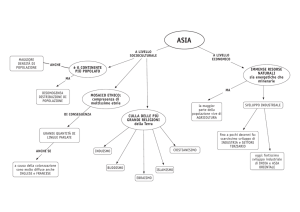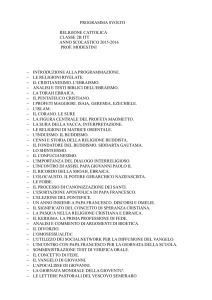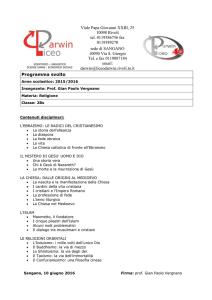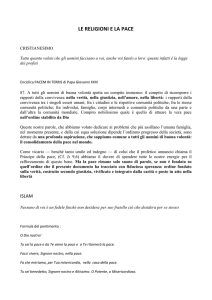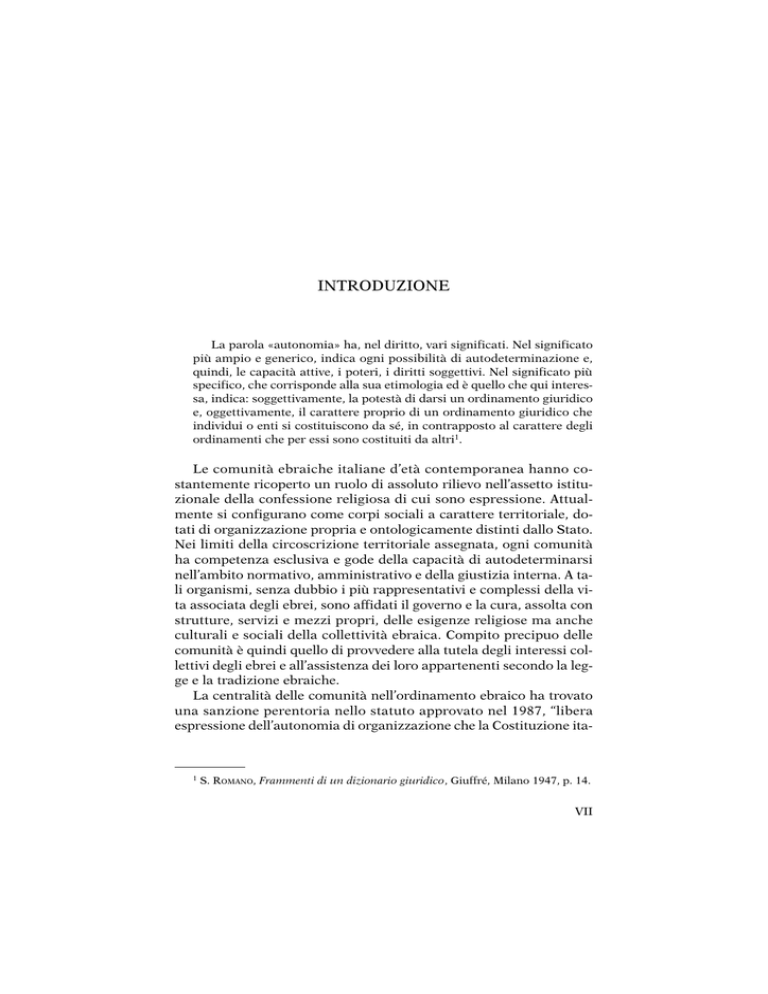
INTRODUZIONE
La parola «autonomia» ha, nel diritto, vari significati. Nel significato
più ampio e generico, indica ogni possibilità di autodeterminazione e,
quindi, le capacità attive, i poteri, i diritti soggettivi. Nel significato più
specifico, che corrisponde alla sua etimologia ed è quello che qui interessa, indica: soggettivamente, la potestà di darsi un ordinamento giuridico
e, oggettivamente, il carattere proprio di un ordinamento giuridico che
individui o enti si costituiscono da sé, in contrapposto al carattere degli
ordinamenti che per essi sono costituiti da altri1.
Le comunità ebraiche italiane d’età contemporanea hanno costantemente ricoperto un ruolo di assoluto rilievo nell’assetto istituzionale della confessione religiosa di cui sono espressione. Attualmente si configurano come corpi sociali a carattere territoriale, dotati di organizzazione propria e ontologicamente distinti dallo Stato.
Nei limiti della circoscrizione territoriale assegnata, ogni comunità
ha competenza esclusiva e gode della capacità di autodeterminarsi
nell’ambito normativo, amministrativo e della giustizia interna. A tali organismi, senza dubbio i più rappresentativi e complessi della vita associata degli ebrei, sono affidati il governo e la cura, assolta con
strutture, servizi e mezzi propri, delle esigenze religiose ma anche
culturali e sociali della collettività ebraica. Compito precipuo delle
comunità è quindi quello di provvedere alla tutela degli interessi collettivi degli ebrei e all’assistenza dei loro appartenenti secondo la legge e la tradizione ebraiche.
La centralità delle comunità nell’ordinamento ebraico ha trovato
una sanzione perentoria nello statuto approvato nel 1987, “libera
espressione dell’autonomia di organizzazione che la Costituzione ita-
1
S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffré, Milano 1947, p. 14.
VII
liana riconosce e garantisce alle Comunità ebraiche, formazioni sociali originarie, la cui esistenza plurimillenaria si basa sui principi
religiosi, etici e sociali dell’ebraismo”. E tuttavia, va ricordato, in precedenza la loro posizione di istituzioni basilari della minoranza non
era stata messa in discussione nemmeno dalla costituzione di enti
centrali di coordinamento e rappresentanza. Nel 1920 il Consorzio a
carattere volontario, nel 1930 l’Unione delle Comunità israelitiche
italiane corpo morale obbligatorio per legge, avevano conferito alle
molteplici realtà ebraiche presenti in Italia un inedito assetto unitario senza peraltro alterare il tradizionale ordinamento orizzontale,
non gerarchico, del gruppo religioso. Nel corso del Novecento l’ebraismo non si è costituito e consolidato a livello centrale come organismo monolitico, bensì come aggregazione di una pluralità di soggetti originari che hanno conservato intatte la reciproca indipendenza e
le rispettive facoltà di esercitare l’autogoverno all’interno e all’esterno del contesto sociale e giuridico della confessione. Anche sul versante delle relazioni con lo Stato, del resto, si può affermare che in
età contemporanea il rango istituzionale di primaria importanza delle comunità non sia stato messo in discussione neppure in occasione
della loro incorporazione nell’organizzazione statuale stabilita dal
R.D. n. 1731 del 1930 e, in attuazione dei principi costituzionali, esso sia andato incontro, ancor prima della presa d’atto contenuta nell’intesa del 1987, a una serie di importanti riconoscimenti in sede
giurisdizionale.
Se le comunità costituiscono la struttura portante della confessione e ne contraddistinguono il profilo in modo affatto peculiare
nel panorama religioso nazionale, è lecito ritenere – e l’assunto è tra
i motivi di fondo del presente studio – che l’autonomia dell’ebraismo italiano, tanto nella sfera interna quanto in rapporto all’ordinamento statuale, si identifichi tout court in quella delle sue istituzioni tradizionali. Naturalmente, la distinzione analitica degli ambiti
in cui si manifesta non deve far velo al dato di fatto che, nel tempo,
la fisionomia e il grado di autonomia delle comunità sono andati variando in funzione di processi complessi, frutto dell’inevitabile intersecarsi di istanze soggettive – le volontà degli ebrei – e di condizionamenti esterni – l’ordinamento dello Stato e la disciplina dei
suoi rapporti con la minoranza. Col presente studio si è inteso, per
l’appunto, illustrare anche in chiave storico-istituzionale come l’intreccio dei due piani abbia determinato, fatte salve talune costanti, i
VIII
diversi assetti dell’autonomia comunitaria. E in questo senso, alla
luce dei caratteri specifici del caso ebraico che si sono subito palesati, è parso opportuno non circoscrivere la ricostruzione dei processi di formazione delle relative norme alle fasi immediatamente
antecedenti la loro approvazione; ed estenderla invece ai densi dibattiti in seno alla minoranza – eloquenti di una realtà tutt’altro che
indifferenziata al suo interno e di volontà per nulla univoche –, alle
conseguenti scelte operate dal gruppo e alle altrettanto impegnative
interlocuzioni dei suoi organi dirigenti nazionali con autorità e istituzioni centrali e locali dello Stato, che nell’insieme, come si vedrà,
hanno alimentato più o meno lunghe ma sempre intense stagioni di
transizione verso l’assestamento e l’attuazione dei nuovi assetti ordinamentali.
A conforto e precisazione di tale impostazione è venuto il riscontro di autorevoli formulazioni di teoria generale del diritto. Il presupposto teorico e l’opzione metodologica preferenziale dell’indagine si sono così individuati nella duplice definizione del concetto giuridico di autonomia che, a partire dalla lezione romaniana richiamata in epigrafe, la dottrina si è incaricata di enucleare come capacità di
individui ed enti di autodeterminarsi e come relazione tra soggetti e tra
ordinamenti. Si è quindi anzitutto tenuto conto che per la dogmatica
giuridica i suddetti fattori, soggettivo e oggettivo, sono obbligatori e
inscindibili, come a dire i due volti inseparabili dell’autonomia, il cui
valore emerge compiutamente solo se viene delineata, oltre che in se
stessa, nei confronti di chi o di cosa essa sia tale. Ulteriori specificazioni dottrinali hanno suggerito che, nell’esperienza storica contemporanea, il termine di autonomia si riferisce principalmente, se non
in maniera esclusiva, a relazioni che dati organismi hanno nei confronti dello Stato inteso quale soggetto di diritto, e a quelle che, di
conserva, vengono a instaurarsi tra i rispettivi ordinamenti; e ancora
come, in base alle argomentazioni che precedono, si ravvisi l’esistenza non di un unico modello, ma di tante forme di autonomia quante
sono le innumerevoli fattispecie ipotizzabili di relazioni tra ordinamenti. Dal che si è infine dedotto che la stessa dottrina arriva implicitamente a rinunciare, perché di fatto impraticabile, a un’esaustiva
classificazione del fenomeno, affidando alla ricerca empirica l’onere
di esplorare e interpretare caso per caso, nella loro estrema varietà,
le configurazioni effettivamente rivestite dall’autonomia nella realtà
giuridica.
IX
Sulla scorta di tali premesse, l’analisi del caso ebraico ha evidenziato in primo luogo come le tappe salienti della definizione dell’autonomia interna siano riconducibili a una persistente urgenza, alla
necessità di adeguare la struttura organizzativa della compagine alle sollecitazioni di due distinti processi storici: per un verso, a quelle prodotte dai profondi mutamenti indotti nell’ebraismo dalle trasformazioni della società, anzitutto alla crisi delle comunità che già
sul finire dell’Ottocento, in seguito all’intensificarsi delle dinamiche
assimilazioniste e alla maggiore mobilità degli ebrei sul territorio
nazionale, conobbero gli effetti destabilizzanti della loro relativa disaffezione alle pratiche religiose e del conseguente appannamento
dell’identità collettiva ebraica; per un altro, a quelle determinate dai
grandi cambiamenti politico-istituzionali che hanno interessato
l’Italia nel corso del Novecento, prima con la transizione dal sistema
eterogeneo d’età liberale, in larga parte eredità del periodo preunitario, a un’impostazione univocamente pubblicistica nel periodo fascista, poi con l’assunzione di una struttura organizzativa aderente alla
Costituzione repubblicana. Peraltro, si avrà modo di rilevare come il
processo giuridico in questione non fu affatto il riflesso immediato,
automatico di contesti ed evoluzioni generali, e si svolse invece anche secondo scansioni temporali, modalità e motivi specifici: in particolare, le coordinate del modello organizzativo che si affermò sotto il regime fascista, già in parte individuate in età giolittiana, vennero messe a punto in ambito ebraico; in età repubblicana, riserve e
resistenze interne alla minoranza hanno a lungo precluso l’aggiornamento dell’ordinamento confessionale ai principi costituzionali.
Anche sotto il profilo dell’adeguamento ai regimi istituzionali vigenti, in sostanza, la rimodulazione della struttura organizzativa
dell’ebraismo fu condizionata in modo considerevole dalle dinamiche interne alla confessione, dall’incessante tensione dialettica tra
spinte innovative e tendenze conservatrici, che rese inevitabilmente
più complesso e gravoso il compito dei suoi dirigenti di mediare tra
le ragioni della stabilità e quelle dell’autonomia delle comunità, in
altri termini di preservare la loro esistenza senza alterarne più di
tanto il carattere e le prerogative tradizionali. Non a caso, questioni
cruciali come la debolezza strutturale e finanziaria delle comunità
minori, alcune delle quali a rischio d’estinzione, e la frammentazione dell’ebraismo in tante realtà locali in scarso o nullo collegamento
tra loro, attesero decenni prima di trovare soluzioni largamente conX
divise. Componenti non secondarie dell’ebraismo resistettero a lungo sia ai progetti di uniformazione degli ordinamenti interni, sia
all’ipotesi di costituzione di un ente centrale di coordinamento e rappresentanza, nel timore che potesse derivarne, invece di un rafforzamento delle strutture delle comunità, una grave lesione del loro potere di autodeterminazione. Occorsero così i primi vent’anni del secolo per venire a capo di un organismo consortile in grado di svolgere un’azione unitaria in campo nazionale a tutela degli interessi religiosi e di rafforzamento delle istituzioni della minoranza, e almeno
altri dieci per riconoscergli un’effettiva preminenza e giungere a
un’omologazione normativa, a una “struttura conforme a tutte le comunità israelitiche italiane”. Fu infatti solo negli anni della riorganizzazione fascista dello Stato che in seno alla compagine maturò il
convincimento dell’attuabilità, anzi dell’improcrastinabilità di una
riforma organica dell’assetto giuridico delle comunità, imposto ormai non solo da ragioni interne – non ultima la necessità di una perequazione di diritti e doveri individuali degli ebrei italiani –, ma anche dalla tendenza in atto a ricondurre i corpi sociali alla sfera pubblica. L’accelerazione del processo prese le mosse dall’opinione diffusa, e solo in apparenza paradossale, che la costruzione del regime
costituisse all’un tempo un fattore di rischio e un’opportunità per
l’ebraismo italiano. Al timore che un’iniziativa unilaterale in chiave
accentratrice del regime potesse, prima o poi, avviare una fase di pesanti ingerenze dello Stato, sino a sopprimere gli spazi di autonomia
e libertà delle istituzioni ebraiche, si affiancò ben presto l’auspicio
che proprio il modello istituzionale corporativo che il fascismo stava
attuando potesse favorire la riforma in chiave pubblicistica dell’ordinamento delle comunità, da tempo considerata l’unica davvero in
grado di assicurare loro solidità e continuità. Di qui l’iniziativa del
Consorzio che, auspice Mario Falco, rimise al vaglio del governo uno
schema di disegno di legge nel quale tutte le comunità erano riconosciute quali corpi morali necessari a carattere territoriale – vi avrebbero quindi appartenuto obbligatoriamente tutti i membri della confessione residenti nelle rispettive circoscrizioni (appartenenza di diritto) – e dotate di poteri d’impero e privilegi fiscali in materia di riscossione.
Il regio decreto del ’30 ricalcò pressoché integralmente lo schema elaborato dal Falco, cosicché i correttivi apportati all’organizzazione delle comunità – la stessa rinuncia all’autonomia statutaria, la
XI
soppressione delle assemblee, l’indebolimento dei poteri dei consigli di comunità e il corrispondente rafforzamento degli organi esecutivi – vanno opportunamente ascritti non a una volontà vessatoria del regime verso la minoranza, ma a istanze di verticalizzazione
maturate all’interno del mondo ebraico all’insegna di una maggiore
efficienza gestionale. Del resto, pur trasformando tutte le comunità
in corporazioni di diritto pubblico assimilate agli enti autarchici, il
provvedimento non sancì una totale revoca della loro autonomia.
Esse mantennero infatti un discreto livello di autodeterminazione
sul piano amministrativo, fiscale e anche, nella misura che si accerterà, giurisdizionale e normativo. Un margine ulteriore di autogoverno, tutt’altro che residuale sebbene in genere sottovalutato in
dottrina, venne loro assicurato dal mantenimento di prerogative
che gli altri enti pubblici territoriali avevano già perduto a seguito
della riforma dell’ordinamento comunale e provinciale attuata tra il
’26 e il ’28. Le comunità rimasero in età fascista le uniche corporazioni di natura giuridica pubblica regolate da organismi decisionali di tipo collegiale democraticamente eletti – per di più da un elettorato anche femminile – e pertanto al riparo dall’eventuale nomina governativa di dirigenti di estrazione non ebraica, che per giunta si prescriveva venisse “possibilmente” evitata pure in caso di
commissariamento governativo. Nemmeno la costituzione del nuovo ente centrale di rappresentanza come “unione obbligatoria”,
dunque, violò le consolidate “tradizioni italiane” di autogoverno
delle comunità israelitiche che – si legge nella relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo, anch’essa redatta dal Falco –
suggerivano di non “imitare l’ordinamento dei paesi a tipo francese,
secondo cui tutti gli ebrei dello Stato costituiscono una corporazione unica della quale le comunità locali sono membri con limitata
autonomia”. L’Unione delle Comunità israelitiche italiane, investita
di compiti di vigilanza sull’adempimento delle finalità perseguite
dalle comunità, nasceva sì quale ente obbligatorio e preminente, ma
pur sempre espressione di un sistema di democrazia interna che
culminava nella celebrazione di un congresso nazionale con l’elezione diretta del consiglio e indiretta del presidente e della giunta.
Né a tale area di rispetto dell’autonomia delle comunità si deve ritenere recasse pregiudizio il pur complesso regime di controlli cui esse erano sottoposte, che traeva la sua specialità non da un particolare intento intrusivo dello Stato, ma dalla duplice natura degli orXII
ganismi comunitari – corporazioni equiparate agli enti pubblici e
istituti di un culto ammesso –, e dunque dalla contestuale subordinazione alle disposizioni previste dai RR.DD. n. 289/1930 e n.
1561/1931, di attuazione rispettivamente della legge n. 1159/1929 e
del R.D. n. 1731/1930.
In definitiva, ricondotte quali enti pubblici al disegno corporativo dello Stato, le comunità ebraiche rinunciavano ipso facto all’autonomia statutaria, ma tale perdita veniva compensata, per quanto
possibile nelle condizioni date e nella nuova cornice istituzionale,
sia con una riserva di autonomia amministrativa prossima a quella
garantita a comuni e province in età prefascista, sia con il contenimento entro l’ambito confessionale dei poteri di controllo sulle funzioni più strettamente inerenti i loro scopi istituzionali e la sfera religiosa, sia, ancora, con l’attribuzione all’ente di rappresentanza
dell’accertamento dei presupposti della loro costituzione, cessazione o riorganizzazione. Insieme all’appartenenza di diritto, che col favore dello Stato sancì la prevalenza dei diritti del gruppo su quelli
del singolo, della libertà confessionale sulla libertà religiosa, ci paiono questi i requisiti essenziali dell’operazione che, unico esempio di
legislazione concordata in quegli anni con un culto acattolico, non
a caso è stata in seguito definita un’intesa ante litteram, ma che in
questa sede si è preferito riconoscere quale espressione di giurisdizionalismo consensuale: formula forse più idonea a restituire il tenore e la portata generali di una legge che – a differenza di quanto
ha ritenuto una parte della dottrina – non fu imposta dal fascismo,
né tanto meno può considerarsi un antecedente ideologico e giuridico delle leggi razziali. Invocato dalla dirigenza ebraica con un larghissimo consenso della base, il regio decreto venne, per così dire,
concesso dal regime fascista per il suo interesse generale a regolare
e controllare il fenomeno religioso secondo l’orientamento corporativo e nell’ambito delle scelte di politica ecclesiastica operate in
quegli anni, a partire dalla legge sui culti ammessi, per bilanciare
l’opzione confessionista dello Stato rappresentata dai Patti lateranensi.
La legge Falco, com’è noto, ebbe lunga vita. Percepita e rappresentata, al momento della sua emanazione, come l’espressione della
piena adesione del corpo dell’ebraismo alla nazione fascista, sopravvissuta alla legislazione razziale, passò indenne anche le fasi della defascistizzazione e della Costituente, restando in vigore sino al 1989,
XIII
anno di emanazione della legge attuativa dell’intesa stipulata con lo
Stato nel 1987. Dal punto di vista ebraico, le ragioni di tale longevità
a dispetto dell’impronta fascista si spiegano dapprima con la necessità di soprassedere a qualsiasi ipotesi e istanza di modifica o revoca
del provvedimento per favorire una tempestiva ripresa della vita comunitaria, indispensabile alla riaggregazione del gruppo confessionale travolto dalla tragedia della persecuzione nazifascista; in seguito, sino ai primi anni ’60, con la convinzione della dirigenza che la
legge del 1930, di cui si volle rivendicare la matrice ebraica, continuasse a corrispondere appieno alle esigenze di stabilità e sicurezza
delle comunità; infine, con il vano tentativo, a lungo perseguito da alcune componenti dell’ebraismo, di superarla con un assetto istituzionale che consentisse il recupero della piena autonomia statutaria,
senza tuttavia comportare la rinuncia alle principali prerogative connesse alla natura pubblicistica.
L’impulso al definitivo superamento dell’edificio normativo in vigore dal ’30 venne da fattori esterni al mondo ebraico, a lungo attraversato da profonde divergenze sull’indirizzo della riforma. L’avvio
del processo di revisione dei Patti lateranensi nei primi anni ’70, la
dichiarata disponibilità dello Stato ad aprire contestualmente trattative in vista della stipulazione di intese con le confessioni diverse dalla cattolica, ma soprattutto il primo pronunciamento della Corte costituzionale sull’incostituzionalità dell’art. 4 (sent. n. 239/1984), per
un verso sollecitarono, per un altro costrinsero la minoranza ebraica
a uscire dalla lunga empasse e ad abbandonare definitivamente l’impostazione giurisdizionalista per conformare il proprio assetto al
modello pattizio previsto dalla Costituzione.
Anche sulla fase cruciale dei negoziati con lo Stato (1985-1987)
pesò la sorte delle prerogative che la minoranza avrebbe voluto mettere al riparo dalla perdita della natura pubblicistica delle comunità,
inserendole nel testo dell’intesa ex art. 8, comma 3 Cost. quali norme
cogenti dotate di rilevanza civile. Ma pure quest’estremo tentativo di
coniugare privilegi pubblici e autonomia confessionale risultò vano,
di fronte all’orientamento della commissione governativa, incline a
riconoscere in esso una forma latente di giurisdizionalismo, incompatibile coi principi di laicità e con quell’indipendenza che lo Stato
democratico intendeva per suo conto recuperare e riconoscere alla
confessione ebraica.
Stipulata all’insegna di un’effettiva separazione dei due ordini e
XIV
nello stesso tempo di una tutela concreta dell’identità e della libertà
della minoranza, l’intesa del 1987 riconobbe alle comunità ebraiche
la natura di formazioni sociali originarie e all’Unione quella di ente
associativo a base non più obbligatoria. Nel pieno rispetto della loro
autonomia, la Repubblica italiana si limitava a prendere atto delle attività e delle finalità perseguite dalle comunità e debitamente stabilite nello statuto che, espressione di un inedito ‘patto sociale’ vincolante per individui e comunità, in cui tutto l’ebraismo italiano si riconosce assumendolo come sua carta fondamentale, venne approvato insieme all’intesa dal congresso straordinario del 1987 e contestualmente a essa acquistò rilevanza civile nel 1989 (legge n. 101/1989). A
garanzia della piena autonomia istituzionale della confessione, gli
ambiti del disciplinamento delle comunità e della regolazione dei
rapporti con lo Stato – compendiati in quel complesso normativo
ambivalente che era stata la legge del ’30 – risultavano ora nettamente separati, affidati l’uno allo statuto organizzativo di competenza esclusiva del gruppo religioso, l’altro all’intesa, strumento costituzionale di concertazione tra lo Stato e le confessioni acattoliche.
Spettò dunque allo statuto dare forma compiuta al recupero della capacità di autodeterminazione dell’ebraismo, regolando tutti i
settori della vita comunitaria, finalmente restituita all’antica autonomia, a partire dai rapporti con i singoli ebrei cui, in ottemperanza al principio costituzionale di libertà religiosa, è riconosciuta la
facoltà di perfezionare autonomamente l’appartenenza agli enti comunitari mediante l’atto d’iscrizione volontaria. Ribadita la loro
centralità, il testo di autoregolamentazione disciplina dettagliatamente struttura e finalità delle comunità, definendo la composizione interna e i criteri di elezione degli organi consultivi ed esecutivi,
la gestione amministrativa e contabile, la formazione e il funzionamento degli organi preposti alla risoluzione delle controversie interne. Ne risulta un modello di autonomia istituzionale articolata sui
tre livelli normativo, amministrativo e della giustizia interna, in cui
tradizionalmente la minoranza ha esercitato il governo delle proprie
istituzioni.
Con l’entrata in vigore dell’intesa e dello statuto, l’assetto giuridico dell’ebraismo italiano, negli aspetti organizzativi interni come sul
versante della regolamentazione dei rapporti con lo Stato, adeguandosi al dettato costituzionale definiva il nuovo equilibrio tra le ragioni dell’autonomia e quelle della stabilità delle istituzioni tradizionali
XV
di una minoranza storicamente esigua. In passato, la modesta consistenza numerica dell’ebraismo italiano e gli incombenti rischi di
scompaginamento, a motivo prima del processo di assimilazione, poi
della persecuzione razziale, avevano orientato i suoi gruppi dirigenti
ad affidare di preferenza al rafforzamento e al consolidamento istituzionale il compito di preservare la tradizione ebraica. Ciò li aveva
indotti dapprima a rinunciare all’autonomia statutaria, poi a rimandarne il recupero, complice peraltro la mancata attuazione per quasi
quarant’anni dell’art. 8, comma 3 Cost. Dopo un lungo e complesso
dibattito interno alle comunità e all’Unione, determinanti per il pieno recupero dell’autonomia sono risultate, come si è detto, la riaffermazione in sede giurisdizionale e l’applicazione in sede legislativa
dei principi costituzionali. E tuttavia non v’è dubbio che, al culmine
di quel processo, sia stata la felice convergenza tra una volontà ormai
matura al suo interno e l’azione dello Stato, a dischiudere all’ebraismo la prospettiva di una radicale riforma della propria condizione
giuridica, ma anche di un profondo ripensamento della propria presenza nella società italiana.
XVI