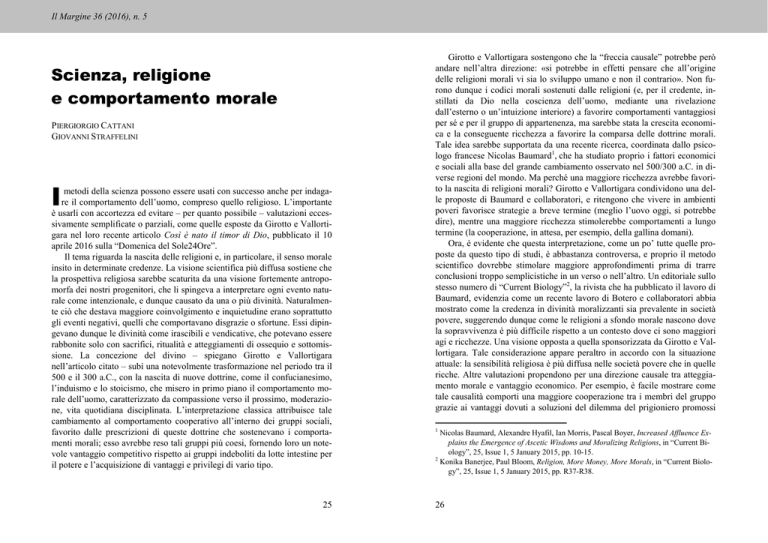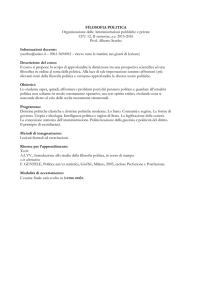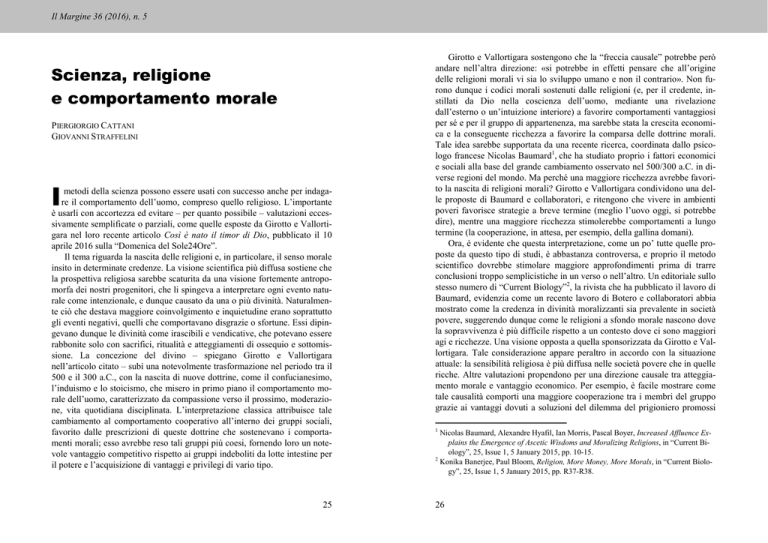
Il Margine 36 (2016), n. 5
Scienza, religione
e comportamento morale
PIERGIORGIO CATTANI
GIOVANNI STRAFFELINI
I
metodi della scienza possono essere usati con successo anche per indagare il comportamento dell’uomo, compreso quello religioso. L’importante
è usarli con accortezza ed evitare – per quanto possibile – valutazioni eccessivamente semplificate o parziali, come quelle esposte da Girotto e Vallortigara nel loro recente articolo Così è nato il timor di Dio, pubblicato il 10
aprile 2016 sulla “Domenica del Sole24Ore”.
Il tema riguarda la nascita delle religioni e, in particolare, il senso morale
insito in determinate credenze. La visione scientifica più diffusa sostiene che
la prospettiva religiosa sarebbe scaturita da una visione fortemente antropomorfa dei nostri progenitori, che li spingeva a interpretare ogni evento naturale come intenzionale, e dunque causato da una o più divinità. Naturalmente ciò che destava maggiore coinvolgimento e inquietudine erano soprattutto
gli eventi negativi, quelli che comportavano disgrazie o sfortune. Essi dipingevano dunque le divinità come irascibili e vendicative, che potevano essere
rabbonite solo con sacrifici, ritualità e atteggiamenti di ossequio e sottomissione. La concezione del divino – spiegano Girotto e Vallortigara
nell’articolo citato – subì una notevolmente trasformazione nel periodo tra il
500 e il 300 a.C., con la nascita di nuove dottrine, come il confucianesimo,
l’induismo e lo stoicismo, che misero in primo piano il comportamento morale dell’uomo, caratterizzato da compassione verso il prossimo, moderazione, vita quotidiana disciplinata. L’interpretazione classica attribuisce tale
cambiamento al comportamento cooperativo all’interno dei gruppi sociali,
favorito dalle prescrizioni di queste dottrine che sostenevano i comportamenti morali; esso avrebbe reso tali gruppi più coesi, fornendo loro un notevole vantaggio competitivo rispetto ai gruppi indeboliti da lotte intestine per
il potere e l’acquisizione di vantaggi e privilegi di vario tipo.
25
Girotto e Vallortigara sostengono che la “freccia causale” potrebbe però
andare nell’altra direzione: «si potrebbe in effetti pensare che all’origine
delle religioni morali vi sia lo sviluppo umano e non il contrario». Non furono dunque i codici morali sostenuti dalle religioni (e, per il credente, instillati da Dio nella coscienza dell’uomo, mediante una rivelazione
dall’esterno o un’intuizione interiore) a favorire comportamenti vantaggiosi
per sé e per il gruppo di appartenenza, ma sarebbe stata la crescita economica e la conseguente ricchezza a favorire la comparsa delle dottrine morali.
Tale idea sarebbe supportata da una recente ricerca, coordinata dallo psicologo francese Nicolas Baumard1, che ha studiato proprio i fattori economici
e sociali alla base del grande cambiamento osservato nel 500/300 a.C. in diverse regioni del mondo. Ma perché una maggiore ricchezza avrebbe favorito la nascita di religioni morali? Girotto e Vallortigara condividono una delle proposte di Baumard e collaboratori, e ritengono che vivere in ambienti
poveri favorisce strategie a breve termine (meglio l’uovo oggi, si potrebbe
dire), mentre una maggiore ricchezza stimolerebbe comportamenti a lungo
termine (la cooperazione, in attesa, per esempio, della gallina domani).
Ora, è evidente che questa interpretazione, come un po’ tutte quelle proposte da questo tipo di studi, è abbastanza controversa, e proprio il metodo
scientifico dovrebbe stimolare maggiore approfondimenti prima di trarre
conclusioni troppo semplicistiche in un verso o nell’altro. Un editoriale sullo
stesso numero di “Current Biology”2, la rivista che ha pubblicato il lavoro di
Baumard, evidenzia come un recente lavoro di Botero e collaboratori abbia
mostrato come la credenza in divinità moralizzanti sia prevalente in società
povere, suggerendo dunque come le religioni a sfondo morale nascono dove
la sopravvivenza è più difficile rispetto a un contesto dove ci sono maggiori
agi e ricchezze. Una visione opposta a quella sponsorizzata da Girotto e Vallortigara. Tale considerazione appare peraltro in accordo con la situazione
attuale: la sensibilità religiosa è più diffusa nelle società povere che in quelle
ricche. Altre valutazioni propendono per una direzione causale tra atteggiamento morale e vantaggio economico. Per esempio, è facile mostrare come
tale causalità comporti una maggiore cooperazione tra i membri del gruppo
grazie ai vantaggi dovuti a soluzioni del dilemma del prigioniero promossi
1
Nicolas Baumard, Alexandre Hyafil, Ian Morris, Pascal Boyer, Increased Affluence Explains the Emergence of Ascetic Wisdoms and Moralizing Religions, in “Current Biology”, 25, Issue 1, 5 January 2015, pp. 10-15.
2
Konika Banerjee, Paul Bloom, Religion, More Money, More Morals, in “Current Biology”, 25, Issue 1, 5 January 2015, pp. R37-R38.
26
Il Margine 36 (2016), n. 5
dalla visione religiosa e morale (in tale contesto si parla anche di “etica efficiente”).
Per il credente, naturalmente, tutte queste osservazioni sono interessanti,
ma non decisive per quanto riguarda la sua fede. Nulla impedisce, infatti, di
vedere nei meccanismi dell’evoluzione per selezione naturale – comunque si
siano dispiegati nel tempo – il modo tramite il quale Dio ha indirizzato il
suo Logos creativo. E nulla vieta di pensare – anzi! – che l’evoluzione culturale dell’uomo abbia aiutato, e aiuti ancora, a perfezionare la comprensione
di Dio (prima vendicativo, poi amorevole). Quello che desta maggiori perplessità è però l’approccio generale di questi studi e che pure i due studiosi
sembrano avere nei confronti delle religioni, in particolare
dell’atteggiamento dei credenti. È abbastanza limitativo pensare – per esempio – che una persona di fede si comporti in un determinato modo semplicemente perché ha timore che Dio le infligga una punizione ora o nell’aldilà,
oppure per ottenere un premio. Sottesa a questa impostazione sta un sottile
pregiudizio verso i credenti, giudicati alla stregua di bambini, a fronte degli
“adulti” scienziati. Ciò non fa bene al dibattito intellettuale.
27
Il logico dal volto umano
ALBERTO GAZZOLA
I
l 13 marzo scorso si è spento all’età di quasi novant’anni Hilary Putnam,
il grande patriarca della filosofia americana e mondiale (nel 2013 aveva
ricevuto il Rolf Schock Prize, l’equivalente del Nobel per la filosofia).
Poco noto (purtroppo) al grande pubblico, era considerato uno dei maggiori filosofi viventi, una figura monumentale della filosofia a ragione della
vastità impressionante di interessi e contributi, oltre che per il ruolo ecumenico di grande “ricucitore” delle fratture che affliggono il pensiero contemporaneo (all’interno della filosofia, tra scienze e umanesimo, tra cultura e
società). Fornì contributi rilevanti in filosofia della logica, della matematica
e della fisica (e in filosofia della scienza generale) ed elaborò celebri tesi in
filosofia del linguaggio e della mente. Ma si occupò anche di etica e filosofia morale, di filosofia della politica, di ontologia, metafisica, filosofia della
religione. Un pensatore a tuttotondo, che non amava etichette e limitazioni
di campo.
Di formazione analitica (la filosofia dominante nel mondo angloamericano), era stato in gioventù un valente matematico (contribuendo alla
risoluzione di uno dei celebri problemi di Hilbert), oltre che tra i pionieri
delle allora nascenti scienze cognitive. Il padre era un famoso traduttore e
Putnam passò l’infanzia in Francia, assorbendo precocemente una grande
attenzione per la letteratura e il linguaggio (laureandosi in germanistica, matematica e filosofia – tra parentesi, perché in Italia, a differenza degli altri
paesi, non vengono permessi questi percorsi universitari ibridi tra scienze e
humanities?), tema che poi avrebbe sviluppato in senso filosofico. Poliglotta, oltre all’inglese parlava correntemente francese e tedesco (e leggeva diverse altre lingue e le relative letterature, in particolare il romanzo russo di
Tolstoj e Dostoevskij). La madre era di origine ebraiche, ma la famiglia era
di estrazione complessivamente laica, impegnata politicamente negli ambienti della sinistra americana. Egli stesso in gioventù militò negli ambienti
politici radicali, ma se ne staccò ben presto.
La fama filosofica, dopo il dottorato con il neopositivista Reichenbach
(dissertazione in filosofia della fisica), lo raggiunse negli anni Sessanta, grazie a una brillante e creativa serie di lavori in filosofia del linguaggio (sviluppando una concezione causale del riferimento) e in filosofia della mente.
28