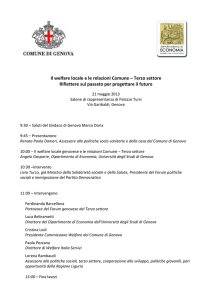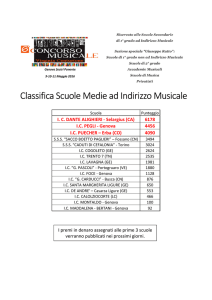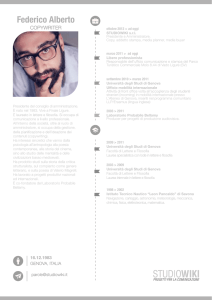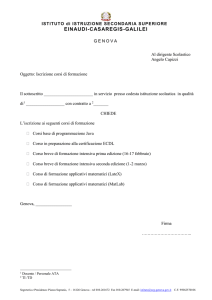Genova
e la canzone d’autore
a cura di Enrico de Angelis
Copertina: grafica a cura di
GGallery Publishing
Si ringraziano per l’amichevole
collaborazione:
Jacopo Aloisi, Simonetta Cerrini,
Marta Delfino, Guido Festinese,
Nini Giacomelli, François Gribi,
Luigi Manconi, Ugo Mannerini,
Massimo Micalizzi, Michele Neri,
Floriana Panseri, Claudia Pastorino,
Sergio Secondiano Sacchi, Franco
Settimo, Lea Tommasi.
Genova e la canzone d’autore
a cura di Enrico de Angelis
Testi di:
Alberto Bazzurro, Giovanni Choukhadarian,
Lorenzo Coveri, Enrico de Angelis,
Enrico Deregibus, Athos Enrile,
Guido Festinese, Annino La Posta,
Alessio Lega, Luigi Manconi,
Marco Mangiarotti, Claudia Pastorino,
Andrea Podestà, Sergio Secondiano Sacchi,
Mauro Selis, Paolo Talanca, Jacopo Tomatis,
Renato Tortarolo, Margherita Zorzi.
Progetto e realizzazione:
GGallery Publishing
Art Director:
Cinzia Costa
Direzione editoriale:
Redazione:
Traduzioni:
Impaginazione:
Segretaria di redazione:
Paolo Macrì
Alessia Luca, Francesca Veneziano
Annalisa Damonte, Manuela Gualandri
Massimo Berrutti
Luciana Santoro
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi
forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro senza
l’autorizzazione scritta dei proprietari dei diritti e dell’editore.
L’editore ha assolto tutti i diritti relativi ai contenuti e alle immagini.
Tuttavia è disponibile ad assolvere i propri impegni nei confronti dei titolari
di eventuali diritti sulle fotografie e sui contenuti pubblicati che erano
sconosciuti o non reperibili al momento della stampa del volume.
I crediti grafici e fotografici delle copertine discografiche mancano quando
non sono indicati sugli originali.
© 2014 GGallery s.r.l.
© 2014 Banca Carige S.p.A.
Dopo l’apprezzamento riscontrato dall’iniziativa editoriale dedicata a Genova e il jazz,
anche quest’anno il Gruppo Banca Carige affronta nel suo volume strenna il rapporto tra
la Liguria e la musica. Una liason che può sembrare innaturale, per una regione popolata
da gente a prima vista ruvida, introversa e taciturna, abituata com’è a scrutare la
monotonia dei suoni del mare. Ma proprio in questa convivenza perenne con l’ignoto, in
questa congenita simbiosi con una natura avversa e maestosa, da interpretare ed ascoltare
in ogni suo piccolo movimento, risiede forse quell’inattesa passione per le sonorità della
musica che fa della gente di Liguria un insospettato popolo di musicisti virtuosi, geniali e
innovatori, da Paganini in poi.
Non è quindi un caso che nasca nell’alveo della tradizione di creatività e coraggio
incarnata dai liguri anche la grande canzone d’autore, genere artistico a sé stante, sorto
da un’inedita fusione di musica e testo in un intreccio inscindibile.
Porto di mare, aperto per natura ai venti di novità e alle contaminazioni artistiche e
culturali, Genova è stata la culla di una koinè semantico-melodica da cui si è sviluppata
quella sinfonia di voci, versi, emozioni che ha fatto da colonna sonora a mezzo secolo di
storia nazionale, dal Dopoguerra fino ai giorni nostri. Alle note e alle rime scaturite dalla
penna dei grandi chansonier e parolieri della scuola genovese sono legate vicende,
immagini e ricordi che appartengono alla vita di tutti noi.
Promuovendo la presente opera, Banca Carige vuol tributare un omaggio a questi grandi
artisti, anticipatori di un’epoca e di una nuova cultura come spesso i liguri lo sono stati, in
tantissimi ambiti, nella storia. Gente abituata ad affrontare le correnti avverse, a leggere il
mutare dei venti e ad affrontare la vita in mare aperto, con le sue gioie, le sue difficoltà e le
sue emozioni. Da figli di questa terra, aspra e meravigliosa.
Cesare Castelbarco Albani
Presidente di Banca Carige S.p.A.
Prefazione
Preface
In questo libro, lo diciamo subito, Genova va da La Spezia a Sanremo. Nessuno se la prenda, ma quando le edizioni GGallery e la
Carige mi hanno proposto di coordinare quest’opera sulla famosa
storica presunta controversa “scuola genovese” di cantautori, man
mano che si procedeva nel lavoro ci si rendeva conto non solo di
una cosa risaputa, ovvero di quanto Genova, come una lucertola,
si allunghi sulla costa da una parte e dall’altra di se stessa, ma
anche di come gli immediati paraggi, da Rapallo a Savona, non
potessero non considerarsi di matrice culturalmente genovese… e
poi via via, verso est e verso ovest, come se tutti quegli artisti che
da una località o da un’altra ci spuntavano davanti alla mente non
potessero che rientrare nella stessa vicenda artistica, si fossero plasmati su quella stessa rivoluzione anni ’60 senza la quale quasi
nient’altro ci sarebbe stato, fossero fatti insomma della stessa materia, quella appunto che cerchiamo di indagare in questo volume
a più voci. E poco importa se alcuni di quegli innovatori non sono
peraltro nati a Genova: se a Genova sono cresciuti e si sono attratti
e si sono compattati, vuol tanto più dire che sia stato proprio il
clima di questa città, clima in tutti i sensi possibili, a informare di
sé una comune sensibilità.
Abbiamo così chiamato a raccolta alcuni dei migliori e più autorevoli esperti, scrittori e fotografi di “canzone d’autore”, molti dei
quali ruotanti intorno al Club Tenco che guarda caso ha sede a
Sanremo, per mettere a fuoco, per la prima volta in maniera così
massiccia, sistematica e polifonica, ciascuno a modo suo, col proprio taglio e il proprio stile, il singolarissimo fenomeno dei “genovesi” in musica. E se vi pare che manchi qualche altra
prestigiosa firma a cui avevo pensato… è stato solo perché qualche
impedimento contingente, a malincuore, non gliel’ha consentito.
C’era da scrivere per tutti, per tutti i gusti e per tutte le cronache
possibili. Dall’humus della tradizione dialettale, pardon, della lingua genovese che porta nel mondo Ma se ghe penso alle prime intuizioni italiane di swing vocale che dobbiamo a Natalino Otto;
dalla stupefacente raffica di “cantautori della rivoluzione” che
praticamente in un paio d’anni cambiano la faccia della musica in
Italia (Bindi, Paoli, Tenco, Lauzi, De André: scusate se è poco) a
tutto un milieu di “fiancheggiatori” che, a partire da Giorgio Calabrese e i fratelli Reverberi, sostengono i cantautori con la sapienza della parola e della musica; da una certa vena di beat, rock
e prog attenta ai contenuti testuali (un esempio sublime: il connubio
fra i New Trolls e il poeta Riccardo Mannerini) alle nutrite generazioni di cantautori immediatamente successive, capitanate da
Ivano Fossati e culminanti, cronologicamente, col terzetto Cristiano De André-Francesco Baccini-Max Manfredi; dalle venature
In this analysis of the Genoese songwriters we consider “Genoa” as an “imaginary” place from La Spezia to Sanremo:
Genoa actually lies on the coast like a
long lizard, and its culture spreads in the
neighborhood from East to West reaching
all Ligurian artists, who developed the
same sensibility. In this book some of the
best and most important music experts
will focus on the unique phenomenon of
Genoese songwriters, which developed in
many different directions: from the Genoese dialectal tradition to the first Italian examples of swing; from the wave of
the songwriters of the “revolution” to the
“flankers” who supported the songwriters
with their lyrics and arrangements; from
a beat, rock and prog inspiration to the
large new generations of songwriters;
from the jazz sounds that from the very
beginning permeated almost all songwriters’ works to the theatrical and cabaret
experiences; up to a surprising flourishing
of new talents, mostly women.
These Genoese artists introduced a number of important reforms into the world
of pop music. First of all, the idea of
using their songs to talk about themselves, their private world, their feelings
and their point of view about society. Unexpectedly, songs started talking about
all human knowledge: life and death; nostalgia, loneliness and lack of communication; the province and metropolitan
alienation; social climbing and segregation; power, war and civil solidarity; love
and sex, senses and sensuality; but above
all, there was an uprising against the social and political models, a quiet omen of
the 1968 revolts. The second songwriters’
“revolution” refers to the language of
their lyrics that drifted apart from the
rigid rhetoric and absorbed concrete and
5
familiar sentences, idioms and words,
never heard before in songs. These authors’ music is surely perceived as the
most real and complete one, because they
sang their own world with their own
words.
The Genoese songwriters also had a miscellaneous cultural background, rich in
“good reading” and good music. They read
Marx, but also Saint Francis from Assisi
and Saint Ignazio from Loyola, the French
existentialists, the Italian poets, the US
beat literature. On the musical ground,
they introduced a “new” way of writing
songs after having heard, assimilated and
loved jazz music, the musical genre and
Tin Pan Alley, rock’n’roll, classical music,
traditional Italian songs, the French chansonniers, cabaret; then folk and the US
protest music. These are the various and
heterogeneous roots of the songwriters’
songs that would become the point of reference for the following Italian music,
and that differ from other countries.
No one knows why the songwriters’ phenomenon happened precisely in Genoa.
Maybe only by chance, or because Genoa
was a high-density city, which had to give
vent to its internal tensions; maybe because it had to rise again after the Second World War devastation, or because of
the presence of the sea, which instills the
charm of the unknown and melancholy;
maybe because of its port – Mediterranean, furthermore – and the fact of
being a frontier city, full of colours,
scents and strong tastes, where the combination between different cultures and
languages enhanced creativity.
In conclusion, the Genoese songwriters
were so many and so important, that critics often labelled them as the artists of
the “scuola genovese” (Genoese school).
But they always rejected this definition,
looking at themselves more as a circle of
good friends sharing the same values and
experiences, characterized by a deep
sense of solidarity and a friendly collaboration in writing music.
Enrico de Angelis
6
jazz che fin dall’inizio percorrono l’opera di tutti questi artisti a
una certa vocazione teatral-cabarettistica che non trascura la canzone; da alcuni cantanti popolari che la “canzone d’autore”
l’hanno sfiorata (è solo in questo senso che abbiamo azzardato nel
titolo l’espressione borderline) fino a una sorprendente fioritura di
nuovi talenti – in buona parte femminili – che forse non si ha chiaro
quanto abbiano costellato gli ultimi vent’anni finché non li si vedranno riuniti ed elencati in questo libro.
Ma che cosa ha veramente “rivoluzionato” l’arrivo di quest’accolita di genovesi (a cui vanno doverosamente aggiunti i “forestieri”
ma-non-tanto Endrigo, Gaber, Jannacci, Ciampi) nell’ammuffito
mondo della musica leggera, che solo da pochissimo tempo stava
cominciando a rinfrescarsi con l’irruzione di Modugno, del
rock’n’roll, del terzinato, degli urlatori?
Innanzitutto, novità non da poco, improvvisamente in canzone si
può parlare di tutto: il tempo, la nostalgia, la vita e la morte; la
solitudine, l’incomunicabilità, il disagio esistenziale; la provincia
paesana o l’alienazione metropolitana; l’arrivismo, l’emarginazione, gli squilibri sociali, il potere, la violenza, il militarismo, la
guerra, la solidarietà civile; l’amore sì, ma anche il sesso e la sessualità, il senso e la sensualità, specie in Tenco, in Paoli, in De
André. Natalia Aspesi nel 1963 etichettava Luigi Tenco come “paladino del sesso e della politica nella canzonetta italiana”. C’è già
una sia pur generica ribellione di costume e di stile che sembra
presagio del ’68; un rifiuto anarcoide e generazionale dei modelli
sociali e politici, ma all’inizio appena “sussurrato”, un’insofferenza più che una mobilitazione, una protesta sottovoce, per immagini e allusioni, discreta, lieve, e per questo tanto più efficace
dal punto di vista artistico.
Insomma si fa strada l’idea che la canzone possa essere usata per
esprimere se stessi, il proprio mondo personale, che sia quello sentimentale intimistico o la propria visione della società civile. Sono
“cantautori”, questi. La figura di qualcuno che esterna ciò che egli
stesso ha scritto e quindi “sente” è evidentemente la figura più autentica, compiuta e motivata che possa esistere in questo campo.
Il linguaggio, poi, con cui si raccontano queste cose va e vuole andare contro ogni cristallizzata retorica. Entrano in canzone frasi,
locuzioni o vocaboli inconcepibili prima, perché troppo concreti,
materiali o “dimessi”, magari non immediatamente adeguati alla
musica corrispondente e quindi con effetti spiazzanti. Si incontrano
per la prima volta parole “inedite”, apparentemente “impoetiche”,
come portacenere, sassi, soffitto, una di quelle, bicchiere di spuma,
donne e motori, latta di birra, pattumiere, fossa comune, bidello, il
bello della sera, acchiappanuvole, contagocce, mi piace vederti soffrire, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare…
persino stanza da bagno in una squisita canzone d’amore. È tutto
un realismo poetico circoscritto, precisato, ambientato. Paoli ne è
un maestro: è un attimo entrare in quella stanza col soffitto viola,
in quella soffitta vicino al mare o in quel caffè coi camerieri maleducati. Le ispirazioni sono reali, spesso nate da momenti effettivi
della vita, perché attinte o dall’autobiografia o dalla cronaca.
Poi, sempre all’improvviso, si comincia a prendere atto che pure i
cantanti sanno leggere. Questi signori manifestano un background
culturale ricco di fermenti, di attenzione, di curiosità,
che si rivela in misura francamente singolare rispetto
al circostante mondo della musica leggera di allora;
innovativi anche in questo, perché da allora si inizia finalmente a supporre uno spessore culturale anche in
chi fa canzoni e si apre la strada ai cantautori della
successiva generazione. L’influenza del clima esistenzialistico francese o della letteratura americana contemporanea è forte. Un bagaglio di “buone letture”
emerge ricorrentemente nelle interviste, nelle ricostruzioni biografiche, nella loro stessa produzione scritta.
Tenco legge Marx ma anche San Francesco o Ignazio
di Loyola, Fenoglio e Silone, Sartre e Camus, Steinbeck
ed Hemingway, Kerouac e Ferlinghetti; e dentro ha Pavese. De André è zeppo di riferimenti letterari: da Villon a Prévert, da Cecco Angiolieri a Lee Masters, da
Àlvaro Mutis al citato Mannerini, solo per dirne pochi.
Anche su un piano musicale, costoro approdano alla
“nuova canzone” dopo aver ben conosciuto, assimilato
e amato, uno dietro l’altro, il jazz, il musical e Tin Pan
Alley, il rock, la musica classica (Bindi in primo luogo),
la tradizione italiana (sia popolare che d’autore, dalla
canzone napoletana alla romanza, al varietà), gli chansonnier francesi, il cabaret; più avanti il folk e la canzone di protesta d’oltreoceano. Le loro musiche non
sempre sono orecchiabili, sono spesso molto articolate
(Bindi), fuori schema (Tenco), oppure legate a toni parlati e cantilenanti (Paoli). E poi quel nuovo modo di
cantare codifica, dopo il primo scossone di Modugno,
il taglio netto coi miti del belcanto e dell’ugola d’oro,
specialmente in Bindi, l’antesignano, e in Paoli, voce
quest’ultima che all’inizio viene testualmente accostata
a “uno strumento dal timbro metallico” e lascia stupefatti.
È curioso come da tanti e tali radici eterogenee sia
venuta fuori una forma-canzone che, dopo essersi
scrollata di dosso le influenze più evidenti, ha finito
per costituire un nuovo modello tutto italiano di canzone “nazionale”, che di fatto si distingue nel mondo,
anche se nel mondo non ha la popolarità che potrebbe
meritare.
Perché sia accaduto proprio a Genova tutto ciò, io non
so dirvelo. Sono state date tante spiegazioni. Magari
solo un caso. Oppure perché, è stato detto, Genova è
una città compressa, a densità molto alta, che deve sfogarsi da qualche parte. Che doveva risorgere dall’oppressione e dalle macerie della seconda guerra
mondiale, che lì era stata particolarmente devastante.
Oppure perché c’è il mare e col mare la tensione verso
il fascino dell’ignoto; e se non si riesce ad appagarla
ci si ripiega nella malinconia. E perché è un porto, e
come tutte le città di porto è brulicante città di frontiera, di confine, e si sa che la commistione tra culture
e linguaggi diversi è sempre stata foriera di creatività
nella musica, e non solo nella musica. Per di più un
porto mediterraneo: la sostanza culturale-etnica di Genova è più vicina al Marocco, all’Algeria, alla Sicilia,
alla Spagna, alla Grecia, che non al continente; quindi
un coacervo di creatività piena di colori, profumi e sapori forti. Si pensi a De André, alla sua scelta di vivere
in Sardegna, al lavoro fatto con Creuza de mä, con quei
suoni e quegli strumenti della tradizione islamica e macedone e occitana e catalana, con quel dialetto che non
è solo genovese. Disse Fabrizio a proposito di Creuza
de mä: “L’idea decisiva mi nacque dalla scoperta che
la lingua genovese ospita al suo interno oltre duemila
vocaboli di provenienza araba o turca”; non a caso la
prima stesura dei testi di Creuza de mä era in un arabo
maccheronico.
Ma tutto questo a Genova lo si ritrova non solo in
acqua ma anche nel suo ventre terragno (anzi, si sa che
proprio i marinai amano la terra più del mare), e
quindi nei proverbiali vicoli del suo misterioso intestino
(pensiamo al mondo della prostituzione, che oggi giustamente associamo a violenza, sfruttamento e delinquenza, ma un tempo costituiva forse un ambiente che
non a caso personaggi come Paoli o De André amavano e rielaboravano poeticamente).
Sono stati, in conclusione, così tanti e così importanti
e così caratterizzati, gli autori di cui si tratta in questo
libro, che si è sempre parlato di “scuola genovese”.
Ora, è anche vero che Tenco e Lauzi erano compagni
di banco… ma i diretti interessati hanno sempre rifiutato l’etichetta di “scuola”. Era una complice cerchia
di amici molto stretti, che gravitavano intorno agli
stessi punti d’incontro, per esempio la spiaggia della
Foce, ovvero la foce del torrente Bisagno, luogo anche
e soprattutto di lavoro, dove abitava, come dice Paoli,
“gente chiusa e sincera, semplice e scorbutica, che mi
assomiglia”. E parlando di questi amici Paoli aggiunge: “C’era un’enorme solidarietà tra di noi, questo
sì. Quando qualcuno di noi voleva fare qualcosa, tutti
gli altri se potevano lo aiutavano. Se Tenco stava finendo un testo e io potevo dargli una mano gliela davo,
come faceva lui con me. Ma questo non si chiama
scuola, è semplicemente un trovarsi di… quattro amici
al bar, chiacchierare, stare insieme e volersi molto
bene. A questo punto il passaggio da questa solidarietà
amichevole al concetto di scuola non è stato difficile,
anche perché uscivamo dalle stesse esperienze.”
Non era una scuola, ok, ma questi artisti sono stati così
bravi che hanno finito per farci credere che lo fosse
davvero.
Enrico de Angelis
7
Introduzione
Introduction
Luigi Manconi
Geo-gastronomia
e musica leggera.
Umbre de muri,
muri de mainè
Se assumiamo come universo di riferimento di linguaggio e di senso il canone della musica leggera, due
canzoni sembrano parlarci, meglio di tutte le altre,
della produzione musicale genovese e ligure. La
prima canzone ci offre la lettura dall’esterno di
Genova-mondo; la seconda ce ne offre la più perfetta
interpretazione dall’interno. Va da sé che la prima è
Genova per noi, scritta e musicata da Paolo Conte
quarant’anni fa. Si rilegga il testo, sempre prestando
attentissimo ascolto alla musica che consente, di
quelle parole, la sola piena ricezione. Eccolo:
Con quella faccia un po’ così
quell’espressione un po’ così
che abbiamo noi prima di andare a Genova
che ben sicuri mai non siamo
che quel posto dove andiamo
non c’inghiotte e non torniamo più…
Eppur parenti siamo un po’
di quella gente che c’è lì
che in fondo in fondo è come noi, selvatica,
ma che paura ci fa quel mare scuro
che si muove anche di notte e non sta fermo mai.
10
Tenuto conto che l’autore di quel testo è nato ad Asti
e lì tuttora risiede, questo sguardo così profondo e
acuto e, allo stesso tempo, così prudente e guardingo
è stato interpretato sempre come quello proprio dei
quasi-conterranei (“eppur parenti”). Ovvero dei limitrofi e dei confinanti (appena 118 km tra Asti e Genova e un tragitto in auto che richiede poco più di
un’ora). Come se il capoluogo ligure fosse, diciamo
così, la discesa a mare di quegli abitanti delle campagne piemontesi ma anche, a ben vedere, delle stesse
città, medie e piccole, della regione: una intera cittàspiaggia per quel vasto entroterra costituito dal Piemonte. Una sorta di grande stabilimento balneare
che – della località di mare – presenta tutte le attrattive e le insidie, le suggestioni e i pericoli, il fascino
e la minaccia.
Ma non stiamo parlando solo di Genova e di Asti,
della Liguria e del Piemonte. E infatti, Genova, come
altre città (Livorno, Napoli, Bari, Ancona, Trieste...)
rappresenta il bagnasciuga di tutta quella popolazione
“continentale” che abita la nostra Penisola e che solo
di recente (qualche decennio fa) ha acquistato, se non
familiarità, una certa consuetudine con l’acqua del
mare. Mi avventuro spericolatamente sul terreno della
geografia del costume per dire che – forse con la sola
eccezione della Riviera di Levante e di quella Romagnola, e con l’anomalia di Sardegna e Sicilia – il rapporto intrattenuto con il mare dall’italiano
urbanizzato e, ancor più, da quello rurale, è stato
massimamente “circospetto” fino a tutti gli anni Sessanta. Mentre
le vacanze al mare diventavano consumo di massa, nell’inconscio
dell’italiano che partecipava del nuovo stile di vita e di un uso
diverso del tempo libero, rimaneva la sottile paura che quell’acqua “c’inghiotte e non torniamo più”. In altre parole, l’italiano
medio faticava a intrattenere una relazione serena con il mare e
le statistiche denunciavano, fino a pochi anni fa, una percentuale
elevatissima di connazionali totalmente incapaci di nuotare. E
drammaticamente soggetti ai rischi che quella inabilità comporta
(qualcuno mi dice che in nessun altro Paese che si affacci sul
mare il bagnino è così popolare e apprezzato come nel nostro;
non solo destinatario di torride fantasie erotiche, ma anche protagonista di epopee feriali).
A segnalare un autentico salto di quantità e di qualità nella fino
ad allora modesta consuetudine della vacanza al mare, sarà proprio un autore diventato “genovese” come Gino Paoli. E la canzone-manifesto, la canzone-promo, la canzone-testimonial è
ovviamente Sapore di sale. Per me, semplicemente, una delle
canzoni più belle al mondo e, in ogni caso, una canzone perfetta:
ossia la più felice integrazione tra testo, musica, arrangiamento
e interpretazione. Se c’è una canzone-estate è certamente quella
(sarà un caso, ma l’altra splendida canzone-estate è, per sublime
negazione, la precedente Odio l’estate di Bruno Martino, nato a
Roma). Si pensi all’anno in cui venne pubblicata Sapore di sale,
quel 1963 che vedeva, appunto, le vacanze al mare diventare, da
opzione elitaria, consumo di massa.
A quel passaggio corrispose con rapidità notevole un mutamento
di costume e mentalità. Un mutamento certo determinato da molti
altri fattori, ma che aveva nella vita di spiaggia, con tutto ciò che
comportava, un potente incentivo e una esuberante manifestazione. Quel passaggio da opzione elitaria a consumo di massa,
che avveniva parallelamente al pieno dispiegarsi del “miracolo
economico” e come sua conseguenza portava all’affermarsi progressivo e, infine, al trionfo di uno scenario fino ad allora sconosciuto: la nudità di massa. Per milioni di italiani fu un autentico
shock. Qualcosa di simile a un trauma collettivo, ricco di aspettative e inquietudini, di pulsioni e turbamenti, di piaceri e frustrazioni. E, ancor prima, di tempeste ormonali e di lascivie
adolescenziali. Un intero popolo (beh, diciamo un quinto di popolo) che si metteva a nudo, maschi e femmine, infoiati e allegri,
euforici e pallidi, mostrando vicendevolmente – con una combinazione di spudorata innocenza e di sfrontata timidezza – quelle
che alcune cronache definivano ancora “le vergogne”. Per gli anziani fu uno stupore in parte accigliato e in parte compiaciuto,
per le giovani generazioni una scoperta gioiosa e felice. Per tutti,
una trasformazione profonda. Si ricordi che all’epoca, i costumi
da bagno di maschi e femmine erano ancora, se non di lana, di
cotone pesante e permeabilissimo; le scollature di quelli femminili assai composte e vereconde, i modelli notevolmente rigidi e
informi. Quelli maschili, poi, oscillavano tra fogge che li facevano somigliare a brache da esercito coloniale, e sfuggenti triangoli davvero indecenti, incredibilmente tollerati perché il nudo
maschile godeva di una sua immotivata guarentigia. Su quella
umanità che si muoveva ancora “circospetta” e, tuttavia, colma
Geo-gastronomy
and pop music.
Umbre de muri,
muri de mainè
The Genoese and Ligurian songwriters’ work
is explained at its best by two songs: Genova
per noi, words and music by the Piedmontese
Paolo Conte, which offers an external point
of view on Genoa and Sapore di Sale, by the
Genoese Gino Paoli. The first one reflects the
deep and acute but, at the same time, cautious gaze of the foreigners on Genoa and is
a symbol of the rural and urban Italians’ wary
relationship with the sea. At that time the
percentage of Italians completely unable to
swim was very high, which made the lifeguard more popular and appreciated than in
other countries, and subject of passionate
erotic fantasies. It was not only the case of
Liguria and Piedmont: also other cities, as
Livorno, Naples, Bari, Ancona, Trieste, and so
on, represented the foreshore for all the Italians from the mainland who, only few
decades ago, started to become familiar with
the sea – with the only exception of the East
and the Romagna coast and the anomaly of
Sicily and Sardinia. It were the Sixties, the
years of the “economic miracle”, when the
holidays at the sea became part of mass culture, with the claim of a new collective scenario: mass nakedness. The idea of dozens of
scantily-dressed people in the same place and
at the same time – a combination of shameless innocence and impudent shyness – was
inconceivable till then, shocking for the conformists but fascinating for the young, who
glimpsed the coming of the sexual revolution.
This is the background of Sapore di sale, in
my opinion simply the best song ever, the
perfect summer hit, the fullest integration of
music, arrangement and interpretation, an
unstoppable flow of erotic energy. It had the
power to dissolve the odd outfits of the
bathers of that days – with the women wearing some priggish wool swimsuits and the
men compelled to choose between long military-style boxer shorts or, on the contrary,
some indecent cloth triangles – and the oppressive smell of the vile sun-creams. That
“salt flavour / that you have on your skin /
that you have on your lips”, instead, is like a
moan of passion, a declaration of a so far
11
quiet, tacit and mental love, maybe deferential to the place where it is (probably a
crowded beach), completely different from
the fierce love sung in other Paoli’s compositions (i.e. Il cielo in una stanza, Senza fine,
La storia di un ricordo, about loves consumed
in the secret of a bedroom). Gino Paoli’s voice
is, as usual, dreamy and sorrowful at the same
time, traversed by pleasure and torment, in
its timelessness even more expressive of the
fury of sensuality.
Sapore di sale also has in its title the secret
code to decrypt the identity of the so-called
“scuola genovese” of songwriters. As in a
Scandinavian legend or in a detective novel
of the XIX century, the evidence that resolves
the mystery is under the eyes of everyone,
and the three words of the title show how Genoese artists shared the same culture and the
same ideas, but also the same tastes, and the
passion for good food. As a matter of fact,
salt has great importance in Ligurian cuisine
for its property of food conservation – we can
remember here some traditional dishes such
as salted anchovy, Ligurian salted olives,
brine vegetables and so on – and for being
the main ingredient of the omnipresent focaccia bread. So, Sapore di sale, song of torrid
love, sparkling sea and burning sand, becomes the possible title of a food-and-wine
adventure, with Conte’s external point of view
giving way to the native voice of Fabrizio De
André. In his songs he talked about broddu
de fàru, amë, ûga spin-a, sûgu, selvaggin-a,
spica, while in Crêuza de mä we can find frittûa de pigneu, çervelle de bae, lasagne da fiddià ai quattru tucchi, paciûgu in aegruduse de
lévre de cuppi (in a book like this, published
in Genoa, it is stricly forbidden to translate
these words), typical dishes of a land and a
culture made of hand and heart work. Those
foods and their names really seem to define
the identity of a personality – and of a certain kind of music, too – growing up between
the sea and the hills, the vegetable gardens
and the paths called crêuze. In A çimma – according to Maurizio Maggiani, the most beautiful among De André’s songs – he described
the making of the old traditional dish called
“cimma” as an almost sacred ritual, with a
hand carefully sewing a pouch of calf leather
stuffed with vegetables, meat and cheese, to
prevent the filling from coming out during
the long cooking time.
12
di desideri, pesava l’odore greve delle creme solari del tempo:
nulla di simile alla sofisticata evanescenza dei prodotti attuali e
qualcosa che, piuttosto, rammentava una nauseabonda poltiglia.
Ebbene, lì, su quelle donne e su quegli uomini, e ragazze e ragazzi, precipitano saltellando – in quell’estate del 1963 – le note
di Sapore di sale. Tutto quanto fin qui descritto (costumi impresentabili e creme solari disgustose, frustrazioni patite e desideri
covati compresi) svanisce al suono di quel flusso di energia erotica allo stato puro, che quella canzone perfetta trasmette con
forza incontenibile e vitalissima. Quel “sapore di sale che hai
sulla pelle, che hai sulle labbra” è come un gemito di passione:
una dichiarazione di amour fou. Per moltissimi giovani dell’Italia
di quegli anni è l’annuncio della rivoluzione sessuale che, come
tutte le rivoluzioni, prima si manifesta nella mente e nella fantasia
e solo poi nei gesti e nei movimenti. E negli amplessi. La voce
di Gino Paoli, in quella interpretazione, è la voce di Gino Paoli:
come sempre trasognata e desolata allo stesso tempo, come sempre attraversata da piacere e dolore, come sempre allusiva di un
sogno e avvertita della sua labilità. È una voce che non ha alcunché di giovanilistico (si può dire che Paoli allora ha appena 29
anni oppure che ha già 29 anni, ma questo vale anche oggi che
di anni ne ha 80): e questa sua atemporalità sembra renderla ancor
più espressiva di un delirio dei sensi. Sia chiaro: è in realtà delirio
ancora quieto, sottaciuto, tutto mentale, quasi fosse rispettoso
dell’ambiente in cui si manifesta (una spiaggia presumibilmente
affollata e sguardi particolarmente curiosi), che non ha il tono
parossistico raggiunto in altre composizioni come Il cielo in una
stanza, Senza fine, La storia di un ricordo (e si capisce: queste
ultime parlano di amori consumati nel segreto umido di una camera da letto).
Ma, ecco il punto, la canzone perfetta costituisce anche il codice
e la chiave di interpretazione dell’indecifrabile rebus proposto
da quella che viene chiamata, seppure impropriamente, “scuola
genovese”. Come in una leggenda scandinava o in un romanzo
d’appendice dell’Ottocento, incerto tra investigazione criminale
e denuncia sociale, l’indizio che risolve il mistero si trova lì, nelle
pieghe della tappezzeria di un divano o tra gli oggetti in pelle di
uno scrittoio. O addirittura, come vorrebbe l’abusata immagine
della “lettera rubata”, eccola proprio là: sotto gli occhi di tutti.
La chiave del mistero della “scuola genovese” si trova ancora in
quelle tre parole: sapore di sale. È questa la traccia da seguire:
l’identità di quella cultura e dei musicisti che di quella cultura si
nutrono (attenzione: nutrirsi) si fonda non certo marginalmente
sulla conoscenza, sul gusto e sul piacere del sapore e dei sapori.
Il sale poi riveste un ruolo particolare nella cucina ligure. Gran
parte delle preparazioni tradizionali si basa, infatti, sulla conservazione degli alimenti: acciughe sotto sale, olive alla ligure, prodotti in salamoia, intingoli vari. E il sale è ingrediente
fondamentale nella preparazione di quel monumento regionale
che è la focaccia. Ecco che allora Sapore di sale, canzone dell’amore assolato e del mare scintillante e della sabbia rovente,
diventa – per allusione e per slittamento di sensi (ancora: sensi) –
il possibile titolo di un’avventura gastronomica. Qui lo sguardo
esterno di Paolo Conte e degli abitanti dell’entroterra cede il
posto allo sguardo più interno e, direi, intestino (appunto, ma so di esagerare: intestino).
E la canzone perfetta richiama irresistibilmente altre
due canzoni perfette, entrambe di Fabrizio De André.
La prima è Crêuza de mä. In un libro come questo
edito a Genova, credo sia severamente vietato pubblicarne la traduzione e, dunque, chi non capisce quel
testo chieda a qualcuno che conosce il vocabolario
genovese-italiano. Ecco i termini che troviamo: frittûa de pigneu, çervelle de bae, lasagne da fiddià ai
quattru tucchi, paciûgu in aegruduse de lévre de
cuppi. Poi, sparsi in altre canzoni: broddu de fàru,
amë, ûga spin-a, sûgu, selvaggin-a, spica. Penso di
poter dire che Crêuza de mä arrivi a “spiegare” tutte
le canzoni di tutti i musicisti di Genova e della Liguria. Quelle parole magnifiche, cantate a bocca semiaperta (o forse semichiusa) parlano davvero di una
Genova-mondo: e ne parlano come di una terra, di
una produzione della natura e di una produzione della
cultura fatte di lavoro delle mani e del cuore, del
gusto dell’occhio e dell’olfatto, del tatto e della
bocca. Quei cibi e i loro nomi sembrano definire davvero i tratti di un carattere – e, se si vuole, anche di
una musica – che si forma tra mare e collina, tra orti
e crêuza de mä. Lo si capisce bene ascoltando un’altra canzone di De André, quella che, secondo Maurizio Maggiani, è “la più bella tra le belle”: A çimma.
È la descrizione di un atto, la narrazione di un rito, il
racconto di una creazione: la preparazione della
“cimma”, appunto. Piatto di tradizione antica, la
“cimma” è composta da una tasca di vitello farcita
con verdura, carne, uova e formaggio, e cucita con
ago e filo in modo che, durante la lunga cottura, il ripieno non venga fuori. È del tutto evidente che la preparazione della “cimma” solo a un cuore insensibile
e a orecchie sorde può apparire come la semplice confezione di un cibo tipico. E vengono in mente, per
contrasto, quella letteratura e quella critica di ispirazione idealistica che parlano della creazione d’arte
come "nutrimento spirituale", "cibo dell'anima" e perfino "pane di Dio". Qui il canone viene rovesciato: la
canzone (parola e musica) si sottrae al fascino corrivo
dell'astrazione per farsi materia, corpo, esperienza fisica. Qui il cibo è cibo, il pane è pane e per fare il
pesto servono aglio olio basilico pinoli pecorino e
parmigiano. E per fare una buona canzone serve tutto
questo e un certo sapore di sale.
Gino Paoli alla Foce.
(Foto Publifoto)
13
La città e il sogno
Genova
The city and the dream
Genoa
Annino La Posta
...siamo sognatori di mondi...
Ivano Fossati
Sospesa atavicamente tra il mare e la montagna,
margini antitetici del groviglio che s’intreccia, s’insegue, affonda e sale spinto dai venti che scavano o
dal sole che evoca, Genova si aggrappa al suo orizzonte come un pesce inquieto catturato dalla rete:
possente e fragile, superba e discreta, acquatica, terrigna e ventosa, accoglie e fonde tutte le voci nelle
sue volute profonde di creatura viva che si svela e
si nasconde con la stessa ciclicità delle onde del
mare in cui si rispecchia.
Nessuna città è visibile contemporaneamente nella
sua totalità, lo sguardo deve accontentarsi di piccole
porzioni. Inutile cercare monadi che concentrino
leibnizianamente il tutto. Il modo migliore per vederle è affidarsi alla fantasia, che tutto comprende
ma che tutto trasforma, amalgamando il visto all’immaginato e il vissuto al sognato. Materiale onirico
Genova ne offre molto, e molto di più se ne trova
nelle canzoni che di quel materiale spesso si nutrono.
Una canzone offre una realtà già trasformata, che a
sua volta viene reimmaginata dall’ascoltatore. Non
c’è un modo migliore di ascoltare una canzone che
quello di portarla via mentre se ne viene portati via,
non esiste una reale possibilità di penetrazione nell’immaginazione, la giusta lettura presuppone una
grossa dose di lost in translation: è obbligatoria.
L’immaginazione è possibilità non realizzata, è
come trovarsi davanti alle innumerevoli vie di fuga
che il mare promette e non imboccarne neanche una.
Così nasce la poesia, e così nasce la canzone. È successo a Napoli, succede a Genova:
16
Le città di mare
sono i punti di incontro di mille avventure
di lingue diverse e di facce scure
di gente che passa
e si ferma a guardare.
Le città di mare
che son fatte apposta per non far capire
se la storia più bella deve ancora venire
o se si allontana
sera per sera.
da Le città di mare di Eugenio Bennato
Dal mare spesso si arriva, e il mare è anche l’unico
punto di vista a restituire un’illusoria unità, che, purtroppo, si frantuma appena si posano i piedi a terra:
Chi guarda Genova sappia che Genova
si vede solo dal mare
quindi non stia lì ad aspettare
di vedere qualcosa di meglio, qualcosa di più
di quei gerani che la gioventù
fa ancora crescere nelle strade.
da Chi guarda Genova di Ivano Fossati
La dicotomia del mare: via d’uscita e al contempo
barriera che frena, è riassumibile interamente in un
porto verso cui non resta che veleggiare:
Signore di questo porto
vedi mi avvicino anch’io
vele ancora tese
bandiera genovese
sono io.
da Passalento di Ivano Fossati
In un porto, prima di tutto, approdano i pescatori:
Tutti, tutti sulla spiaggia, arrivano i pescatori.
A sbrogliare le reti è sempre una magia,
può venire fuori una sirena che cantando ti porta via
ma l’argento delle acciughe ti riporta giù.
da Arrivano i pescatori di Sergio Alemanno
Il pesce, però, non è l’unica merce ad arrivare in un porto. Da
molto più lontano, altri porti, altre città offrono molto di più:
Accordeon, papiri, scorfani, ricci di mare, leudi, agorà,
algebra, Corfù, bitte, cime d’acciaio, kolo, sirtaki,
bilance, empori, sfruttatori, bagasce.
E poi:
Canti gitani, voci da un bazar,
lamento slavo, la morte di un marinaio,
parlar forte, preti ubriachi, tarantelle, processioni,
canditi, sestanti, donne selvatiche, paranchi,
baruffe per un bicchiere di vino.
E ancora:
Chitarre, bibbie, inquisizione,
suk, mendicanti, Napoleone, massacri orrendi,
tuoni, mole da fabbro, ammiragli, santi,
lanterne, droghieri, navi, battaglie, pipistrelli.
da Magazzino Mediterraneo di Buby Senarega
Altri mondi che si mescolano, altre facce che si mischiano, altre
realtà che diventano una.
Fuori dal porto basta alzare lo sguardo per capire che quel ricamo
....we are dreamers of worlds....
Ivano Fossati
Set between the sea and the mountains,
Genoa looks like many different cities: it
is at the same time powerful and frail,
moderate and “Superb”. Like any other
city, it is impossible to see Genoa in its
entirety, so the best way to look at it is
to stargaze, to dream about it through the
Genoese songwriters’ songs, which are
made of dreams and where the reality is
transformed by the author first and then
by the listener.
The sea seems to be the best viewpoint to
see the city, the only one that gives the
illusion of catching it in its entirety (Chi
guarda Genova, Ivano Fossati). The sea is
at the same time an outlet and a border
(Passalento, Ivano Fossati), lending place
to the fishermen (Arrivano i pescatori, Sergio Alemanno) and to goods and cultures
from all over the world (Magazzino
Mediterraneo, Buby Senarega) that mix up
and merge in a single entity.
Beyond the port, a gaze is enough to understand that Genoa is different from any
other citiy: it is a “steep city” (Fado del
dilettante, Max Manfredi), which climbs
quickly the mountains and goes down at
the same speed. Its charm can frighten
the strangers to the extent of making
them wish to run away from it (Genova per
noi, Paolo Conte).
Entering the city, Genoa welcomes the
strangers with the discretion of its alleys,
the carrugi, which are like a Dante’s circle
between the land and the sky. They force
17
di pietra non è una città come le altre, disposta in obliquo sale
rapidamente verso le colline e con la stessa velocità torna giù:
Genova città ripida
buone gambe per camminare
flipper messo in bilico
dove rotola un temporale
città da cantautori
per i ciclisti è micidiale
se pisci sulle alture
mezzo minuto e si inquina il mare.
da Fado del dilettante di Max Manfredi
Per lo sguardo estraneo, cui manca la familiarità del luogo, al
fascino può seguire il timore, l’incapacità di dimostrarsi all’altezza:
Con quella faccia un po’ così
quell’espressione un po’ così
che abbiamo noi prima di andare a Genova
che ben sicuri mai non siamo
che quel posto dove andiamo
non c’inghiotte e non torniamo più.
(…)
Ma quella faccia un po’così
quell’espressione un po’così
che abbiamo noi mentre guardiamo Genova
ed ogni volta l’annusiamo
e circospetti ci muoviamo
un po’ randagi ci sentiamo noi.
Allora, non resta che fuggire:
Lasciaci tornare ai nostri temporali,
Genova, ha i giorni tutti uguali.
da Genova per noi di Paolo Conte
Da un avamposto come può essere un porto, finalmente, si entra
nella città.
Genova accoglie tutti con la ritrosia dei suoi carrugi: un girone
dantesco in bilico tra la terra e il cielo, raggomitolato su se stesso
per far dimenticare “posizioni rotte e nomi” e spingere il viandante a ricercare nella fatica del passo l’epifania di un angolo
che, anche solo per un momento, dia ordine al tutto:
Genova che crolla si lascia andare
dietro ad ogni muro quante sorprese
18
dolce è la fatica delle mie scale
dietro alla finestra che lascia entrare un temporale.
E non cercare qualcosa da raccontare
vagabondare le sere è così naturale
e non stupirti di tutto questo perché
la vera Genova quella dei vicoli ruba anche te.
da La vera Genova quella dei vicoli
di Claudia Pastorino
Non resta che immergersi, dunque, e farsi rapire. Provare ad appoggiare l’immaginazione sui rumori, sugli
umori, sulle voci, sulle tante ombre e le poche luci,
su quello che si vede e che non si sa mai se ci sia davvero. Inseguire tutto l’inseguibile, con tutti i sensi di
cui si dispone, perdere se stessi e ritrovare la città fino
a sorprendersi, con lo sguardo alzato, a contemplare
un bassorilievo posto su un muro con sotto una scritta
che nella mente si allarga:
Ama e ridi se amor risponde
piangi forte se non ti sente
dai diamanti non nasce niente
dal letame nascono i fior.
da Via del Campo di Fabrizio De André
Siamo in Via del Campo. A due passi da qui c’è la
bottega-museo di Gianni Tassio, memoria storica
della canzone d’autore a Genova (o “da Genova”
come ama dire Max Manfredi).
Entrare e parlarci è un attimo. Lo troviamo intento
a leggere un testo in genovese ma che arriva all’orecchio (e sarà sempre così) in una lingua più
comprensibile ai foresti. Gli zeneixi non ce ne vogliano:
Lo scirocco, lo scirocco
sale dalla spiaggia a curiosare
e nelle crêuze si sente odore di mare (…)
Lo scirocco, lo scirocco
come un bambino gioca a nascondersi
tra le porte delle case
e ti cerca, e ti sveglia e ti bacia
lo scirocco.
da O sciöco di Bruno Lauzi
Di chi è questa canzone?
“Di Bruno Lauzi, della scuola genovese, quella che
ha rivoluzionato la canzone d’autore.”
Ma qui ci sono scritti i nomi di altri autori…
“Una canzone è di chi la canta. Di chi è Grande
grande grande?”
Certo, è di Mina. La scuola genovese dicevi, ma è
esistita davvero?
“La scuola genovese: qualcuno dice che non sia mai
esistita, qualcun altro sì. Fatto sta che Genova ha
messo dentro a una manciata di persone il germe dell’arte. Senza Genova non ci sarebbe la scuola genovese. Sembra un paradosso ma a ben guardare non
lo è affatto.”
Ma allora, perché tutto questo fermento musicale c’è
stato proprio a Genova?
“Merito dell’aria… e della focaccia.”
L’aria e la focaccia, perché no.
Solo uscendo ci si ricorda che Gianni Tassio manca
da troppo tempo, che è scomparso nel 2004, ma è
solo un particolare, un’idea come un’altra.
Un momento dopo si è in balia del vento, allora ci si
ricorda di quanto detto da Piaf Max: “C’è un vento
fortissimo a Genova, s’imbuca nei carruggi, ti sorprende: è
un vento che attacca l’uomo”.
A Genova il vento ha una fisicità impensabile altrove
e una forza tale che detta il ritmo delle giornate.
Quando soffia il vento caldo di scirocco, che qui
chiamano anche garbino, i pensieri s’intorpidiscono,
tutto si ferma in un’atmosfera irreale. Torna alla
mente il testo letto da Tassio, e non solo:
E quando scende la sera fra dita calde di scirocco
gli dei concedono ai mortali il profumo del
bergamotto.
Vento di garbino, vento di grecale
qualche volta ti voglio bene, qualche volta ti voglio
male.
Tra le luci della notte e le fiamme della controra
certe volte venivi meno, certe volte, ancora e ancora.
da Danza composta di Max Manfredi
La macaia influenza gli umori, favorisce gesti che si
spingono lontani dall’ordinaria amministrazione e
“tra sogno e realtà non lo so chi si piazza vincente”:
Annalisa gioca a scacchi da sola
perché poco prima ha litigato
ora il suo uomo non può reagire
con la lama rotta nel costato.
E c’è caldo, caldo, caldo, caldo, caldo.
E c’è un caldo da impazzire.
da Caldo da impazzire di Federico Sirianni
19
Fortunatamente, però, un caldo come questo, il più
delle volte, spinge verso il fresco delle osterie: un luogo
di aggregazione mascherato da ritrovo culinario:
Siete mai stati in un’osteria
vecchi tavoli messi a caso
dietro al banco non c’è mai nessuno
il padrone ama star con la gente.
Gente vecchia che negli occhi
ci si legge che cosa hanno nel cuore
gli basta qualche bicchiere
e ritornano dei bambini.
da Ostaie di Sergio Alemanno
C’è chi di un’osteria ha fatto un’abitudine e, con qualsiasi tempo, non smette mai di perpetuarla:
Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino
quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino
li troverai là, col tempo che fa, estate e inverno
a stratracannare a stramaledir le donne, il tempo ed il
governo.
Loro cercan là la felicità dentro a un bicchiere
per dimenticare d’esser stati presi per il sedere
ci sarà allegria anche in agonia col vino forte
porteran sul viso l’ombra di un sorriso tra le braccia
della morte.
da La città vecchia di Fabrizio De André
Nelle osterie è preferibile bere. Per mangiare ci sono
le trattorie, anche se il confine è spesso più che sfumato. I meno abbienti spesso sono costretti ad accontentarsi di una tripperia:
C’è tanta gente
che non si è mai seduta
a un tavolo di una tripperia
con davanti una tazza fumante
ed in mezzo alle gambe un “micino che ronfa”.
da Tripperia di Sergio Alemanno
Qualche volta, e quel gatto sulle ginocchia dovrebbe indurre al sospetto, a far compagnia c’è anche qualche
topo. A Genova qualcuno sostiene che ce ne siano otto
per ogni abitante ma che non se la passino troppo bene:
Otto topi fracidi in cerca di un ospizio
20
si tuffano negli acidi del degrado edilizio
otto topi superstiti lanciando alte le grida
per non vivere a Genova, si calan topicida!
da La ballata degli otto topi di Max Manfredi
La trattoria, però, è soprattutto un posto dove sentire il
sapore della città, un posto dove assaggiare la sua storia.
La preparazione di un piatto storico, la cima, assume
caratteri magici e la ricetta si trasforma in canzone:
Bel guanciale materasso di ogni ben di Dio
prima di battezzarla nelle erbe aromatiche
con due grossi aghi dritti in punta di piedi
da sopra a sotto svelto la pungerai
aria di luna vecchia di chiarore di nebbia
che il chierico perde la testa e l’asino il sentiero
odore di mare mescolato a maggiorana leggera
cos’altro fare cos’altro dare al cielo.
Cielo sereno terra scura
carne tenera non diventare nera
non ritornare dura
e nel nome di Maria
tutti i diavoli da questa pentola / andate via.
da ‘A ҫimma di Fabrizio De André
Riprendere i vicoli, dopo un lungo e condito soggiorno
in uno di questi locali, qualche volta non è un’impresa
semplice, specie se fuori ad aspettarci c’è ancora il
vento. Questa volta arriva da una diversa direzione,
spazza i carruggi e mulinella nelle piazzette. Mentre ci
avvolge sembra voler esaudire ogni desiderio, e allora:
Canta un fato che non mi ha beccato,
ninnolo di spari lungo il litorale,
fionda e fughe, il salto delle streghe,
il volo delle acciughe sulle vie del sale.
Sciuscia, sciuscià libeccio / si danza fino al largo.
da Libeccio di Max Manfredi
Un vento così secco è anche l’ideale per asciugare, più
prosaicamente, le file variopinte dei panni stesi tra un
palazzo e l’altro e, se si è appena usciti da un’osteria,
lo si può scambiare anche per un vento africano:
Pozze di vino spesso non son più lo stesso
ghibli portami con te, là, sopra il vicolo
schivando i panni stesi, gatti e piccioni obesi.
da Onde clandestine di Federico Sirianni
Gira e rigira, una strada “persa” ci porta di nuovo in Via del
Campo. Tendendo l’orecchio si ha l’impressione di sentir cantare
Amalia Rodrigues, la regina del fado:
C’era sempre una canzone per voi
un bicchiere due risate con noi
nella casa in Via del Campo
dove dolce andava il tempo
dove ho riso amato e tante volte ho pianto
ci scaldavano le ore
qualche volta in fondo al cuore
rimaneva un’ombra triste di rimpianto
nostalgia di non poter guardare il sole
nella casa in Via del Campo.
da La casa in Via del Campo di Roberto Arnaldi
Ma è già notte e nel buio la strada appare diversa, ancora meno
lineare, ancora più difficile da cogliere, come Medusa va affrontata di sbieco, cercando angolazioni che non feriscono.
Adesso tra i vicoli corrono pensieri che sono persone, ricordi di
gente lontana che torna anche solo per un momento a cercare
quello che non c’è più.
Voci che cercano una città perduta…
Genova era una ragazza bruna
collezionista di stupore e noia
Genova apriva le sue labbra scure
al soffio caldo della macaia
e adesso se ti penso io muoio un po’
se penso a te che non ti arrendi.
da Notti di Genova di Cristiano De André
…un figlio che ricorda suo padre…
Per quanto tempo ti penserò
in quelle notti a Genova
giù lungo il porto, dentro quei bar (…)
bevevi troppo, fumavi un po’
perso nella tua musica.
da Invincibili di Cristiano De André
…parole nel vento che si confondono agli inviti di quelle anime
appoggiate ai lampioni:
Via del Campo c’è una graziosa
gli occhi grandi color di foglia
tutta notte sta sulla soglia
vende a tutti la stessa rosa.
Via del Campo c’è una puttana
21
the wanderer to look for the epiphany of
a corner that puts all things into place (La
vera Genova quella dei vicoli, Claudia Pastorino). So the only thing to do is to dive
in and abandon oneself to all the noises,
the moods, the voices, the shadows and
the little lights (Via del Campo, Fabrizio
De André). Without Genoa and its thousands of faces the so called “scuola genovese” of songwriters would not exist,
because it’s the city itself that gave the
seed of art to a handful of people.
Strolling the alleys the wanderer realises
he is at the mercy of a wind that seems to
almost attack him, a powerful wind that
marks the rhythm of the days and that is
inconceivable elsewhere. Many songwriters wrote about the wind, for instance the
Sirocco (‘O sciöco, Bruno Lauzi) that
numbs the thoughts and produces an unreal atmosphere (Danza composta, Max
Manfredi).
The warmth affects the moods, triggers
unexpected reactions (Caldo da impazzire,
Federico Sirianni) and, often pushes towards the cool wine of the inns (Ostaie,
Sergio Alemanno). Some of these alleys
are frequented by the regular customers of
the inns and, no matter the weather outside, they spend their whole day in them
(La città vecchia, Fabrizio De André).
“Trattorie” are better places where to eat
but for the poorest there are the”tripperie” (TN shops where tripe is cooked and
sold) (Tripperia, Sergio Alemanno), where
sometimes you can find yourself in the
company of a mouse (La ballata degli otto
topi, Max Manfredi). The “trattoria”, however, is above all a place where you can
taste the city and its history through its
typical dishes (‘A ҫimma, Fabrizio De
André) before setting off and bumping
into another wind again, the Libeccio,
which blows from a different direction
(Libeccio, Max Manfredi) and is ideal to
dry the multi-coloured rows of laundry
hanging from a building to another (Onde
clandestine, Federico Sirianni).
Wandering and getting lost through the
alleys, you can reach Via del Campo again,
where you have the impression of hearing
Amalia Rodrigues singing a fado song (La
casa in Via del Campo, Roberto Arnaldi).
But it is night already and the alley looks
22
gli occhi grandi color di foglia
se di amarla ti vien la voglia
basta prenderla per la mano
e ti sembra di andar lontano,
lei ti guarda con un sorriso
non credevi che il paradiso
fosse solo lì al primo piano.
da Via del Campo di Fabrizio De André
Adesso più che in ogni altro momento appare lecito sognare:
Lingua infuocata Jamin-a
lupa di pelle scura
con la bocca spalancata
morso di carne soda
stella nera che brilla
mi voglio divertire
nell’umido dolce
del miele del tuo alveare.
da Jamin-a di Fabrizio De André
C’era una volta un sogno comune a tutti questi vicoli, un sogno
fatto di case dai soffitti colorati…
Quando sei qui con me
questa stanza non ha più pareti ma alberi,
alberi infiniti quando sei qui vicino a me
questo soffitto viola no, non esiste più
io vedo il cielo sopra noi.
da Il cielo in una stanza di Gino Paoli
…ma era un sogno di altri tempi, un sogno che s’infranse…
…quando venne la Merlin
per scindere il bene dal male
quando chiusero tutti i casini / e fu freddo, a Natale.
da Molo dei Greci di Max Manfredi
Lungo le vie del sogno, però, un ménage può ancora sublimarsi
nei versi di una canzone:
Volevo una canzone come una donna di malaffare,
di tutti e di nessuno, come una lingua, come un altare.
Tutti in fila al lavatoio, quando all’alba si va a lavare,
tutti in fila sul portone, lei solo sceglie chi deve entrare.
da La Fiera della Maddalena di Max Manfredi
Ora che siamo penetrati fino al cuore della città e ne
siamo rimasti ammaliati confondendo i nostri sogni
con i suoi, riuscire a venirne fuori costa molta fatica:
L’ultimo respiro (…)
me lo tengo per uscire vivo
dal nodo delle tue gambe.
da Jamin-a di Fabrizio De André
Ma anche le notti più belle finiscono e l’alba impietosa le spazza via insieme alla spazzatura:
Alé, ci siamo, popoli, all’era della rûmenta
questo mare che v’incanta: godetevelo, è qui.
Beato chi ci naviga, meschino chi ci annegherà
dentro.
da A rûmenta di Piero Parodi
Il modo migliore per chiudere una notte genovese è
quello di entrare in un forno e consumare la focaccia
che molti, a queste latitudini, non la cambierebbero con
niente:
Duecento pizze non fanno una focaccia.
da A fugassa di Piero Parodi
È l’alba ormai, e fuori dai carrugi, la città respira,
offre prospettive più ariose, punti di vista più morbidi,
più rassicuranti. È il proscenio su cui per vie ampie
si arriva al suo nucleo centrale, quello più urbano, più
concreto. Lo sguardo libero di spaziare abbraccia edifici, strade e piazze, così, come in un giro di giostra,
scorrono veloci: Piazza De Ferrari...
Siamo attaccati ai nostri lavoretti saltuari
quasi come agli orari di Piazza De Ferrari
da I fiascheggiatori
dell’Assemblea Musicale Teatrale
…Via XX Settembre, dove anche l’abituale si veste
d’inconsueto…
Le donne hanno volti diversi (…)
negli archivolti di Via XX Settembre.
da Donne di Paolo Cogorno
…la galleria…
Ragazze vestite di rosso,
tristi come cespugli di more (…)
e una di loro che (…)
ha gli occhi dicembrini
le dico di darmi un passaggio
fino in Galleria Mazzini.
da Centerbe di Max Manfredi
…la cattedrale con i suoi leoni stilofori che nel sogno
diventano cani:
Sono meglio i capelli a caschetto
perché il Mille dovrà pur venire
con il vin champenoise messo in ghiaccio
per brindare al tuo dolce dies irae.
Porti calze listate di nero
su gambe di vedova ballerina
e se sogni, sogni cani di pietra
che ti hanno in custodia da quand’eri bambina.
da Cattedrali di Max Manfredi
E dal centro, perdendosi nel traffico, con meno poesia
che tra i vicoli…
Perduti nel traffico nel centro di Genova
sparisce la polvere dal cuore guardandoti.
da Perduti di Gino Paoli
… lo sguardo rimbalza oltre e giunge sotto i porticati
di Via Prè, un po’ carruggio un po’ fiera multietnica
brulicante di gente, voci, mercanti e mercanzie:
È caratteristica
la strada di Via Prè
con tanta gente in mezzo
e sempre tra i piedi
lì parlano tutte le lingue
e qualunque dialetto
qualche volta anche genovese.
da Toponomàstega zenéize di Giuseppe Marzari
Da qualche parte, in mezzo al viavai, stazionano gli
“occhi da gatta” della bella Rosetta, “la meglio di
tutta Via Prè”, che solo da morta svela il suo segreto:
23
La verità si è saputa dai giornali
ci ha lasciati tutti di stucco
sotto la foto della bella Rosetta
c’era un nome “Deodato Pasquale”.
da A bella Rosetta di Sergio Alemanno
Che poi, a voler essere precisi, è la stessa scoperta a
cui era giunto Fabrizio De André, commerciando con
la graziosa di Via del Campo.
Alla fine di Via Prè c’è la stazione di Porta Principe,
principale approdo ferroviario:
Dall’ultima galleria
sembra mai più poter riaprirsi il sole
e quando luccica dal fondale
sulla rugginosa ferrovia.
Dalle budella della grande vedova
dritto in faccia a un muro alto
Piazza Principe in un sussulto
ti vomita addosso a Genova.
Ma se ci penso allora vedo il mare
vedo i miei monti e Piazza della Nunziata,
rivedo Righi e mi si stringe il cuore
vedo la Lanterna, la Cava, laggiù il molo,
rivedo a sera Genova illuminata.
da Ma se ghe penso di Mario Cappello
Scivola lo sguardo nella valle e va ad abbracciare il
cimitero di Staglieno:
Il lavatoio dove vanno le bianche bugaixe di notte a
lavare i lenzuoli dei morti di peste, e poi stenderli al
buio.
Qualche volta, a Staglieno, se passi le senti cantare.
da Dall’ultima galleria di Alessio Lega
da Il molo dei Greci di Max Manfredi
Quando è notte la stazione assume fattezze diverse,
lontane dalla frenesia del giorno:
Dall’altro lato sorge Marassi, teatro di mitiche imprese calcistiche che si spengono in ricordi colorati,
in nostalgie da non rincorrere:
Genova vive anche di notte
quando la gente non esce di casa
e Principe diventa un letto a due piazze
per chi la casa ce l’ha per strada.
da Gli occhi di Genova di Massimo Schiavon
Da qui, arrampicandosi su per le colline si può arrivare fino a Piazza Manin dove, complice la notte, si
ha l’impressione di intravedere Max Manfredi in
compagnia di un suo illustre collega:
Sognavo Majakovskij
che mi passa il papiroski,
stesi sulla piazza di Manin.
da Notti slave di Max Manfredi
24
è inutile andare a cercare fuori dai confini dell’immaginario un Molo dei Greci o la Fiera della Maddalena,
mentre il porto di Atene è qui, basta solo saperlo cercare. Da Piazza Manin alle alture il passo è breve, un
po’ più su c’è il Righi da cui si domina tutta la città:
Proveniva da Via G. Byron, Max Manfredi, luogo al
contempo reale e irreale. A cercarlo su una cartina lo
si trova ma non necessariamente è lo stesso della canzone, che lo reinventa regalandogli nuova vita.
Allo stesso modo, o in un modo solo un po’ diverso,
Io questa notte ti vorrei parlare
e invece parto per mandarti a dire
che tu sei bella, sì, ma da ricordare
bella più che mai.
Non mi basta un blues
per averti un po’ di più
Genoa, you are red and blue.
da Genova blues di Francesco Baccini
Poco più in là, il Biscione, enorme complesso di edilizia popolare, imbruttisce la collina e devia lo
sguardo altrove:
Ultima fermata Biscione
non troppo distante da casa di Dio.
da Ultima fermata Biscione di Federico Sirianni
Da quassù ce ne sono di cose su cui spostare lo sguardo,
che si può spingere fino ad abbracciare tutta la “grande
Genova”, quella che va da Voltri a Sant’Ilario.
E dove non dovesse arrivare la vista sicuramente arriva l’immaginazione, che ricrea le cose con la materia del sogno di cui tutti noi,
è noto, siamo fatti.
Questi posti davanti al mare
con questi cieli sopra il mare
quando il vento riscalda a suo tempo
il mare.
da Questi posti davanti al mare di Ivano Fossati
Proprio laggiù in fondo si vede Sant’Ilario, certo non la stazione,
ma è facile immaginare quella donna che scende dal treno e semina lo scompiglio:
La chiamavano Bocca di Rosa
metteva l’amore, metteva l’amore,
la chiamavano Bocca di Rosa
metteva l’amore sopra ogni cosa.
Appena scesa alla stazione
nel paesino di Sant’Ilario
tutti si accorsero con uno sguardo
che non si trattava di un missionario.
C’è chi l’amore lo fa per noia
chi se lo sceglie per professione
Bocca di Rosa né l’uno né l’altro
lei lo faceva per passione.
da Bocca di Rosa di Fabrizio De André
Il pellegrinaggio di Bocca di Rosa prosegue, si sa, alla stazione
successiva, che potrebbe essere quella di Quarto, luogo più di
partenza che di arrivo, in realtà. All’alba del 6 maggio 1860, infatti, dalla sua spiaggia presero il largo 1085 uomini con la camicia rossa:
Camicie rosse, all’avventura
in una nuvola di bandiere
camicie rosse così nessuna
delle ferite si può vedere.
da Camicie rosse di Massimo Bubola
Avvicinando l’occhio alla città, s’incontra Boccadasse, villaggio
di pescatori dove visse la sua bohème un giovane Gino Paoli:
Ti ricordi il sole nella casa al mare?
Ti ricordi i fiori che curavi tu?
I sorrisi rossi dei gerani appesi?
Sale sopra i vetri e suoi tuoi capelli?
(…)
25
different, even less linear and more difficult to discern (Notti di Genova, Cristiano
De André). It’s the time of love (Jamin-a,
Fabrizio De André) that makes you dream
about houses with coloured ceilings (Il
cielo in una stanza, Gino Paoli), and other
times it is dream (Molo dei Greci, Max Manfredi) that exalts itself in the lines of a
song (La Fiera della Maddalena, Max Manfredi).
But even the best nights are supposed to
finish and the merciless dawn sweeps
them away with the garbage (A rûmenta,
Piero Parodi). For a Genoese, the best way
to start the day is surely entering in a
bakery and eating focaccia bread (A fugassa, Piero Parodi).
Beyond the alleys, the city can breathe
and offers more spacious views, more reassuring viewpoints. Trough wide streets
the wanderer reaches the inner part of the
town, with Piazza De Ferrari (I fiascheggiatori, Assemblea Musicale Teatrale), Via
XX Settembre (Donne, Paolo Cogorno),
Galleria Mazzini (Centerbe, Max Manfredi),
Saint Lorenzo’s cathedral (Cattedrali, Max
Manfredi), but also the chaos of the traffic
(Perduti, Gino Paoli), just up to the colonnade of Pré street that is at the same time
an alley and an open-air market full of
mysterious people (A bella Rosetta, Sergio
Alemanno), voices, traders and goods (Toponomàstega zenéize, Giuseppe Marzari).
At the end of Pré street there is Piazza
Principe station, in the morning main railway yard of the city (Dall’ultima galleria,
Alessio Lega) and at night shelter for the
homeless (Gli occhi di Genova, Massimo
Schiavon).
Climbing the hills you can reach Piazza
Manin (Notti slave, Max Manfredi) and the
Righi panoramic viewpoint, which overlooks all the city (Ma se ghe penso, Mario
Cappello), from Staglieno cemetery and
Marassi stadium, location of legendary
soccer matches that vanished in colourful
memories (Genova blues, Francesco Baccini), through the “Biscione”, a gigantic
example of council housing that spoils the
hill and diverts the gaze elsewhere (Ultima fermata Biscione, Federico Sirianni),
just up to the two far ends of the “big
Genoa”, Voltri and Sant’Ilario (Questi posti
davanti al mare, Ivano Fossati). Here, you
26
Non ricordo niente di quello che è stato,
mi ricordo solo che ero innamorato.
Quel che c’era intorno non contava niente,
c’era solo amore, c’eri solo tu.
da Boccadasse di Gino Paoli
Come dimenticare invece una soffitta a due passi dal cielo e a
uno dal mare:
C’era una volta una gatta
che aveva una macchia nera sul muso
e una vecchia soffitta vicino al mare
con una finestra a un passo dal cielo blu.
Se la chitarra suonavo
la gatta faceva le fusa
ed una stellina scendeva vicina,
poi mi sorrideva e se ne tornava su.
da La gatta di Gino Paoli
Prima del porto, c’è la Foce. Da lontano sembra proprio quella
cantata da Bruno Lauzi:
Qui tanti anni fa c’era la nostra spiaggia.
Ricordo che c’erano solo i relitti delle chiatte da sbarco,
quello che era il parco giochi di chi sognava l’avventura
e lungo tutta la Foce l’acqua era limpida e pura
e sugli scogli i pescatori avevano la mano sicura:
è così che tanti anni fa era il nostro quartiere.
da La nostra spiaggia di Bruno Lauzi
Lo stesso posto dove spera di approdare un povero pescatore di
acciughe per approfittare delle acque fresche del torrente Bisagno:
Se sbarcherò alla foce
e alla foce non c’è nessuno
la faccia mi laverò
nell’acqua del torrente.
da Le acciughe fanno il pallone di Fabrizio de André
A ponente del porto si erge il faro, secolare testimone di sogni e
umori in odor di salsedine:
La Lanterna impassibile
guarda da secoli gli scogli e l’onda.
da Piazza Alimonda di Francesco Guccini
Subito dopo, Sampierdarena con le sue banchine
d’approdo e le fabbriche:
Mi vengono col vento dei cantieri
solo le rime di Sampierdarena
che si baciano come fuori scuola,
che s’imboscano dentro ogni portone,
che limonano in ogni mia parola,
che mi sloggiano dalla mia canzone.
E al santo, perché sempre di un santo si tratta, un miracolo bisogna pur chiederlo:
E così siamo in ballo da anni su questa galera
ed abbiamo dormito su altari intarsiati di guano
aspettando San Giorgio a cavallo, nei bar della sera
che ci porti a vedere le nebbie di un porto lontano
che ci porti a vedere la nebbia del porto a Milano.
da Molo dei Greci di Max Manfredi
da Le rime di Sampierdarena di Max Manfredi
Più avanti, a cominciare da Pegli, le spiagge. Al centro,
incastrato tra ponente e levante, il porto. Prima di arrivarci, percorriamo una delle vie d’accesso:
Sulla strada che val al porto
dopo un arco c’è una piazza
sempre piena di bambini
qualche gatto
e un vu’ cumprà (…)
E infine, eccolo. Ecco il porto, il luogo “dove tutto rinasce e ricomincia”, la possibilità di ricrearsi fuori
dai propri confini:
Con il mare proprio sotto casa mia
il mio destino in fondo quale vuoi che sia
ho scelto la mia vita libera
può darsi che non torni più
del mio ricordo fanne un po’ quel che vuoi tu.
da All’ultimo amico di Ivano Fossati
tra un negozio di bottoni
e un tizio che si fa
c’è un ufficio senza targa e senza età.
Ed è l’ufficio delle
cose perdute, quelle
che son sparite in fondo
a qualche momento chiuso.
da L’ufficio delle cose perdute di Gino Paoli
Poco più giù, un altro ufficio sorge in riva al mare:
Qua, Lei si accomodi qua
e mi dica che Le pare
del mio ufficio in riva al mare.
Beh, l’arredamento non c’è
però c’è il mare da ascoltare
e il tramonto da aspettare.
da L’ufficio in riva al mare di Bruno Lauzi
Se siamo di fronte al mare, sogno o realtà che sia, alle
nostre spalle c’è un palazzo con un San Giorgio dipinto sulla facciata che di notte, come tutti i dipinti,
scende dal muro e s’inoltra nella città:
San Giorgio ci aspetta giù al caffè Klainguti
con la Ghepard fatta di pelle di drago.
da Natale fuoricorso di Max Manfredi
Da questo porto, un po’ di tempo fa, un navigatore ha
levato le vele per raggiungere la Spagna e, da lì, una
nuova terra:
E naviga, naviga là
come prima di nascere l’anima naviga già,
naviga, naviga ma
quell’oceano è un acquario di sogni e di sabbia
poi si alza un sipario di nebbia
e come un circo illusorio s’illumina l’America.
da Cristoforo Colombo di Francesco Guccini
Da quel fatidico momento, innumerevoli volte si è
fatto spola tra i due continenti…
Su questa rotta inconcludente
da Genova a New York.
da Ma come fanno i marinai
di Lucio Dalla e Francesco De Gregori
…e ogni volta si è lasciato qualcuno su un molo a
salutare:
Dalla mia riva
solo il tuo fazzoletto chiaro (…)
27
28
e so bene stai guardando il mare
da Io e il mare di Bruno Lauzi (per Umberto Bindi)
can almost see that woman who gets off
the train and upsets the quiet village
(Bocca di Rosa, Fabrizio De André). Going
on you reach Quarto, from whose beach
set out 1085 men with red shirts (Camicie
rosse, Massimo Bubola).
Another beach, that of Boccadasse, was
the location of a young Gino Paoli’s ‘Bohème’ (Boccadasse, Gino Paoli), in a little
loft a hair’s breadth away from the sea and
the sky (La gatta, Gino Paoli), while the
Foce beach was sung by Bruno Lauzi (La
nostra spiaggia, Bruno Lauzi) and it is the
same place where a poor fisherman hopes
to land in order to take advantage of the
fresh water of the Bisagno creek (Le acciughe fanno il pallone, Fabrizio de André).
Going on, you can see the Lanterna, lighthouse of the city and witness of its
dreams and moods (Piazza Alimonda,
Francesco Guccini), Sampierdarena, with
its docks and farms (Le rime di Sampierdarena, Max Manfredi) and then, starting
from Pegli, again the beaches. In the middle, entrapped between the West and the
East, there is the port, with its busy access roads (L’ufficio delle cose perdute,
Gino Paoli), work (L’ufficio in riva al mare,
Bruno Lauzi) and briefcases (Natale fuoricorso, Max Manfredi).
And finally here is the port, where all
things arise and restart (All’ultimo amico,
Ivano Fossati); where a navigator set out
to reach Spain and, then, a new land
(Cristoforo Colombo, Francesco Guccini);
starting point for intercontinental voyages
(Ma come fanno i marinai, Lucio Dalla and
Francesco De Gregori), place of farewells
(D’ä mæ riva, Fabrizio De André) and returns (Il grande mare che avremmo attraversato, Ivano Fossati). And the return is
the obsessive thought of emigrants,
forced to leave, poverty-stricken (Preghëa
de ‘n’emigrante, Giorgio Calabrese for Gino
Paoli), who hope to see Genoa again, in
this life or in the other (Io e il mare,
Bruno Lauzi per Umberto Bindi).
Anche oltre i confini di questa vita, quindi, quello che conta è restare aggrappati con tutte le forze a quest’entità segreta e supposta che tanto tempo fa Francesco Petrarca, passando da qui, trovò
“regale, addossata a una collina alpestre, superba per uomini e
per mura, il cui solo aspetto la indica signora del mare”.
Because it is impossible to quit for good
this city “regal, superb, queen of the sea”
– in the words of the poet Francesco
Petrarca.
un po’ più al largo del dolore (…)
E son qui a guardare (…)
la tua foto da ragazza
per poter baciare ancora Genova
sulla tua bocca in naftalina.
da D’ä mæ riva di Fabrizio De André
La partenza, in nuce, implica già il ritorno, perché chi parte non
lo fa mai da solo. Di una città ci si porta sempre dietro qualcosa:
Dentro me
c’è una barca che non parte
dentro me
c’è un uomo che non sa
che bisogno c’è di partire per poi
non pensare che a tornare.
da Il grande mare che avremmo attraversato di Ivano Fossati
Nella testa di chi parte suo malgrado, di chi è costretto a
emigrare, invece, il ritorno è l’unico pensiero:
Vorrei, prima di morire,
potermene ritornare
nella mia Genova
che l’ho sempre avuta
dentro il mio cuore.
da Preghëa de ‘n’emigrante (Giorgio Calabrese per Gino Paoli)
E se non ci si riesce da vivi, si spera di ritornare dopo, per altre
strade, in altre forme:
So che tornerò
alla spiaggia della Foce
quando tornan le lampare
sarò tra i pesci
che avranno tirato su
rinchiuso tra le loro reti
gettate nel più profondo mare.
29
I dialettali
The dialectal songwriters
Lorenzo Coveri
Mettere in musica
la lingua di Genova
De André: un dialetto fatto ad arte
È l’estate del 1984. CRÊUZA DE MÄ, scritto con Mauro
Pagani, album concettuale di sette canzoni tutte in genovese, premio della critica discografica di quell’anno, considerato da David Byrne dei Talking
Heads tra i primi dieci titoli di world music del decennio, esplode clamorosamente nella già ventennale
carriera di Fabrizio De André (Genova 1940-Milano
1999), aprendone una nuova fase, e contemporaneamente dando luogo a quella stagione della canzone
“neodialettale” italiana che non si è ancora esaurita.
Per la prima volta, Fabrizio sembrava rendere più intimo, toccando le corde del dialetto, il rapporto con
la sua città, già presente, sia pure in maniera topograficamente sfumata, fin dai primi dischi; ma, come
aveva dichiarato, “CRÊUZA DE MÄ non è dedicato né
al genovese né a Genova, ma al bacino mediterraneo.
Io dovevo scrivere delle parole che rispecchiassero
letterariamente, perché sono sempre versi per canzoni, quello che è il mondo del Mediterraneo”.
Veniva così a compimento un lungo progetto, da
tempo meditato, che aveva visto tra l’altro come precedenti poco noti due canzoni, A famiggia di Lippe e
Ballata triste, scritte nel 1972 rispettivamente con
Peo Campodonico e Vito Elio Petrucci, per un album
del folksinger genovese Piero Parodi e recentemente
riedite da Parodi stesso. CRÊUZA DE MÄ, beninteso, è
lontanissima da quel folklore goliardico. Come De
André aveva confidato a Cesare G. Romana in una
citatissima intervista, raccolta nel libro Amico fragile,
“quella di un disco cantato nel mio dialetto, anzi
nella mia lingua, fu una voglia, per così dire, primordiale, nel senso che aveva le sue radici in quelle
mie e della mia gente. Me la portavo in pancia da
anni, forse da quando avevo cominciato a scrivere
canzoni e a tradurre Brassens, molti dei cui personaggi avrebbero potuto benissimo essere abitanti
dei nostri caruggi. Ma non avevo mai trovato l’incoscienza o la fede, o la chiarezza di idee sufficienti
a tradurre l’intenzione in fatti”.
32
Seguiva la cronaca della genesi del disco, con accenni
al poeta Mario Tortora, a Parodi, a Petrucci, a Campodonico, alle ricerche dell’etnomusicologo Edward
Neill, all’abitudine scherzosa, giocata sull’ assonanza
tra genovese e portoghese, di sposare il dialetto a
ritmi di samba e di bossanova, come avevano fatto i
fratelli Reverberi, Bruno Lauzi, Giorgio Calabrese e
soprattutto il grande, troppo presto dimenticato, Natalino Otto, e come farà qualche giovane esponente
della nuova scuola genovese di cantautori, come Fabrizio Casalino.
Ma “col tempo – è di nuovo De André che parla all’amico Romana – mi si rafforzò la convinzione che la via da seguire fosse
un’altra, e l’idea decisiva mi nacque dalla scoperta che la lingua
genovese ospita al suo interno oltre duemila vocaboli di provenienza araba o turca: un retaggio di antichi traffici mercantili,
comune soprattutto alle città di mare dell’area mediterranea. Allora, il genovese è la meno neolatina tra le lingue neolatine, mi
dissi. E cominciammo, con Pagani, a costruire delle trame musicali che rispondessero al progetto di un album mediterraneo,
con suoni, ritmi, strumenti della tradizione islamica, greca, macedone, occitana. Cominciai a scrivere i testi in un arabo maccheronico, che poi tradussi in genovese, o meglio nella lingua
di una Genova sorella dell’Islam”.
Si potranno discutere certe affermazioni, filologicamente azzardate. Ma l’intento è chiarissimo. E così, con l’apporto decisivo
di Pagani, con l’aria per gaida sola di Tracia di Domna Samiou,
parte, con un lamento da muezzin, il disco mediterraneo a lungo
sognato da Fabrizio. L’eco è enorme, a Genova e fuori Genova:
si ha subito la sensazione di un prodotto non locale, che fonde la
Setting to music
the language of Genoa
De André: an “artistic” dialect
CRêUzA DE Mä was published in summer 1984:
it is a concept album including seven songs
in the Genoese dialect, written by Fabrizio
De André and Mauro Pagani. The album immediately won the recording industry
critic’s prize and was considered by David
Byrne of Talking Heads one of the first ten
albums of the decade, opening a new phase
in De André’s twenty-year career and in the
field of Italian dialect music.
The album was the accomplishment of a De
André’s project started many years before,
that produced some goliardic folk songs
such as A famiggia di Lippe. De André always had the will to realise a whole album
Copertina dell’album di
Fabrizio De André
CRêUzA DE Mä , 1984.
Foto di Jay Maysel, grafica
Area di Comunicazione.
33
using the Genoese dialect, without being
reckless enough – he said – to do it.
The opportunity came after the discovery
of thousands of Arabic and Turkish words
in the Genoese dialect, so De Andrè started
realizing the album he had dreamed of, full
of Mediterranean atmospheres. CRêUzA DE Mä
actually opens with a muezzin’s lament and
moves away from the great ethnic tradition
of Genoese trallalero and other folk songs.
De André’s not accurate pronunciation and
the lexical selection show the “anti-dialect” and anti-folklore direction of this
album. Actually the dialect of CRêUzA DE Mä
is a poetical language artificially created
starting from real Genoese words and mixing the past and present background of the
city. So CRêUzA DE Mä is considered the prototype of that “neo-dialect” music which
in the Eighties opened a new era of renewal
in the Italian song context.
De André carried on the experience of
CRêUzA DE Mä in the multilingual album LE
NUVOLE (1990, music by Mauro Pagani), that
includes song in the Genoese dialect (Megu
megùn, A çimma), the Neapolitan dialect
of Don Raffaé (written with Massimo
Bubola) and the pseudo-German of Ottocento. The Genoese and Sardinian dialects
are also present in De André’s last album
ANIME SALVE, written in 1996 with Ivano Fossati (music by Piero Milesi), where the linguistic and stylistic variety is a way to
describe different types of humble people.
The ancestors
CRêUzA DE Mä, representing a turning point
in the Italian songwriters’ use of dialect,
originates from the popular anonymous tradition of Genoese trallalero and the dialectal songs of the Twenties, whose most
important authors were the tenor Mario
Cappello (Se ghe penso, 1925), the poet
Costanzo Carbone (Tranvaietti da Doia, Boccadaze, Madoninn-a di pescoei) and the comedian Giuseppe Marzari who, in the
postwar period, was the first to use the dialect not with a nostalgic look but for comical purposes.
Between folk and songwriter’s music
The modern generation of Genoese authors
took over from the folk and neo-dialect
music to write original melodies.
34
sonorità arcaica del dialetto con un suo riuso innovativo.
Ma che genovese è quello di Fabrizio, come suona alle orecchie
dei suoi concittadini dialettofoni? La prima impressione è quella
di straniamento. Nulla a che fare con la grande tradizione etnica
del trallalero genovese (CRÊUZA è stata inserita, con esiti non felici, nel repertorio di qualche squadra di canto popolare) o dei
cantanti dialettali più o meno folk. La dizione di De André, intanto, così accurata in italiano, in genovese è quella di un alloglotto. Si è detto, rozzamente, che De André non sapesse il
dialetto, o che lo pronunciasse male, come se questo fosse il
punto. Ma questo aspetto contribuisce semmai a spingere l’album
in direzione radicalmente “antidialettale”, cioè antifolclorica e
antipopolare. Del resto, da figlio della buona borghesia (con genitori non genovesi ma piemontesi – padre di Torino, madre di
Bra – e non dialettofoni), e formatosi adolescente nei dialettofobi
anni Cinquanta, Fabrizio non poteva, non doveva sapere il genovese. Era disdicevole, e solo la sua ostinazione da bastian contrario poteva portarlo a ricercarne gli echi nei vicoli della città
vecchia. Il dialetto come scelta anche antiborghese, insomma.
Ma, ancora, quale dialetto? Non solo la pronuncia di Fabrizio lo
rendeva quasi inaudito alle orecchie dei genovesi, ma anche le
sue scelte lessicali. Andrea Podestà ha cercato pazientemente nei
vocabolari le tracce del dialetto di CRÊUZA DE MÄ: ebbene, si
tratta di una vera e propria lingua poetica costruita a tavolino, ma
nello stesso tempo fatta di tante schegge di reale: varianti geografiche e diacroniche anche a breve distanza di verso (ganöffani
e garöfani, béive e béie) arcaismi e neologismi, italianizzazioni,
modi di dire antichissimi e metafore inedite, una lingua fuori del
tempo e dello spazio, fatta di quella stoffa di cui sono fatti i sogni,
costruita sfogliando il dizionario della memoria e dell’invenzione. La lingua di una Genova mai esistita ma che conteneva
tutte le Genove del presente e del passato, del centro storico e
delle periferie fino ai fondachi della Repubblica Marinara nel
Mediterraneo, Genova dei marinai, dei galeotti e delle puttane.
La fusione dei fonemi del dialetto con la strumentazione di Pagani estraeva poi dal genovese sonorità nuove, echi misteriosi,
vibrazioni inaudite. Un dialetto che più antivernacolare non
avrebbe potuto essere. Si può capire allora che CRÊUZA DE MÄ sia
stato considerato a ragione il prototipo di quella canzone “neodialettale” che dagli anni Ottanta in poi, in singolare coincidenza
con il recupero di una nuova dialettalità nella poesia lirica (Pier
Vincenzo Mengaldo, Franco Brevini), ha costituito uno dei principali momenti di rinnovamento del linguaggio canzonettistico.
Dopo il monolinguismo di CRÊUZA DE MÄ, è la volta del plurilinguismo di LE NUVOLE, ancora con Mauro Pagani, del 1990. Qui
troviamo non solo il genovese (in Megu megùn e A çimma, quasi
un’ eco, ma sociolinguisticamente più realistica, del disco dell’84);
c’è anche l’ultimo verso di La domenica delle salme, recitato con
forte intonazione regionale, come una citazione (“di vibrante protesta”); troviamo anche il napoletano “maccheronico”, dice De
André (e italiano popolare diatopicamente marcato), di Don Raffaé scritta con Massimo Bubola, quello digiacomiano di La nova
gelosia (dal repertorio di Roberto Murolo), e lo pseudotedesco (la musica sembra rinviare all’area austrobavarese o tirolese) di Ottocento con Pagani. Il
progetto mediterraneo di CRÊUZA si colorava dunque,
in NUVOLE, di una gamma di varietà più ampia, anche
con una valenza più esplicitamente ideologica.
L’interesse per gli umili e per le loro parlate è anche il
tema centrale del testamento spirituale di Faber, ANIME
SALVE, forse il suo capolavoro, scritto nel 1996 con
Ivano Fossati e arrangiato da Piero Milesi. Qui la scelta
plurilingue de LE NUVOLE diventa più programmatica
che stilistica o metrica (commentando CRÊUZA DE MÄ,
Fabrizio alludeva alla maggiore facilità di trovare nel
dialetto le parole tronche in fine di frase musicale che
in italiano, come è noto, non abbondano) e ancor più
universale che nelle due tappe precedenti. Sono nove
canzoni, nelle quali emergono nuove varietà linguistiche, e insieme nuove tipologie di umili, di ultimi, di
esclusi: come in Prinçesa (ispirata alla biografia di un
transessuale brasiliano scritta da Maurizio Janelli e
dallo stesso transessuale, Fernanda Farìas) dove l’enumerazione finale di oggetti in portoghese, un catalogo
di stampo surrealista, è quanto di più lontano dal similgenovese goliardico di cui si è detto, e suona come una
dolente litania, desiderio impossibile di recuperare l’infanzia e l’innocenza perduta.
E anche in ANIME SALVE tornano i dialetti-icona di Fabrizio, il sardo (solo evocato nel titolo di Disamistade,
la faida) e appunto il genovese, che fornisce il calco a
Le acciughe fanno il pallone, un titolo che sarà forse
piaciuto a Nico Orengo. In  cúmba, dialogo tra un
pretendente (Fossati) e il padre della futura sposa (Fabrizio), il dialetto si libera di ogni connotazione polemica e ridiventa puro gioco fonosimbolico, autonomia
del significante. Non è un caso che al poeta Roberto
Giannoni, uno dei maggiori poeti dialettali genovesi
viventi, piaccia, oltre che  cúmba, lo scioglilingua del
coro di Dolcenera (con Luvi De André e Dori Ghezzi),
ispirata all’alluvione di Genova del 1994: “Amíala ch’a
l’aría amía cum a l’è cum a l’è / amiala cum a l’aría
amia ch’a l’è lé ch’a l’è lé / amiala cum a l’aría amia
amia cum a l’è / amiala cum a l’aría ch’a l’è lé ch’a l’è
lé” [Guardala che arriva, guardala com’è com’è / guardala come arriva, guarda che è lei che è lei / guardala
come arriva, guarda guarda com’è / guardala come arriva che è lei che è lei] il cui fascino
“deriva, oltre che dalla struttura armonica, dalla
sincerità con cui si dà al dialetto una funzione puramente fonica, dimenticando per un attimo la duplice ipoteca del populismo e della sublimità
letteraria”.
E ancora Giannoni:
“Forse sta qui il modo vero, il senso ultimo del rapporto che De André ebbe con i dialetti. Perché al di
là dell’anelito al lirismo, proprio di ogni neodialettale, di là dall’immersione nella ‘realtà popolare’,
sognata da qualsiasi naródnik, v’era in lui una tendenza ad esiti fonosimbolici, parallela alla ricerca
timbrica compiuta sul piano musicale. Si sarebbe
tentati di dire, esagerando un poco, che gli strumenti esotici e i vocaboli sconosciuti alla lingua ufficiale convergessero in un’unica operazione, in
una medesima elaborazione del sound, e che il dialetto ligure fosse a quel punto un ingrediente timbrico, non dissimile da un flauto berbero o da un
mandolino circasso”.
Gli antenati
Anche se il 1984 di CRÊUZA rappresenta una svolta
per l’uso del dialetto nella canzone d’autore (intesa
come canzone di qualità artistica), l’operazione di De
André nasce su un terreno fertile, quello della tradizione popolare del trallalero studiato da Edward Neill
e da Mauro Balma (e che, ancor prima, Roberto Leydi
definiva una forma di canto maschile a cappella unica
nel panorama europeo, con corrispettivi solo in Sardegna e Georgia russa). Ma esisteva a Genova, fin
Copertina dell’album di Bruno
Lauzi GENOVA PER NOI, 1975.
35
popolare e poi anche di molti cantanti folk. Si costituisce così la tradizione di una canzone popolare genovese, che vede successivamente la presenza di
altre voci molto seguite, come quelle di Emilio Fossati, di Carlo Cinelli, di Gino Villa, di Mario Bertorello e altri.
Piero Parodi.
(Foto Petrosino)
Ma il personaggio più originale, secondo per popolarità forse soltanto a Gilberto Govi, è quello di Giuseppe Marzari (Genova 1900-1974, ora bene
illustrato in un volume di Cesare Viazzi), attore, cabarettista, umorista, cantante, autore dell’indimenticabile macchietta di O Scio Rattèlla (diffusa,
singolarmente, anche attraverso il mezzo del disco a
78 giri) e protagonista della popolarissima trasmissione della sede genovese della Rai A Lanterna, cui
si deve un uso del dialetto (un genovese del centro,
“portoliano”, che Marzari articolava con dizione
secca e precisa, come ha notato Franco Bampi) a fini
comici lontano le mille miglia da quel “consumo
della nostalgia” che caratterizzava tanti personaggi
della genovesità fino al dopoguerra, e anticipatore di
una comicità modernissima, con tratti surreali, che
avrebbe caratterizzato più avanti il filone di una sorta
di “via genovese” all’ironia paradossale (si pensi soltanto a Paolo Villaggio) tutt’altro che trascurabile.
dagli anni Venti, anche una tradizione di canzone dialettale d’autore (intesa, questa volta, come canzone
non anonima, a differenza del trallalero), forte di una
sua vita locale ma non sotterranea, con interpreti, autori di testi e musiche, rassegne, e soprattutto un pubblico appassionato.
Il “padre” della canzone dialettale genovese è senz’altro il tenore Mario Cappello (Genova 18951954), interprete (e autore del testo) di quel Se ghe
penso (1925; il più noto titolo con premesso un Ma
è successivo) con la collaborazione musicale del
maestro Attilio Margutti, diventato nel tempo una
sorta di inno nazionale della genovesità (e, absit iniuria verbis, anche modello di certi stucchevoli succedanei canzonettistici locali giocati esclusivamente
sul filo della nostalgia).
36
Altro grande protagonista di quegli anni, il poeta e
poligrafo Costanzo Carbone (Genova 1884-1955, cui
rende giustizia una bella monografia di Balma, Ferloni e Laura), autore di moltissimi testi cari ai genovesi (Tranvaietti da Doia, Boccadaze, Madoninn-a
di pescoei, Ciassa de Pontexello, Foxe…) perché entrati nel repertorio di Cappello, delle squadre di canto
Tra folk e canzone d’autore
A cavallo tra il folk, la canson zeneize e le nuove
esperienze della canzone d’autore in dialetto si collocano alcune figure di cantanti e interpreti che, in
una carriera di lungo corso, hanno saputo via via raccogliere nuovi stimoli e proporsi in modo sempre
inedito a un pubblico di aficionados. È il caso del
folksinger di Sestri Ponente Piero Parodi (Genova
1935), che, partendo dal successo storico (centocinquantamila copie) della divertente canzone scioglilingua ‘A Seissento (1963), ha saputo confrontarsi
con la canzone neodialettale e collaborare con i maggiori protagonisti della scena genovese (tra i quali il
gruppo rock La Rosa Tatuata del figlio Max, prematuramente scomparso), fino ad approdare ad esiti di
rilievo con CONTIME ‘NA STOJA (1999), summa della
sua fortunata carriera (una quarantina di singoli a 45
giri, una dozzina di vinili) e i più recenti GENOVA (Pe
fase ricordà) e FUENTA (che contiene tra l’altro un
remake de ‘A Seissento, diventata ‘O computer).
Grandissimo il successo di pubblico anche del duo I
Trilli (1971-1997), ossia Pucci [Giuseppe Deliperi]
(Genova 1942-1997) e Pippo [Giuseppe Zullo] (Genova 1948-2007), lanciati da un altro sestrino, Michele [Maisano] e dallo sturlino Giorgio D’Adamo
dei New Trolls, che hanno mescolato con grande
Sergio Alemanno
con Marco Spiccio.
(Foto Garibaldi)
verve brani della tradizione e composizioni nuove tra umorismo
goliardico (i popolarissimi stornelli che prendono il nome dal
gruppo) e nostalgia, sin dal primo disco (CANTI DE CASA MAE,
1972) attraverso una decina di album (il nome e il repertorio dei
Trilli sono ora ripresi da Vladimiro Zullo, figlio di Giuseppe,
con Francesco Zino e Fabio Milanese).
Altro personaggio di quella Sturla canterina di “Gianni a Sturla”
e dello studio G (di Gianni De Scalzi, padre di Vittorio e di Aldo)
che per qualche anno ha rappresentato il crocicchio musicale dei
genovesi è stato il pittore (autore della copertina di SENZA ORARIO SENZA BANDIERA dei New Trolls) e cantautore Bunni [Benito
Merli] (Montepiano Vernio FI 1923-1993), la cui vocazione è
ripresa dal figlio Matteo.
It’s the example of the folksinger Piero Parodi, who, starting from the tong-twister
song A Seissento (1963), worked with the
main protagonists of the Genoese scene in
the remarkable albums CONTIME ‘NA STOjA,
GENOVA (Pe fase ricordà) and FUENTA.
A great success is also that of I Trilli
(1971-1997), Pucci [Giuseppe Deliperi] and
Pippo [Giuseppe zullo], who from their first
album (CANTI DE CASA MAE, 1972) mixed traditional songs and new compositions between goliardic humour and nostalgia.
E ha iniziato a Sturla, giovanissima, col folk anche Franca Lai
(Genova 1953), la cui vasta popolarità di interprete (anche in
italiano), di autrice e di intrattenitrice si deve tra l’altro alla sua
partecipazione in numerosi programmi delle televisioni locali.
Gianni De Scalzi’s Studio G was the training
place of the painter and songwriter Bunni
[Benito Merli] who realised the cover of
New Trolls’ album SENzA ORARIO SENzA BANDIERA.
E infine Sergio Alemanno è forse più noto come personaggio
(raccoglie tutto; e non a caso la sua canzone più celebre è ‘O
strassé, scritta nel 1970 per Bruno Lauzi; ha avuto un momento
di grande esposizione mediatica quando ha portato al Maurizio
Costanzo Show la sua idea di “serenate su commissione”) che
come artista e cantante. Ma ingiustamente, perché rappresenta
l’anello di congiunzione tra una certa tradizione folk e la canzone d’autore.
Folk music was the starting point also of
Franca Lai, singer, songwriter and showwoman, and Sergio Alemanno, who in 1970
wrote ‘O strassé for Bruno Lauzi.
After De André: not only Genoa
After CRêUzA DE Mä, it needs to go on the Ligurian Riviera, to find new and original
melodies.
37
Bubi [Angelo] Senarega, from Camogli, set
to music Edoardo Firpo’s dialectal poems in
the cd AVEVAMO CERTE FACCE TIPO FOTO DOPOGUERRA
(2010).
Marco Cambri, from Neirone, wrote about
the rural life of Ligurian farmers, their
work, their effort, the sadness of emigration, using a true Ligurian dialect (A CURPI
DE PRìA, 2004; VIVO).
Antonio Lombardi, from Ameglia (La
Spezia), is another songwriter who started
from the work of a dialectal poet (Paolo
Bertolani) to write the beautiful album
RAITà (2009), written together with the Gnu
Quartet and winner of the Premio Lerici Pea.
The bands
In the Eighties in Italy started a music
movement that came from the rasta jamaican culture (reggae, ragamuffin) and
afro-american ghetto music (rap) and
found in the use of dialect its peculiarity.
The use of dialect represents here a request
of protest, alternative and antagonism. The
most important experience is that of the
band Sensasciòu (winners of the Targa
Tenco award in 1997) and the “trallamuffin” of the albums CANGIA ‘STA VITTA (1994),
IN SCIO BLEU (1995) and IN SCIA LUNN-A
(1996). The reggae is the universe of the
band I Bìnduli, while the Blindosbarra
refers to funk music: its first album of 1993
includes some songs in Genoese dialect,
such as CULMV, dedicated to dock workers.
Other contemporary bands are more dedicated to folk music: we can here remember
the band Orchestra Bailam (the album
GALATA is an interesting fusion of trallalero
and Middle Eastern rithms), La Combriccola, La Bandassa and I Mandillà (which
plays De André’s song, sometimes translated in the Genoese dialect).
Dialect for delight
Many songwriters of the “scuola genovese”
wrote and interpreted songs in the Genoese
dialect for “delight”, nostalgia or tribute to
the tradition, starting from the songwriters’
pioneer Natalino Otto [Natale Codognotto],
who spread the swing in Italy with Alberto
Rabagliati and published some 45 rpm albums in the Genoese dialect: the most
38
Dopo Faber: non solo Genova
Non è forse privo di senso il fatto che, dopo il genovese di
CRÊUZA, occorra andare fuori città, in Riviera, per trovare accenti
inediti, o inauditi.
Dopo un quarantennio di attività artistica (e di impegno nel sociale), il camoglino Bubi [Angelo] Senarega pubblica finalmente
il suo cd AVEVAMO CERTE FACCE TIPO FOTO DOPOGUERRA (2010,
con presentazione di Silvio Ferrari), dedicato in buona parte alla
messa in musica di poesie di Edoardo Firpo, il maggiore poeta
dialettale del Novecento ligure: scommessa audace, perché di solito sono le parole a doversi adattare alla musica, e non viceversa.
In questi casi Senarega si limita infatti ad un recitativo con la sua
bella voce da basso e commento musicale di chitarra, ma laddove
il sound è affidato alla suggestione fonica del dialetto non meno
che alle note (come nella litania Magazin mediterraneo, elenco
sterminato di oggetti dal nome esotico o desueto), l’effetto è
molto suggestivo. “Dalle prove ‘iniziali’ dedicate alle tragedie
storiche e politiche dell’Europa (Varsavia) e del nostro Paese
(Mariolina X), attraverso la rivisitazione della propria infanzia,
del proprio angolo di Liguria, dei propri indelebili miti sportivi
(Mae nonno o l’Angeo, L’olmo del Boschetto, Fostò) passando
per una lirica descrizione delle figure di una Camogli scomparsa
(Ciao vecchio Joe), per raggiungere la migliore qualità espressiva
nella trasposizione di alcune poesie del grande poeta genovese
già citato e nella lettura del Mediterraneo compiuta da un intellettuale come Predrag Matvejevic, siamo finalmente in grado di
apprezzare la ‘voce’ di Senarega” (Silvio Ferrari).
Da Neirone (ma è nato a Quinto) la voce di Marco Cambri (A
CURPI DE PRÌA, 2004; con un seguito in VIVO) arriva netta e scabra
come la pietra, la pria neigra, l’ardesia, dalle viscere di quella
Liguria rurale di cui si è dimenticata l’esistenza. La Liguria della
fatica, del lavoro dei campi regolati dalle fasi della lunn-a, delle
fasce, delle falci e dei falcetti affilati a curpi de pria, dell’emigrazione, della nostalgia di un mare/male (nel dialetto, significativamente, omofoni e omografi: ma) di cui si avvertono solo gli
echi lontani in una ninnananna (Ninnamì), del vino rosso che
brilla nel bicchiere all’ostaia, delle feste di pàise, dei personaggi
come l’Angiolinn-a e il Sarvaego, dell’amore nato in balera a
tempo di tango (Rissi, dove chitara fa rima con mascara). Quadretti e ritratti di evidenza narrativa e visiva che non hanno nulla
di elegiaco o di idillico. Il dialetto (genovese con qualche venatura lessicale – despetaddo ovvero dispettoso – e fonetica della
Fontanabuona) è un dialetto reale e carnale, non quello sognato
e ricostruito in direzione mediterranea da De André. Il percorso
di Cambri (“antiDeandré” in quanto cantore non della Liguria
dei marinai, ma della Liguria dei contadini) è del tutto autonomo,
non c’è né contrapposizione alla cultura in lingua né sterile nostalgia o sogno di un passato lontano nel tempo e nello spazio.
Cambri, con il suo viso di apache che sembra scolpito anch’esso
nell’ardesia, assomiglia solo a se stesso. Il suo dialetto non risponde a una moda, non è né naif né intellettualistico: è, semplicemente, necessario. È la voce degli ultimi, dei dimenticati, di
Sensasciou al Tenco 1997.
(Foto Brenzoni)
chi non appare, che sgorga potente e inedita (perché
inaudita) dalle sue note. E anche la tradizione popolare musicale (giga, valzer, mazurca, ritmi di banda,
girotondi di figgieu) sembra qui reinventata e riproposta per la prima volta dal suo affiatatissimo gruppo
(Fabrizio Padoan anche arrangiatore, Marco Cravero,
Mauro Panzeri, Alfredo Vandresi, Fiorella Zito; poi
Filippo Gambetta, Roberto Izzo, Pino Parello, Marica
Pellegrini) con freschezza e perentorietà. Un progetto
covato per anni, pensato e lavorato come la pietra.
E bisogna spingersi sino all’estremo lembo di Liguria, ad Ameglia (La Spezia), per ascoltare la voce ligure-toscana di Antonio Lombardi che, dopo SEINÀDA
DE MAE [“Serenata di mare”] (con Armando Corsi),
ha, tra l’altro, messo in musica dieci poesie del poeta
(della Serra di Lerici) Paolo Bertolani in RAITÀ [“Rarità”] (2009, con lo Gnu Quartet, Premio Lerici Pea
2009). Così il cantautore:
“Ho conosciuto Paolo Bertolani in dialetto, nel nostro “codice”, che permette di scambiarsi, di capirsi, di entrare facilmente. Con la sua mancanza
mi sono accorto che era già tutto scritto, il suo
mondo un po’ mi apparteneva, e rileggendolo intensamente, in soli due giorni sono scese giù quelle
che ho impaginato come canzoni. Per me è scontato
scrivere con la chitarra, e ancor di più quando le parole già scritte sono così profonde da rapirmi, insegnarmi e incantarmi”.
Le band
Accanto al filone della canzone “neodialettale” d’autore nasce e si sviluppa anche a Genova, a partire dagli
anni Ottanta, un movimento che si può collegare alla
cultura rastafariana della Giamaica (reggae, raggamuffin) e dei ghetti afroamericani (rap): una corrente tutta
d’importazione, ma che trova la sua curvatura locale
nell’uso del dialetto, un dialetto “sporco”, spesso contaminato con l’italiano e con altre lingue. Qui l’uso
del dialetto assume una valenza ideologicamente ben
spiccata, oltre a quella – cui accennava già De André
– di maggiore duttilità ritmica e metrica: una richiesta
di contestazione, di alternativa, di antagonismo.
L’esperienza più interessante è quella del gruppo (oggi
disciolto; Targa Tenco nel 1997) dei Sensasciòu (con
gioco di parole tra “fiato” e “show”), coagulato attorno
a Bob “Doc” Quadrelli, figura storica dell’underground locale, che fa del “trallamuffin” (contaminazione del trallalero con il raggamuffin) negli album
CANGIA ‘STA VITTA (1994), IN SCIO BLEU (1995) e IN
SCIA LUNN-A (1996), con un dialetto, come avevano dichiarato, “reimparato dai nonni”. Riuscito esperimento
intergenerazionale,
con
tracce
di
mistilinguismo (del gruppo fa inizialmente parte il senegalese Jacques Badji, che canta inserti in lingua
wolof ): “Canto zeneize in a ramadan style, canto
zeneize in a ramadan dub. Sentilo ben sto ritmo,
tegnilo ben, piggilo, piggilo e tegnilo ben”.
All’area reggae fanno riferimento anche i Bìnduli. E
si collocano piuttosto nella zona del funk i disciolti
39
Blindosbarra (è la denominazione di un conduttore ad
alto voltaggio usato nel porto di Genova; i componenti erano tutti figli di camalli), con quattro album
tra il 1993 e il 2002, il primo dei quali, con il titolo
del gruppo, contiene alcuni brani in genovese, tra cui
CULMV, dedicato ai portuali.
I Blindosbarra.
(Foto Patrizia Lanna)
Più legate al filone folk restano alcune band attive
negli ultimi anni, come l’Orchestra Bailam (interessante contaminazione tra il trallalero e ritmi mediorientali, con l’album GALATA), la Combriccola, la
Bandassa di Enzo Guido e i Mandillà (tribute band di
De André, che hanno voltato in genovese anche suoi
brani in italiano).
Dialetto per diletto
Non sono pochi i cantautori della sempre negata
(dagli stessi protagonisti) “scuola genovese” che, per
“diletto”, per nostalgia, per omaggio, si sono misurati,
più spesso come interpreti, col dialetto nativo (o acquisito).
A partire da quello che è considerato, a ragione, il
precursore dei cantautori, prima che la parola stessa
nascesse nel 1960: il grande, troppo presto dimenticato, Natalino Otto [Natale Codognotto] (Cogoleto
Genova 1912 - Milano 1969), iniziatore (con Alberto
Rabagliati) dello swing in Italia. Negli anni ’60 Otto
incise per la sua Telerecord alcuni 45 giri in genovese
(Madaenna/O pescòu, 1964; Me son innamuòu de
ti/Texo, 1965), tra i quali il più significativo rimane
Bossa figgieu/Arrio (1964) per la parodia del brasiliano (qui bossa vale “occhio, attenzione”; e oggi bossare è del gergo giovanile per “marinare la scuola”;
ma naturalmente si strizza l’occhio al ritmo carioca)
che poi verrà ripresa da molti altri.
Per esempio da Bruno Lauzi (Asmara, Eritrea 1937 Peschiera Borromeo 2006), che ha pure spesso giocato sulla affinità fonica tra genovese e portoghese
del Brasile, come nel suo più grande successo del genere, il 45 giri (con lo pseudonimo Miguel e i Caravana) ‘O frigideiro (1962, di Calabrese-LauziCalabrese-Reverberi), su ritmo di bossa nova, ripreso
anche dai Buio Pesto, e in altre canzoni (Sto ciccheton
de ‘n Gioan, A bertoela di Calabrese-Lauzi-Reverberi, la filastrocca Finale Ligure) inserite in dischi in
italiano.
E così da Gino Paoli (Monfalcone 1934), che nella
sua lunghissima vicenda musicale ha trovato spazio
per un 33 giri Durium (che doveva essere l’inizio di
una serie, anche con canti partigiani), CIAO SALUTIME
UN PO’ ZENA (1975), con classici della tradizione popolare come Ma se ghe penso e A canson da Cheullia.
Anche il popolarissimo Joe [Rino Luigi] Sentieri
(Genova 1925 - Pescara 2007), dopo aver tradotto in
dialetto alcuni chansonnier francesi, si era dilettato,
verso la fine della carriera, di interpretare canzoni genovesi popolari (POPON DE PESSA, 1971) o d’autore
(RINO “JOE” SENTIERI CANTA GENOVA, 1996).
40
E naturalmente Ivano Fossati (Genova 1951) che, da
buon conoscitore del genovese come lingua materna,
prima collabora con Fabrizio de André alla stesura
dei testi di Megu Megùn e di A çimma, ghiotta ricetta
in musica che risente delle poesie dialettali di Martin
Piaggio e di Aldo Acquarone (in LE NUVOLE, 1990),
poi interviene come coautore con Faber (una entente
non sempre pacifica) di ANIME SALVE (1996), dove si diverte a
interpretare (con dizione sicura) la parte del pretendente in ‘A
cumba.
Dopo aver spesso frequentato il genovese nella sua fortunatissima carriera con i New Trolls, anche Vittorio De Scalzi (Genova
1949) ha finalmente pubblicato nel 2008 un album tutto suo in
dialetto, MANDILLI (arrangiato dallo stesso Vittorio col fratello
Aldo), dieci tracce che fondono al meglio, con partiture di prim’ordine, tradizione (a Gente de Liguria partecipano i Canterini
della Vecchia Sturla) e cantautorato (soprattutto del De André
“mediterraneo”).
Hanno cantato in dialetto anche Max Manfredi (Genova 1956),
che tra le sue ricche esperienze annovera anche la partecipazione
alla squadra di trallalero A Rionda (unica in cui il posto del soprano, ‘o primmo, è occupato da una donna, Laura Parodi), e
Gian Piero Alloisio (Ovada 1956), autore del divertente blues,
“inno dei coltivatori delle piantagioni di basilico”, Baxeicò (interpretato anche dal gruppo dei Cavalli Marci; ora in OGNI VITA
È GRANDE, 2012), e i più giovani Zibba [Sergio Vallarino] (Varazze 1978) con gli Almalibre (in gruppo dal 1998), che ha cantato O mae ma (featuring Vittorio De Scalzi, in COME IL SUONO
DEI PASSI SULLA NEVE, Targa Tenco 2012) e ‘O frigideiro (in E
SOTTOLINEO SE, 2013, omaggio a Giorgio Calabrese). Si sono cimentati col genovese anche musicisti del calibro di Paolo Bonfanti (Genova 1960), Beppe Gambetta (Genova 1955), Bob
Callero (Montoggio GE 1950).
Dialetto al femminile
Nella pattuglia, sempre più numerosa, di cantautrici, non è facile
trovare chi si sia dedicata esclusivamente al dialetto. Poco più
che episodici, anche se di grande impatto mediatico, devono
considerarsi le incursioni da interpreti nel genovese-bandiera di
Ma se ghe penso di Mina (nel 1967) e di Antonella Ruggiero
(Genova 1952) nel suo tributo ai cantautori di GENOVA, LA SUPERBA (2007), con cover di Bindi, Tenco, Lauzi, Paoli, De André,
De Scalzi. Anche Claudia Pastorino ha voluto tentare un’incursione nel suo dialetto rivisitando (con Bob Callero) la popolare
Lanterna de zena (nell’album INVENTARE L’ALLEGRIA, 1997).
Ma è a Roberta Alloisio che si deve il più significativo esperimento di declinare il dialetto (genovese con qualche inflessione
monferrina, essendo nata a Ovada) sul versante femminile.
Brava esponente (spesso insieme al fratello Gian Piero) del teatro-canzone, buona presenza scenica (derivante dalla sua esperienza col Teatro della Tosse), nell’album LENGUA SERPENTINA
(con l’Orchestra Bailam, 2007, arrangiamenti principali di
Franco Minelli) Roberta si misura con la grande tradizione popolare e letteraria della Liguria, dagli stornelli di Ceriana (da cui
la title track) a testi anonimi come Primma che t’abandun-ne,
da verseggiatori antichi (audace e riuscito è il tentativo di mettere in musica, con la complicità di Gian Piero, le rime dell’Anonimo Genovese due-trecentesco, padre della tradizione dialettale
relevant is Bossa figgieu/Arrio (1964),
where he took advantage from the similarity between Genoese and Portuguese language to write a parody of Brasilian music.
Bruno Lauzi wrote many songs using the dialect: just like Natalino Otto, he also published a parody of Brasilian bossa nova, ‘O
frigideiro (1962), also played by the band
Buio Pesto.
Gino Paoli sang some classic dialect song
such as Ma se ghe penso and A canson da
Cheullia in the 33 rpm album CIAO SALUTIME
UN PO’ zENA (1975).
joe [Rino Luigi] Sentieri, after having
translated many French chansonniers’ songs
in the Genoese dialect, released two albums including some Genoese songwriters’
songs and songs of the tradition (POPON DE
PESSA, 1971 and RINO “jOE” SENTIERI CANTA GENOVA, 1996).
Ivano Fossati collaborated with Fabrizio de
André in the writing of some songs in Genoese dialect for the albums LE NUVOLE
(1990) and ANIME SALVE (1996).
Vittorio De Scalzi, leader of the band New
Trolls, in 2008 published MANDILLI, a solo
album of dialect songs.
Copertina dell’album di
Gino Paoli CIAO SALUTIME
UN PO’ zENA, 1975.
Disegno di Gino Paoli.
41
zibba in una foto del 2012.
(Foto Brenzoni)
Other contemporary songwriters performed
in the Genoese dialect, such as Max Manfredi, who was a member of the trallalero
band A Rionda, Gian Piero Alloisio, author
of the funny blues Baxeicò (also played by
Cavalli Marci), zibba [Sergio Vallarino] and
the Almalibre, who sang O mae ma (featuring Vittorio De Scalzi, in the album COME IL
SUONO DEI PASSI SULLA NEVE, Targa Tenco 2012)
and ‘O frigideiro, even other excellent musicians as Paolo Bonfanti, Beppe Gambetta
and Bob Callero dealed with dialect.
Dialect and the women
Many female songwriters wrote using the Genoese dialect, even none of them dedicated
exclusively to it. It’s worth remembering the
performances of Mina (Ma se ghe penso,
1967) and Antonella Ruggiero’s cover album
GENOVA, LA SUPERBA (2007), where she sang
hits of Bindi, Tenco, Lauzi, Paoli, De André
and De Scalzi. Claudia Pastorino revisited
with Bob Callero the popular song Lanterna
de Zena in the album INVENTARE L’ALLEGRIA
(1997). Roberta Alloisio’s album LENGUA SERPENTINA (2007) was a remarkable project
where she measured herself with the big
popular and literary Ligurian tradition and
that continued in the multilingual album
jANUA (Targa Tenco 2011 for the best singer).
Dialect on stage
More than in music, the Genoese dialect is
used in theatre by comedians for cabaret
and mise-en-scenes taken from tradition.
We can remember here the performances of
Buio Pesto, a group of musicians and actors
that also published a dozen of albums
(from BELINLANDIA, 1995 to BUIO PESTO,
2014), but also the songwriter and comedian Fabrizio Casalino and the rock-blues
guitarist lent to cabaret Marco Manusso.
From one De André to another
Cristiano De André took over from his father Fabrizio in two tours (2009-10) that
preceded the publishing of the albums DE
ANDRé CANTA DE ANDRé (vol. I, 2009 and vol.
II, 2010,). He also wrote in the Genoese
dialect a verse of the song Invisibili (an
homage to Fabrizio and the city of Genoa)
that won the Critic Prize at the Festival of
Sanremo 2014 and is included in the album
COME IN CIELO COSì IN GUERRA, 2014.
42
ligure) a poeti più vicini a noi (gli ottocenteschi Giambattista
Vigo e Bepìn da Cà, savonese). E non manca il Dante di Paolo
e Francesca dall’Inferno V (“amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”…) nella traduzione in vernacolo (1905) del Padre Angelico F. Gazzo (“l’amou, che int’un cheu fin lesto o
s’açende”…). Virtuosistico. Il progetto ha il suo seguito nell’album plurilingue JANUA (2011, arrangiamenti principali di Fabio
Vernizzi), dedicato alla donna “strega” e “venditrice di vento”
(e Venditrici di vento è un bel brano di Max Manfredi, anche
voce recitante con Adolfo Margiotta), tra italiano aulico e canto
popolare, tra provenzale e, naturalmente, dialetto (il seicentesco
Gian Giacomo Cavalli con “Donna, serpente de l’inferno crùa”,
ancora il Cava, l’anonima Lanterna de zena e la classica Ave
Maria zeneize di Piero Bozzo e del maestro Agostino Dodero,
grande protagonista del genovese in musica). Il disco, che ha
avuto importanti collaborazioni musicali (Mario Arcari, Armando Corsi, Marco Fadda, Piero Milesi, Esmeralda Sciascia)
e ha ricevuto la Targa Tenco 2011 per la migliore interprete, rappresenta (per adesso) il più maturo approdo di Roberta Alloisio
alla canzone d’autore.
Dialetto in scena
Prevalentemente parodistico e comico, o paragoliardico (secondo una tradizione secolare che si può far risalire addirittura
alla Commedia dell’Arte) è l’uso del dialetto in contesti teatrali
o cabarettistici. Prima che un fenomeno musicale, sono un fe-
nomeno mediatico gli impenitenti bogliaschini dei
Buio Pesto, ironici sin dal calembour del nome, capeggiati dal carismatico Massimo Morini (tra l’altro
recordman di direzione d’orchestra al Festival di
Sanremo), che in oltre vent’anni di attività hanno totalizzato non solo una dozzina di album (da BELINLANDIA, 1995 a BUIO PESTO, 2014), ma sei film,
centinaia di concerti pubblici, decine di partecipazioni e una intensa attività di promozione e di merchandising (e di trovate, e anche di beneficenza).
La chiave del successo dei Buio Pesto consiste soprattutto nella proposta di cover di hit internazionali
in versione dialettale (da Macarena a Dragostea din
tei a Waka Waka), non di rado licenziosa, in cui il
cortocircuito tra i due codici sortisce un effetto esilarante.
Aveva iniziato come cantautore, con il classico accostamento genovese-brasiliano, anche Fabrizio Casalino (Genova 1970), che poi si è impegnato
soprattutto sul fronte cabarettistico (è una presenza
fissa di zelig); ed è anche cabarettista il chitarrista
rock-blues genovese, ma romano d’adozione, Marco
Manusso.
Da un De André all’altro
Dopo avere a lungo esitato, come oppresso dal peso
di quel cognome, il figlio primogenito di Fabrizio,
Cristiano De André (Genova 1962), già impegnato
come abile polistrumentista nei concerti dal vivo del
padre, ne raccoglie in pieno l’eredità in due tour
(2009-10), da cui i due album (con dvd) DE ANDRÉ
CANTA DE ANDRÉ (vol. I, 2009; vol. II, 2010, arrangiamenti di Luciano Luisi), che contengono tra l’altro Mégu megùn, A çimma, ‘A duménega, Crêuza de
mä. La dizione del dialetto, calcata su quella che si
potrebbe definire la “lingua-padre”, non è sempre
perfetta, ma sull’effetto “postumo” (fastidioso in
certi casi, come per esempio quello di Natalie Cole
in Unforgettable) prevale quello della continuità artistica, per cui l’emozione è intatta.
E al genovese Cristiano è tornato autonomamente in
una quartina di Invisibili (Ferraboschi-Cristiano De
André), presentata al Festival di Sanremo 2014 (poi
nell’album COME IN CIELO COSÌ IN GUERRA, 2014,
produzione e arrangiamenti di Corrado Rustici), che
è insieme un tributo a Fabrizio e alla città natale di
entrambi. Un ritorno, un incontro, una pacificazione:
“ma òua che se vedemmu” / “ma òua che ghe vedemmu” [ma ora che ci incontriamo / ma ora che
riusciamo a vedere] è la felice ambiguità che solo il
dialetto riesce ad esprimere.
E così il cerchio del dialetto nella canzone d’autore,
aperto in quel lontano 1984 di CRÊUZA, può dirsi
chiuso. Almeno per il momento.
Roberta Alloisio.
(Foto Molteni)
43
I classici
The Classics
Alberto Bazzurro
Enrico de Angelis
Guido Festinese
Sergio Secondiano Sacchi
Jacopo Tomatis
Renato Tortarolo
Margherita zorzi
Diverso da chi?
Umberto Bindi,
il primo (quasi)
cantautore
Jacopo Tomatis
Umberto Bindi è il meno ascoltato dei primi cantautori,
il più diverso, il più difficile da razionalizzare secondo
la nostra idea di cantautore. Nato a Bogliasco – e dunque sulla carta perfetto rappresentante della cosiddetta
“scuola genovese”, composta perlopiù da genovesi nati
altrove – è stato iscritto nella storia della canzone d’autore italiana come un’anomalia. Da un lato, sfogliando
la ricca pubblicistica sul genere, si ha a volte l’impressione che ci si senta quasi costretti a “canonizzarlo” vicino ai Paoli e ai Tenco. Lui che, tecnicamente
parlando, componeva solo le musiche delle sue canzoni, affidandosi a “parolieri” (per quanto di riconosciuto valore come Giorgio Calabrese). Dall’altro, a
fronte di migliaia di pagine scritte sui primi cantautori,
Bindi risulta decisamente sottoindagato.1 Alcuni collegano la sua “diversità” con l’omosessualità prima negata e poi pudicamente nascosta, che favorì sicuramente
il suo isolamento artistico e l’allontanamento dagli spazi
televisivi e discografici. Discriminato da un sistema
musicale che mai ha brillato in quanto a progressismo,
quasi sicuramente. Ma il cantautore, nel senso comune,
è associato ad un’immagine maschile (talvolta maschilista: basti pensare a molti classici della canzone d’autore) molto più di quanto comunemente si pensi, o si
voglia pensare. In Italia, i cantautori omosessuali dichiarati sono rari, e altrettanto rare – fino a tempi recenti
– sono state le cantautrici.
Molti ricordano Bindi come musicista dotato e raffinato,
di studi classici, l’unico vero musicista fra i primi cantautori, perlopiù descritti come artisti naïf dediti all’abuso del giro di do. È questo da sempre un grande
paradosso di chi ha scritto della canzone d’autore italiana
come se fosse poesia, fino a passaggi che suonano come
veri e propri lapsus: “È improprio definirlo un cantautore
perché era più esattamente un musicista”, scrive ad
esempio Paolo Jachia (La canzone d’autore italiana
1958-1997, Feltrinelli, Milano, 1998, p. 55). Altri ancora, ad esempio Leonardo Colombati (La canzone italiana 1861-2011: storie e testi, Ricordi-Mondadori,
Milano, 2011, p. 775), riportano di come Bindi, in
mezzo ad amici appassionati di Kafka e Rimbaud, fosse
l’unico a non essere un “lettore forte”. Vista la tradizione
della pubblicistica sulla canzone d’autore in Italia, scrivere di Bindi – non potendolo trattare come un poeta –
è più difficile: bisogna parlare di musica, o di altro.
Basta questo – “musicista”, omosessuale, non intellettuale – a fare di Bindi un personaggio laterale, problematico, non ignorabile nella sua importanza e
statura artistica ma derubricato ad eccezione che
conferma la regola. Diverso, in ogni senso.
46
Questa strana posizione assunta da Bindi è comprensibile solo se la si colloca nel contesto dell’ideologia
del cantautore che si è codificata in Italia a partire dai primi anni
Sessanta, e poi soprattutto, nel corso dei Settanta, con il successo
del Premio Tenco come “luogo” – mentale, fisico e simbolico –
della canzone d’autore. La storia del concetto di
“cantautore” molto deve, naturalmente, all’invenzione di quella
strana parola – cantautore – e a tutte le connotazioni estetiche, di
autorialità e di autenticità, che recava in sé fin dall’inizio. Partendo da queste idee in potenza, il cliché – acustico, visivo, comportamentale – del cantautore così come lo conosciamo si è
costruito poco a poco intorno ad alcune figure carismatiche e a
determinati stili personali: Gino Paoli in una prima fase, Luigi
Tenco, e poi soprattutto, dalla fine dei Sessanta, Fabrizio De
André, fino ai nuovi cantautori dei Settanta, alla Guccini. Ancora
oggi, nel senso comune (che potrà pure essere criticato, ma che è
un dato non ignorabile) l’identikit del cantautore non sembra discostarsi poi troppo da quello di questi personaggi fondamentali,
spesso essi stessi ridotti ad alcuni tratti caratterizzanti: i testi impegnati o esistenziali; un certo tipo di vocalità, con estensione limitata e nel registro medio-basso, a volte con peculiarità di
pronuncia; un certo modo di stare sul palco; un certo modo di accompagnarsi con la chitarra, e così via.
In questo percorso, da questo punto di osservazione contemporaneo, Bindi appare – appunto – diverso.
Different from whom?
Umberto Bindi, the first
(almost) songwriter
Umberto Bindi is the least heard and least
studied of the first generation of songwriters. In the history of Italian songwriters he
is considered a sort of anomaly. Partly because of his homosexuality, which caused
his discrimination by a music environment
that has never stood out for its progressiveness, partly because of its purely musical vocation that makes him the less
“intellectual” among the songwriters.
Mainly because of the distorted idea that
has been associated with the concept of
singer-songwriter, that he has come to assume some characterizing traits, same
clichés that are also physically embodied
by some charismatic characters of the Sixties and Seventies (Gino Paoli, Luigi Tenco,
Fabrizio De Andrè, Francesco Sinatra): the
Umberto Bindi nel 1957.
(Foto Leoni)
47
profound or existential lyrics, a certain kind
of vocal style, with limited extension and
lower-middle register, sometimes with peculiarities of pronunciation, a certain way
of being on stage and the accompaniment
of the guitar, and so on.
In this sense, Bindi is – in fact – different.
Bindi the “singer-songwriter” ahead of
his time
Bindi’s repertoire is quantitatively less significant than that of the other “Genovese
songwriters”, and mainly limited to the
first part of his career. Unlike Paoli, or Endrigo, who have had a career extending
over several decades, Bindi has remained
the one remembered for his songs of the
Sixties. None of the subsequent “returns”
– in 1972 CON IL PASSARE DEL TEMPO,
Copertina dell’EP Girotondo
per i grandi, 1959.
48
Bindi il “cantautore” ante litteram
La domanda da farsi non è però in che modo possiamo considerare
oggi Bindi come un cantautore. Piuttosto, dovremmo chiederci in
che modo lo è stato intorno al 1960. Nella distanza che corre fra
l’ideologia del cantautore oggi codificata, a volte al limite del
luogo comune, e l’interpretazione che di lui diedero i suoi contemporanei, si nasconde (probabilmente) l’unico modo interessante per parlare di Bindi al di fuori dei soliti schemi triti e ritriti.
Soprattutto se si rivaluta – negando e ribaltando l’idea di Bindi
come “eccezione” – il suo decisivo ruolo nel costruire proprio
quella ideologia del cantautore che oggi lo relegherebbe ai margini del discorso.
Il repertorio di Bindi è quantitativamente meno significativo di
quello degli altri “genovesi”, e limitato in gran parte alla prima
parte della sua carriera, che coincide anche con il momento di
maggior successo di pubblico dei primi cantautori. La sua produzione si affievolisce durante tutti i Sessanta, fino a cessare per diversi anni. Nessuno dei successivi “ritorni” – nel 1972 CON IL
PASSARE DEL TEMPO, nel 1976 IO E IL MARE, nel 1982 D’ORA IN POI,
l’omaggio di amici e colleghi di BINDI (anno 1985), e
ancora DI CORAGGIO NON SI MUORE per la Fonopoli di
Renato Zero (1996) – garantisce al cantautore un ritorno di fan e di successo. La morte, nel 2002, lo coglie in povertà, al termine di una campagna avviata da
amici e colleghi per garantirgli un vitalizio, grazie alla
Legge Bacchelli.
A differenza di Paoli, o di Endrigo, rilanciatisi a più
riprese in una carriera estesa su diversi decenni, Bindi
è rimasto quello delle sue canzoni degli anni Sessanta.
Uno sguardo più da vicino a questo “periodo d’oro”
ci mostra come gli anni più attivi siano proprio quelli
fra l’esordio, datato 1959, e il 1961. Limitandoci al lavoro di Bindi come “cantautore” (escludendo cioè i
brani scritti per altri e mai incisi da lui), sono otto le
nuove canzoni pubblicate nel 1959, undici nel 1960,
e cinque nel 1961 (non contando le numerose re-incisioni, a volte con arrangiamento diverso). Scendono
poi a quattro nel 1962, e due per anno (cioè appena un
45 giri) dal 1963 al 1965. La produzione riprende nel
1968 con un nuovo singolo, un altro nel 1969, e poi
cessa fino all’Lp del 1972 CON IL PASSARE DEL TEMPO.
Per significativa completezza, ecco qui di seguito la
produzione di Bindi fra il 1959 e il 1965.2
1959
Arrivederci (Calabrese-Bindi)
Odio (Calabrese-Bindi)
Nuvola per due (Calabrese-Bindi)
Amare te (Calabrese-De-Simone-Bindi)
Girotondo per i grandi (Calabrese-Buffoli-Bindi)
Basta una volta (Testa-Bindi)
Tu (Beretta-Buffoli-Bindi)
Non so (Calabrese-Bindi)
1960
Appuntamento a Madrid (Calabrese-Bindi)
Il confine (Calabrese-Bindi)
È vero (Nisa-Bindi)
Luna nuova sul Fuji-Yama (Calabrese-Bindi)
Un giorno, un mese, un anno (Calabrese-Bindi)
Lasciatemi sognare (Calabrese-Bindi)
Il nostro concerto (Calabrese-Bindi)
Se ci sei (Calabrese-Bindi)
Chiedimi l’impossibile (Calabrese-Bindi)
Marie Claire (Rosselli Massone-Bindi)
Un paradiso da vendere (Cason-Bindi)
1961
Non mi dire chi sei (Calabrese-Bindi)
Riviera (Testa-Moustaki-Bindi)
Vento di mare (Calabrese-Bindi)
Ninna nanna di Natale (Calabrese-Bindi)
Noi due (Calabrese-Bindi)
1962
Jane (Beretta-Pallavicini-Buffoli-Bindi)
Carnevale a Rio (Calabrese-Bindi)
Un ricordo d’amore (Paoli-Bindi)
Vacanze (Rossi-Bindi)
1963
Il mio mondo (Paoli-Bindi)
Vieni, andiamo (Bardotti-Bindi)
1964
Ave Maria (Siberna-Bindi)
Un uomo che ti ama (Siberna-Bindi)
1965
Quello che c’era un giorno (Rossi-Bindi)
Il giorno della verità (Paoli-Bindi)
Nonostante le “poche” canzoni, la sola cronologia
dei brani – se sovrapposta a quella degli altri “genovesi” – rende giustizia all’importanza avuta da Bindi,
tanto a livello di influenza sui suoi colleghi, quanto
nella costruzione sociale della categoria di “cantautore”, sebbene ante litteram. La parte più importante,
qualitativamente e quantitativamente, del repertorio
di Bindi viene infatti pubblicata prima che il termine
“cantautore” venga introdotto e si affermi nell’uso
linguistico.
Anche nell’affermazione della nuova espressione,
comunque, Bindi gioca un ruolo da protagonista. Si
ritiene, comunemente, che l’iniziale diffusione del
neologismo “cantautore” sia stata propiziata dalla
RCA Italiana per promuovere – soprattutto – alcuni
cantanti più “leggeri” come Gianni Meccia e Maria
Monti, anche in contrapposizione con l’offerta artistica della rivale Ricordi. Eppure, la prima occorrenza del termine risale all’agosto del 1960 (per
intenderci, Bindi ha pubblicato Il nostro concerto
prima dell’estate), in riferimento ad uno spettacolo
itinerante intitolato “Il Cantautori” (sic).3 In questo
“Carro di Tespi” della musica leggera sarebbero stati
inclusi Maria Monti, Enrico Polito, Franco Migliacci, Edoardo Vianello, Gianni Meccia, Gino
Paoli. Quest’ultimo era sotto contratto con Ricordi,
come Bindi, Calabrese e Giorgio Gaber che – infatti
– sono accostati al nuovo “progetto” collettivo appena poche settimane dopo:
Nel gruppo vi sarebbero quindi oltre alla Monti,
Gino Paoli, Umberto Bindi, Giorgio Gaber, Meccia,
mentre il filo conduttore sarebbe fabbricato dal paroliere Calabrese (Sorrisi e Canzoni, 18 settembre
1960, n. 38, p. 19).
49
Copertine di due EP del 1960:
Il nostro concerto (foto Publifoto)
e Un giorno, un mese, un anno
(foto di G.G.Greguoli).
Nel medesimo articolo, questi nuovi “cantanti-autori”
(il termine “Cantautori”, ancora al plurale, indica in
questa fase lo spettacolo e non i singoli) sono accomunati dallo scrivere testi “mica stupidi”, e canzoni
che abbiano “un significato e uno scopo”.
Cronologia alla mano, Bindi è uno degli anticipatori
di queste ambizioni. Prima della definitiva affermazione del nuovo termine, a cui sarà da subito solidamente associato, è perlopiù catalogato con
espressione analoghe come “cantante-compositore”,
o “chansonnier”. E questo nonostante sia chiaro a tutti
che nessun testo porta la sua firma. Nel suo riconoscimento come “cantautore” conta, naturalmente,
anche la collaborazione privilegiata con Giorgio Calabrese: delle trentaquattro canzoni incise e pubblicate da Bindi fra il 1959 e il 1965, diciassette (la
metà, quindi) sono co-firmate con lui, e in altre due
Calabrese compare come autore insieme a Bindi e
altri.4 Inoltre, tutte le canzoni portano la sua firma
come compositore della musica, perlopiù esclusivo.
Del resto, anche gli altri primi “cantautori” non sono
sempre interamente autori dei materiali che propongono, almeno in questa fase.
Dunque, se il nuovo termine “cantautore” è da subito
svincolato dal dato puramente “tecnico” che sembra
suggerire, Bindi non è l’eccezione che conferma la
regola, ma uno dei modelli su cui la “regola” stessa
si forma. “Cantautore” assume dal primissimo momento una connotazione di intelligenza, di raffinatezza artistica, di alternativa alla canzone
commerciale. E di questa tendenza Bindi è, fino al
decisivo successo di Paoli con La gatta a partire dalla
primavera del 1960, l’indiscusso campione. Basta,
per farsi un’idea, leggere le sue prime recensioni sui
giornali che si occupano di musica.
[…] pezzi come Arrivederci e È vero […] non sono
solo delle canzoni ma delle autentiche opere d’arte
(Recensione di Il nostro concerto / Un giorno, un
mese, un anno, Ricordi SRL 10-141, in Musica &
Dischi, luglio 1960).
Abbiamo già segnalato […] le qualità di questo giovane artista (una volta tanto il termine è usato a proposito) (Recensione di Girotondo per i grandi,
Ricordi ERL 128, in Sorrisi e Canzoni, 12 luglio
1959, n. 28, p. 29).
Il pubblico tace, si fa improvvisamente attento. Capisce di essere di fronte ad un autentico artista (Rodolfo d’Intino, “Ecco una voce veramente nuova”,
in Sorrisi e Canzoni, 24 maggio 1959, n. 21, p. 20).
50
Al punto che nel 1962 già si arriva a riconoscere,
implicitamente, il suo ruolo nella costruzione di un nuovo “genere” di canzone.
Il genere di Bindi sin dal principio, […] costituì una svolta nella
concezione della nostra musica leggera. Erano canzoni che sia
nella musica che nelle parole presentavano nuovi concetti e
nuove espressioni (Recensione di Noi due / Appuntamento a Madrid, Ricordi SRL 10216, in Il Disco, marzo 1962).
Un nuovo tipo di canzone, e i suoi modelli stranieri
Intorno al 1960 non era così normale attribuire alla sfera dell’arte
un prodotto di canzone “commerciale”, neanche nel contesto di
una scrittura giornalistica non specializzata – e meno che mai da
parte della critica “colta”, musicale o letteraria che fosse. Il dato
è ancora più rilevante se si considera come molte delle canzoni
di Bindi di questo primo periodo (anche quelle con Calabrese)
aderiscano – almeno in parte – al modello di canzone diffuso in
Italia in quegli anni, sia di gusto “moderno” (il rock’n’roll) che
– per così dire – “raffinato/da night”. Ascoltate oggi, queste canzoni sono difficilmente riconducibili al classico modello del cantautore di “scuola genovese”. Non è necessario nemmeno tirare
in ballo uno dei primi successi di Bindi come autore (la famigerata I trulli di Alberobello, presentata al Sanremo 1958): il repertorio a suo nome contiene titoli che oggi ci paiono decisamente
ingenui. Ad esempio, alcune reveries dal sapore esotico come
Appuntamento a Madrid e Luna nuova sul Fuji-Yama, costruite
intorno a orchestrazioni ricercatissime, rispettivamente di sapore
ispanico la prima, e quasi à la Debussy la seconda, con varie “cineserie” armoniche e timbriche. Le due canzoni non si risparmiano alcun cliché né di contenuto (“Olé”, corride, “ciliegi in
fior”, “lanterne”…) né stilistico, compresa una serie di rime baciate tronche (“vincerà” / “dovrà” / “oscurità”, in Appuntamento
a Madrid), svariate apocopi, anastrofi (“che rabbioso va in cerca
di te”, “una vita seguire la dovrà”), e così via. O basta riascoltare
pochi versi di Nuvola per due, canzone “di nozze” su un terzinato
da rock’n’roll:
1976 IO E IL MARE, 1982 D’ORA IN POI, the
tribute of friends and collaborators in
BINDI (1985), and again DI CORAGGIO NON
SI MUORE for Renato zero’s Fonopoli
(1996) – gave him a successful comeback
and he ended his life in poverty in 2002.
Therefore, if we consider that his artistic
production began well before the introduction of the term “singer-songwriter”,
coined in 1960 by the record company RCA
to promote some of his singers, it is easy
to understand that Bindi was an artist who
helped build that idea of the songwriter
that today would relegate him to the margins of this category, rather than to have
adapted to it. The term was born for a collective project called “I Cantautori”, a travelling show where the artists were united
by writing “non stupid” lyrics and songs
that had “a meaning and a purpose.” Bindi
is one of the forerunners of these ambitions, even if he is not the author of the
lyrics of his songs, but he will make good
use of important collaborations (first of all
with Giorgio Calabrese).
Umberto Bindi in una cartolina
promozionale del 1960.
Ci compreremo una nuvola in ciel
per festeggiare la luna di miel,
sotto un cartello ricamato
con scritto “riservato”
andrem a zonzo per il ciel.
D’altra parte, né Nanni Ricordi (che lanciò Bindi per primo fra i
nuovi “genovesi”), né i suoi colleghi e omologhi alla Rca Italiana
dovevano avere ben chiaro che fare dei giovani talenti che gli
erano capitati per le mani: semplicemente, in Italia, mancavano
modelli (interpretativi, ma anche di marketing) a cui rifarsi. Molti
racconti di quel periodo (ad esempio, Cesare Romana e Liliana
Vavassori, Il mio fantasma blu – Gino Paoli si racconta, Sperling
& Kupfer, Milano, 1996) sottolineano il clima di “sperimentazione”, e citano la possibilità di “sbagliare” concessa ai nuovi artisti come determinante nella formazione degli stili personali.
Si cita spesso, in questa fase della storia dei cantautori,
51
The term “singer-songwriter”, and then,
beyond a purely ‘technical’ information
which seems to suggest, assumes from the
very first moment a connotation of intelligence, artistic refinement, of an alternative
to the commercial song, of which Bindi is
the undisputed champion until the decisive
success of Paoli with La gatta, as the critics
immediately recognized in their reviews.
A new type of song and its models from
abroad
Many of the early songs by Bindi are “commercial” products they are difficult to relate to the classical model of the
songwriters of the “scuola genovese” (i.e.
I trulli di Alberobello, presented at the festival of Sanremo 1958). The tracks are built
around refined orchestrations, that do not
cede to any cliché neither in the content
nor in the style.
On the other hand, neither Nanni Ricordi
(who first launched Bindi among the new
“Genovesi”), nor his colleagues and counterparts at the Italian RCA had to be clear
about what to do with the young talents
that they had in their hands: basically, in
Italy, there were no models (interpretative,
but also in marketing) to refer to. At that
time there was a spirit of “experimentation”
that in part justifies the mistakes made by
new artists in forming their own personal
style. In the first songs recorded by the new
songwriters it is evident the recovery of the
American models in vogue in those years,
rather than the French taste (well expressed
in the lyrics, instead). Even Bindi – in spite
of a greater harmonic variety – at first fell
in many of these schemes, and on his debut
he was firmly placed within the “pop” world.
Arrivederci is – according to Sorrisi e canzoni
– the best-selling album of 1959, and its author and interpreter was seen as a champion
of the new music youth, like the so-called
urlatori (T.N. screamers), both representatives of an opposition “institutionalized” by
the recording industry to the traditional
Italian song, although acting with different
means.
The songwriter as an artist
The articles on Bindi that appeared on the
newspapers between 1959 and 1960 put
the emphasis on his “artistry” as the ability to write his own songs with musical
52
l’influenza francese. Questa fu decisiva, a ben vedere, innanzitutto nel senso di una fascinazione, di un guardare alla Francia,
nel desiderio di avere una propria tradizione di canzone artisticamente significativa sul modello di quella d’Oltralpe. Non è
forse un mero dato aneddotico, dunque, che buona parte degli articoli di lancio di Bindi si premurino di farci sapere che è figlio
di padre francese – collegando talvolta esplicitamente questa origine con lo stile delle sue composizioni… I richiami all’immaginario dell’esistenzialismo (un esistenzialismo piuttosto di
maniera, in verità), ad una Parigi decadente di café-chantant, al
cinema francese sono peraltro all’ordine del giorno anche nella
costruzione dell’immagine di Gino Paoli, e in maniera decisamente più esposta.
In realtà, la cosa che più salta all’orecchio ascoltando i primi
brani incisi dai nuovi cantautori è piuttosto la smaccata ripresa
dei modelli americani in voga in quegli anni, più che un qualche
gusto francese (ben espresso nei testi, invece). A partire dal sempre citato “giro di do” di Paoli, che si può ascoltare in decine di
canzoni rock and roll del tipo “teen angel milksap” (la definizione
è in Popular music. Da Kojak al Rave di Philip Tagg, Clueb, Bologna, 1994, p. 236), per lo più a tema amoroso e giovanile, e per
un pubblico giovanile. Anche Bindi – pur in una maggiore varietà
armonica – ricade dapprincipio in molti di quegli schemi, compreso l’immancabile terzinato di accompagnamento, che sarà
stigmatizzato pochi anni dopo nel classico Le canzoni della cattiva coscienza (Michele L.Straniero-Emiio Jona-Sergio Liberovici-Giorgio De Maria, Bompiani, Milano 1964) come epitome
della canzonetta “gastronomica”. Lo stesso libro non risparmia,
peraltro, taglienti giudizi proprio su Bindi, uno dei pochi cantautori a guadagnarsi una citazione con Arrivederci.
Bindi, a dispetto dell’immagine che se ne è tramandata, è dunque
al suo esordio collocato ben saldamente all’interno del mondo
“pop”. Arrivederci è – secondo Sorrisi e canzoni – il disco più
venduto del 1959, e il suo autore e interprete è trattato di conseguenza: come un campione della nuova musica giovanile; al pari,
cioè, dei cosiddetti urlatori. La distinzione fra i nuovi “cantanticompositori” e gli urlatori non appare così netta, in questa fase:
entrambi rappresentano una opposizione – “istituzionalizzata”
dall’industria discografica – al sistema tradizionale della canzone
italiana, sebbene agiscano con differenti mezzi. Non stupisce più
di tanto che in un “musicarello” uscito all’inizio del 1960, Urlatori alla sbarra (film diretto da Lucio Fulci), Bindi compaia
come personaggio secondario a fianco dei grandi divi Mina e Celentano; c’è anche Chet Baker, che esegue proprio Arrivederci in
una scena d’amore.
Eppure, Urlatori alla sbarra già contiene indizi tanto dell’inadeguatezza dei nascenti cantautori in quel contesto, quanto della
nuova idea “promozionale” che sarà alla base della loro affermazione, e dell’ideologia del genere così come la conosciamo oggi.
Il personaggio di Bindi nel film non parla, è significativamente
soprannominato “Agonia” ed è oggetto di scherzi da parte dei
suoi amici più dinamici e vitali (fra cui un iperattivo Gianni Meccia). Una buona metafora.
Il cantautore come artista
In effetti, gli articoli di presentazione di Bindi sui
giornali fra il 1959 e il 1960 spingono su alcuni
punti chiave che si riveleranno decisivi. L’artisticità,
di cui si è detto, è vincolata in parte al fatto che
Bindi scrivesse i propri brani, o al riconoscimento
di rimandi musicali al repertorio eurocolto (soprattutto per Il nostro concerto e la sua introduzione
strumentale, inusitata per l’epoca). Ma si collega
anche, e forse anche di più, ad altre decisive “marche” di autenticità, come la novità nell’uso della
voce, la “sincerità” dell’interpretazione, il non essere un professionista della musica e – non da ultimo
– una certa prossemica – o posa – “da vero artista”
(o da “vero musicista”). Con alcune trovate che insistono sul modello dell’artista come “disadattato”,
inadatto alle costrizioni della società e dell’industria,
e un po’ naïf:
È vero che Umberto Bindi non riesce a cantare se
non si accompagna al pianoforte, tanto che quando
deve incidere un disco con l’orchestra, ha bisogno
di una tastiera muta (“È vero”, in Sorrisi e Canzoni, 20 dicembre 1959, n. 51, p. 21).
Le foto pubblicitarie e le copertine dei dischi rinforzano questo tipo di immagine. La pubblicità a tutta
pagina di È vero/Luna nuova sul Fuji-Yama che esce
– ad esempio – su Musica e Dischi a partire dal febbraio 1960 è una foto in bianco e nero (significativo,
in mezzo a pubblicità stampate, come minimo, in bicromia) che ritrae Bindi a figura intera, mentre cammina in un parco, da solo e con sguardo perso.
Altrove è colto mentre suona il pianoforte (sulla copertina dell’Lp UMBERTO BINDI, LA SUA VOCE, IL SUO
PIANOFORTE, LE SUE CANZONI, Ricordi ERL 126), o
mentre scrive (presumibilmente) su un pentagramma
Copertina del 33 giri
UMBERTO BINDI del 1961,
il suo primo album.
Grafica di Daniele
Usellini.
53
Dall’alto in basso copertine
di due 45 giri:
Noi due del 1961 (grafica
di Pizzorno).
Riviera del 1961 (grafica
di Daniele Usellini).
(sulla copertina di UN GIORNO, UN MESE, UN ANNO,
Ricordi ERL 151). Questo tipo di iconografia del
cantautore, che ha in Paoli un esempio anche migliore, sembra essere destinata a sostituire un’altra
strada tentata nello stesso periodo: quella del cantautore “simpatico”, alla Gaber, o alla Meccia, raffigurato mentre fa smorfie, scherzi, in pose strane o
location curiose.
Ma è la voce, soprattutto, a guidare l’identificazione
di Bindi come primo esponente di una nuova tendenza. Così ad esempio nel lungo pezzo di presentazione, già citato, che Rodolfo d’Intino gli dedica
nel 1959 su Sorrisi e Canzoni, recensendo la sua
presentazione alla stampa in un night di Roma.
Ecco una voce veramente nuova
Umberto Bindi è stato definito “la voce che sconvolge”. È diventato cantante per un puro caso: due
mesi fa presentò a una casa musicale le sue composizioni. Il maestro Boneschi, presente all’audizione, lo consigliò di cantare lui stesso le sue
canzoni. […] Bisognerebbe mettersi d’accordo
sulla parola “cantare”: in effetti le canzoni di Umberto Bindi sono un cocktail di parole, di grida, di
silenzi, di musica, di sguardi, di gesti. La sua preoccupazione non è l’acuto, non è la “modulazione
pastosa” (Rodolfo d’Intino, “Ecco una voce veramente nuova”, in Sorrisi e Canzoni, 24 maggio
1959, n. 21, p. 20).
E così, retrospettivamente, un critico su Discoteca,
ricordando (forse) il medesimo spettacolo:
[…] quella sua voce agra, ruvida, acerba, quasi
sdrucita e lacera, produsse […] un effetto straordinario sul pubblico che gremiva la sala e che
certo non s’aspettava una prova così originale
(R.G., recensione a Umberto Bindi, Ricordi MRL
6012, in Discoteca, gennaio 1962, p. 52).
54
Ripensata oggi, Bindi è la decisiva figura di passaggio nello sviluppo della vocalità della canzone italiana. Sebbene la sua voce non sia la tipica voce da
tenore leggero che dominava nei decenni precedenti,
è comunque lontana dall’essere una “voce da cantautore” come la intendiamo oggi. Non è una voce
“stonata” alla Paoli; riprende, piuttosto, alcuni birignao di Modugno (ad esempio, una certa chiusura
delle “o”), ma con una minore impostazione attoriale. Se il modello di partenza era – come è ragionevole, e come la struttura e le armonie delle
canzoni sembrano suggerire – un certo tipo di interpretazione da ballad alla Nat King Cole, la sua applicazione alla lingua italiana non sembra essere
Bindi al pianoforte.
(Foto Leoni)
così lineare nelle prime prove di Bindi, ad esempio in Arrivederci. Il risultato è che, non venendo da un’impostazione lirica,
e soprattutto quando si trova a dover “timbrare” la voce (specie
nel registro acuto), Bindi sforza e deforma le “o”, le “e”. L’impressione è quella di una voce “naturale” che cerca in ogni
modo di suonare come una voce “da cantante”5. Può essere
anche utile confrontare questa interpretazione con quelle di Sergio Endrigo (che era invece un cantante di professione) all’inizio della sua carriera, tanto nel suo esordio come cantautore
(Bolle di sapone/Alle quattro del mattino, Tavola Rotonda, T
70001, 1960) quanto nelle incisioni con il complesso “da night”
di Riccardo Rauchi: emissione potente, leggermente impostata,
con vibrato, ma che suona decisamente più “naturale” di quella
di Bindi.
Per capire al meglio la questione della “naturalezza” della voce
di Bindi nel 1959, basta confrontare la sua versione di Arrivederci con quella incisa nello stesso anno da Don Marino Barreto
Junior, che la portò al successo. Nonostante l’accento cubano,
la versione di Barreto suona decisamente più “naturale”: è
references to the “euroeducated’ repertoire
and the authenticity of a new use of the
voice, the “sincerity” of his interpretation
and a certain proxemics – or pose – like “a
true artist” a kind of “misfit”, unsuitable
to the constraints of society and industry,
and a bit naïve. Even the publicity photos
and covers of the discs will contribute to
strengthen that picture. This type of
iconography of the singer seems to be intended to replace another road attempted
in the same period, that of the “endearing”
singer-songwriter, like Gaber. But it is the
voice, above all, the guide to the identification of Bindi as the first representative
of a new trend, a harsh, rough, unripe
voice that captivates the audience with its
originality. It is a voice built thinking of
Nat King Cole, but that at the beginning,
55
Bindi nel 1980.
(Foto Publifoto)
56
when Bindi was not yet a professional
singer, sounded quite unnatural. It is right
on the “naturalness” that he will work to
give credibility to his interpretations, taking example from the version of Arrivederci
recorded by Don Marino Barreto junior,
that led it to success, despite his Cuban
accent. And this is the prototype on which
the interpretations of songwriters will take
shape - including the subsequent Bindi:
clean interpretation, no drawl and forcing,
which expands and slows down. Bindi isn’t
therefore, in this passage, different from
anyone. On the contrary, the others tend
to be like him, sometimes imitating him,
and then each developing their own independent artistic path, each with their own
peculiarities.
Be marginalized or discriminated against,
or stood on the side on purpose, or be that
his work has run out: nothing can downsize the weight Umberto Bindi had in that
invention called ‘singer-songwriter’, which
still acts as a protagonist of every day in
our music.
un’interpretazione da crooner, quasi a mezza voce. È questo,
paradossalmente, il prototipo su cui si modelleranno le interpretazioni dei cantautori, compreso il Bindi successivo.
Bindi incise due versioni di Arrivederci. La prima è quella sopra
descritta, con le “e” e le “o” chiusissime e un arrangiamento
ritmato e terzinato (per clavicembalo, contrabbasso, pianoforte
e batteria). È inclusa sull’ep del 1959 LA SUA VOCE, IL SUO PIANOFORTE, LE SUE CANZONI (Ricordi Erl 126), e sul singolo dello
stesso anno (Ricordi SRL 10029; da matrice, risulta incisa il 24
marzo). L’altra, successiva alla versione di Marino Barreto, risale al 3 maggio del 1960, ed è inclusa nel primo lp di Bindi,
BINDI E LE SUE CANZONI.6 Un pubblico diverso (45 giri contro
lp), aspettative diverse per, infine, un genere diverso: la band
sparisce e lascia spazio al solo piano. Il terzinato rimane di
sfondo come figura ritmica del pianoforte, ma l’interpretazione
si fa pulita, senza birignao e forzature, si dilata e si rallenta,
fino a durare oltre un minuto in più. Una versione “da cantautore” (o da Marino Barreto…), infine.
La distanza fra le due versioni di Arriverci simboleggia bene il
passaggio che porterà, di lì a pochi mesi, alla definitiva esplosione dei cantautori come nuovo fenomeno della canzone italiana. Questo è il momento chiave per capire come una serie di
caratteristiche “nuove” siano state razionalizzate come coerenti
e, poco a poco, siano divenute tipiche di un nuovo genere musicale. Bindi non è, in questo passaggio, diverso da nessuno.
Umberto Bindi alla fine
degli anni Novanta.
(Foto Leoni)
Sono piuttosto gli altri ad essere simili a lui, talvolta
imitandolo, e sviluppando poi ognuno il proprio autonomo percorso artistico, ognuno con le sue peculiarità.
La parabola artistica di Bindi è piuttosto corta: resterà sempre, fino alla morte, l’autore di Arrivederci
e Il nostro concerto. Che sia stato emarginato o discriminato, che si sia messo ai margini da solo, che
la sua vena si sia esaurita: nulla può ridimensionare
il peso avuto da Umberto Bindi in quell’invenzione
sociale chiamata “cantautore”, che ancora oggi agisce da protagonista di tutti i giorni nella nostra musica.
NOTE
1
Fra le eccezioni: Umberto Bindi, di Michele Neri e
Franco Settimo, Coniglio Editore, Roma, 2011.
2
I dati sulle canzoni, così come quelli discografici riportati in tutto il saggio, sono tratti dalla Discografia
Nazionale della Canzone Italiana,
http://discografia.dds.it.
3
Sorrisi e canzoni, 7 agosto 1960, n. 32, p. 12. Sul tema
dell’origine di «cantautore» si veda Jacopo Tomatis,
“Vorrei trovar parole nuove”. Il neologismo “cantautore” e l’ideologia dei generi musicali nella canzone
italiana degli anni Sessanta, in Iaspm@Journal, vol
1. n. 2, 2010, iaspmjournal.net.
4
Con la necessaria avvertenza che è sempre difficile,
soprattutto in questo periodo e in Italia, capire quanto
gli autori secondari registrati corrispondano agli autori
reali.
5
Stessa impressione che ad esempio darà, nel 1961 (la
data è corretta, contrariamente a quanto riportato da
molte discografie) Nuvole barocche di Fabrizio De
André, la cui interpretazione pare riprendere quella di
Arrivederci.
6
Ringrazio Franco Settimo per l’aiuto decisivo nel ricostruire questa cronologia.
57