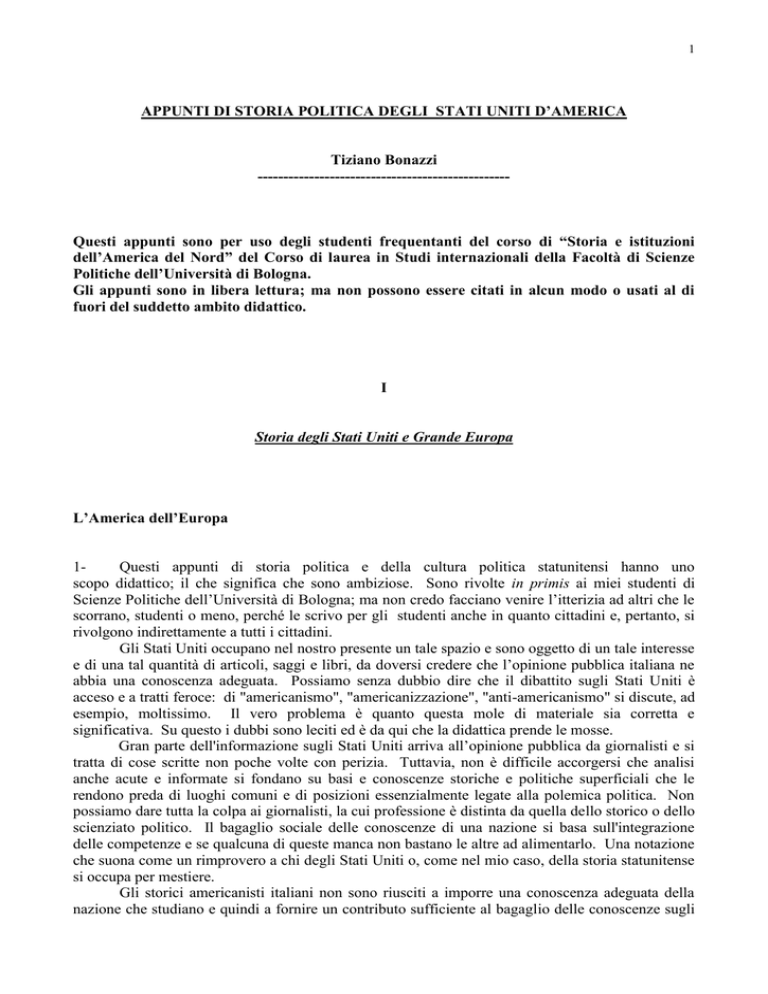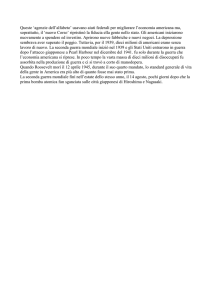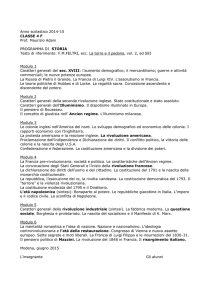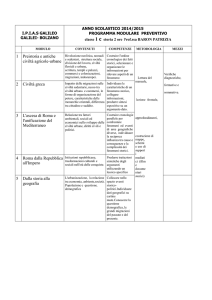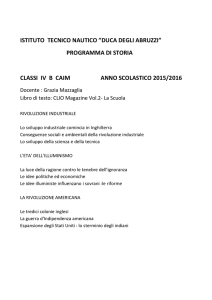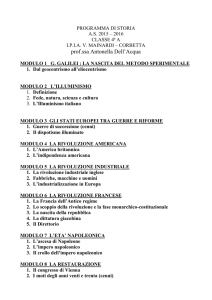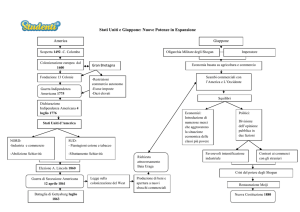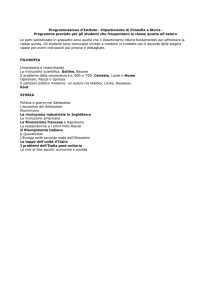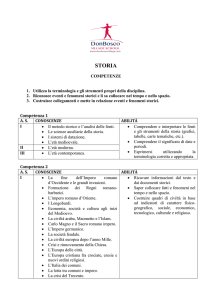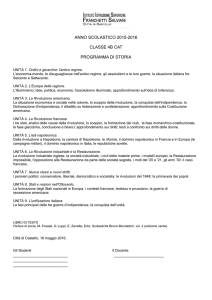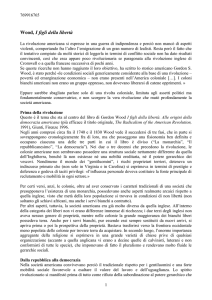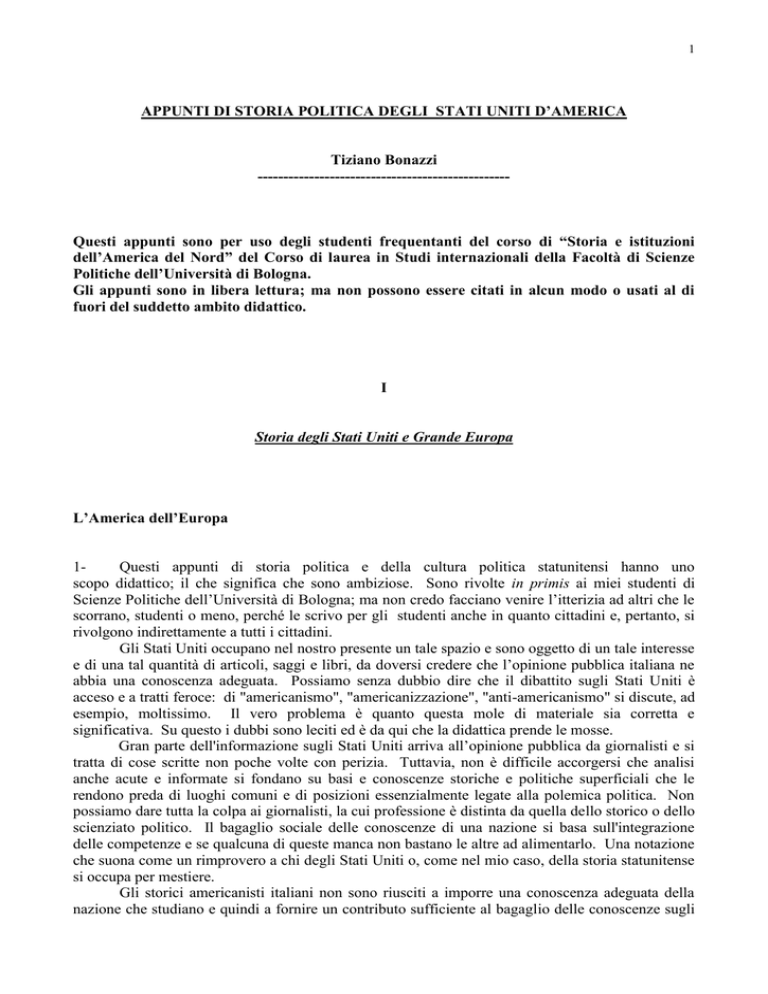
1
APPUNTI DI STORIA POLITICA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Tiziano Bonazzi
-------------------------------------------------
Questi appunti sono per uso degli studenti frequentanti del corso di “Storia e istituzioni
dell’America del Nord” del Corso di laurea in Studi internazionali della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Bologna.
Gli appunti sono in libera lettura; ma non possono essere citati in alcun modo o usati al di
fuori del suddetto ambito didattico.
I
Storia degli Stati Uniti e Grande Europa
L’America dell’Europa
1Questi appunti di storia politica e della cultura politica statunitensi hanno uno
scopo didattico; il che significa che sono ambiziose. Sono rivolte in primis ai miei studenti di
Scienze Politiche dell’Università di Bologna; ma non credo facciano venire l’itterizia ad altri che le
scorrano, studenti o meno, perché le scrivo per gli studenti anche in quanto cittadini e, pertanto, si
rivolgono indirettamente a tutti i cittadini.
Gli Stati Uniti occupano nel nostro presente un tale spazio e sono oggetto di un tale interesse
e di una tal quantità di articoli, saggi e libri, da doversi credere che l’opinione pubblica italiana ne
abbia una conoscenza adeguata. Possiamo senza dubbio dire che il dibattito sugli Stati Uniti è
acceso e a tratti feroce: di "americanismo", "americanizzazione", "anti-americanismo" si discute, ad
esempio, moltissimo. Il vero problema è quanto questa mole di materiale sia corretta e
significativa. Su questo i dubbi sono leciti ed è da qui che la didattica prende le mosse.
Gran parte dell'informazione sugli Stati Uniti arriva all’opinione pubblica da giornalisti e si
tratta di cose scritte non poche volte con perizia. Tuttavia, non è difficile accorgersi che analisi
anche acute e informate si fondano su basi e conoscenze storiche e politiche superficiali che le
rendono preda di luoghi comuni e di posizioni essenzialmente legate alla polemica politica. Non
possiamo dare tutta la colpa ai giornalisti, la cui professione è distinta da quella dello storico o dello
scienziato politico. Il bagaglio sociale delle conoscenze di una nazione si basa sull'integrazione
delle competenze e se qualcuna di queste manca non bastano le altre ad alimentarlo. Una notazione
che suona come un rimprovero a chi degli Stati Uniti o, come nel mio caso, della storia statunitense
si occupa per mestiere.
Gli storici americanisti italiani non sono riusciti a imporre una conoscenza adeguata della
nazione che studiano e quindi a fornire un contributo sufficiente al bagaglio delle conoscenze sugli
2
Stati Uniti. Nessuno di noi è sicuramente un gigante della storiografia; ma la qualità dei nostri
lavori è apprezzata anche al di là delle frontiere, per cui non è la nostra incompetenza la ragione
prima della situazione in cui ci troviamo. Un segnale più significativo della scarsa attenzione
scientifica per gli Stati Uniti proviene dal fatto che siamo molto pochi, che la grande maggioranza
degli Atenei italiani non ha neppure un insegnamento di storia degli Stati Uniti e che non siamo
quindi in grado di formare massa critica. La cosa non riguarda solo gli storici. Molto pochi sono
gli scienziati politici che lavorano sugli Stati Uniti e pressoché assenti i sociologi. L’interesse per lo
studio scientifico della società, della politica e della storia statunitensi in Italia è, quindi, assai
carente.
Le ragioni di un simile paradosso in un paese come l’Italia che all’orbita politica americana
appartiene ormai da più di sessant’anni e nei confronti di una nazione che non solo ha segnato la
storia del Novecento al punto che questo secolo viene spesso detto il “secolo americano”, ma che
domina a tutt’oggi l’orizzonte mondiale, stanno nel ritardo culturale che in questo come in altri
campi attanaglia il nostro paese. Non certo molti ad esempio, per restare in ambito parallelo a
quello di cui sto trattando, sono gli studiosi delle altre “aree”, cioè dei paesi e delle zone esterne a
quella che durante la Guerra fredda si chiamava Europa occidentale, la quale ultima, per restare in
campo storico, costituisce il fulcro dell’attenzione degli storici non solo contemporaneisti. E’
corretto che l’Italia e l’Europa attirino un interesse tutto particolare; non lo è che lo studio delle altre
aree del mondo ne riceva così poco. Una situazione che risente ancora dell’eurocentrismo (non
dimentichiamo che le stesse categorie di storia antica, medievale, moderna e contemporanea
vennero costruite in funzione della storia europea e della sua egemonia) degli anni e dei secoli in cui
l’Europa era culturalmente e politicamente dominante e guardava al resto del mondo come a un
“fuori”, oggetto di studio in quanto colonia e cultura “altra” (o inferiore) e non come soggetto dei
principali processi storici, che si riteneva fossero solo quelli europei. L’eurocentrismo, tuttavia, in
un mondo in via di globalizzazione in cui culture e stati non europei fanno ormai pienamente valere
la loro voce, è uno strumento addirittura controproducente e se, in un paese come il nostro, è
soprattutto l’attenzione all’Europa o, meglio,all’Europa a ovest della vecchia “cortina di ferro” ad
alimentare il bagaglio delle conoscenze in campo storico-politico, ritengo legittimo temere per la
capacità dell’Italia di tenersi al passo con i processi culturali e gli sviluppi politici in atto.
La situazione si complica, però, ulteriormente in rapporto agli Stati Uniti – e in buona parte
anche agli altri paesi del continente americano -, dal momento che, se essi sono geograficamente
lontani e hanno sempre meravigliato per le loro peculiarità, non li si è mai potuti considerare a tutti
gli effetti estranei all’Europa. Nei confronti degli Stati Uniti si assiste in Italia, ma anche nei
principali paesi europei, come a un effetto ottico distorcente per cui essi appaiono al tempo stesso
vicini e lontani, oggetto di meraviglia e di disprezzo, modello e antimodello di progresso e di
civiltà, frutto perfetto o perverso della storia; molto raramente una nazione fra le nazioni e, in
particolare, una nazione assimilabile a quelle europee. In conseguenza anche altrove nel “Vecchio
mondo”, sia pure in misura spesso meno rilevante che da noi, lo studio della storia e della società
statunitensi è limitato. L’intera Europa, quindi, sembra soffrire di un “complesso americano” che la
fine dell’egemonia europea e l’assoggettamento a quella statunitense non hanno fatto che
intensificare, come si vede in ogni discussione sul ruolo internazionale dell’Unione Europea, sul
rapporto fra Unione, singoli stati e NATO, sul seguire o meno le iniziative politiche statunitensi,
come nel caso della guerra contro l’Iraq, ovvero a proposito della cosiddetta “americanizzazione”.
Ci troviamo qui di fronte a un nodo culturale dalle fondamentali ricadute politiche: la
difficoltà europea, che proviene da molto lontano, a misurarsi in modo realistico con il “Nuovo
Mondo” e con gli Stati Uniti in particolare.
2Il Nuovo Mondo costituì un formidabile problema intellettuale per gli europei fin dai primi
viaggi di Cristoforo Colombo. La sua casuale scoperta mentre si andava alla ricerca di un passaggio
più veloce di quello attraverso il Capo di Buona Speranza per raggiungere un luogo ormai noto,
3
l’India, li pose, infatti, davanti a qualcosa di estraneo al pur formidabile apparato culturale
rinascimentale di cui disponevano: una realtà che si manifestava empiricamente là dove, secondo le
loro categorie, non doveva esserci niente. Pur ammettendo, come vari fra gli scienziati e nel clero
ammettevano almeno in via di ipotesi probabile, che la terra fosse una sfera, si riteneva, infatti, di
aver conoscenza di tutte le terre emerse, e di tutti i popoli che le abitavano, per quanto remoti. La
scommessa di Colombo di arrivare in Oriente andando verso Occidente partiva da dati scientifici
che molti condividevano. Quello che nessuno, a partire da Colombo stesso, riteneva possibile era di
incontrare terre di cui non si aveva nessuna nozione. Il continente americano non doveva esserci,
era un “vuoto”, un nulla che si materializzò di colpo ponendo enormi problemi. Perché Dio aveva
tenuto così a lungo segreta l’esistenza di un continente immenso e di tanti popoli? E questi popoli
erano davvero tali, erano cioè umani, avevano un’anima o erano animali dalle sembianze umane?
Li si doveva cristianizzare? Li si poteva mettere al lavoro forzato? E le grandi, ma estranee e a
volte terribili civiltà delle Americhe erano manifestazioni diaboliche? Gli spagnoli si interrogarono
a lungo durante il Cinquecento su questi problemi, anche se a risolverli fu la pratica concreta di
quella che, da scoperta, divenne immediatamente una conquista.
Nel corso della conquista il “vuoto” americano si popolò di sogni, di misteri, di incubi, di
brutalità e di eroismi man mano che gli europei prendevano a conoscerlo e restavano affascinati e
terrorizzati dalla forza spaventosa della natura e da spazi dalla grandezza inconcepibile. L’America
nutrì l’immaginazione politica europea con “Utopia” di Tommaso Moro, l’isola ipercivilizzata,
potentissima e pacifica che il pensatore inglese di inizio Cinquecento collocò, come l’America,
nell’Oceano, e in quella letteraria con “La tempesta” di Shakespeare, mentre l’immaginazione si
accendeva al mito di El Dorado. Una volta deciso che i nativi delle Americhe erano umani e
avevano un’anima, essi divennero oggetto di intensi dibattiti sul se, del tutto privi di costumi e di
una morale europea, erano rappresentanti del demonio o gli ultimi superstiti di un’umanità
originaria e pura. Gli autori illuministi, ad esempio Diderot, se ne servirono per costruire
l’immagine dell’uomo naturale, incorrotto dalla civiltà, e per dare il via ai primi studi di tipo
antropologico. Così come il fondamentale dibattito settecentesco sulla corruzione dei costumi
provocata dall’avanzare della civiltà trovò modo di esercitarsi sulle conseguenze, positive o
negative a secondo degli autori, della scoperta dell’America e della crescita del commercio e delle
ricchezze che ne era derivata, come nel caso del concorso dell’Académie Francaise del 1792. Un
quarto di secolo prima, nel 1776, Adam Smith scriveva invece fiducioso in un capitolo de “La
ricchezza delle nazioni” che le grandi scoperte geografiche, e quindi quella dell’America, avevano
aperto una nuova e più pacifica e avanzata età della storia umana, quella del commercio, di cui la
Gran Bretagna, ormai potenza dominante sui mari, era l’indiscusso alfiere. Anche la natura
americana divenne oggetto di una famosa disputa settecentesca fra chi sosteneva che essa era
superiore a quella europea e chi invece trovava animali e piante del Nuovo Mondo più piccoli,
deboli e meno vitali, con la conseguenza che molto difficilmente le società europee in America
avrebbero potuto svilupparsi al pari di quelle del Vecchio Mondo.
Il continente americano, insomma, non solo venne appropriato dagli europei che lo
conquistarono e lo divisero fra loro; ma fu colonizzato dalla loro esuberante cultura, che se ne servì
per affilarvi le proprie armi intellettuali, costruire il proprio senso di supremazia e scaricarvi le
proprie paure.
Per questo quando in Nordamerica, nel 1776, scoppiò la rivolta di tredici delle colonie
inglesi che vi si trovavano e i ribelli si imposero alla principale potenza dell’epoca in nome dei più
avanzati principi del pensiero europeo – la libertà, i diritti naturali dell’individuo, la natura pattizia e
consensuale dei governi - la cosa suscitò enorme scalpore in quanto sembrava impossibile che quei
principi, che non trovavano ancora applicazione al centro del mondo civile, venissero messi in
pratica nelle lande selvagge della lontanissima America. Negli anni della Rivoluzione gli inviati
americani in cerca di aiuti e di alleanze fecero il possibile per dimostrarsi all’altezza delle raffinate
maniere delle corti e dei salotti europei; ma non per caso a conquistarli fu Benjamin Franklin, che
con raffinata astuzia vi si presentava con in testa il berretto di castoro dei cacciatori americani di
4
pellicce e giocava la parte dell’ “uomo naturale”, pur essendo un noto scienziato, membro della
Royal Society di Londra. L’“uomo naturale”, il “buon selvaggio” incorrotto dalla civiltà e per
questo in grado di vivere alla luce dei principi della ragione naturale, divenne l’immagine di cui si
servì l’intelligentsia europea fra Settecento e Ottocento per comprendere quanto andava succedendo
oltreatlantico: gli americani erano stati capaci di compiere il balzo verso la libertà ancora negata
agli europei in quanto, pur europei di origine, nelle foreste nordamericane erano tornati allo stato di
natura e alla ragione incorrotta che vi regna.
Ampiamente sfruttato a fine Settecento da chi si schierava a favore della libertà – ma vi era
anche chi vedeva nella libertà americana un pericolo gravissimo che proprio l’imbarbarimento degli
ex coloni inglesi nelle selvagge lande d’oltreatlantico aveva nutrito -, il mito del “balzo
all’indietro”, fuori dalla corrotta civiltà europea, fu il momento di arrivo del plurisecolare, intenso e
contraddittorio rapporto della cultura europea con il Nuovo mondo. Esso segnò anche l’istante
formativo da cui si sviluppò il “mito americano” degli europei, l’idea che gli Stati Uniti fossero
“diversi”, estranei o solo parzialmente partecipi dei processi storici del Vecchio mondo.
Per tutto l’Ottocento i rapporti dei viaggiatori e le lettere degli emigranti alimentarono, in
positivo o in negativo, l’immagine della diversità americana, il cui culmine teorico troviamo ne “La
democrazia in America” di Alexis de Tocqueville del 1835, il quale dipinse gli Stati Uniti come il
laboratorio del futuro politico europeo, la nazione all’avanguardia della storia. Quando costruita in
negativo, quella diversità diventava invece rozzezza delle maniere e mancanza di originalità
culturale, fanatismo per l’uguaglianza e materialismo senza freni. In ogni caso gli Stati Uniti erano
sentiti lontani, non solo geograficamente; ma al tempo stesso diventavano un modello, desiderato o
temuto, di ciò che l’umanità stava diventando. In questo modo essi finirono per riassumere in sé
tutto ciò che il continente americano nel suo insieme era stato fino alla loro nascita: divennero
“l’America”, mentre il resto del continente, anche per la sua arretratezza politica ed economica,
sprofondava al di fuori della storia, dimenticato. Se gli Stati Uniti non erano Europa, ma quasi una
figura mitica che preannunciava all’Europa il suo futuro – splendido o miserabile a seconda delle
opinioni -, gli altri stati americani non lo erano per la ragione opposta, perché ormai considerati
fuori dai grandi processi storici.
Sebbene per tutto l’Ottocento ai margini delle vicende europee, anzi, proprio in quanto
sentiti così lontani, gli Stati Uniti divennero il “luogo” ideale in cui l’immaginazione sociopolitica
europea poté esercitarsi, misurandosi con un paese in cui tutto appariva capovolto e nuovo e che
sembrava da tanti punti di vista non “appartenere” alla famiglia delle nazioni del Vecchio mondo,
pur non essendo affatto estraneo, se non altro per le intense correnti migratorie che mantenevano
vivi i contatti umani fra le due sponde dell’Atlantico.
Nel corso del Novecento, col crescere a partire dagli anni Venti della penetrazione
economica e culturale statunitense e dopo il 1945 con l'egemonia americana in Europa occidentale,
gli europei a ovest della cortina di ferro si trovarono a contatto diretto con una realtà che li
oltrepassava di gran lunga quanto a forza economica e politico-militare, ma anche quanto a capacità
di attrazione culturale. "Americanismo" e "americanizzazione" divennero così termini di dibattito
quotidiano e di ansiose domande sulla perdita di indipendenza dell'Europa. Gli Stati Uniti non
venivano più analizzati come luogo di deviazioni grossolane dalla storia europea o di anticipazione
di processi storici che avrebbero potuto investire l'Europa; ma come un presente invasivo capace di
incidere vieppiù pesantemente sull'oggi degli europei. Lo scontro ideologico della Guerra fredda, la
modernizzazione dei paesi dell'Europa occidentale sulla falsariga di quanto avveniva oltreatlantico e
la contrapposizione con il modello sovietico in Europa orientale fecero si che l'"americanismo" e
l'"antiamericanismo" soprattutto culturali e teorici degli anni fra le due guerre mondiali si
trasformassero in concreti scontri politici sul presente e acquistassero una pregnanza del tutto
particolare. Chiusi in questa morsa e privi di strumenti conoscitivi adatti a misurare realisticamente
cosa fossero la nuova civiltà e la potenza degli Stati Uniti, gran parte degli europei continuò a
mantenere un atteggiamento stupito di superiorità offesa ovvero uno di subordinazione quasi
incondizionata nei loro confronti, senza riuscire a determinare cosa era cambiato rispetto al periodo
5
precedente la Seconda guerra mondiale
L’Europa dell’America
1Se gli Stati Uniti vennero velocemente a occupare una posizione tutta particolare – né
dentro, né fuori – rispetto al mondo europeo, la cultura politica americana acquisì ancor più
rapidamente forti tratti antieuropei.
La rivoluzione del 1776 fu un doloroso atto di rivolta contro la potenza coloniale inglese che
era al tempo stesso la madrepatria della grande maggioranza dei coloni. Quando ebbe inizio – dopo
oltre dieci anni di dispute e riavvicinamenti – essa consistette in un ripudio della Gran Bretagna, del
suo re e del suo sistema politico che portò a una guerra di liberazione della durata di sette anni
(1776-1783) e alla creazione di istituzioni politiche repubblicane (Costituzione Federale del 1787)
che contrapponevano la “libertà americana” al “corrotto” sistema inglese.
Negli anni Settanta e Ottanta il nemico era quindi l’Inghilterra, non il resto dell’Europa. Le
élite rivoluzionarie americane erano infatti guidate da princìpi illuministi e libertari europei assai
diffusi anche fra la popolazione e ciò fece si che la Rivoluzione francese venisse accolta con
entusiasmo, come un ulteriore capitolo dell’espansione della libertà; ma l’uccisione del re Luigi
XVI, l’affermarsi del radicalismo giacobino, il Terrore e il concludersi del processo rivoluzionario
nel regime napoleonico, fecero svanire ogni entusiasmo, sostituito dalla convinzione che l’Europa
intera fosse troppo corrotta per seguire la via di libertà aperta dagli Stati Uniti. Successivamente, la
Restaurazione, l’unione fra trono e altare che essa sostenne, l’assenza di libertà e di democrazia nei
regni europei, la povertà delle masse e l’esodo verso gli Stati Uniti sia di patrioti italiani, ungheresi,
tedeschi in fuga dalle fallite rivoluzioni nazionali degli anni Trenta e Quaranta, che di centinaia di
migliaia di europei in cerca di una vita migliore non fecero che confermare, come scrisse a metà
secolo il principale storico americano del periodo, George Bancroft, che storia e Provvidenza
avevano destinato gli Stati Uniti a essere un faro di libertà, di stabilità politica e sociale e di
speranza per tutti i popoli della terra.
Durante la prima metà dell’Ottocento, quindi, non solo gli Stati Uniti consolidarono le loro
istituzioni politiche e iniziarono un impetuoso sviluppo economico sia agricolo che industriale; ma
svilupparono un robusto nazionalismo costruito attorno alla contrapposizione fra la libertà
americana e la corruzione e la servitù europee.
Gli americani riconoscevano che il loro paese
dipendeva ancora dall’Europa in campo culturale e artistico e amavano profondamente l’Europa
come culla della civiltà; ma il loro amore si trasformava in un senso di distacco e di superiorità nei
confronti del Vecchio Mondo quando si passava alle istituzioni politiche e sociali o al campo della
fede religiosa.
In vari ambienti durante gli anni della Rivoluzione era stata accolta l’idea che gli americani
si dimostravano capaci di resistere alla “tirannia inglese” perché erano “veri cristiani” e addirittura –
sulla base di elaborazioni teologiche proprie del protestantesimo soprattutto calvinista - che gli
americani, al pari degli antichi Ebrei, vivevano in uno speciale “patto” con Dio che garantiva loro
libertà spirituale e politica finché si mantenevano fedeli a Cristo e alla Parola della Bibbia contro il
papismo di Roma e la tiepida fede protestante del Vecchio Mondo. La piena libertà religiosa e il
divieto di istituire una chiesa di stato fissati dal I° Emendamento (1791) alla Costituzione
rafforzarono, invece che indebolire le varie denominazioni religiose e gli impetuosi revival religiosi
di inizio Ottocento fecero di un acceso Protestantesimo, intensamente vissuto nelle sue più varie e
creative manifestazioni, una sorta di “religione civile” che accompagnò e spesso guidò
l’affermazione della democrazia negli anni Trenta e si integrò perfettamente con il nazionalismo.
La libertà, la prosperità, la pace interna, il benessere americani vennero ascritti a istituzioni politiche
diverse da ogni altra esistente, fondate sul dato provvidenziale che la terra e il popolo degli Stati
6
Uniti erano benedetti da Dio e destinati al compito storico di mostrare che libertà, pace e progresso
erano possibili sulla terra.
Nel primo periodo di vita nazionale gli Stati Uniti costruirono a tutti i livelli un ambiguo
rapporto di vicinanza e distacco rispetto all’Europa che non si è mai attenuato. Quando scoppiò la
Prima guerra mondiale il Presidente Wilson mantenne neutrale il paese fino alla primavera del 1917
in quanto riteneva, assieme a buona parte dell’opinione pubblica, che si trattasse di una guerra fra
potenze europee imperiali e imperialiste con le quali gli Stati Uniti non avevano nulla da spartire né
a livello politico, né. soprattutto, morale. Alla fine degli anni Trenta il Presidente F.D. Roosevelt,
pur convinto della estrema pericolosità di nazismo e fascismo per la democrazia, si mosse con
estrema cautela perché ben sapeva che i cittadini americani erano profondamente isolazionisti e
convinti che gli Stati Uniti, protetti dalla barriera dell’Oceano, non avevano nulla da temere e nulla
da chiedere all’Europa. Ciò è tanto vero che alla fine del 1941, quando i giapponesi attaccarono a
Pearl Harbour, gli Stati Uniti non erano ancora in guerra con la Germania e l’Italia, pur se aiutavano
in tutti i modi la Gran Bretagna. Negli anni di guerra le élite americane si convinsero vieppiù
dell’inadeguatezza degli europei a gestire se stessi e il mondo e della necessità che fossero gli Stati
Uniti a prendersi carico degli equilibri politici mondiali sostituendo definitivamente le potenze
europee, anche quelle alleate come la Gran Bretagna e la Francia.
2Fu proprio durante la Seconda guerra mondiale che le élite intellettuali statunitensi presero a
sviluppare la tesi secondo cui gli Stati Uniti, lungi dal non possedere una cultura all’altezza di
quelle europee come ancora molti in America ritenevano, ne avevano creato una del tutto originale
e non avevano più bisogno, neppure a questo livello, di un’Europa capace solo di creare mostri. La
vittoria americana e la successiva Guerra fredda rafforzarono ulteriormente il senso di orgogliosa
peculiarità degli americani, che avevano liberato l’Europa dall’orrore fascista, la salvavano dalla
fame con il Piano Marshall, le stavano insegnando a mettere in pratica i principi della libertà e della
modernità e la guidavano nella lotta mortale contro un altro mostro ideologico europeo nemico della
libertà, il comunismo.
La storiografia americana degli anni Cinquanta ebbe larga parte in questo processo con
quella che è stata chiamata la "scuola del consenso", parallela a un'altrettanto importante tendenza
della scienza politica. La scienza politica, infatti, riteneva di poter dimostrare che negli Stati Uniti
non vi era, né vi era mai stata lotta di classe, perché le classi studiate da Karl Marx erano il prodotto
di divisioni sociali europee che non si erano riprodotte oltreatlantico, dove ad essere socialmente ed
economicamente, oltre che quantitativamente dominante era la classe media, la “middle-class” che
agiva da cerniera fra tutte le classi sociali e garantiva il consenso politico attorno alla democrazia.
Negli Stati Uniti si aveva quindi pluralismo di idee e di progetti politici e quindi conflitto politico
pacifico fra "gruppi di interesse" diversi che si radunavano in maggioranze costantemente mutevoli,
ma che condividevano gli stessi ideali di base - quelli contenuti nella Dichiarazione di Indipendenza
e nella Costituzione. Ciò garantiva sia la libertà, perché nessun gruppo intendeva far prevalere una
propria ideologia sugli altri, sia la stabilità politico-sociale. Negli stessi anni gran parte degli
storici, scavando nel passato più lontano della nazione, l'età coloniale, ritennero di poter dimostrare
che sul suolo americano la storia europea aveva subito una radicale trasformazione che aveva dato
luogo a società non solo prive di aristocrazia, ma egualitarie, che potevano essere giudicate middleclass e quindi omogenee e nelle quali la presenza di un ampio diritto al voto già nel Settecento
garantiva la libertà e i fondamenti della democrazia. Da queste origini si era sviluppata per gli
storici del “consenso” una storia fondamentalmente priva di conflitti sociali, a partire dalla
rivoluzione del 1776; una rivoluzione che non aveva conosciuto gli scontri sociali e quindi le
catastrofi di quella francese; ma era stata una lotta di liberazione nazionale da parte di un popolo
che già possedeva istituzioni politiche libere. Il fatto che la generazione dei rivoluzionari del 1776
governò il paese per decenni – i primi cinque Presidenti, da George Washington a James Monroe
(1816-24), avevano tutti partecipato alla rivoluzione -, mentre la Rivoluzione francese aveva
"divorato i suoi figli" e la Francia rivoluzionaria non aveva conosciuto né stabilità politica, né
7
stabilità sociale, era per loro un'ulteriore dimostrazione della differenza, anzi, della profonda
spaccatura fra storia statunitense ed europea.
Da queste premesse si sviluppò la tesi dell' "eccezionalismo" americano, elaborata nella sua
forma definitiva dal sociologo Seymour Martin Lipset in The First New Nation del 1963, per la
quale la storia degli Stati Uniti sfuggiva alle "leggi" o ai processi storici che spiegavano la storia
europea e si muoveva lungo un percorso di libertà totalmente autonomo. Era questo loro incarnare
la libertà che aveva consentito agli Stati Uniti di correre in aiuto dell'Europa per ben due volte nel
corso del Novecento e che rendeva legittima la leadership americana nella lotta contro il
comunismo. Durante gli anni Cinquanta uno storico molto noto, Daniel J.Boorstin, scrisse che gli
americani avevano realizzato la libertà che gli europei erano stati solo capaci di pensare, facendo
così degli Stati Uniti l'unico paese in grado di incarnare lo spirito della civiltà occidentale. La
contrapposizione fra l’immagine di un'Europa astratta, persa nelle sue elucubrazioni, schiava delle
sue contraddizioni e schiacciata dal peso insopportabile e polveroso della sua storia, e un'America
giovane, libera, entusiasta, pragmatica, antiideologica divenne così uno degli elementi chiave del
sistema di autoidentificazione nazionale degli Stati Uniti. Contestualmente gli americani ritenevano
che gli europei non avessero altra alternativa che seguire la strada americana verso la democrazia e
la modernità.
Durante la Guerra fredda l’Europa aveva ancora un ruolo internazionale forte, Era il luogo
principale della medesima, l’area che le due superpotenze dovevano ad ogni costo controllare
ovvero nella quale le loro forze dovevano equilibrarsi. Non per nulla le guerre della Guerra fredda
– dalla Corea, al Vietnam, al Corno d’Africa, all’Angola - vennero sempre combattute lontano
dall’Europa, in aree dove USA e URSS potevano confrontarsi, vincere o perdere senza mai
scontrarsi direttamente. In Europa ciò sarebbe stato impossibile. Ogni tentativo da parte dell’una di
alterare gli equilibri di potere fra i due blocchi avrebbe portato allo scontro diretto con l’altra; per
questo l’Unione Sovietica non reagì quando, su impulso americano, il Partito Comunista Italiano
venne estromesso dal governo nel 1947 e gli Stati Uniti non fecero nulla quando la Rivoluzione
ungherese del 1956 e la Primavera di Praga del 1968 furono schiacciate dai carri armati sovietici.
Le cose stavano in questo modo perché l’Europa, nonostante le rovine della guerra, era ancora
considerata il fulcro dell’economia, del conoscere e aveva un valore simbolico essenziale per
entrambe le superpotenze che se ne consideravano le eredi e prosecutrici. Non per nulla la Guerra
fredda è terminata in Europa, con la caduta del muro di Berlino; ma la sua fine ha anche significato
la fine del ruolo internazionale dell’Europa. Un ruolo che, sia pure soltanto indiretto - attraverso
l’importanza primaria che essa aveva per le due superpotenze - era tuttavia centrale.
Se fra il 1945 e il 1989 gli Stati Uniti ritenevano di doversi battere per l’Europa perché la
civiltà americana realizzava le speranze di progresso e di libertà che nel Vecchio Mondo erano nate
ed erano state teorizzate, caduto il muro di Berlino esso è diventata una delle varie delle regioni del
mondo con cui l’unica superpotenza globale deve necessariamente avere rapporti. Rapporti ancora
suffusi di un particolare legame emotivo, estremamente intensi da un punto di vista economico e
privilegiati perché i sistemi sociopolitici europei sono ancora i più simili a quello americano; ma
non più centrali come prima del 1989. Come ha scritto un abile autore statunitense che si è
interrogato sulle differenze fra americani ed europei (Richard H.Pells, Not like Us, 1997), l’Europa
per gli americani è ormai soprattutto un museo da visitare durante le vacanze.
La Grande Europa
1-
Quanto scritto finora spero renda l’idea di un problema, di una grave difficoltà che è esistita
8
e continua a esistere nell’analisi reciproca portata avanti sia da europei che da statunitensi. Né gli
uni, né gli altri sono mai riusciti a comprendere bene cosa e perché li legava e li divideva al tempo
stesso e con quale prospettiva ci si doveva guardare dalle due sponde dell’Atlantico. Entrambi si
sono persi in una sorta di Labirinto intellettuale che li ha portati a fronteggiarsi senza riuscire a
comprendere esattamente l’interlocutore.
La porta d’ingresso nel Labirinto probabilmente consiste nella dicotomia costantemente
proposta oltreatlantico, ma accettata nel Vecchio mondo, fra “Europa” e “Stati Uniti”, che propone
un confronto, o un raffronto, fra due entità non paragonabili, in quanto disomogenee nella realtà.
Gli Stati Uniti sono, infatti, uno stato, hanno personalità giuridica internazionale, sono capaci di
esprimere una volontà politica unitaria, hanno un altrettanto unitario sistema economico e una
unitaria, anche se estremamente complessa società. La famosa battuta di Madeleine Albright,
Segretaria di Stato di Clinton, che diceva ironicamente che quando c’era bisogno di telefonare al
Ministro degli Esteri europeo non sapeva che numero fare, riflette ancor oggi un fatto che ancor più
era vero in passato, vale a dire che l’Europa è un insieme di entità politiche autonome,
profondamente diverse fra loro e con alle spalle storie altrettanto differenziate, non un’entità
politica, storica o culturale unitaria. Se così non fosse perché due guerre “mondiali” fra gli stati
dell’Europa soltanto nel Novecento? Perché una lunga storia di guerre di religione? Perché storie
di sviluppo economico e sociale tanto disomogenee? E perché tante difficoltà, oggi, a dar vita a
un’Unione europea davvero funzionante in modo unitario? E’ una questione di cattiva volontà e di
scarsa abilità politica, oppure di profonde differenze storiche e di interessi realmente diversi fra i
vari stati europei, pur nella consapevolezza che l’Unione è un punto di arrivo ineludibile? Definire
l’Europa in un modo unitario e univoco è pressoché impossibile, come mostra inequivocabilmente
Pietro Rossi in un recente libro (L’identità europea, 2007): né i suoi confini, né la sua storia, né le
sue cosiddette “radici” sono più che vasti processi, mutevoli e contraddittori al loro interno, e forse
proprio la differenziazione è la caratteristica prima di ciò che in modi sempre diversi nei vari
momenti storici possiamo chiamare Europa.
Nel contesto che qui ci riguarda, quello del rapporto Europa - Stati Uniti, “l’Europa” è in
buona parte un’”invenzione” (nel senso tecnico teso famoso da Hobsbawm) o una “costruzione”
della cultura americana; una costruzione necessaria a quest’ultima per auto-identificarsi e per
definirsi. E’, infatti, costruendo un personaggio fittizio chiamato “Europa” presentato come antitesi
di tutto ciò che gli Stati Uniti vogliono e debbono essere, che questi ultimi hanno fin dalle origini
definito se stessi – il proprio io ideale. La democrazia americana contrapposta all’autoritarismo e
alle dittature europee, la pace sociale opposta alla lotta di classe, il benessere alla povertà, il melting
pot americano al nazionalismo etnico europeo, il progresso al tradizionalismo. Lungo tutta la storia
americana le virtù a cui gli Stati Uniti debbono attenersi per non fallire nella loro missione storica di
libertà sono state illustrate – in modi diversi a seconda delle circostanze - mostrando le tragiche
conseguenze della loro assenza in “Europa”.
Può sembrare paradossale; ma la cultura statunitense ha costruito a proprio uso un’ “Europa”
quando ancora nessuno o pochi, in un Vecchio Mondo costituito da stati-nazione in competizione
continua fra loro e che intendevano radicalmente differenziarsi l’uno dall’altro, ne parlava come di
un soggetto politico unitario, oppure se ne parlava come di una “repubblica delle lettere”, di una
“civiltà” proveniente dall’antichità classica e cristiana, superiore alle barbare e decadute culture del
resto del mondo. La cosa interessante da notare è che, dal Settecento al Novecento, anche quando in
qualche modo gli europei parlavano di una comune civiltà europea, nel presente la si vedeva
incarnata e proseguita non in tutta Europa, bensì in un singolo stato. Così era, per non fare che tre
esempi, per Hegel che vedeva lo Spirito del Mondo realizzarsi storicamente nella Prussia di inizio
Ottocento o per gran parte degli intelletutali francesi che vedevano il razionalismo illuminista,
culmine della storia umana, imporsi al resto dell’Europa e al mondo attraverso la Rivoluzione del
1789, oppure per gli inglesi dell’età vittoriana che con il loro impero affermavano di portare nel
mondo la superiore civiltà dell’uomo bianco – il suo “fardello” come scrisse Kipling. La “civiltà
europea” esisteva in quanto si proponeva come superiore e dominatrice; ma erano singoli stati
9
europei - i più “avanzati” - a esprimerla e le teorie che ne parlavano erano normalmente espressione
del nazionalismo che permeava singoli autori e singole culture nazionali.
2Lungi dal poter proporre come fondante del rapporto storico fra le due sponde dell’Atlantico
la dicotomia “America” (vale a dire Stati Uniti) “Europa”, si deve allora riconoscere che le
differenze storiche fra Portogallo e Norvegia o fra Polonia e Inghilterra sono almeno altrettanto forti
di quelle proposte fra i due astratti campioni posti a giostrare fra loro sulle due sponde
dell’Atlantico ovvero anche di quelle fra Stati Uniti e un qualunque, singolo stato europeo. Invece
di un rapporto a due è quindi un polverio di entità e di storie nazionali quello a cui ci troviamo
davanti; un polverio dal quale occorre escludere oppure includere gli Stati Uniti.
Escludere gli Stati Uniti rafforzerebbe l’eccezionalismo e l’antieuropeismo americani e con
essi l’antiamericanismo più degenere, quello che fa dell’America un’entità estranea al corpo “sano”
dell’Europa – ancora “l’Europa”, ma questa volta reificata non al di là, bensì al di qua dell’Atlantico
-. Dichiarare gli Stati Uniti “europei” quando non è neppure possibile dare scientificamente
all’Europa una natura unitaria non porterebbe, però, ad alcun chiarimento sostanziale. Ancora una
volta il problema nasce dal voler fare dell’Europa o degli Stati Uniti dei veri e propri individui
dotati di un “carattere”, di una “identità” proprie; ma questa non è la realtà storica né degli Stati
Uniti, né di quella “persona ficta” che gli americani hanno costruito hanno chiamato Europa, né dei
singoli stati del Vecchio mondo, che sono tutti diversi, unici, originali eppure in qualche modo
“europei”
Ciò, tuttavia, non significa che lo storico si arrenda e rinunci a trovare un soddisfacente
quadro storico complessivo. Il suo compito è quello di dar ragione sia delle differenze, sia di ciò
che in qualche modo unisce le nazioni europee, nonché del rapporto fra le entità storiche e politiche
europee e gli Stati Uniti.
In una serie di volumi pubblicati a partire dagli anni 70’ lo storico economico Immanuel
Wallerstein, studiando le origini del capitalismo europeo nella prima età moderna, giunse a
teorizzare quello che chiamò il “sistema-mondo”, il “world-system”, capitalista. Con questo egli
intendeva non un sistema che copriva tutto il mondo o che dominava il mondo, perché in quei secoli
non era così, bensì un sistema che era “un mondo” in quanto era completo in se stesso e conteneva
in sé i principali meccanismi del proprio sviluppo. Tale sistema era situato in Europa ed era
composto dalle entità politiche europee che, a partire dal XVI secolo, vanno individuate con gli
stati. Il capitalismo è infatti una realtà internazionale che si sviluppa a livello interstatale; ma i
mercati statali – i mercati che gli stati garantiscono garantendo la pace interna, la difesa dagli
attacchi esterni e uno spazio economico il più possibile unitario – ne costituiscono la base
necessaria e tali sono restati fino a un periodo molto vicino a noi. Secondo Wallerstein il sistemamondo del capitalismo europeo è stato un sistema dinamico sia verso l’esterno, perché si è esteso
giungendo a dominare direttamente o indirettamente sempre più vaste zone extraeuropee, sia al
proprio interno. All’interno egli lo considera strutturato in tre anelli. Un anello centrale di “core
states”, gli stati principali, economicamente più avanzati, un secondo anello, che chiama semiperiferia, di stati mediamente avanzati e una periferia di stati arretrati. Questa struttura non si
modifica per Wallerstein nel tempo; ma in ogni anello mutano gli stati che ne fanno parte, perché
alcuni perdono di importanza e possono scivolare fino alla periferia, mentre altri possono giungere
dall’esterno fino al “core”, al centro. I casi principali nella storia moderna europea sono stati quelli
opposti della Spagna e dell’Inghilterra. La prima precipitò dal centro alla periferia fra il XVI e il
XIX secolo; la seconda risalì dalla periferia al centro fra il XVI e il XVIII.
La tesi che Wallerstein usa per la storia economica può facilmente essere applicata a quella
politica. Wallerstein medesimo, come appena detto, indica infatti negli stati i protagonisti della
storia del “world-system” capitalista. Inoltre, proprio a partire dall’età moderna l’economia diventa
la protagonista dell’insieme dei processi che vanno sotto il nome di modernizzazione, che ha
anch’essa negli stati un referente essenziale. Sulla modernizzazione esiste una letteratura
10
sterminata, in questa sede possiamo limitarci a parlarne come di una autonomizzazione delle varie
sfere dell’agire sociale – vale a dire delle diverse attività sociali degli individui - rispetto alla
situazione dominante fino al tardo Medio Evo. In età pre-moderna era. infatti, la sfera dell’agire
religioso che, da un punto di vista culturale anche se certo non sempre in pratica, dettava i principi
fondamentali dell’azione mondana. Un segnale sicuro dell’inizio della modernizzazione è dato
dall’autonomizzazione della sfera politica a cui diede il via Machiavelli con la tesi per la quale il
fine dell’azione del principe è la salvaguardia dello stato, da perseguire anche a costo di azioni
immorali e di mettere in forse la propria salvezza eterna. Con Machiavelli, come con la teoria della
sovranità di Bodin e con Hobbes, la politica diventa “auto-noma” nel senso greco del termine, cioè
diventa norma a se stessa – si auto-legittima -. A livello teorico non viene più spiegata attraverso la
teologia. Lo stesso avvenne per l’economia in un lungo processo che trovò ne “La ricchezza delle
nazioni” di Adam Smith il suo punto di arrivo e al tempo stesso il punto di partenza della teoria
economica moderna. L’autonomizzazione, cioè la capacità di trovare al proprio interno le regole
che reggono i comportamenti sociali – il mercato per l’economia, la sovranità statale per la politica , comporta una complessità e una pluralizzazione crescenti della vita sociale che costituiscono una
delle caratteristiche centrali della modernità e che si è estesa alla scienza, al consumo e a molti altri
campi.
Lo stretto nesso fra la crescita dell’autonomia della politica e la crescita dell’autonomia
dell’economia consente di applicare la teoria sistemica di Wallerstein agli stati europei. Da un
punto di vista politico, pertanto, possiamo dire che a partire dal XVI secolo in Europa si formò un
sistema i cui elementi base erano gli stati. Possiamo parlare di sistema in senso tecnico, come se ne
parla in matematica e in geometria, vale a dire un insieme di entità autonome l’una dall’altra, ma
unite fra loro da legami necessari. Le entità pienamente autonome – si pensi, ad esempio, al
principio della sovranità – sono gli stati, i legami sono stati di varia natura: legami dinastici,
alleanze, le stesse guerre seguite da trattati di pace, il commercio, la fede religiosa – sia quando
univa che quando divideva -, la cultura – nel Settecento si parlava di una “repubblica delle lettere”
europea, così come vi era una comunità scientifica europea -. Il sistema degli stati europei venne
ratificato con la pace di Westfalia del 1648, che pose fine alla Guerra dei trent’anni e inaugurò quel
sistema dell’ “equilibrio di potenza” che ha consentito al sistema di esistere fino alla sua tragica fine
nella Seconda guerra mondiale. L’ “equilibrio di potenza” o “balance of power” è stato il principio
non scritto, ma reale, che ha governato il sistema e per il quale nessuno stato riuscì mai a dominare
l’Europa, perché ogni volta che uno di essi ci provò – come nei casi della Francia di Luigi XIV o di
Napoleone o di Hitler – l’alleanza degli altri stati finì con l’impedirlo. Per questo in Europa non
sorse mai un impero e fin dal Settecento Montesquieu poté parlare degli imperi come di quelle
realtà politiche dispotiche che erano proprie dell’Asia, ma non trovavano spazio in Europa.
3Il sistema degli stati europei si è quindi retto sulla sua struttura in tre anelli – identica a
quella del “sistema-mondo” capitalista - ed è stato tenuto in equilibrio dal principio della “balance
of power”. Non si è trattato, però, di un sistema statico, al contrario. I processi di modernizzazione
che vi si sono instaurati a cominciare dal tardo Medio Evo e che hanno anche facilitato la nascita
degli stati, lo hanno dinamizzato sia all’interno che verso l’esterno. All’interno, come già detto, essi
hanno creato a partire dal tardo XV secolo un continuo flusso di entità politiche (all’inizio stati,
principati, signorie, città, poi soprattutto stati) che muovevano sia verso la periferia che verso il
centro del sistema a seconda della loro capacità di metter a frutto le spinte modernizzatici. Inoltre,
quei processi hanno fatto costantemente crescere la potenza complessiva del sistema portandolo ad
ampliarsi in aree ad esso esterne. Non parlo in questo momento del processo di colonizzazione in
Africa o in Asia, che è cosa diversa; ma del vero e proprio ampliamento dei confini europei che si
ebbe a est come a ovest. A est la Russia, dopo essere entrata a far parte dei sistema degli stati
europei nel XVI secolo diede il via a un processo di espansione territoriale che la portò a
conquistare l’intera Siberia, a spingersi verso il Caucaso e a strappare vasti territori all’impero
turco lungo il Mar Nero nel XVIII secolo. L’Austria cominciò a sua volta una lenta, ma continua
11
avanzata nei Balcani turchi, che si manifestò soprattutto dopo il fallimento del secondo assedio
ottomano a Vienna nel 1683 e proseguì lentamente fino al tardo XIX secolo. Nella prima metà
dell’Ottocento la Grecia, liberatasi anch’essa dai turchi nel 1829 dopo una pluriennale, sanguinosa
lotta, entrò a far parte del sistema europeo. Così pure la Romania nel 1877 e la Bulgaria dal 1878.
A ovest si ebbe la conquista più nota e spettacolare, quella delle Americhe da parte degli stati
atlantici e del nord Europa, Spagna, Portogallo,Olanda, Inghilterra, Francia e, per un breve periodo,
anche Svezia.
La conquista e la successiva colonizzazione delle Americhe da parte di queste nazioni diede
vita a imperi composti da colonie in cui la popolazione creola, vale a dire quella proveniente dalle
metropoli imperiali, era o numericamente maggioritaria o, se minoritaria, dominava con la forza la
popolazione locale o gli schiavi importati dall’Africa. In entrambi i casi si trattava di colonie in cui
la cultura dei conquistatori non si affiancò a quella delle popolazioni indigene e quest’ultima
normalmente non sopravvisse - come avvenne nelle del tutto diverse condizioni dell’India in cui gli
inglesi erano una piccola minoranza -, anche se soprattutto nelle colonie spagnole andine si verificò
un incontro e una sorta di meticciaggio fra le culture dei conquistatori e dei conquistati. Le colonie,
quindi, qualunque fosse la potenza europea colonizzatrice, vennero costruite a immagine della
madrepatria di cui gli abitanti creoli replicavano la cultura e le istituzioni e della cui economia esse
erano integralmente parte.
E’ quindi possibile dire che il sistema degli stati europei si ampliò oltreatlantico e formò una
sorta di quarto anello geograficamente del tutto esterno al Vecchio mondo e composto da società
separate, ma non autonome dalle metropoli ed espressione – quasi una continuazione – degli stati
che le possedevano. Nel tempo queste società, che inizialmente incontrarono forti difficoltà a
sopravvivere, si dimostrarono vitali e, pur mantenendo integra la loro fedeltà alle rispettiva
metropoli e la volontà di replicarne la struttura, vennero portate dalle condizioni locali a sviluppare
delle novità storiche locali, delle variazioni, insomma, a differenziarsi e a dar vita a realtà originali,
dotate di forme proprie di identità che non corrispondevano interamente a quelle delle metropoli ed
erano anche diverse da colonia a colonia all’interno del medesimo impero. Così il Messico e il Perù,
come la Virginia e il Massachusetts nel caso inglese. La crescita e la differenziazione delle società
coloniali non mise per un lungo periodo in crisi gli imperi europei che furono in grado di accettarle
e di assorbirle; ma dal terzo quarto del Settecento quelle differenze diedero luogo a contrasti di
interesse che si rivelarono irrisolvibili – una vera a propria alterità fra colonie e madrepatria – e
portarono a crisi senza precedenti degli imperi spagnolo e britannico I mutamenti intervenuti nello
stesso periodo anche nelle due metropoli (il trionfo inglese a partire dalla vittoria contro la Francia
nella Guerra dei sette anni terminata nel 1763 e la grande crisi spagnola di fine Settecento) non
fecero che aggravare la situazione e provocare una serie di rivoluzioni anticoloniali.
Nel mezzo secolo fra l’inizio della Rivoluzione americana nel 1776 e la piena indipendenza
del Messico nel 1821 la maggioranza delle colonie inglesi e spagnole d’oltreatlantico si resero
indipendenti. Sorse così un numeroso gruppo di stati sovrani abitati e dominati da europei che entrò
immediatamente a far parte del sistema degli stati europei, perché le loro istituzioni erano di tipo
europeo al pari della loro cultura e le loro economie erano legate al sistema economico europeo Si
trattava di stati deboli al momento dell’indipendenza e che per lo più rimasero tali a lungo, per cui
non solo si collocavano all’estrema periferia del sistema, ma anche strutturalmente appartenevano
alla sua periferia meno sviluppata. Tuttavia ne facevano a tutti gli effetti parte, costituivano un
ampliamento oltreatlantico dell’Europa, tanto che dagli anni delle rivoluzioni americane in poi non
si può più parlare di un sistema degli stati europei, perché esso si era ampliato al di là del Vecchio
mondo ed era diventato un più vasto “sistema degli stati della Grande Europa euro-americana”.
Parlare di “sistema della Grande Europa” è più corretto che parlare di un sistema politico
europeo e di uno americano – anche se i due possono essere considerati sottosistemi del sistema
grande-europeo -; ma più importante è che analizzare il mondo euto-americano attraverso le lenti
del sistema consente di superare le difficoltà legate al modo in cui gli europei hanno guardato alle
Americhe prima e agli Stati Uniti poi; ma anche quelle derivanti dall’eccezionalismo americano e
12
dall’antieuropeismo che lo accompagna. Infatti, qualora riconosciamo che gli Stati Uniti non hanno
avuto una storia “eccezionale”, estranea a quella degli stati del Vecchio mondo, ma hanno fatto
parte del sistema della Grande Europa dalla loro nascita fino alla distruzione di quest’ultimo nella
Seconda guerra mondiale, si arriva alla conclusione che essi, al pari di tutti gli altri stati, hanno
avuto una storia scientificamente comprensibile considerandola al tempo stesso originale e diversa
da tutte, e tuttavia legata a quelle europee da legami sistemici che sono empiricamente verificabili.
E’ sulla base di tutto quanto detto finora che si può formulare un quesito centrale per
chiunque si interessi di storia politica degli Stati Uniti e utile per valutare gli Stati Uniti nel
presente. Vale a dire, se gli Stati Uniti sono stati parte integrante del sistema degli stati della Grande
Europa e se al tempo della Seconda guerra mondiale erano ormai una delle grandi potenze, perché
non sono stati travolti da questa guerra al pari delle altre potenze – sia quelle sconfitte come la
Germania e l’Italia che quelle vincitrici come la Francia e la Gran Bretagna – a esclusione
dell’Unione Sovietica? Che cosa ha consentito loro non solo di salvarsi dalla disfatta o dal declino,
ma di trasformarsi in superpotenza e di dar vita con la stessa Unione Sovietica al sistema bipolare
della Guerra fredda? La risposta, in base a tutto quanto detto, è da cercarsi nell’intreccio fra lo
svolgersi di un comune processo di modernizzazione nei vari stati grande-europei e le specifiche
novità storiche che si sono sviluppate negli Stati Uniti e che hanno consentito loro di resistere alla
tempesta della cosiddetta “guerra civile europea” del Novecento e di uscirne vincitori.
.