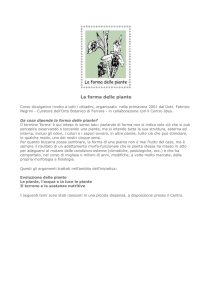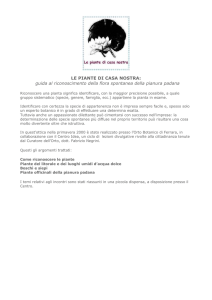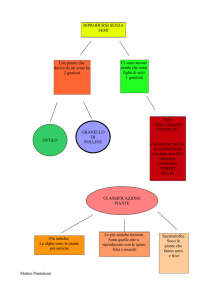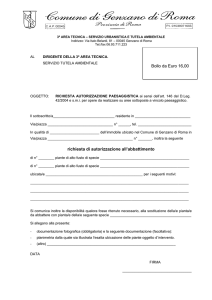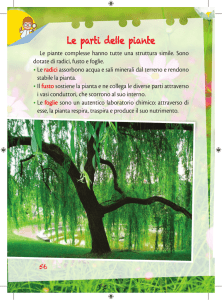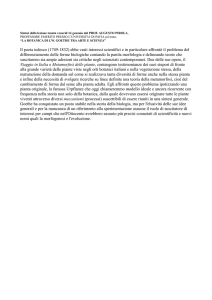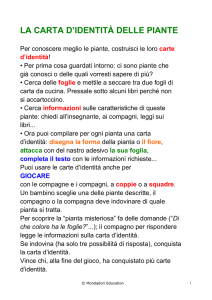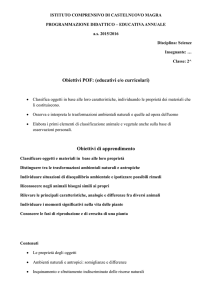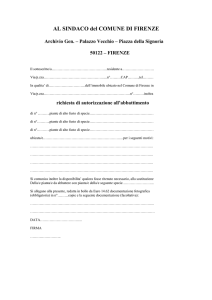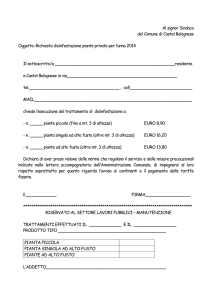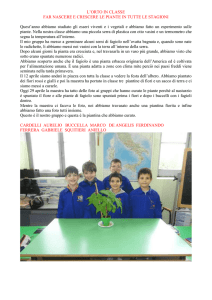selvicoltura
Selvicoltura d’albero nei
cedui giovani
Interventi di valorizzazione delle specie sporadiche
nell’ambito del Progetto LIFE+ PProSpoT
di Dalila Sansone, Elisa Bianchetto,
Claudio Bidini, Serena Ravagni
Damiano Nitti, Alessandro Samola
Francesco Pelleri
Il progetto Life+ PProSpoT (LIFE09 ENV/IT/000087) costituisce l’occasione di
applicare in Toscana, a livello di comprensorio, l’approccio selvicolturale ad
albero all’interno di formazioni boschive caratteristiche del contesto collinare e
montano dell’anti-appennino toscano. In questo articolo si descrivono i criteri di
intervento in popolamenti cedui in fase giovanile all’interno di formazioni miste
di latifoglie tipiche della fascia sopramediterranea.
I principi dell’approccio selvicolturale ad albero ed i primi
casi di applicazione nel territorio regionale sono stati discussi in alcuni articoli e manuali (Mori et al. 2007, Pelleri
et al. 2010, Pelleri 2010). Le tecniche di intervento proposte sono funzionali alla tutela e alla valorizzazione
delle specie considerate sporadiche dal Regolamento Forestale regionale (Regione Toscana 2003). Tutela
e valorizzazione da intendersi da un punto di vista sia
ecologico che produttivo, laddove le condizioni risultino
idonee a perseguire tale scopo. Il progetto prevede la
realizzazione di interventi dimostrativi in due diversi comprensori, caratterizzati da formazioni forestali differenziate
per composizione specifica e forma di governo:
• il complesso delle Colline Metallifere (Provincia di
Grosseto) con formazioni cedue di latifoglie a diverso
stadio di sviluppo;
• il complesso Abetone-Melo (provincia di Pistoia) con
altofusto di faggio e cedui di castagno invecchiati.
L’approccio ad albero, distinto da quello di popolamento
(Del Favero 2005), si ritiene essere in grado di garantire la
valorizzazione in senso lato delle specie sporadiche (Spiecker 2008) naturalmente presenti nelle formazioni boschi-
ve regionali. La maggior parte delle specie classificate
come tali (riferimento normativo art. 12 R48/2003) ha capacità competitive ridotte rispetto alle specie dominanti,
5
Sherwood
n .185
L uglio -A gosto 2012
a causa di differenti ritmi di crescita, di maggiori esigenze
di luce e/o di specifiche condizioni stazionali. In alcuni
casi la selvicoltura di tipo tradizionale, caratterizzata da
interventi diffusi e orientati a favorire le specie sociali che
caratterizzano il popolamento, ha causato una progressiva riduzione della presenza delle specie sporadiche, in
particolare nei popolamenti invecchiati.
Nei contesti in cui la diffusione di specie sporadiche è
significativa, l’accessibilità al bosco sia favorevole e le
condizioni ecologiche locali ne consentano un buono
sviluppo, l’applicazione di una selvicoltura incentrata
sul singolo soggetto invece che sul popolamento
consente sia il mantenimento di condizioni idonee alla
persistenza di tali alberi nella composizione specifica (ed
eventualmente alla loro rinnovazione), che la loro valorizzazione in termini produttivi. Con questo contributo si
descriveranno il contesto ed i criteri di intervento in popolamenti cedui in fase giovanile del comprensorio delle
Colline Metallifere, all’interno di formazioni miste di latifoglie tipiche della fascia sopramediterranea.
Nella particella A37 il ciavardello (Sorbus torminalis L.) è
la specie sporadica prevalente, ed è presente un maggior numero di specie sporadiche, con un peso percentuale in termini di area basimetrica (5,83%), più significativo che non nella B18 (0,44%). Nella particella B18 la
specie prevalente è il sorbo domestico (Sorbus domestica L.) e si riscontra una minore diversificazione specifica.
All’interno dei popolamenti presi in esame sussistono le
condizioni per la valorizzazione economica delle specie
sporadiche (buona accessibilità, condizioni favorevoli al
loro sviluppo); in particolare, la loro significativa diffusione consente di selezionare un numero sufficiente di piante obiettivo e le condizioni ecologiche presenti garantiscono modalità di crescita idonee per ottenere soggetti
di buono sviluppo.
Nei casi in cui la diffusione delle specie sporadiche è limitata, gli interventi a loro favore avranno invece carattere
prevalente di tutela, finalizzati a mantenere e/o incrementare la biodiversità a livello di popolamento. Avendo
come obiettivo la tutela della biodiversità gli interventi
verrebbero realizzati a favore di tutte le piante di specie
sporadiche presenti e non solo su quelle valorizzabili in
termini produttivi.
L’obiettivo duplice di tutela e valorizzazione comporta
l’attuazione di interventi che consentano di mantenere
o incrementare la mescolanza naturalmente presente e
portare a fine ciclo produttivo alcuni soggetti di piante
sporadiche a legname pregiato, mantenendo il governo
Area di intervento
Gli interventi sono stati realizzati in due particelle assestamentali del comprensorio Colline Metallifere - Monti di
Prata (GR), gestiti dall’Unione dei Comuni Montana delle
Colline Metallifere. Si tratta di formazioni cedue di latifoglie miste a dominanza di cerro. Nei due popolamenti la
presenza di specie sporadiche risulta diversa (Grafico 1).
Sorbo
domestico
31
Ciavardello
45
Acero
campestre
3
Acero
montano
2
Sorbo
domestico
5
Ciliegio
2
Ciavardello
4
Acero
campestre
4
Agrifoglio
2
Perastro
1
Grafico 1 - Ripartizione specie sporadiche per particella. Valori riferiti alle sole piante obiettivo. Particella A37 a sinistra e B18 a destra.
Superficie (ha)
Età del ceduo
N. piante obiettivo
Diametro (cm)
Altezza media
(m)
Altezza di
insidenza (m)
Diametro
chioma (m)
A37
9,38
15
59
13,8
10,7
4,3
4,16
B18
8,97
13
40
4,2
5,9
2,7
1,64
N. particella
Tabella 1 - Caratteristiche medie delle piante obiettivo selezionate nelle due particelle.
Qualità
Particella
Lunghezza media tronco da lavoro (m)
A
B
C
D
nc
A37
3,78
1,67%
41,67%
38,33%
15%
3,33%
B18 (5m)(1)
2,88
20%
55%
25%
B18 (3m)(2)
3,02
10%
85%
5%
Note (1) Taglio di tutte le piante a 5 m della pianta obiettivo. (2) Taglio di tutte le piante a 3 m della pianta obiettivo
Tabella 2 - Lunghezza media del tronco da lavoro e ripartizione percentuale per classi di qualità delle piante obiettivo selezionate.
6
Sherwood
n .185
L uglio -A gosto 2012
a ceduo della parte restante del soprassuolo. Ciò porterà
quindi un incremento tanto del valore ecologico (mantenimento di soggetti di specie sporadiche in buone condizioni di vigore e sviluppo, in grado di fruttificare e potenzialmente riprodursi), tanto di quello economico della
formazione boschiva nel suo complesso (produzione di
assortimenti di pregio in aggiunta alla legna da ardere).
Intervento
Nelle due aree, analogamente a quanto fatto per tutte le
superfici su cui è prevista l’attuazione del progetto (Fantoni et al. 2012), sono state selezionate e posizionate
con GPS 99 piante classificabili come alberi obiettivo (59 nella A37 e 40 nella B18). I parametri presi in
esame per la selezione sono nell’ordine:
• accessibilità;
• vigore;
• qualità del fusto.
Le piante obiettivo devono essere facilmente raggiungibili
per ovviare ad un aggravio eccessivo dei costi di intervento; il soggetto deve risultare vigoroso e quindi potenzialmente competitivo, non presentare sintomi di indebolimento e, se oltre a scopi di tutela della biodiversità ci
sono anche intenti produttivi, deve avere caratteristiche
del fusto idonee per ottenere un tronco da lavoro collocabile nella fascia alta di mercato (Chièze e Sardin 2005).
Le caratteristiche medie delle piante selezionate sono riportate in Tabella 1. Si tratta di soggetti verso la fine della
fase di qualificazione(1) o all’inizio della fase di dimensionamento(2) con lunghezza media del tronco da lavoro, privo
di rami, superiore ai 3 m, (Tabella 2). Nella classificazione
dei potenziali tronchi da lavoro si è fatto riferimento alla
metodologia descritta per gli impianti di arboricoltura da
legno in fase di dimensionamento (Nosenzo et al. 2008).
Il tipo di intervento proposto è un diradamento dall’alto, localizzato nell’intorno delle piante obiettivo, con
intensità localmente forte ma mediamente debole,
finalizzato a rimuovere la competizione esercitata dalle
chiome delle piante vicine. La differenza sostanziale tra un
diradamento tradizionale e quello effettuato è sia di tipo
spaziale (diradamento localizzato e non uniforme su tutta
la superficie) che d’impostazione.
Non si agisce in modo diffuso su tutto il popolamento,
concentrando il prelievo su alcune classi sociali, ma si interviene eliminando i diretti competitori delle piante obiettivo, il che comporta che localmente numero e
posizione sociale dei competitori possano essere molto
diversi. La tecnica di diradamento descritta, nota come
dètourage (Claessens 2004), è comunemente adottata
nelle foreste centro europee in cui si pratica selvicoltura
d’albero per la produzione di legname di pregio (Bastien
e Wilhelm 2003); riducendo la compressione laterale
delle chiome, aumenta lo spazio a disposizione della pianta obiettivo per poter espandere la chioma
e mantenere un incremento diametrico sostenuto, quanto più possibile costante, fino all’occupazione
di tutto lo spazio liberato dal taglio, momento in cui si
dovrà procedere al dètourage successivo. Il tempo di
ritorno oltreché dall’intensità del diradamento realizzato
(distanza tra chioma della pianta obiettivo e chioma dei
Specie
Diametro
(cm)
Altezza media
(m)
Altezza di
insidenza (m)
Diametro
chioma (m)
Acer campestre
10,5
10,47
3,07
3,1
Acer pseud.
10,1
10,75
4,15
5,43
Sorbus torminalis
13,37
10,49
4,24
4,06
9,5
5,3
1
3,34
Ilex aquifolium
Prunus avium
22,75
15,1
6,3
6,69
Sorbus domestica
16,64
12,42
5,84
3,59
Tabella 3 - Caratteristiche medie per specie delle piante obiettivo particella A37 (età del
ceduo 15 anni).
Specie
Diametro
(cm)
Altezza media
(m)
Altezza di
insidenza (m)
Diametro
chioma (m)
Acer campestre
3,75
5,4
2,1
1,87
Sorbus domestica
3,6
5,38
2,53
1,61
Sorbus torminalis
3,75
5,82
2,6
1,45
Tabella 4 - Caratteristiche medie per specie delle piante obiettivo B18 trattate a 3 m dal
fusto (età del ceduo 13 anni).
Specie
(1) Fase in cui progressivamente si forma, per potatura naturale o
artificiale, un fusto privo di rami per 1/4 o 1/3 dell’altezza potenziale
della pianta a maturità.
(2) Fase in cui si cerca di ottenere il massimo accrescimento diametrico garantendo un adeguato spazio alla chioma con opportuni
diradamenti.
Diametro
(cm)
Altezza media
(m)
Altezza di
insidenza (m)
Diametro
chioma (m)
Acer campestre
3,95
5,85
2,6
2,55
Sorbus domestica
4,93
6,47
2,9
1,87
Sorbus torminalis
2,6
5,1
2,2
1,19
Pyrus piraster
4,7
7,3
2,9
2,14
Tabella 5 - Caratteristiche medie delle piante obiettivo B18 trattate a 5 m dal fusto (età del
ceduo 13 anni).
7
Sherwood
n .185
L uglio -A gosto 2012
Particella
Diametro buca
post taglio (m)
Ampiezza
dètourage (m)
N. competitori
tagliati (%)
Rid.% indice
di Hegyi
A37
7,71
1,77
12 (35,3%)
62%
B18 (5 m)(1)
8,82
3,59
31 (100%)
100%
B18 (3 m)(2)
6,93
2,64
14 (40%)
50%
Note (1) Taglio di tutte le piante a 5 m della pianta obiettivo. (2) Taglio di tutte le piante a 3 m della pianta obiettivo
Tabella 6 - Caratteristiche del diradamento localizzato nell’intorno delle piante obiettivo.
A37
Piante
(n/ha)
Ceppaie
(n/ha)
Area
basimetrica
(m2/ha)
Diametro
medio
(cm)
Altezza media
(m)
Pre
5.292
1.087
Taglio
Prelievo %
16,93
5,55
8,77
368
1,41
5,79
8,95
6,95%
8,33%
Tabella 7 - Caratteristiche del popolamento e del diradamento particella A37 (15 anni).
B18
Piante
(n/ha)
Ceppaie
(n/ha)
Area
basimetrica
(m2/ha)
Diametro
medio
(cm)
Altezza media
(m)
Pre
2.874
2.341
Taglio
Prelievo %
11,84
6,85
7,65
225
0,9
6,94
7,69
7,83%
7,60%
Tabella 8 - Caratteristiche del popolamento e del diradamento particella B18 (13 anni).
presente entro un raggio di 3 o 5 m dal piede della pianta
obiettivo (indipendentemente dalla competizione effettiva tra le chiome). Nelle Tabelle 3, 4 e 5 sono riportate
le caratteristiche medie per specie delle piante obiettivo
rispettivamente della particella A37, B18 con interventi
a 3 m dal fusto e B18 con interventi a 5 m dal fusto.
Le piante obiettivo attorno alle quali sono stati realizzati
gli interventi sono oggetto di monitoraggio tanto dei
parametri dendrometrici caratteristici, quanto delle dinamiche di competizione, mediante calcolo di un
indice specifico, l’indice di Hegyi(3). In seguito al taglio
è stato possibile stimare quantitativamente, attraverso la
variazione dell’indice, la riduzione della competizione a
livello di singola pianta (Tabella 6) ma non essendoci riferimenti specifici in letteratura, sarà il monitoraggio, negli
anni successivi, a farci capire in che modo le variazioni
dell’indice siano correlate alla dinamica di crescita dei
soggetti presi in esame.
Discussione
Figura 1 - Esempio grafico di un intervento di dètourage intorno alla pianta obiettivo.
competitori) dipende dalla capacità di espansione della
chioma ed è quindi in funzione tanto della specie quanto delle condizioni stazionali. Nell’ambito degli interventi
dimostrativi del LIFE+ PProSpoT, sono stati adottati due
approcci metodologici diversi, per valutarne la facilità di
replica sia in fase di martellata che di esecuzione dei tagli.
Nella particella A37 sono stati rimossi tutti gli individui in
competizione diretta con la pianta obiettivo, cioè con la
chioma entro 1 o 2 m di distanza, rilasciando tutte le altre
piante (generalmente soggetti dominati con chiome al di
sotto di quella della pianta obiettivo). Nella B18 invece
sono state tagliate tutte le piante che avevano il tronco
8
Sherwood
n .185
L uglio -A gosto 2012
A livello di popolamento l’intervento risulta debole, asportando in media circa l’8% di area basimetrica e il 7,4%
del numero di alberi. Le piante al taglio hanno caratteristiche medie analoghe a quelle del popolamento (Tabella
7 e 8). Ai fini del calcolo dell’indice di competizione si
considerano “competitori” tutte le piante comprese
entro un raggio di 5 m dal piede dell’albero obiettivo. In media sono stati tagliati 19 competitori per albero
obiettivo, con delle differenze a seconda dell’approccio
(3) L’indice di Hegyi, è un indice di competizione di facile applicazione, basato sul rapporto dimensionale tra la pianta obiettivo ed i competitori e la distanza reciproca (Indice H = ∑ diametro competitore/
diametro pianta obiettivo * 1/distanza competitore-pianta obiettivo). Il
problema principale nell’applicazione di tale indice è l’individuazione
dei competitori. In questo caso sono stati considerati tali tutte le
piante presenti entro 5 m di raggio dal piede della pianta obiettivo.
metodologico. Nella A37, dove sono stati tagliati solo i
competitori con chiome in competizione diretta con quella dell’albero obiettivo, il diradamento ha interessato il
35,3% dei competitori consentendo mediamente l’apertura di un gap con al centro l’albero obiettivo di 7,71 m
di diametro (circa 47 m2). Nella B18, per le piante con
rimozione di tutti gli alberi entro un raggio fisso di 5 m,
il 100% dei competitori è stato rimosso e si è praticata
un’interruzione della copertura mediamente di 8,82 m di
diametro medio con al centro la pianta obiettivo(4). Nel
caso delle piante liberate entro 3 m è stato tagliato il 40%
dei competitori con conseguente apertura di 6,93 m di
diametro medio. L’ampiezza del dètourage definita
come la distanza media tra la proiezione della chioma
dell’albero obiettivo e la chioma delle prime piante non
tagliate, risulta rispettivamente 1,77 m, 3,59 m e 2,64 m
(Figura 1).
Tempi di lavoro
La fase di individuazione, selezione, marcatura e posizionamento con GPS delle piante obiettivo, deve essere
eseguita da tecnici abilitati all’esecuzione della martellata
e in grado di attribuire una classe di qualità potenziale
al tronco da lavoro della pianta obiettivo. In questa fase
vengono anche individuate e segnate le piante da abbattere. Il lavoro è stato svolto da squadre di due persone
con una produttività di 6 piante obiettivo all’ora: individuate, georeferenziate e segnate in modo permanente
con vernice; in questi tempi è compresa anche la martel(4) Anche in questo caso l’ampiezza della buca è stata calcolata a
partire dalla proiezione delle chiome delle piante poste ai margini
dell’apertura praticata nella copertura del popolamento arboreo. Con
questo approccio lo spazio messo a disposizione di ciascuna pianta
obiettivo è risultato essere mediamente di 61 m2, quindi mediamente
più ampio del 32% di quello delle piante obiettivo presenti nella
particella A37.
lata, cioè l’individuazione e la marcatura dei competitori
da rimuovere con il dètourage. Il taglio è stato eseguito
dagli operai dell’Unione dei Comuni Montana delle Colline Metallifere, in amministrazione diretta, con squadre
composte da due operai di cui uno con motosega. I dati
relativi ai tempi di taglio e allestimento sono parziali e riguardano solo la particella B18. Il dètourage ha richiesto
mediamente 50 minuti a squadra per ogni pianta obiettivo, ovvero 1h e 40’ a operaio. L’intervento, in cedui di
questa fascia di età, non è economicamente positivo in
quanto prevede l’abbattimento in media di 0,35 mst di
legna da ardere per pianta obiettivo. Il valore complessivo
del materiale di risulta non è sufficiente a coprire i costi
di intervento. Sebbene non conveniente in termini economici, il diradamento in questa fase di sviluppo risulta
determinante per garantire condizioni ottimali di crescita
alle specie sporadiche.
Si tratta di un vero e proprio intervento colturale che,
con semplici accorgimenti, può essere integrato con la
normale attività di ceduazione sul resto del soprassuolo. Condizioni ottimali di illuminazione oltre a favorire
l’accrescimento diametrico, stimolano la fruttificazione e
consentono la conservazione delle specie meno competitive con indubbi vantaggi anche dal punto di vista
della biodiversità (diversificazione della composizione e
della struttura del popolamento, mantenimento di nicchie
ecologiche specifiche). è tuttavia da rilevare che un diradamento localizzato di questo tipo non rientra tra gli
interventi normalmente realizzati dagli operatori, di conseguenza anche la mancanza di “familiarità” con la procedura ha probabilmente un ruolo non indifferente nella
determinazione dei tempi di lavoro.
Dotare le squadre di mappe con indicazione delle curve
di livello e della posizione relativa di ciascuna pianta obiettivo (posizionate con GPS) è un accorgimento importante
per ridurre i tempi di spostamento da una pianta all’altra,
soprattutto in condizioni di scarsa visibilità come un ceduo giovane. Anche eseguire il lavoro in amministrazione
diretta è una scelta particolarmente importante a questo
stadio di sviluppo, poiché il rischio di danneggiare irreversibilmente la pianta obiettivo, eseguendo in maniera
incauta il taglio nelle immediate vicinanze, è piuttosto alto.
Considerazioni
L’interesse per la realizzazione nei cedui giovani di interventi localizzati mirati a favorire l’espansione delle chiome, il conseguente accrescimento diametrico, nonché
la futura fruttificazione, scaturisce dal fatto che le piante
giovani mostrano maggiore reattività in risposta alla variazione delle dinamiche di competizione, soprattutto diretta. Nei cedui invecchiati invece quando il portamento e la
qualità del fusto sono già stati determinati dalle condizioni
di crescita precedenti, la capacità di reazione alle cure
colturali è limitata dall’età delle piante stesse ed i margini
di miglioramento delle caratteristiche dei singoli soggetti sono fortemente ridotti. Il progetto PProSpoT prevede
9
Sherwood
n .185
L uglio -A gosto 2012
comunque il monitoraggio di piante obiettivo oggetto di
interventi localizzati anche in cedui invecchiati, i cui dati
saranno oggetto di un prossimo contributo.
Esperienze di interventi con approccio selvicolturale ad
albero in Italia sono riconducibili a pochi esempi (Giulietti
et al. 2009, Pelleri et al. 2009, Raviglione et al. 2011,
Wolinsky et al. 2006), per lo più realizzati in fustaie, quindi a carico di specie ed in contesti forestali completamente diversi. Poco si conosce anche della dinamica di
crescita delle specie sporadiche in questo tipo di realtà
dal momento che gli studi disponibili sono stati condotti
in centro Europa e solo per alcune delle specie a cui si
fa riferimento.
Di conseguenza il monitoraggio di questi interventi consentirà di osservare le dinamiche di crescita e di competizione delle specie sporadiche trattate all’interno di boschi cedui di fascia sopramediterranea. Obiettivo di tali
osservazioni è principalmente quello di fornire indicazioni
utili a tarare intensità e tempi di ritorno degli interventi
proposti, in modo tale da sviluppare un modello di selvicoltura, sostenibile anche dal punto di vista economico,
che integrando il trattamento di tipo tradizionale dei boschi governati a ceduo consenta effettivamente di tutelare la diversità dei popolamenti forestali e accrescerne
parallelamente il valore economico.
Valutazione degli assortimenti ritraibili. Sherwood - Foreste ed
Alberi Oggi, n. 145: 15-19.
Pelleri F., Pividori M., Giulietti V., 2009 - Cure colturali in acerofrassineti secondari in Italia settentrionale. Atti III Congresso
Nazionale di Selvicoltura, Taormina, 16-19 ottobre 2008: 887-893.
Pelleri F., 2010 - La selvicoltura d’albero e le specie sporadiche nei cedui. ATTI del 46° Corso di Coltura in Ecologia - San
Vito di Cadore 7-10 giugno 2010. “Gestione multifunzionale e
sostenibile dei boschi cedui: criticità e prospettive”: 189-200.
Pelleri F., Giulietti V., Sansone D., Samola A., Nitti D., 2010 Valorizzazione delle rosacee arboree. Esperienze nei cedui
delle colline metallifere (GR). Sherwood - Foreste e Alberi Oggi,
n. 160: 5-11.
Raviglione M, Collattin A., Motta R., Nosenzo A., Berretti R., Meloni F., Wolinski A., 2011 - Interventi selvicolturali sperimentali
in boschi di faggio della Val Sessera. www.regione.piemonte.
it/foreste/cms/media/files/pian_gest/ricerca/progetto_valses
sera.pdf
Regione Toscana, 2003 - Regolamento Forestale della Toscana. DPGR n. 48/R
Spiecker H., 2008 - Specie sporadiche. Un’opportunità per foreste multifunzionali. Sherwood - Foreste ed Alberi Oggi n. 145: 4-8
Wolynsky A., Berretti R., Motta R., 2006 - Selvicoltura multifunzionale orientata alla qualità. Sherwood - Foreste ed Alberi
Oggi n. 118: 5-12.
i n f o . artic o l o
Autori: Dalila Sansone, Assegnista CRA-SEL.
E-mail [email protected]
Elisa Bianchetto, Ricercatore CRA-SEL. E-mail [email protected]
Claudio Bidini, Tecnico CRA-SEL. E-mail [email protected]
Serena Ravagni, Contrattista CRA-SEL. E-mail [email protected]
Damiano Nitti, Tecnico Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere.
Bibliografia
Bastien Y., Wilhelm G.J., 2003 - Selvicoltura d’albero: un approccio per la produzione di legname con buone caratteristiche e di grandi dimensioni. Sherwood - Foreste e Alberi Oggi
n. 86:5-13.
Chièze F., Sardin T., 2005 - Designazione degli alberi obiettivo.
Sherwood - Foreste e Alberi Oggi n. 117: 9-12.
Claessens H., 2004 - Réflexion sur le détourage des feuillus à
croissance rapide. Forêt wallone n. 71 : 3-11.
Del Favero R., 2005 - Considerazioni sulla gestione dei boschi alpini di latifoglie per la produzione di legname di qualità. In: Foreste Ricerca Cultura. Scritti in onore di Orazio Ciancio.
Accademia Italiana di Scienze Forestali, Firenze: 153-166.
Fantoni I., Miozzo M., Rella E., 2012 - Pianificazione e specie
sporadiche. Prime esperienze italiane in ambito del Progetto
LIFE+ PProSpoT. Sherwood, Foreste ed Alberi Oggi n. 184: 9-14
Giulietti V., 2008 - Short term scientific mission report. COST
E42, growing valuable broadleaved tree species.
www.valbro.uni-freiburg.de/stsm.-php.
Giulietti V., Ferretti F., Pelleri F, 2009 - Prove di diradamento
in acero-frassineti di neoformazione nella Comunità Montana Agno-Chiampo (VI): risultati dopo il secondo intervento.
Annali CRA-SEL, 35, 2007-2008: 87-100.
Mori P., Buresti Lattes E., Bruschini S., Giulietti V., Grifoni F.,
Pelleri F., Ravagni S., Berti S., Crivellaro A., 2007 - Selvicoltura
delle specie sporadiche in Toscana. Agenzia Regionale per lo
Sviluppo e l’Innovazione nel settore Agricolo-forestale (ARSIA)
della Toscana, Firenze, 352 pp.
Nosenzo A., Berretti R., Boetto G., 2008 - Piantagioni da legno.
10
Sherwood
n .185
L uglio -A gosto 2012
E-mail [email protected]
Alessandro Samola, Tecnico Unione dei Comuni Montana Colline
Metallifere. E-mail [email protected]
Francesco Pelleri, Ricercatore CRA-SEL. E-mail [email protected]
Parole chiave: Selvicoltura d’albero, specie sporadica, ceduo giovane,
intervento localizzato, pianta obiettivo, détourage, indice di competizione
Progetto LIFE+ PProSpoT, Toscana.
Abstract: Tree oriented silviculture interventions in young broadleaves coppices to favour sporadic tree species. The PProSpoT LIFE+
project. The paper describes first tree oriented silviculture interventions
in Tuscan young broadleaves coppice. The interventions have been
planned in the framework of the Life+ project PProSpoT with the aim to
introduce the tree oriented silviculture in Tuscany forests. Different criteria
of selective thinnings have been carried out only around target sporadic
tree species to increase the available space for their crown-growing. This
approach allows to maintain forest biodiversity and to increase the wood
value of these sporadic species.
Key words: Tree oriented silvicolture, sporadi tree species, young broadleaves coppie, localized intervention, target tree, détourage, competition
index, PProSpoT LIFE+ project, Tuscany.
Sia nell’impostazione del lavoro che per la realizzazione finale degli interventi sono stati fondamentali la collaborazione, la disponibilità, l’esperienza
ed il supporto di tutti gli operai dell’Unione dei Comuni Montana delle
Colline Metallifere ai quali vanno i nostri ringraziamenti.
ll presente articolo è stato prodotto nell’ambito del
Progetto LIFE09 ENV/IT/000087 P.Pro.Spo.T. - Policy and
Protection of Sporadic tree species in Tuscany forest.
www.pprospot.it