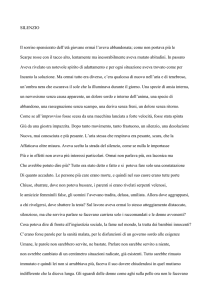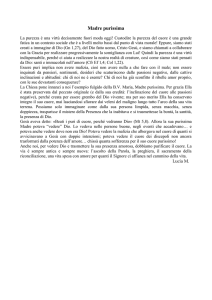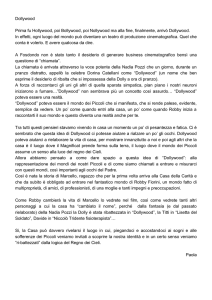caricato da
emilio.valino
Diritto romano Istituzioni e Storia Eva

DIRITTO ROMANO, ISTITUZIONI E STORIA – Eva Cantarella I romani fecero del diritto una scienza, un sistema articolato di principi, estratti dalle diverse norme che regolavano la loro vita sociale. Esso, attraverso i secoli, è giunto sino ai nostri giorni, influenzando in diversa misura il diritto di molte nazioni moderne. A partire dall’anno 1000 circa, infatti il diritto romano, attraverso la Compilazione giustinianea in cui era stato raccolto nel secolo VI d.C., ricominciò a essere studiato nelle scuole (grazie in primis a Irnerio nella sua scuola di Bologna) e a essere utilizzato nella pratica in molti paesi europei; solo l’Inghilterra non recepì il diritto romano e mantenne la sua Common Law (influenzata comunque dal sistema romanistico). Nacquero quindi due grandi famiglie di diritti di origine europea, quella dei diritti derivati dalla Common Law (nei vari paesi anglosassoni), e i diritti di tradizione romanistica (applicati in quasi tutti i paesi europei i cui sistemi si basano sui principi affermati durante la seconda vita del diritto romano). Tra i secoli XI e XIII lo studio del diritto romano fu opera e appannaggio della scuola dei glossatori (le glosse erano delle annotazioni che loro facevano studiando i testi giustinianei), la cui opera più imponente è quella di Accursio, composta di 96.000 glosse. Nei due secoli successivi (XIV e XV) esso venne tradotto in principi risolutivi di questioni scolastiche, nate nella pratica del commercio e della vita internazionale, che valevano in quanto communis opinio doctorum (opinione comune tra gli esperti). Il diritto romano ha lasciato tracce di sé anche quando ha cessato di essere diritto vigente; questo accadde nel secolo XIX, a partire dall’emanazione del Codice francese napoleonico del 1804 e quello austriaco del 1811, cui fecero seguito, i codici degli Stati italiani preunitari, i codici del Regno d’Italia del 1865 e, infine, nel 1900 il Codice civile tedesco (BGB). Tutt’oggi lo studio del diritto romano fondamentale della formazione dei giuristi. continua a essere parte Storicizzare il diritto I sistemi giuridici che fiorirono nel mondo antico prima del diritto romano furono molti. Il fatto che il diritto romano si sia sviluppato acquistando un’importanza del tutto speciale non giustifica che esso sia prospettato come un fenomeno isolato e solitario, nato fuori della storia e degli influssi culturali dell’epoca. Esso non va studiato come fenomeno isolato e solitario, ma va inserito e valutato nell’ambiente storico e culturale in cui si sviluppò. A. Premessa storica. La penisola prima di Roma a) Il problema delle origini Secondo Erodoto, gli etruschi sarebbero venuti dalla Lidia (Asia Minore) tra il 1500 e il 1000 a.C., ma Dionigi di Alicarnasso sosteneva che gli etruschi non fossero un popolo immigrato da terre straniere, ma bensì indigeno; gli storici moderni tendono ad accettare questa seconda ipotesi, non di rado collegando il sorgere della civiltà etrusca alle ultime manifestazioni di quella villanoviana. Partendo dall’insediamento originario in Toscana, gli etruschi si espansero a Nord sino alla Pianura Padana; a Sud, essi non solo dominarono Roma per una parte del secolo VI a.C., ma giunsero a Cuma, Napoli e nel salernitano e tra i secoli VII­VI a.C. avevano ormai conquistato il controllo del Mar Tirreno. Alla fine del secolo, però, il potere etrusco cominciò a declinare; nel 510 i re etruschi furono cacciati da Roma, ove venne instaurata la repubblica; questa sconfitta, insieme a quella subita nel 474 a.C. ad opera dei greci di Siracusa segnò per gli etruschi l’inizio della fine. b) Le istituzioni politiche Le città etrusche più importanti erano organizzate come città­stato, vale a dire come entità politiche autonome, al pari delle poleis greche e di Roma. Dodici di esse formavano una federazione i cui scopi erano soprattutto economici e religiosi; politicamente invece la federazione aveva scarsa importanza. In età arcaica le città etrusche erano governate da un re detto “lucumone”, assistito da un consiglio degli anziani. Agli inizi del secolo VI a.C., il re venne sostituito da magistrati eletti annualmente e la monarchia venne sostituita da una repubblica di tipo aristocratico. La penisola italiana era in continuo contatto con le popolazioni orientali, che tra l’altro frequentavano da lungo tempo le sue coste. Per capire la storia di Roma bisogna tener conto non solo delle ricche e composite esperienze delle diverse civiltà regionali, ma anche degli influssi esterni e in particolare orientali che Roma subì sin dalle sue origini. B. Premessa teorica. Cos’è il diritto? 1. Diritto e prediritto Secondo alcuni il diritto è un fenomeno che cambia e che abbia anche una vita prenatale; secondo uno studioso francese, Gernet, nelle comunità la cui organizzazione si basa su una serie di norme che non posseggono ancora i caratteri della giuridicità, la vita dei consociati sarebbe regolata dalle forze del prediritto. Gernet individuò alcuni ambiti nei quali queste forze si manifestavano: • Il primo di questi ambiti era il mondo delle relazioni interfamiliari, regolato dallo scambio dei doni ospitali; nel mondo greco precittadino i rapporti tra stranieri erano regolati dalla legge dell’ospitalità in forza della quale chi accoglieva nel suo gruppo familiare uno straniero gli offriva doni ospitali, e chi li riceveva era obbligato, in futuro, a restituire ospitalità e doni a tutti i membri del gruppo che lo aveva ospitato. • Un altro ambito in cui si manifestavano le forze del prediritto, erano il mondo del pensiero magico­religioso. Secondo Gernet sarebbe possibile stabilire una relazione tra la pratica giuridica e la credenza negli effetti magici di determinate parole, oggetti, comportamenti; i romani credevano nell’efficacia magica delle parole e dei gesti. Di questa credenza rimase traccia, nelle XII Tavole, là dove, ad esempio, queste prevedevano il ricorso a una pratica detta obvagulatio, consistente nel canto di formule magiche dinanzi alla porta del testimone che rifiutava di recarsi in giudizio; vi erano numerosi esempi di queste formule e riti magici nelle XII Tavole oltre all’esempio sopra descritto; a volte invece venivano previste sanzioni per pratiche magiche utilizzate ad esempio per danneggiare le messi del campo del vicino; il rapporto tra le tecniche magiche e le pratiche giuridiche, a volte era quindi di continuità, mentre altre volte era in antitesi, cioè quando la pratica magica veniva criminalizzata. • Un altro campo d’azione privilegiato di passaggio dal prediritto al diritto era rappresentato dai giochi. Gernet ha individuato nella vittoria atletica il fatto che determinava il sorgere di un potere individuale sul premio, che a suo giudizio era assolutamente equivalente al diritto di proprietà, individuando i due elementi che ne determinavano la nascita, ossia, la presa di possesso e la ratifica del gruppo dinanzi al quale la procedura doveva aver luogo così come doveva aver luogo il sorgere di un potere individuale sulla cosa, cioè la spartizione del bottino di guerra. 2. La vendetta privata Nelle società preletterate, vendicare i torti subiti non significava solamente soddisfare un bisogno privato di reagire a un torto, ma un dovere sociale, un atto non solo lodevole ma inevitabile; alla vendetta privata veniva affidata la funzione di mantenere l’assetto sociale. In età omerica il peso sociale di un individuo e di un gruppo erano legati all’onore e chi subiva un torto senza reagire perdeva l’onore; questa era la ragione per cui la vendetta era un dovere. In considerazione del fatto che alla vendetta partecipavano, accanto all’offeso e all’offensore, i rispettivi gruppi familiari, il sistema della vendetta rischiava di portare con sé una lunga catena di guerre; per ovviare a ciò, la società omerica aveva già sviluppato alcune regole fondamentali, considerate tra le prime regole giuridiche greche. Era entrata nell’uso la prassi di offrire all’offeso una compensazione in natura o in denaro detta poiné (derivata nel latino poena e in italiano pena), che, se accettata, veniva solennemente consegnata dall’offensore all’offeso alla presenza del popolo, e che consentiva all’offeso di rinunziare onorevolmente alla vendetta. Si affermò quindi la regola che l’accettazione della poiné fosse alternativa alla vendetta, nel senso che chi aveva accettato una poiné non poteva vendicarsi per lo stesso torto. Se chi aveva pagato una poiné veniva minacciato o inseguito dall’offeso, che pretendeva ancora di vendicarsi, la collettività interveniva attraverso il consiglio degli anziani per accertare i fatti; se la poiné era stata effettivamente pagata, chi rischiava di subire una vendetta illegittima, poteva fare uso della forza fisica per respingere l’ingiusto attacco; se non era stata pagata allora il gruppo dell’offeso poteva portare a compimento la vendetta. Grazie a questa sentenza degli anziani, chi usava la forza non agiva come vendicatore privato, ma come agente socialmente autorizzato. Questo venne traslato anche nel diritto romano, dove nelle XII Tavole esisteva una norma che prevedeva la legge del taglione come risposta a determinati torti. C.Premessa istituzionale. I gruppi sociali precittadini 1. La divisione in classi di età: i riti di passaggio Una serie di indizi consente di cogliere le tracce di una società organizzata sulla base delle divisione della popolazione in classi di età, di una popolazione in cui la popolazione, a seconda che fosse maschile o femminile, apparteneva a diversi gruppi di età e, passava dal gruppo inferiore al gruppo superiore attraverso la celebrazione di solenni riti cittadini, detti riti di passaggio; l’individuo doveva trascorrere un periodo di segregazione in cui apprendeva da una o più persone delle classe superiore le competenze e le virtù necessarie a far parte del nuovo gruppo. In caso di maschio, nel passaggio del’età impubere a quella pubere, il ragazzo doveva apprendere a cacciare e combattere; per la ragazza ad esempio doveva imparare i compiti domestici. A.Il quadro storico 1. Leggenda e realtà sulle origini Roma, come altre città del Lazio, nacque a seguito di una lunga e lenta evoluzione, che trasformò in città un insediamento, presente ai margini della pianura laziale già nell’età del bronzo. Nel secolo X a.C. erano sorte le prime capanne sul Palatino e alla fine del secolo VII a.C. questo primo insediamento si era già trasformato in un borgo di agricoltori e di pastori con i caratteri di una primitiva città. Il luogo dove poi sorse Roma era da tempo il punto d’incontro tra due correnti di traffico, una che si svolgeva tra le regioni a Nord e a Sud del Tevere e un’altra che si svolgeva dalle montagne al mare. Esposti agli attacchi di altre popolazioni, e in particolare degli etruschi, durante i secoli VIII­VII i villaggi di pastori si unirono, a scopi di difesa, in una lega definita settimonzio, in un nuovo spazio urbano delimitato da mura, il cui nome deriva da saepti montes, ossia monti cintati. Il septimontium si diede quindi un capo unico, detto rex. Da questo momento Roma può essere considerata una vera e propria città, alla cui originaria popolazione latina si aggiunsero sin dall’inizio gruppi di popoli diversi, da cui la nota leggenda del ratto delle sabine; per aumentare il numero di cittadini Romolo aprì un asilum dove dare rifugio a tutti i fuoriusciti dalla regione, facendo aumentare il numero delle componenti etniche trasformandola in una città aperta. 2. La crisi della Repubblica: quadro generale Sul finire del II a.C. Roma dominava il Mediterraneo, ma le guerre avevano creato molti squilibri economici, arricchendo alcuni ceti e riducendo alla miseria altri. 3. L’Impero bizantino Costantinopoli, circondata di mura possenti e difesa da un esercito organizzatissimo, rimase per altri mille anni la capitale dell’Impero d’Oriente, detto anche bizantino, e fu sede di una ricca e raffinata civiltà; il commercio era fiorente, l’istruzione era diffusa e la cultura fondeva felicemente elementi della tradizione greca, di quella romana e di quella cristiana. 4. Giustiniano (527­565 d.C.) Giustiniano era nato nel 482 a Tauresio, in Macedonia da una famiglia di umilissime origini. Il suo nome originario era Pietro Sabbazio. Il nome con cui è conosciuto deriva da quello dello zio materno Giustino, che lo aveva adottato. a) La riorganizzazione dello Stato e della giustizia La prima preoccupazione di Giustiniano fu quella di riorganizzare l’amministrazione dello Stato, decidendo di mettere ordine al sistema delle norme giuridiche. Giustiniano selezionò i più esperti giuristi dell’epoca, e li incaricò di raccogliere tutte le regole di diritto in vigore in una compilazione poi chiamata Corpus Iuris Civilis. B.Il quadro sociale e costituzionale Nei primi secoli della sua vita Roma sperimentò due forme costituzionali, la monarchia (753­509 a.C.) e poi la repubblica. 1. L’età regia La prima forma costituzionale assunta da Roma fu quella dello Stato­città governato da un re (rex); lo stato­città era una città libera e autonoma, che si governava da sola, nella quale la sovranità non spettava ad una sola persona, e nella quale non esistevano dei sudditi, ma dei cittadini (cives) che delegavano a dei magistrati l’esercizio del potere sovrano. Nella prima fase il potere era esercitato da un solo magistrato (il rex) e quindi in questa fase Roma era una città­Stato monarchica. 2. La crisi della Repubblica Quando alla metà del III secolo a.C. le istituzioni repubblicane entrarono in crisi, questo portò alla nascita di un nuovo sistema, caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani di un solo personaggio, princeps, a cui si deve il nome del sistema come principato; questo sistema si diffuse rapidamente dandosi l’organizzazione interna sempre più burocratica di un vero e proprio impero. a) Le ragioni economiche e sociali della crisi delle istituzioni Le continue conquiste avevano creato molti squilibri economici, facendo arricchire alcuni ceti di persone e riducendone altre nella miseria più disperata. I motivi più importanti sono: La scomparsa della piccola proprietà e la nascita del latifondo. Non essendo in grado di competere con i prodotti provenienti dai territori conquistati, i piccoli contadini erano andati in rovina, e le loro terre erano state acquistate da coloro che si erano arricchiti durante le guerre, i cavalieri; questo fece nascere il latifondo. L’aumento del numero degli schiavi, il mutamento nel rapporto servo­ padrone e lo sfruttamento della manodopera servile Sempre a causa delle guerre si verificò un radicale mutamento nella condizione servile, che fu causa di problemi e tensioni gravissime. In principio gli schiavi, anche se erano oggetti di diritto (e non soggetti), erano considerati persone di famiglia e trattati con umanità; ma sul finire del II secolo a.C. cambiari i rapporti schiavo/padrone, anche in considerazione dei circa 2 milioni di schiavi portati da Pompeo e utilizzati come strumenti di produzioni e oggetti di sfruttamento disumano. La nascita delle clientele politiche Legata alla guerra vi fu l’inurbamento di enormi masse di contadini ridotti in miseria; questi nelle città riuscivano a sopravvivere solo grazie alla protezione delle grandi famiglie, di cui divenivano clientes; questi ovviamente, alle assemblee votavano secondo i desideri dei loro protettori, facendo, tra l’altro, degenerare la vita politica. La corruzione delle magistrature Altro aspetto delle degenerazione della vita politica è rappresentato dalla corruzione delle magistrature, che non venivano più considerate come un onore, ma fatte per il solo scopo di trarne indebiti profitti economici, immediati o futuri di carriera. b) I problemi istituzionali L’organizzazione dei territori conquistati: le province Dopo l’annessione della Sicilia con la nuova formula giuridica della provincia, anche la Sardegna e la Corsica e un numero sempre maggiore di territori fu annesso con tale formula, il cui sfruttamento contribuì al benessere economico dei romani; lo sfruttamento era legato al loro statuto giuridico; erano infatti governate da un proconsole o propretore che tramite dei privati, i publicani, riscuotevano i tributi per Roma. Le province oltre a fornire tributi, risolsero anche il problema politico rappresentato dalla continua richiesta di terre da parte dei cittadini, assegnandole ai romani. Una nuova figura: il suddito di Roma La nascita delle province portò, come conseguenza, alla nuova figura, il suddito di Roma, il cui rapporto con il più simile alle popolazioni orientali con i loro sovrani; pochi problemi in quanto nel territorio coesistevano repubblicano e ordinamenti di fatto monarchici. nascita di una governatore era questo creò non un ordinamento c) Le fasi della crisi La ricerca di soluzione all’interno delle istituzioni In un primo momento, e in qualche misura i tentativi di risolvere la crisi furono compiuti utilizzando le istituzioni, in modo peraltro assai spregiudicato; basti pensare l’iterazione del tribunato di Caio Gracco, la rielezione per ben sette volte di Mario al consolato, gli imperia proconsularia conferiti per anni e anni a Cesare oppure gli strumenti cui Silla ricorse per attuare le sue riforme istituzionali. Le riforme costituzionali di Silla Caratteristica dell’azione politica di Silla fu il tentativo di collegare gli ordinamenti provinciali con quello cittadino, valorizzando e rafforzando il potere del Senato; egli aveva legalizzato il suo potere facendosi nominare dai comizi dictator legibus scribundis et republicae costituendae. Regolamentò il certus ordo magistratuum, con introduzione del limite minimo di età per ogni carica; diede organizzazione alle province con la lex de provinciis ordinandis e attuò la riforma sillana del processo criminale Il nuovo processo criminale: le quaestiones perpetuae Il processo criminale in uso all’inizio della Repubblica era il processo comiziale, davanti ai comizi centuriati; questi giudicavano solo i colpevoli dei crimini più gravi, e quindi la repressione della maggior parte dei crimini restava sottoposta all’esercizio del potere di polizia magistratuale (coercitio); l’enorme numero di giudici si prestava con grande facilità ad essere manipolato da chi tentava e spesso riusciva a orientare secondo le sue esigenze lo svolgimento del processo. Inoltre l’enormità dei territori, a seguito delle vittorie militari, determinò una crisi di fondo del sistema che non era più in grado di svolgere le sue funzioni. Dopo la fine della seconda guerra punica (201 a.C.), i governatori delle province iniziarono ad approfittare in maniera notevole delle popolazioni locali e queste inviarono dei rappresentanti presso il Senato, incaricati di denunciare i torti subiti e chiedere la nomina di una commissione d’inchiesta (quaestio), per ottenere il denaro sottratto (pecuniarum repetitio). Le quaestiones erano commissioni d’inchiesta nominate extra ordinem, ossia in occasioni specifiche. Nel 149 a.C., però, una lex Calpurnia de pecuniis repetundis, introdusse la prima quaestio perpetua, che sedeva in permanenza e agiva come una vera e propria corte criminale. Silla introdusse man mano poi una serie di commissioni in modo da coprire la maggior parte dei crimini più gravi e organizzò in modo definitivo il sistema penale. I comizi centuriati rimasero, sulla carta, per i crimini con giudicati da quaestio, ma nella pratica la repressione si perpetrò attraverso l’esercizio della coercitio magistratuale, in forma pubblica dinanzi a contiones assembleari. Le quaestiones iniziavano i loro lavori a seguito di un’accusa (quaestio) che poteva essere mossa da qualunque cittadino, composte da 30 o più giudici senatoriali e presieduti da un pretore; ogni quaestio risolveva un solo crimine o un gruppo di crimini, che veniva giudicato in prima e ultima istanza. I giudici accertavano che il crimine fosse di loro competenza e se lo riscontravano applicavano la pena, di solito la aqua et igni interdictio, ossia l’esilio. Le questioni gravissime erano il de repetundis (estorsioni commesse dai governatori delle province), de maiestate (tradimento), de sicariis et veneficiis (venivano puniti e sicari e gli avvelenatori), de falsis (falsificare monete, pesi e documenti), de peculato (appropriazione di denaro pubblico) e de ambitu. Col nuovo sistema, i cittadini da una parte non erano più esposti all’arbitrio dei magistrati, ma dall’altro fu cancellato il diritto di appello e quindi l’eventuale condanna non poteva essere modificata. La concentrazione dei poteri Le regole costituzionali vennero svuotate poco alla volta e si concentrò il potere nelle mani di una sola persona; già evidente con Pompeo, questo fenomeno si manifestò in modo ancor più clamoroso con Cesare, sotto il cui governo, le istituzioni repubblicane esistevano solo formalmente. Cesare nel 63 a.C. era già pontefice massimo, aveva assunto i titoli di imperator e di padre della patria, poi si fece nominare dittatore a vita e si era fatto attribuire l’inviolabilità tribunizia, divenendo come i tribuni, sacrosanctus. Alla sua morte, Augusto si trovò una strada già tracciata verso il potere pressoché assoluto, ma sapendo che i cittadini romani non volevano essere sudditi, lasciò formalmente intatta la costituzione repubblicana, ma accentrò in sé tutti i poteri che questa prevedeva. 3. Il principato di Augusto (PERIODO PRECLASSICO – 367 a.C. / 27 a.C.) Nel 23 Augusto si fece attribuire i poteri dei tribuni della plebe (tribunicia potestas) e quello dei governatori delle province (imperium proconsolare maius et infinitum). La potestà tribunizia gli consentiva di controllare la città, bloccando con un veto le deliberazioni del Senato e le iniziative dei magistrati; il comando proconsolare gli consentiva di controllare le province. Inoltre egli aveva il titolo di princeps senatus (primo tra i senatori), che gli dava il diritto di aprire le sedute, parlando per primo; egli si limitò a concentrare nelle sue mani tutti i poteri consentiti dalla costituzione repubblicana; in considerazione del fatto che fu chiamato Princeps, la forma di governo da lui organizzata viene definita principato. a) La politica interna Grazie alla politica interna di Augusto le condizioni di vita generali migliorarono sensibilmente. L’imponente rete stradale facilitava gli scambi, le rotte marittime erano finalmente sicure, i contadini lavoravano alacremente la terra. b) La riorganizzazione dello Stato e la nascita della burocrazia Augusto si preoccupò di ricostruire e riorganizzare la burocrazia; nominò nuovi organi di governo sottoposti al suo personale controllo, i più importanti tra questi erano i praefecti (prefetti), tra cui vanno segnalati il praefectus urbi, cui veniva affidata la città, e i praefecti praetorio comandanti della guardia del corpo dell’Imperatore. Le province vennero divise in due categorie: province senatorie, governate personalmente da Augusto, e le province imperiali, controllate da Augusto attraverso dei funzionari. I tributi delle province imperiali andava nella cassa personale del principe, il fisco. I funzionari imperiali I vari organi della Repubblica (formalmente ancora esistenti) non potevano che agire secondo le direttive segnate dalla volontà del principe; sempre un maggior numero di funzionari fu previsto, la cui posizione era antitetica a quella della magistratura. I funzionari erano nominati dal principe e restavano in carico il tempo da egli stabilito, ricevevano uno stipendio e agivano per delega del princeps. c) La politica culturale Nella Roma di Augusto si concentrarono i migliori intellettuali e artisti dell’epoca, tra cui vanno ricordati Virgilio, Orazio, Ovidio, Tibullo e Properzio. Sulle diverse opinioni politiche, Augusto si dimostrò abbastanza tollerante, ma non altrettanto lo fece con Ovidio che propose modelli e ideali di vita diversi da quelli esaltati dalla propaganda augustea (moralizzare la vita familiare) e che fu esiliato a Tomi, sul Mar Nero, dove vi morì senza ottenere il perdono. 4. Dal principato all’Impero. Il modello politico augusteo si consolida Augusto aveva creato un modello politico basato essenzialmente sul suo potere personale; dopo la sua morte questo modello divenne stabile e si consolidò e i suoi successori, che si facevano chiamare Cesari, riuscirono nel complesso a gestire una situazione molto difficile, nel conciliare lo stato formalmente di Repubblica con i poteri supremi che di fatto godevano. 1. Equilibri di forze: l’imperatore, il Senato, i pretoriani, le legioni, la plebe Il principale nemico dell’Imperatore fu il Senato, da questi privato dei suoi poteri e del suo prestigio; per governare l’imperatore aveva bisogno della fedeltà assoluta delle sue guardie del corpo (i pretoriani) e delle legioni, ed aveva inoltre il bisogno del sostegno della plebe, ed l’imperatore dava al popolo panem et circenses. 2. Politiche in materia di cittadinanza All’interno dell’Impero vivevano popoli che parlavano lingue diverse, con storie e culture diverse, però Roma era riuscita nell’intento che queste popolazioni si sentissero parte di un mondo comune; una delle mosse politiche fu quella di concedere progressivamente alle popolazioni sottomesse la cittadinanza romana. Questa politica non si affermò senza tensioni e contrasti, ad esempio, quando nel 40 d.C. l’imperatore Claudio propose di dare ad alcuni galli la possibilità di diventare magistrati e senatori in Senato vi fu chi decisamente si oppose, sostenendo che Roma non aveva bisogno degli stranieri al governo. La politica romana era molto lungimirante e le consentiva di contare su un notevole numero di persone che dalla concessione della cittadinanza traevano vantaggi. 3. L’elogio di Roma di un barbaro Nel 143 d.C. il greco Elio Aristide scrive un Elogio di Roma; se si pensa che sono pronunziate da un greco, e che sono rivolte alla potenza che aveva privato la sua terra della libertà, queste parole non possono non colpire profondamente. La politica di concessione della cittadinanza, fu, certamente, una dimostrazione di grande intelligenza politica. 4. La romanizzazione e le sue conseguenze Divenuti cittadini, i provinciali avevano acquistato un notevole peso nel sistema imperiale; all’inizio del secolo II essi ricoprivano più della metà dei posti in Senato. Da una parte questo segnò la fine del predominio di Roma, intesa come città; con il tempo alcuni provinciali divennero addirittura imperatore, come Traiano, Adriano, Filippo l’Arabo. La romanizzazione non avvenne in maniera sempre pacifica, infatti chi non voleva integrarsi veniva sterminato. 5. Vita da sudditi La vita quotidiana dei sudditi imperiali era molto diversa a seconda che appartenessero alla plebe o alla classe dirigente La plebe La plebe affollava le città alla ricerca di qualche lavoro; però non ve n’era in quanto svolto dagli schiavi. La vita della massa del popolo dipendeva dalla liberalità degli imperatori. La plebe nelle città viveva in abitazioni buie e malsane, le insulae, il cui primo piano era abitato dai più ricchi. I servizi igienici esistevano solo al piano nobile. Il massimo divertimento della plebe era assistere ai diversi giochi organizzati dagli Imperatori. La classe dirigente: dall’”ozio” al “negozio” Nei primi due secoli dell’Impero gli appartenenti alla classe dirigente romana divennero funzionari del principe e la loro vita cambiò, in quanto furono costretti ad abbandonare la loro abitudine all’otium, dedicando tempo alla cura di se, ma furono costretti a impegnarsi in diverse attività (la parola “negozio” deriva da nec otium, non ozio), in qualità di funzionari. Cambia la forma politica, cambia la vita, cambia la mentalità La classe dirigente aveva dovuto modificare i rapporti con il suo prossimo. Per secoli il prestigio di questa classe era dipeso dalla capacità dei diversi patres di affermare il proprio potere sugli altri. Ora erano costretti a trattare ogni giorno con altri funzionari, di pari grado se non superiore al loro e questo li obbligò ad adattarsi a forme di autocontrollo e moderazione. 6. Il cristianesimo e i suoi effetti sulla società e sul diritto Lentamente nuove religioni e filosofie si sostituirono a quelle più diffuse tra le classi colte, ossia la filosofia stoica e la religione pagana. Tra le filosofie ebbe grande successo quella neoplatonica, mentre tra le religioni il cristianesimo. La diffusione di questo verbo fu tutt’altro che indolore; all’inizio vi fu diffidenza e sospetto, soprattutto in quanto la Chiesa dava vita ad una comunità separata dentro la comunità imperiale; inoltre i cristiani ritenevano che la loro fosse l’unica e vera religione e di conseguenza non accettavano le altre e, unito al fatto che vivevano in comunità isolate e chiuse, fece credere che fossero ribelli e pericolose; questo fece si che loro fossero additati di essere colpevoli, in caso di ribellioni e malcontenti, e di fungere da capri espiatori. I cristiani, come aveva fatto Cristo, accettavano questo ruolo e di morire tra atroci tormenti. Il cristianesimo inoltre diffondeva valori di uguaglianza; questo migliorò le condizioni di vita dei poveri e degli schiavi, visto che chi era cristiano doveva aiutare il suo prossimo e doveva trattarlo con umanità. Questa fu una vera e propria rivoluzione che col tempo si rifletté anche sulle regole giuridiche. 7. L’amministrazione della giustizia Durante il Principato, pur senza negare agli abitanti delle città italiche i privilegi che derivavano dall’essere cives Romani, il governo delle regioni venne progressivamente separato da quello della città di Roma. Nell’ultimo secolo della Repubblica, nelle colonie e nei municipi i processi privati più importanti spettavano al praetor urbanus e quelli criminali venivano deferiti alle quaestiones perpetuae della capitale. Solo la giurisdizione per i processi minori era rimasta alle magistrature locali dei duoviri o dei quattroviri iure dicundo. Durante il Principato la giurisdizione criminale venne affidata extra ordinem al praefectus urbi entro 100 miglia da Roma e al praefectus praetorio oltre questo limite. Più avanti nel tempo, Adriano istituì 4 consulares incaricati di giudicare extra ordinem le cause civili. 5. La monarchia assoluta (PERIODO CLASSICO 27 a.C. / 284 d.C.) Con il passare dei secoli, l’Imperatore divenne un monarca assoluto; questo ebbe luogo per gradi, a partire dagli Antonini e con maggior frequenza sotto i Severi; l’imperatore veniva sempre più spesso definito dominus, non solo per i provinciali ma anche per gli italici; al Senato venne sottratta la giurisdizione criminale che passo nelle mani dell’Imperatore e dei suoi funzionari. L’imperatore divenne la fonte principale di produzione del diritto. Questo cambiamento si manifestò nella pienezza della sua portata e delle sue conseguenze sotto il governo e con le riforme di Diocleziano; con egli il titolo di dominus, non era solo onorifico ma anche di fatto. a) Organi e funzioni Della vecchia costituzione restavano in vita, tra le magistrature, il consolato, la pretura e l’edilità; il consolato era ricoperto in genere da personaggi di spicco sociale, nominati dall’Imperatore. Gli edili e i pretori (di nomina imperiale) avevano l’unica funzione di organizzare giochi e spettacoli pubblici; i magistrati non avevano alcun potere e lo stesso dicasi del Senato (due, uno a Roma e uno a Costantinopoli) che godeva di prestigio sociale ma sottomesso alla volontà imperiale. La carica senatoriale era diventata ereditaria e il numero era deciso dall’Imperatore; il Senato svolgeva il ruolo di consiglio municipale, come le curiae. Il potere era nelle mani dei funzionari imperiali, a cui spettavano vari titoli; ai più vicini all’imperatore spettava il titolo di comites (compagni). Particolare rilievo era occupato dal quaestor sacri palatii (ministro della giustizia), il magister officiorum (capo delle cancellerie), il comes sacrarum largitionum (ministro delle finanze); molto importanti erano anche gli agentes in rebus (polizia segreta e servizio postale) e il praepositus sacri cubiculi. Altro ruolo importante fu svolto dalle scholae palatinae, che avevano sostituito i pretoriani. b) L’organizzazione territoriale Con Diocleziano cambiò anche l’organizzazione territoriale dell’Impero. Egli infatti istituì le diocesi, circoscrizioni che riunivano più province e che erano a loro volta riunite in quattro prefetture, a capo di ciascuna delle quali stava un praefectus praetorio, alle dipendenze dirette dell’Imperatore. c) Stato e Chiesa La religione cristiana, dopo l’Editto di Costantino (313), divenne rapidamente la religione dell’Impero; il diffondersi della nuova fede ebbe indiscutibilmente effetti benefici su alcune categorie di persone ed ebbe risonanza positiva anche nel campo del diritto privato. Nel 325 Costantino riunì il Concilio di Nicea, e gli imperatori che vennero dopo di lui continuarono (come Costantino) a intervenire nelle questioni che nascevano attorno ai diversi dogmi, facendo pressioni sul clero perché venisse accolta l’una o l’altra soluzione. Gli affari religiosi divennero affari di Stato. Nel 364 furono vietati, da Valentiniano e Valente, i riti pubblici pagani e nel 380, con l’Editto di Teodosio, il semplice fatto di professare una fede diversa da quella cristiana divenne un illecito e comportò limitazioni della capacità giuridica. d) L’unicità dell’Impero Fallito l’esperimento della tetrarchia diocleziana, l’Impero venne nuovamente diviso in due parti (la pars Orientis e la pars Occidentis). Ma questo non comportò la rinuncia all’idea che l’Impero fosse unico; tra i due imperatori sarebbe rivissuto, mutatis mutandis, il vecchio principio della collegialità delle magistrature. Il tardo Impero era quindi un vero e proprio Regno. 3. Il diritto e le sue fonti 1. Significato di ius La parola latina che corrisponde alla nostra parola “diritto” è ius; per capire cosa intendessero i romani per diritto si potrebbe far ricorso alla celebre definizione del diritto contenuta nel primo frammento del Digesto tratto dalle Institutiones di Ulpiano, che scrive: “il diritto è così chiamato da ‘giustizia’; infatti, come dice elegantemente Celso, il diritto è l’ars del buon e del giusto”. Alcuni pensano che per Ulpiano e Celso il termine ars indichi e che anziché diritto definissero la giurisprudenza, indicando come i giurisperiti come coloro che posseggono l’arte di individuare ciò che è bene ed è giusto; altri invece traducono ars con “sistema” e ritengono che il passo definisca il diritto come sistema del bene e del giusto. Non tutto ciò che è buono ed equo è diritto e, non sempre il diritto è buono ed equo. I romani erano perfettamente consapevoli di questo. 2. Diritto in senso soggettivo e diritto in senso oggettivo La parola ius, come insieme delle norme a carattere giuridico che regolano il comportamento dei romani e l’organizzazione della loro città, è intesa in senso oggettivo. Ma essa ha anche un altro significato, un valore soggettivo, quando indica le conseguenze che l’applicazione delle regole del diritto oggettivo ha sui singoli individui, ossia le situazioni giuridiche in cui questi vengono a trovarsi. Nelle XII Tavole si ritrova l’espressione ricorrente di ita ius esto (così sia il diritto). Ad esempio, la regola uti lingua nuncupassit, ita ius esto (come la lingua ha pronunziato, così sia il diritto) significa che chi ha pronunziato determinate parole, o la persona nei cui confronti sono state pronunziate vengono a trovarsi nella situazione indicate dalle parole stesse. B.Fonti di cognizione e fonti di produzione del diritto Per fonte del diritto si allude al fatto o all’atto dal quale deriva la sua esistenza una regola giuridica, quindi si parla di fonte di produzione della regola, mentre l’espressione fonte di cognizione allude a qualunque documento o reperto dal quale siamo informati, direttamente o indirettamente, dell’esistenza di una regola. Le fonti di cognizione Le fonti di cognizione del diritto vengono abitualmente classificate in fonti giuridiche e fonti extragiuridiche. Per fonti giuridiche s’intendono le opere dei giuristi e i documenti che riportano direttamente regole giuridiche o atti relativi all’applicazione di queste; per fonti extragiuridiche s’intendono tutti gli altri documenti o reperti dai quali possiamo indirettamente desumere informazioni di vario genere sul diritto. Le fonti di produzione La straordinaria articolazione ed elasticità delle fonti del diritto romano, fu una della circostanze che consentirono a questo diritto di adattarsi ai profondi mutamenti delle condizioni politiche, sociali ed economiche verificatisi nei lunghi secoli della sua storia. Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. a) La consuetudine La fonte più antica di produzione del diritto furono le usanze che lentamente si affermarono nella pratica dei rapporti interfamiliari, e che con il tempo presero ad essere rispettate con la convinzione della loro obbligatorietà. Queste antiche consuetudini, chiamate dai romani mores maiorum, nascessero da una decisione giudiziale, una sentenza emessa dal rex; queste decisioni venivano considerate dei precedenti che era opportuno seguire e, quindi, una serie di pronunzie costanti dava vita a un principio che la comunità riteneva una norma vincolante. Il ruolo giocato dalla consuetudine rende dunque il sistema romano assai diverso sia dagli altri diritti antichi sia da quelli dell’Europa continentale dopo la Rivoluzione francese. Il peso attribuito alle consuetudini, rende il sistema romano, simile ai sistemi di Common Law. b) Le leges regiae Sotto il nome di leges regiae è giunta una serie di disposizioni attribuite ai diversi re di Roma. Parte della dottrina ha pensato che si trattasse di norme consuetudinarie attribuite dalla tradizione ai re per conferire loro maggior prestigio e autorità. Oggi si ritiene che si trattasse di provvedimenti autoritativi di provenienza regale. E’ stato ritrovato sotto il lapis Niger, nel Comitium, un cippo marmoreo con un’iscrizione databile al primo quarto del secolo VI a.C. dalla quale si leggono alcune parole che minacciano una sanzione a carico di chi avesse violato i luoghi sacri, insomma, segno di una lex regia. La sanzione che nella lingua arcaica dell’iscrizione suona sakros esed, corrisponde alla sanzione che in età successiva verrà espressa con la formula sacer esto (sia sacro); questa sanzione dimostra in modo evidente il carattere sacrale del potere regale e quello religioso delle prime norme giuridiche. Le leges regiae furono le prime norme autoritative della storia romana; anche se vengono indicate come leges, esse non sono tali nel senso tecnico che questo termine assumerà dal momento in cui verrà usato per indicare le deliberazioni dei comizi centuriati. c) L’interpretazione pontificale e l’interpretatio prudentium Nel periodo più antico, quando le regole giuridiche avevano carattere sacro, il compito di custodire e interpretare i mores era affidato ai pontefici, all’interno del cui collegio veniva designato colui al quale era deferito il compito di risolvere i problemi dei privati; i pontefici oltre ad interpretare, creavano il diritto. Essi a volte operavano valutazioni che li spingevano ad adeguare i mores a nuove esigenze; i primi giuristi romani, furono dunque dei sacerdoti, che in un primo momento detenevano il monopolio del sapere giuridico. A partire dall’inizio del secolo V a.C., questo sapere cominciò a diffondersi e a diventare patrimonio di un numero crescente di uomini di cultura laici. d) Le XII Tavole e il ius legitimum vetus La tradizione parla delle XII Tavole come di una lex emanata nel 451­450 a.C. da una magistratura straordinaria, composta in parte da patrizi e in parte da plebei e nominata a seguito di una lotta della plebe per sottrarre agli aristocratici l’esclusività dell’amministrazione della giustizia. Il compito di questi magistrati (10, detti decemviri legibus scribundis) era quello di mettere per iscritto un corpus di leggi che stabilissero criteri di decisione, sottraendo la risoluzione delle controversie al totale arbitrio dei giudici. Le norme raccolte nelle XII Tavole erano le antiche consuetudini che i decemvriri si limitarono a codificare, senza fare molte innovazioni e senza fare molte concessioni ai plebei. Le XII Tavole rappresentano, comunque, una vittoria della plebe, per il semplice fatto di essere state scritte, infatti i magistrati e i pontefici non furono più liberi di individuare e interpretare i mores a loro arbitrio; i giudici erano vincolati all’applicazione di alcuni criteri, che portavano di necessità a una determinata soluzione della controversia. Le XII Tavole erano una fonte anomala di diritto, in quanto, i romani tendevano a non formulare per iscritto regole generali e astratte e prima della compilazione giustinianea, le XII Tavole furono l’unico corpus di leggi che potesse in qualche modo far pensare a un codice moderno; esse costituirono il nucleo centro del ius legitimum. e) La lex (legge comiziale) e il ius legitimum novum La lex era una norma giuridica che esprimeva la volontà popolare; era una deliberazione vincolante, approvata dal popolo, a questo scopo riunito nei comizi centuriati da uno dei magistrati forniti del cosiddetto ius agendi cum popolo (diritto di convocare un’assemblea popolare), i consoli ed i pretori. Il diritto di avanzare proposte di legge (rogationes) spettava esclusivamente ai magistrati, solo dopo essere state approvate dal Senato. Di regola i comizi legiferavano in materia di diritto pubblico, su questioni che riguardavano l’organizzazione e la struttura dello Stato romano. Alcune leges pubblicae regolarono alcuni aspetti del ius civile (ad esempio in caso di successione mortis causa, di matrimonio, di tutela e manomissione degli schiavi). Anche le leges pubblicae furono attratte nella sfera del ius e vennero a formare il cosiddetto ius legitimum novum, in contrapposizione a quello basato sulle XII Tavole, che venne definito ius legitimum vetus. Formazione della legge L’iter legis, ossia il cammino che portava all’approvazione della legge, si iniziava con l’esposizione della proposta al pubblico. Questo atto era detto promulgatio; il periodo che intercorreva tra la promulgatio e la riunione dell’assemblea era detta trinundinum, in quanto era composto da tre periodi di otto giorni ciascuno, detti nundinae. Durante questo periodo il progetto veniva discusso dal magistrato proponente e dal popolo in riunioni informali dette contiones, ma il magistrato non poteva più modificarlo, al limite poteva ritirarlo e sostituirlo con un nuovo progetto, che doveva ripercorrere tutto l’iter legis. Nel giorno fissato per la votazione non era più ammessa alcuna discussione; il magistrato si limitava a interrogare il popolo, che poteva approvare o respingere la proposta. La formula per l’approvazione era uti rogas (come chiedi), mentre quella per respingere era antiqua probo (preferisco le regole antiche). La composizione del corpo elettorale e il sistema di voto La composizione del corpo elettorale romano, a prima vista, era molto democratica; tutti i cittadini avevano diritto di voto, ma il sistema per votare era tale che in realtà il voto di alcuni valeva meno di quello di altri. I comizi centuriati riunivano la popolazione in base alla sua appartenenza a una delle cinque classi di censo, e ciascuna di queste classi era organizzata in centurie; visto che ogni centuria poteva esprimere un solo voto e il numero totale di esse era 193, 98 appartenevano alla prima classe, che sistematicamente aveva la maggioranza. f) I plebiscita Nel 287 a.C. la Lex Hortensia stabilì che i plebisciti universum populum tenerent (vincolassero l’intera popolazione). Prima di questa legge, i plebisciti erano deliberazioni prese dalla plebe riunita in assemblea, che regolavano la condotta dei plebei e dei loro organi. Dopo la lex Hortensia questo cambiò; ai concili tributi partecipavano solamente i plebei e giacché le loro deliberazioni vincolavano tutti, i patrizi si trovarono ad essere vincolati da deliberazioni alle quali non avevano partecipato. Dal secolo III a.C. al secolo III d.C. 1. La giurisprudenza A partire della metà del secolo II a.C. cominciarono ad operare a Roma giuristi significatici come Publio Mucio Scevola. All’età di Augusto nacquero e si svilupparono due grandi scuole di giuristi, detti sabiniani e proculiani (dai rispettivi capi Masurio Sabino e Proculo). I sabiniani (favorevoli alla politica di Augusto) erano i giuristi graditi agli ambienti ufficiali, ma i proculiani (anche se politicamente più conservatori) erano più innovativi dal punto di vista della teoria giuridica. Nella prima metà del secolo II d.C. visse e operò Salvio Giuliano, che ricevette dall’imperatore Adriano l’incarico di codificare l’editto del pretore urbano, fissarlo per iscritto, in modo che così (dal 130 d.C.) nessuno pretore potesse apportarvi modifiche; questo determinò la fine della funzione innovativa del diritto onorario, nato dall’editto del pretore urbano. Tra i più importanti giuristi dell’epoca, che va da Adriano agli Antonini, vanno inoltre ricordati Africano, Pomponio, Marcello e Scevola; all’epoca dei Severi vissero Papiniano, Paolo e Ulpiano, ed infine Marciano e Modestino. Il valore dei responsa prudentium I pareri che i giuristi fornivano nell’esercizio della loro funzione di interpreti del diritto venivano detti responsa prudentium; dalle Istituzioni di Gaio sappiamo che quando erano concordi questi pareri avevano valore di legge; in realtà i pareri dei giuristi si limitavano ad individuare una norma già esistente, chiarendo che nella specie era quella la norma da applicare. Solo in età postclassica i pareri divennero vincolanti e questo accadde perché alcuni imperatori davano ad alcuni giuristi uno speciale diritto di dare pareri ex auctoritate principis, ossia per conto e in nome del principe e poiché la sua volontà aveva valore di legge, ne consegue che tale valore fosse riconosciuto anche ai responsa prudentium; i giuristi forniti di questo diritto furono, tra i vari, Modestino, Paolo, Ulpiano e Papiniano. 2. Gli editti dei magistrati Nel 367 a.C. le leges Liciniae Sextiae avevano attribuito al praetor la giurisdizione civile; a partire dal 242 a.C. venne istituito il praetor peregrinus, incaricato della giurisdizione civile, in caso di controversie tra stranieri o tra romani e stranieri e grazie a ciò cominciarono a venir tutelate situazioni soggettive che sino a quel momento non godevano di tutela. Questo avvenne grazie a degli interventi del pretore urbano, detti interdicta (interdetti), che tutelavano interessi relativi al godimento della terra o altri beni di proprietà del popolo romano; gli interventi più significativi dei magistrati furono legati all’introduzione di un nuovo di tipo di processo, fondato sul loro imperium (comando), che finì per sostituire il vecchio processo per legis actiones. Questo processo venne detto per formulas (formulare), perché basato su un documento scritto, detto appunto formula. Grazie al nuovo processo, i magistrati giusdiscenti superarono la rigidità del diritto più antico, tutelando nuove situazioni, spesso ma non necessariamente nate nella pratica degli affari tra romani e stranieri, creando nuove regole giuridiche. Il complesso delle regole di introduzione magistratuale viene chiamato ius honorarium o limitatamente a quello nato nel tribunale del pretore, ius praetorium; come scrive il giurista Paolo, il ius honorarium, fu introdotto per aiutare, per integrare o per correggere il diritto civile. Le regole del ius civile non vennero modificate dal ius honorarium, ma quest’ultimo affiancò il primo, che rimase sempre formalmente in vigore, anche quando il diritto applicato era ormai regolarmente quello di creazione pretoria. Ben presto i pretori, avvalendosi del ius edicendi (potere di fare comunicazioni ai cittadini) compreso nel loro imperium, all’inizio dell’anno di carica rendevano pubblico una specie di programma, contenente le linee della politica giurisdizionale alla quale si sarebbe attenuto. Questo programma veniva detto edictum perpetuum (editto perpetuo) in quanto vincolava il magistrato per l’intero anno di carica. Questo programma veniva esposto nel Foro su delle tavole dette tabulae dealbatae. 3. I senatusconsulta Il Senato, nonostante la sua importantissima funzione politica, non aveva, formalmente, né il potere di emanare norme generali vincolanti per la collettività, né quello di esprimere pareri che potessero vincolare gli organi costituzionali ai quali venivano dati pareri che quest’organo dava ai magistrati (da cui il termine senatus consulta, pareri del Senato). I comizi popolari scomparvero, come organo legislativo, alla fine del I secolo d.C., mentre il Senato acquistò potere tale da far pensare a volte ad una diarchia, in cui il comando spettava a due organi, il principe e il senato. Quest’ultimo cominciò ad intervenire dando pareri non solo in materia di diritto pubblico, ma anche in quello privato, dando dapprima pareri ai magistrati giusdicenti e, a partire dal I secolo d.C., introducendo nuove regole. I senatoconsulti divennero una fonte di produzione del diritto e col tempo la più importante fonte autoritativa. A partire dal secolo II d.C. le proposte di senatoconsulti vennero fatte sempre più spesso (prima erano i consoli) dal princeps, che pronunziava in Senato una oratio, la cui approvazione era divenuta pura e semplice formalità. 4. Le costituzioni imperiali Una volta conquistato il potere Augusto iniziò a pronunziare sentenze che come è evidente avevano un valore del tutto particolare come precedenti, ed iniziò anche a prendere provvedimenti ed emanare atti di contenuto normativo. Ulpiano scrive: “quel che il principe ha deciso, ha valore di legge”. Quanto al fondamento giuridico del potere normativo imperiale, essa va individuato nella lex de imperio, con cui il popolo avrebbe attribuito al principe il suo imperium e la sua potestas. I provvedimenti imperiali, definiti constitutiones (costituzioni) si dividevano in edicta (atti normativi a carattere generale e astratto), mandata (ordini e direttive di carattere generale indirizzati ai governatori delle province), rescripta (pareri vincolanti del principe su questioni giuridiche sottoposte al suo giudizio) e decreta (sentenze emesse dal principe sia in materia di diritto privato che di diritto penale). 5. La consuetudine Anche senza avere l’importanza assunta nell’età arcaica, i mores continuarono a contribuire alla formazione del diritto anche dopo la pubblicazione delle XII Tavole. La consuetudine contribuì sensibilmente anche alla creazione del ius gentium. A partire dalla metà del secolo II, i giuristi e gli imperatori riconobbero più volte il suo valore. Salvo Giuliano scrisse che in mancanza di leggi scritte si doveva tener conto di ciò che era stato introdotto morbus ed consuetudine; l’imperatore Settimio Severo stabilì che qualora vi fossero dubbi sul significato di una legge si dovesse attribuire questo valore alla consuetudine. Dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano 1. Gli iura Il periodo della grande giurisprudenza era finito; in questa situazione non erano le singole opere a essere fonte del diritto, ma la communis opinio, vale a dire l’opinione prevalente e generalmente condivisa. Ma anche quando questa communis opinio si era formata, non era facile determinare quale essa fosse. Gli imperatori per mettere ordine in questo delicato settore della vita del diritto intervennero con una serie di provvedimenti. Il più importante fu la costituzione emanata nel 426 d.C. da Valentiniano III (legge delle citazioni); essa attribuiva alle opere di Gaio lo stesso valore di fonte del diritto che già avevano le opere di Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino. Questa costituzione stabiliva inoltre che il giudice fosse tenuto ad attenersi al parere dei giuristi solo se sulla questione a lui sottoposta vi fosse communis opinio; quando vi era un numero pari di sostenitori di teorie opposte, era considerata communis opinio l’opinione a favore della quale si era espresso Papiniano. 2. Le leges In quest’epoca ebbero enorme importanza le diverse costituzioni imperiali (edicta, mandata, rescripta e decreta), e in particolare, le c.d. leges generales. Anche quando l’Impero venne diviso in due parti, la concezione unitaria del potere imperiale non venne meno. In un primo momento, le costituzioni emanate da un imperatore, vincolavano automaticamente anche i sudditi dell’altra parte dell’Impero. Successivamente queste dovevano essere trasmesse all’altro imperatore attraverso una costituzione detta pragmatica sanctio, e in una terza fase si ritenne necessario che fossero promulgate dall’imperatore che le aveva ricevute. La pragmatica sanctio era considerata una forma intermedia tra una legge generale e un rescritto. 3. Le collezioni ufficiali come fonte di produzione del diritto Con il passare del tempo nel mondo romano vennero approntati dei “Codici” aventi valore di legge, e furono: a. In età pregiustinianea, il Codex Theodosianus (438). Teodosio II nel 429 progettò di procedere ad una raccolta di leges che comprendesse non solo le costituzioni imperiali, ma anche i pareri dei giuristi aventi valore di legge, ma stante la vastità delle opere, dovette ripiegare su un progetto minore di raccolta di sole leges, che venne pubblicata nel 438 con il nome di Codex Theodosianus; rimase in vigore fino a quando non fu sostituito dal Codice di Giustiniano; b. La compilazione giustinianea (Corpus Iuris Civilis). E’ una raccolta di leges e iura, definita compilazione di Giustiniano, considerata come l’opera giuridica più importante che sia mai stata scritta, e alla quale lavorarono i migliori giuristi dell’epoca sotto la direzione di Triboniano. La ragione che indusse Giustiniano a procedere a quest’opera fu la necessità sempre più forte di mettere ordine nel sistema delle norme giuridiche; accanto alle decisioni imperiali (leges) bisognava tener conto del parere dei giuristi, e anche all’interno di questi era sempre più difficile capire quali tra i diversi principi formulati fossero validi e quali fossero ormai superati. Giustiniano decise di procedere ad una raccolta di tutte le costituzioni imperiali e di tutti i pareri dei giuristi che dovevano essere considerati vincolanti, togliendo valore a tutte le costituzioni e le opere della giurisprudenza che non erano state ricomprese nella nuova opera. Da questo punto di vista, l’intero Corpus Iuris civilis era un codice nel senso moderno del termine. Si compone di quattro parti, ciascuna con un diverso carattere e funzione e sono il Codice (Codex), il Digesto (Digesta seu Pandectae), le Istituzioni (Institutiones) e le Novelle (Novellae). Il Codex è la raccolta delle costituzioni imperiali, che venne pubblicata nel 534; la più antica era di Adriano e la più recente era stata emanata dallo stesso Giustiniano, il 4 novembre 534, ed il Codex entrò in vigore il 29 novembre dello stesso anno. I Digesta sono l’opera nella quale vennero riuniti i frammenti delle opere dei giuristi che esprimevano regole e principi giuridici considerati tuttora attuali; fu pubblicata nel 533; la commissione incaricata di preparare quest’opera doveva estrarre dalle diverse opere della giurisprudenza le parti ancora utilizzabili; questi frammenti furono raccolti per materia e ciascuno di essi venne riportato con un’annotazione (inscriptio) che segnalava il nome dell’autore e dell’opera da cui era stata estratto; il testo svolgeva un discorso organico e coerente e aveva il valore di una legge emanata dall’imperatore. Le Institutiones furono pubblicate nel 533, libro destinato agli studenti di giurisprudenza contenente le nozioni fondamentali del diritto privato. Le Novellae (Novellae Constitutiones, nuove costituzioni) sono la raccolta delle costituzioni emanate da Giustiniano dopo il 534. 4. Le leggi romano­barbariche Nel corso del V e del VI secolo d.C. alcune popolazioni barbariche stanziate sul territorio occidentale dell’Impero costituirono dei veri e propri Stati, come il regno dei visigoti, dei burgundi, dei vandali, dei suebi, degli ostrogoti. I rapporti di queste popolazioni con l’Impero furono diversi; in alcuni casi, i vandali, gli stati barbarici nacquero a seguito di una vera e propria occupazione bellica. In altri casi, come i visigoti e burgundi, essi stabilirono originariamente un rapporto federativo con Roma; in altri casi infine, gli ostrogoti, si stabilì un rapporto di dipendenza dall’Impero. In tutti questi Stati vivevano romani e barbari, e di regola si era venuto a creare un doppio sistema di diritto. I romani continuavano ad applicare il loro diritto e i barbari le regole del loro diritto nazionale, per lo più basate sulle loro antiche consuetudini. Anche presso queste popolazioni si venne affermando il principio che l’unica fonte del diritto era lo Stato e di conseguenza si procedette a delle compilazioni di regole giuridiche (c.d. leggi barbariche); si sentì il bisogno di raccogliere le norme che dovevano regolare la vita dei romani che vivevano in territorio barbarico e in alcune situazioni ci si pose anche il problema di regolare i rapporti tra romani e barbari. Tra le diverse compilazioni vanno ricordate: a. la Lex Romana Wisigothorum (o Breviarum Alaricianum); è una raccolta di regole del diritto romano, ordinata nel 506 dal re visigoto Alarico II a uso dei suoi sudditi romani. Questa raccolta toglieva vigore a tutte le regole che non vi erano state inserite; b. la Lex Romana Burgundionum, raccolta di leggi romane ordinata da re dei burgundi, Gundobado, per uso dei romani che vivevano nel suo territorio; c. l’Edictum Theodorici, compilazione emanata nei primi anni del secolo V da Teodorico, re degli ostrogoti in Italia; Teodorico non procedette a quest’opera come sovrano, ma come titolare di un potere conferitogli dall’Imperatore d’Oriente; egli agì come funzionario, ed emanò un editto anziché una legge e si applicava a tutti i suoi sudditi, ostrogoti e romani. Le leggi barbariche I capi dei regni barbarici emanarono anche leggi dirette a regolare esclusivamente la vita dei loro sudditi. La prima codificazione di un diritto nazionale barbarico fu la lex Visigothorum; il nucleo originario di questa legge venne redatto verso la metà del secolo V per volontà del re Teodorico, aggiornato poi verso la fine del secolo dal re Eurico ed infine dal re Leovigildo verso la seconda metà del secolo VI. Verso la seconda metà del secolo VII, re Recesvindo, stabilì che esso avesse efficacia territoriale, applicabile quindi a tutti coloro che abitavano il territorio visigoto, senza distinzioni. La lex Visigothorum divenne la base del diritto nazionale spagnolo, e rappresenta il modello più progredito e sistematico, e deve la sua raffinatezza alle molte influenze del diritto romano. La lex Gundebada regolava la vita e i rapporti dei burgundi e raccoglieva le regole del diritto nazionale burgundo. 5. La consuetudine Le fonti postclassiche e giustinianee dedicano molta attenzione alla consuetudine; fino al 212 d.C. il diritto romano si applicava in misura limitata nei territori conquistati. I rapporti tra gli abitanti di questi territori, infatti, continuavano ad essere regolati dai diritti nazionali. Quando con il 212 la cittadinanza romana venne concessa a tutti i sudditi dell’Impero, i vari diritti nazionali cessarono di avere vigore, quantomeno in linea di principio, mentre nella pratica continuarono ad essere applicati. Il sistema per conciliare le due esigenze venne trovato nella concezione secondo la quale le regole localmente applicate erano semplicemente comportamenti concreti, che con il loro consolidarsi nella prassi e grazie al consenso di chi le applicava creava diritto consuetudinario. Costantino emanò una costituzione secondo la quale la consuetudine non poteva superare la legge o la ratio; non poteva valere contra legem, e tantomeno abrogare una regola giuridica. Un’altra costituzione inserita nel Codice giustinianeo però, equiparando la consuetudine alle leggi, ammise anche la consuetudine contra legem e il principio venne confermato nelle Istituzioni di Giustiniano, là dove si definisce la consuetudine “costumi costanti, consolidati dal consenso dei consociati”, e si dichiara questi costumi, legem imitantur (imitano la legge). Anche se ogni consuetudine aveva valore in una determinata zona, infatti, il principio che i costumi dei consociati avessero valore di fonte del diritto era un principio valido in tutto l’Impero. 4. Le persone Definizione di vita e sua rilevanza giuridica nel mondo romano Il presupposto di ogni discorso sulla capacità degli esseri umani era nel mondo romano la loro esistenza in vita. Nel sistema romano la nascita induce effetti nel mondo del diritto (in età augustea, ad esempio, la nascita era importante in quanto le donne che partorivano un certo numero di figli erano esonerate dalla tutela). Secondo le fonti del periodo classico, era il momento in cui il feto si staccava completamente dal seno materno (partus editus); in età augustea, i proculiani richiedevano che il nuovo nato avesse emesso un vagito, mentre i sabiniani, la cui tesi prevalse, ritenevano che qualunque segno di vita fosse sufficiente. Per i romani non era da considerare nato il monstrum vel prodigium, ossia il neonato così mostruosamente deforme da essere più simile ad un animale che a un essere umano. Secondo una legge attribuita a Romolo, il padre che abbandonava il figlio mostruoso non incorreva nelle pene previste per l’abbandono dei neonati; l’importante era che cinque vicini accertassero la mostruosità. In alcuni, invece, anche il nascituro veniva preso in considerazione, quando ad esempio chi nasceva da iustae nuptiae che seguiva la condizione del padre al momento del concepimento; oppure in caso di divorzio quando il marito temeva che la moglie incinta abortisse, ed in questo caso poteva chiedere che venisse nominato un curator ventris, persona incaricata ad impedire che la donna privasse l’ex marito della prole. A. Percezione romana del problema della capacità giuridica e sue soluzioni 1. La capacità giuridica Con riferimento alla capacità giuridica, l’individuazione delle persone alle quali era consentito essere punto di imputazione di situazioni giuridiche soggettive era un problema di grande rilevanza, anche perché, al pari delle altre popolazioni antiche, i romani non riconoscevano la capacità giuridica in base al semplice fatto della nascita. a) Le divisiones personarum Quella che oggi chiamiamo capacità giuridica, nel mondo romano spettava solo ad una minoranza di persone; dalle fonti del diritto si ritrovano le divisiones personarum, cioè una serie di classificazioni delle personae in diverse categorie, dall’appartenenza alle quali i romani facevano discendere il riconoscimento della capacità. Liberi e schiavi La prima fondamentale classificazione degli essere umani è quella che divide i liberi dagli schiavi (servi); le persone libere si distinguevano in ingenui (nati liberi) e liberti (liberati dalla schiavitù). Romani e peregrini (stranieri) Questa distinzione riguardava solo le persone libere, distinte a seconda che avessero la cittadinanza romana oppure no; lo status di cittadino romano era condicio sine qua non per l’esercizio dei diritti politici e per il godimento di una serie di privilegi. Tra gli stranieri, i latini godevano di una posizione particolarmente privilegiata. Sui iuris e alieni iuris Coloro che avevano la cittadinanza romana si dividevano a loro volta in sui iuris (di diritto proprio) e alieni iuris (di diritto altrui). Sui iuris erano coloro che non avevano ascendenti maschi superstiti, o che erano stati emancipati. Alieni iuris coloro che avevano un ascendente maschio in vita o che non erano stati emancipati. A seconda del loro rapporto con il paterfamilias, si distinguevano in persone in potestate, in manu, in mancipio. Le persone che non rientravano nelle tre precedenti categorie potevano essere in tutela o in curatione ovvero potevano non essere sottoposte ad alcuno di questi poteri. La posizione dell’individuo veniva indicato dai romani con il termine status; lo status di un persona aveva rilevanza agli effetti del riconoscimento di capacità. La piena capacità giuridica di diritto privato, era riconosciuta solo a chi avesse lo status di persona libera, civis romanus e sui iuris. La capacità di diritto pubblico era legata allo status di cittadino e non di paterfamilias o filiusfamilias. b) Capacità di diritto privato e capacità di diritto pubblico La civitas nel momento in cui nacque, ai fini della gestione della res publica, stabilì dei rapporti con tutti gli individui che componevano le diverse familiae, che erano indipendenti dal fatto che questi fossero sui iuris o alieni iuris; quel che interessava la civitas era il sesso delle persone, la loro età, la loro appartenenza all’una o all’altra classe sociale; erano queste le caratteristiche in base alle quali la civitas stabiliva chi poteva partecipare alle assemblee e chi non poteva farlo, chi aveva il diritto di partecipare ad alcune di esse e chi ad altre, e così via dicendo. Chi non aveva i requisiti per partecipare alla vita pubblica, cioè le donne, gli impuberi e gli schiavi, veniva preso in considerazione come eventuale oggetto di punizioni, qualora si rendesse colpevole di quei comportamenti che agli inizi della storia di Roma erano considerati lesivi della collettività, e cioè la perduellio (alto tradimento) e il parricidio (uccisione di un paterfamilias). Quindi un filiusfamilias poteva diventare console, con il prestigio e potere che ne derivava, ma come filius non aveva un suo patrimonio. 2. La capacità di agire La capacità di agire era riconosciuta a chi fosse considerato capace di intendere e di volere. Vi erano quindi persone che avevano la capacità giuridica ma non quella di agire (gli impuberi sui iuris o i pazzi), mentre vi erano persone che non avevano la capacità giuridica ma avevano quella di agire (ad esempio gli schiavi puberi e sani di mente). Le persone incapaci o limitatamente capaci erano gli impuberi, le donne (tutta la vita), i furiosi (pazzi) e a partire dalle XII Tavole anche i prodighi. Queste persone, non potendo amministrare autonomamente i loro beni erano sottoposti ad un tutore, nei casi di impuberi e di donne, ed ad un curatore, per quanto attiene ai furiosi e ai prodighi. Ovviamente il problema della tutela si poneva solo nel caso di sui iuris, in quanto gli alieni iuris non avevano patrimonio da amministrare. a) La tutela La tutela romana era un istituto potestativo, e non protettivo come oggi. Qualora una persona ritenuta incapace di agire diventasse sui iuris, si suoi familiari si preoccupavano di controllare questa persona per salvaguardare le loro aspettative ereditarie. La trasformazione della tutela in istituto protettivo avvenne con la lex Atilia (forse nel 210 a.C.) che stabilì che il pretore dovesse nominare un tutore a chi non lo avesse; il tutor Atilianus, pur essendo titolare di un potere (potestas o vis), esercitava anche un munus, una funzione che era suo dovere svolgere nell’interesse del pupillo. Gli incapaci non potevano compiere atti di rilevanza giuridica e perché avessero effetto, essi dovevano essere rappresentati o assistiti dal tutore. La tutela sugli impuberi Erano considerate impuberi le persone che non avevano raggiunto la maturità sessuale, che nel periodo arcaico veniva accertata con una inspectio corporis. La tutela sugli impuberi, i pupilli, viene definita come un potere attribuito dal ius civile su una persona di stato libero che a causa dell’età non è in grado di difendere i suoi interessi. Il tutore, era l’adgnatus proximus, vale a dire il parente più stretto in linea maschile; se il pupillo era un liberto, la tutela spettava al suo patrono, mentre se il pupillo era stato emancipato la tutela spettava al parens manumissor; in mancanza di adgnati la tutela spettava ai gentiles. In età antica e preclassica il tutore testamentario poteva rinunciare alla tutela con una abdicatio; il tutore legittimo poteva trasferire il suo potere ad altra persona, chiamata tutor cessicius. Il tutore aveva poteri patrimoniali e poteri di tipo personale, relativi all’educazione del pupillo; dopo il periodo delle XII Tavole, i poteri patrimoniali erano diversi a seconda che il pupillo fosse ancora infans (infante, incapace di parlare) o che avesse raggiunto quel minimo di maturità che gli permetteva di esprimersi. Nel caso di infans, il tutore aveva la totale gestio (gestione) del patrimonio pupillare, mentre nel caso di infans maior (quando il pupillo avesse qualche capacità di ragionare), gli atti compiuti dal pupillo non erano inesistenti, ma imperfetti e necessitavano la ratifica da parte del tutore, compiendo la auctoritatis interpositio. Senza l’intervento del tutore, gli atti compiuti da un infans o un infans maior erano considerati nulli. La tutela sulle donne Alcuni ritengono che originariamente le donne non fossero considerate capaci di avere un patrimonio; di conseguenza il patrimonio ereditato sarebbe stato considerato di proprietà del loro tutore che avrebbe in origine provveduto personalmente alla gestio dei beni, sotto il vincolo di farlo nell’interesse della donna. All’età delle XII Tavole, le donne erano già ammesse alla successione ereditaria, succedendo come heredes suae in qualità di figlie, nipoti in linea maschile (se il padre era premorto) e di mogli in manu, come loco filiae (in condizione di figlia) presso il marito o il paterfamilias di questi. Come adgnatae le donne ereditavano in qualità di sorelle e di nipoti ex fratre, se il padre era premorto; infine come gentiles partecipavano alla successione insieme ai gentiles maschi. Comunque le donne non avevano la capacità di agire e potevano amministrare il loro patrimonio solo con l’assistenza del tutore; solo le vergini Vestali erano esonerate dalla tutela. Tipi di tutela sulle donne e modifiche dell’istituto Le XII Tavole prevedevano due tipi di tutela sulle donne, la tutela legitima (o adgnatitia) spettante per legge ai parenti più stretti in linea maschile, e la tutela testamentaria stabilita per testamento dell’avente potestà sulla donna. La nomina spetta al parente più stretto in linea maschile (adgnatus proximus), e in mancanza di adgnati ai gentiles. Gradualmente il potere dei tutori si attenuò e alle donne si affiancavano tutori di loro gradimento; questo fenomeno è legato anche al fatto che i poteri paterni, col tempo, subirono progressive limitazioni e fu questa la circostanza che a un certo punto della loro storia, rese difficile ai romani continuare a sostenere che le donne erano incapaci. Le Vestali Le sacerdotesse di Vesta servivano la dea per un periodo che in principio era di 5 anni, ma che in epoca storica durava 30 anni; il Pontefice Massimo acquisiva sulle Vestali un potere simile a quello del paterfamilias, che lo perdeva nel momento in cui queste venivano consacrate alla dea. Se la Vestale veniva meno al voto trentennale di castità, il pontifex poteva metterla a morte. Le Vestali godevano di grande prestigio e privilegi, tra i quali, importante, era quello dell’esonero della tutela, grazie al quale erano capaci di fare testamento senza bisogno di un’autorizzazione maschile. Responsabilità del tutore Il tutore che profittava della sua posizione era colpevole di violazione della fides, sanzionato dalle XII Tavole, che prevedevano di agire in giudizio contro il tutore legittimo e di farlo condannare al doppio del denaro sottratto o illecitamente acquistato. b) La cura Erano sottoposti a cura i pazzi (furiosi) e i prodighi. I furiosi Erano considerati furiosi i pazzi che davano evidenti e clamorosi segni di follia. Costoro erano sottoposti al potere dell’adgnatus proximus o, in mancanza di adgnati, dei gentiles. Il curatore si chiamava curator legitimus. Il furiosus era considerato totalmente incapace non solo di compiere atti leciti giuridici, ma anche di compiere atti illeciti e quindi i primi erano nulli, mentre per i secondi non veniva imputato. Il curator aveva la gestio del suo patrimonio, ma non poteva compiere emancipazione, testamento, manomissione o atti di liberalità, ma poteva alienare i beni del furiosus. I prodighi Erano considerati prodighi coloro che dilapidavano il patrimonio familiare con il loro comportamento inconsulto; le XII Tavole prevedevano che essi potevano essere interdetti, e l’interdizione veniva pronunciata dal magistrato (dal 367 a.C. il praetor urbanus) il quale per evitare di mandare i fogli in povertà toglieva il potere al prodigo di disporre dei suoi beni; il prodigo era sottoposto alla cura dell’adgnatus proximus, e in mancanza di adgnati, dei gentiles. B.Le divisioni delle persone 1. Liberi e schiavi a) La schiavitù La schiavitù nel mondo antico era considerata un’istituzione naturale; il fatto che gli essere umani non fossero tutti uguali, che non tutti godessero degli stessi diritti e che alcuni di essi potessero essere sfruttati da altri era cosa normalmente ammessa. b) L’uguaglianza degli antichi e dei moderni La moderna concezione dell’uguaglianza è espressa dall’articolo 3 della nostra Costituzione, là dove afferma che tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di razza, di sesso o di religione. Nel mondo antico un simile principio non esisteva; in quel mondo non ci poteva essere uguaglianza tra diversi, gli uguali erano uguali fra loro all’interno della cerchia ristretta di persone alla quale appartenevano e con i cui esponenti condividevano caratteristiche comuni. Tutti quelli che per una ragione o per l’altra erano diversi dagli uguali venivano da questi trattati diversamente. C.Schiavitù, cittadinanza, capacità Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. 1. La schiavitù e le sue fonti a) Le cause della schiavitù Le prime cause di schiavitù furono la prigionia di guerra e la nascita da madre schiava, oltre ad altre. La prigionia di guerra (captivitas) La causa originaria della schiavitù è stata, probabilmente, la prigionia di guerra; nel Digesto, si parla dei servi che venivano così chiamati perché coloro che in guerra li avevano fatti prigionieri, anziché ucciderli, li vendevano ac per hoc servare (così salvandoli). Considerare propri schiavi i prigionieri di guerra era un principio fondamentale del mondo antico; a Roma l’applicazione di questo principio ebbe conseguenze rilevanti, in quanto l’aumento delle conquiste fece aumentare il numero degli schiavi. Quando un romano cadeva prigioniero dei nemici, i romani ritenevano che la sua posizione fosse transitoria e se egli fosse riuscito a rientrare in patria avrebbe riacquisito tutti i suoi poteri; l’istituto che lo garantiva era il postliminium. La nascita da madre schiava I nati fuori dal matrimonio seguivano lo status della madre al momento della nascita e poiché con la schiava non era possibile contrarre matrimonio, ne risultava che i nati da schiava erano schiavi. La deditio Era la consegna ad uno Stato straniero di un individuo che aveva violato le regole internazionali tra Roma e quello Stato; la deditio ricadeva nell’ipotesi di captivitas. La vendita trans Tiberim Nelle XII Tavole era prevista per una serie di persona la vendita trans Tiberim, al di là del Tevere, in territorio etrusco ove diventavano schiavi e questo valeva per il debitore insolvente, chi si era sottratto al servizio militare (infrequens), il disertore (fugitivus o disertor), colui che si era sottratto al censimento (incensus). La addictio del fur nocturnus al derubato Secondo le XII Tavole il fur manifestus veniva addictus al derubato, a lui assegnato in condizione di schiavitù; secondo alcuni invece il fur manifestus veniva venduto trans Tiberim in quanto la sua addictio al derubato avrebbe comportato la sua schiavitù in patria, cosa contraria ai principi romani. La vendita del filius da parte del paterfamilias Il filiusfamilias venduto dal pater o consegnato ad altro paterfamilias ai danni del quale il filius aveva commesso un illecito, si definiva in mancipio; la condizione in cui veniva a trovarsi il filius in mancipio era quella di una schiavo, infatti alla morte del pater cui era stato venduto egli non acquistava la libertà, ma passava sotto il potere di un nuovo pater, proprio come gli schiavi. Quando si ammise che potesse essere liberato dal compratore, l’atto con cui veniva liberato era la manumissio, lo stesso che dava la libertà agli schiavi. b) Condizione degli schiavi e rilevanza sociale ed economica della schiavitù nel periodo arcaico Nel primo periodo della storia di Roma il numero degli schiavi era limitato e il loro lavoro non aveva grande incidenza sull’economia; a Roma in quel periodo erano i paterfamilias con i loro figli a coltivare i piccoli appezzamenti di terra; anche se assai meno pesante di quella dei secoli successivi, la condizione servile era comunque iniqua; gli schiavi potevano essere venduti, puniti, messi a morte dal loro dominus. A questi poteri erano sottoposti anche i membri liberi della familia; l’unica differenza tra la sottoposizione del filius alla patria potestas, della moglie e delle mogli dei figli alla manus e quella degli schiavi, con la dominica potestas, era che per i primi due soggetti era transitoria, mentre per gli schiavi era perenne e alla morte del dominus, diventavano proprietà di uno degli eredi, in quanto parte del patrimonio. Gli atti compiuti dallo schiavo producevano effetti giuridici a seconda del tipo; se comportavano l’acquisto di un diritto, questo veniva acquisito automaticamente dal dominus, mentre se comportava l’assunzione di un obbligo, il dominus non ne rispondeva. I suoi atti producevano effetti anche dal punto di vista penale, infatti se egli commetteva un delitto, la vittima poteva agire giudizialmente contro il dominus; questi poteva liberarsi di ogni responsabilità compiendo la noxae deditio (dazione a nossa), ossia consegnando lo schiavo alla famiglia dell’offeso. Se invece lo schiavo commetteva un crimine la cui pena non era pecuniaria, allora poteva regolarmente essere processato e condannato, ma le pene erano diverse dalle stesse a cui erano assoggettati gli uomini liberi. c) Modi di liberazione dalla schiavitù La schiavitù era una condizione perenne, che poteva cessare solo per un atto di volontà del padrone, detto manomissione (manumissio); vi era tre tipi di manumissio esistenti sin da un’epoca molto antica, ed erano la manumissio testamento, la manumissio vindicta e la manumissio censu. La manumissio testamento Consisteva in una dichiarazione di ultima volontà del dominus, che nel regolare la sorte del suo patrimonio per il momento successivo alla sua morte donava solennemente la libertà allo schiavo. La manumissio vindicta Era un’applicazione del processo di libertà e si svolgeva dinanzi al magistrato; essa prevedeva un accordo tra il dominus dello schiavo e una persona di fiducia, detta adsertor libertatis, che compiva la vindicatio in libertatem, vale a dire dichiarava dinanzi al magistrato che lo schiavo era di condizione libera, toccandolo con una bacchetta (vindicta); il padrone dello schiavo a questo punto taceva o si ritraeva (anziché effettuare una controvindicatio); il magistrato ratificava la vindicatio compiuta dall’adsertor con una addictio, dichiarando lo schiavo libero; questa era un delle applicazioni della in iure cessio. La manumissio censu Consisteva nella richiesta, fatta dal padrone dello schiavo al censore, di iscrivere lo schiavo nelle liste del censo, ma questa manomissione poteva avvenire solo ogni 5 anni. d) Libertà e cittadinanza In origine, manomettere uno schiavo significava dargli oltre alla libertà, anche la cittadinanza romana, in quanto questi due istituti erano legati tra di loro a tal punto che non potevano non esistere simultaneamente; gli schiavi manomessi anche se erano liberi e cittadini romani non erano uguali agli ingenui (i nati liberi); essi erano definiti liberti e continuavano ad essere legati all’ex dominus, detto ora patronus, da uno speciale rapporto che li vincolava a determinate prestazioni e comportamenti nei suoi confronti. 2. Romani e stranieri a) Modi di acquisto della cittadinanza romana Cittadini romani si poteva essere per nascita, per concessione della libertà da parte del dominus e per concessione da parte della civitas. La nascita Era romano per nascita chi era figlio di un cittadino, o figlio naturale di una cittadina; i figli nati da un matrimonio legittimo seguivano la condizione del padre al momento del concepimento, quelli che nascevano fuori del matrimonio seguivano, invece, la condizione della madre al momento della nascita. Lo status di cittadino non comportava di per sé l’esercizio dei diritti politici, infatti le donne non avevano capacità di diritto pubblico; gli uomini l’acquistavano a 17 anni, età in cui venivano arruolati come soldati. La manomissione Diventava romano lo schiavo liberato dal dominus. Concessioni individuali e collettive da parte della civitas Già durante l’età regia, il rex poteva concedere la cittadinanza a persone di suo gradimento o a intere comunità di persone; in età repubblicana, la concessione sia individuale che collettiva veniva fatta dai comizi, con una legge comiziale. Annessione di un territorio conquistato Si poteva diventare cittadini romani anche in quanto appartenenti a una comunità politica conquistata dai romani, mediante l’annessione. Esercizio del ius migrandi da parte dei latini Diritto di acquistare la cittadinanza romana trasferendosi a Roma. b) La cittadinanza romana come privilegio Essere cittadini romani portava con sé molti privilegi; in primis non poter essere messi a morte dal magistrato senza un giudizio del popolo riunito nei comizi centuriati, attraverso la provacatio ad populum; egli non poteva inoltre essere sottoposto a tortura fisica e a fustigazione. Uno dei motivi che permise ai romani di governare per lungo tempo e su di un vasto territorio, fu proprio quello di dare la cittadinanza romana anche agli stranieri. c) Perdita della cittadinanza La cittadinanza poteva essere persa per vari motivi e precisamente: 1. perdita della libertà; la sua perdita faceva perdere lo status di cittadino romano; 2. acquisto di un’altra cittadinanza; chi si allontanava da Roma e si stabiliva in un altro Stato perdeva la cittadinanza romana; 3. condanna penale; la perdita della cittadinanza veniva inflitta a chi veniva condannato per sacertà e per aqua et igni interdictio, cioè ai condannati a morte che erano riusciti a fuggire da Roma; 4. partecipazione a una colonia latina. d) Gli stranieri Nel mondo antico lo straniero era considerato diverso e guardato con sospetto, ma questa diffidenza non era originaria, infatti a Roma, nei suoi inizi, vi era una certa disposizione a integrare al suo interno (grazie all’asylum) tutti coloro che erano stati costretti per qualunque motivo ad abbandonare la patria; Roma fu una città aperta in quel periodo la cui cultura si giovò di influenze etrusche e greche. e) Gli stranieri privilegiati: i latini I latini, tra gli stranieri, godevano di un trattamento particolare, che risale al foedus Cassianum del 493 a.C.; i cittadini di queste città (quelle della lega latina) venivano detti latini prisci, mentre quelli delle città fondate nei territori conquistati dalla lega latina, venivano detti latini colonia rii. In forza del ius Latii, i latini godevano di vari privilegi: il ius migrandi, cioè il diritto romana trasferendosi a Roma; di acquistare la cittadinanza il ius suffragii, cioè il diritto di votare qualora si trovassero a Roma il giorno in cui si riunivano i comizi; il ius commercii (o commercium), cioè il diritto di compiere atti di trasferimento con il negozio chiamato mancipatio, e di concludere accordi nella forma del nexum; questi negozio, come la mancipatio, era uno dei solenni negozi detti per aes et libram, in quanto il loro compimento richiedeva l’uso di una stadera (libra), sulla quale veniva dapprima realmente e poi simbolicamente pesato un pezzo di bronzo (aes), in funzione di prezzo; il ius conubii (o conubium), cioè il diritto di sposare un cittadino o una cittadina romana; il latino che sposava la romana non acquisiva però su di lei il potere, detto manus. f) Gli altri stranieri I privilegi concessi ai latini potevano essere concessi anche ad altri stranieri o ad altre comunità straniere, e quelli concessi erano il commercium e il conubium. g) Sui iuris e alini iuris La divisione in sui iuris e alieni iuris atteneva alla posizione all’interno della famiglia; erano sui iuris coloro che non avevano ascendenti maschi, mentre erano alieni iuris coloro che erano sottoposti al potere di un paterfamilias; questo potere poteva essere sia la patria potestas sia la manus. h) Soggetti diversi dalle persone fisiche Nel nostro ordinamento si parla di persone giuridiche; nel diritto romano s’iniziò a prendere in considerazione questo problema in età repubblicana, in quanto in età monarchica le formazioni sociali di rilievo (familia, gens, Stato) non venivano prese in considerazione come un insieme di persone e interessi. La familia ad esempio s’identificava nella figura del paterfamilias. In età repubblicana i gruppi di cittadini riuniti in assemblee acquistarono per la prima volta una rilevanza anche esterna; questo gruppo unitario, definito populus romanus, col tempo porterà alla nascita del soggetto astratto di persona giuridica. Dalla metà del secolo III a.C. alla metà del secolo III d.C. 1. Definizione di vita: vecchi e nuovi problemi Secondo i principi del ius civile, il nascituro non aveva esistenza autonoma; Ulpiano sosteneva che il pretore, nel suo editto, ritenne di dar tutela oltre che ai figli che sono già venuti al mondo, anche a quelli non ancora nati. Si pose poi il problema di considerare nato, l’essere che non aveva possibilità di sopravvivenza e il monstrum vel prodigium; secondo la giurisprudenza classica il figlio mostruoso doveva considerarsi come non nato, in quanto, inoltre, segno dell’ira divina e quindi maledetto e contaminante. Con riferimento all’individuazione del momento in cui la vita cessava i giuristi si posero il problema di quando due persone morissero nella stessa circostanza; la soluzione fu affidata in base all’età, cioè in caso di commorienza (di genitore e figlio), si considerava premorto il genitore se il figlio era pubere, e il figlio se era impubere. 2. Le divisiones personarum Le differenze di status che determinavano le differenze delle situazioni personali, furono molto determinanti anche in quest’età. a) Liberi e schiavi In questo periodo il numero degli schiavi crebbe a dismisura e con esso crebbe lo sfruttamento servile; vi era una minoranza di schiavi, però, che godeva di condizioni migliori ed erano i famosi schiavi pedagoghi, quelli che esercitavano la medicina o quelli nominati dal dominus per gestire un’azienda. La condizione degli schiavi non cambiò di molto, vennero inclusi nella categoria delle res mancipi, le cose di maggior importanza sociale, il cui trasferimento richiedeva appositi negozi solenni del ius civile. Si attenuò invece il potere del paterfamilias sui filiusfamilias. I figli della schiava sono “frutti”? In quest’epoca si sviluppò una questione in merito ai figli della schiava data in usufrutto, e cioè se considerare i figli della schiava come frutti e quindi spettanti all’usufruttuario, oppure se non erano da considerare frutti e quindi erano di proprietà del dominus della schiava. La questione si risolse nella seconda ipotesi e questo anche per motivi di natura economica. Con riferimento alla prigionia di guerra, va ricordata l’elaborazione di regole in materia di postliminium e sull’intenzione del captivus di tornare in patria, considerata condizione essenziale per il riacquisto dei diritti iure postliminii; la lex Cornelia de captivis nell’80 a.C. stabilì che se un cittadino romano moriva in stato di prigionia, si fingesse che egli fosse morto libero, così che il suo testamento potesse essere considerato valido. Non rientravano nel campo di applicazione del postliminium il matrimonio ed il possesso e quindi, al termine della prigionia, queste situazioni di fatto produttive di effetti giuridiche andavano ricostruite. In quest’epoca nacque il problema di stabilire se la deditio fosse un atto unilaterale o bilaterale, cioè se la schiavitù del deditus dipendesse semplicemente dalla consegna al nemico, o se fosse necessaria l’accettazione da parte di questo. Non furono più considerate causa di schiavitù la addictio del fur nocturnus al derubato o la vendita del filiusfamilias da parte del pater, mentre vennero considerate fonte di schiavitù iuris civilis alcune circostanze nuove: un senatoconsulto Claudianum del 52 d.C. stabilì che la donna che intratteneva rapporti sessuali con uno schiavo diventasse schiava del padrone di questo, se, dopo 3 diffide del dominus continuasse nella relazione; questa regola infrangeva il principio per cui non si poteva essere schiavi in patria, in considerazione dell’importanza dell’interesse protetto, ossia un interesse patrimoniale del dominus dello schiavo; alcune condanne criminali, come la condanna ad metalla, cioè a lavorare nelle miniere, rendevano il condannato servus poenae; era considerata fonte di schiavitù la condanna a morte, in quanto il condannato perdeva lo status libertatis; diventava schiavo il cittadino di età superiore ai 20 anni che si fosse accordato per farsi vendere come schiavo, allo scopo di dividere il prezzo del suo acquisto con il venditore. Nuove forme di manomissione Le sole manomissioni capaci di conferire al manomesso sia la libertà sia lo stato di cittadino furono le vecchie manumissiones del ius civile; l’unica che continuò ad essere praticata e che non subì modifiche fu quella testamento; la manumissio censu scomparve durante il Principato e quella vindicta era stata sensibilmente semplificata; perché essa avesse valore, non era indispensabile compierla nel luogo in cui il magistrato esercitava le sue funzioni (in iure), ma produceva effetto anche se compiuta nel luogo in cui il magistrato occasionalmente si trovava ed inoltre la procedura era stata snellita. Entrarono in uso forme nuove e non formali di manomissione, all’interno delle quali vennero consolidandosi tre tipo, la manumissio inter amicos, la manumissio per epistulam e la manumissio per mensam: la manumissio inter amicos aveva luogo ogniqualvolta il dominus dichiarava esplicitamente dinanzi ad un gruppo di amici di voler dare la libertà allo schiavo; la manumissio per epistulam aveva luogo quando il dominus inviava allo schiavo una lettera nella quale dichiarava la sua intenzione di liberarlo; la manumissio per mensam consisteva nell’ammettere lo schiavo a un banchetto, in mezzo ai propri amici. In un primo momento queste manomissioni non avevano effetti giuridici, ma a difesa degli schiavi intervenne prima il pretore e poi la lex Iunia Norbana, che riconobbe loro lo status di liberi e di latini coloniarii; la libertà comunque aveva dei limiti, in quanto non prevedeva la capacità di fare testamento, e di conseguenza alla loro morte i loro beni tornavano all’ex padrone. Leggi limitative delle manomissioni In questo periodo ci furono due leggi in materia di manomissioni: la Lex Fufia Caninia (2 a.C.), che stabilì un rapporto tra il numero degli schiavi appartenenti a una persona e quello degli schiavi che questa persona poteva manomette; le manomissioni compiute in fraudem legis erano nulle; la Lex Aelia Sentia (4.d.C.) stabiliva che fossero nulle le manomissioni in frode ai creditori e stabiliva un limite minimo di età sia per chi manometteva sia per chi veniva manomesso. Le manomissioni compiute contro le disposizioni di questa legge non erano nulle, ma conferivano ai manomessi lo status di latini Iuniani o di peregrini dediticii. Augusto, pur desiderando un aumento nel numero dei cittadini, voleva anche evitare che Roma e la penisola fossero popolate da una massa sempre più grande di ex schiavi. Il trattamento degli schiavi: nuove regola giuridiche In questo periodo vennero introdotte nuove regole sul trattamento degli schiavi; alcune di esse peggiorarono la condizione servile, altre la migliorarono. Sicuramente la peggiorò il senatusconsultum Silanianum del 10 d.C., laddove, qualora un dominus venisse ucciso, tutti gli schiavi di casa, dopo essere stati sottoposti a tortura, dovevano essere messi a morte; lo schiavo che rivelava il nome dell’assassino veniva risparmiato e reso libero con decreto del pretore. Inoltre se uno schiavo commetteva un crimine la pena era diversa rispetto ad un cittadino, infatti ai primi toccavano sempre le morti più atroci. A favore degli schiavi ci furono poi una serie di disposizioni, tra cui la lex Petronia, che vietava ai padroni di far combattere i loro schiavi contro le belve e di venderli perché fossero destinati a questa attività. Venne considerato come crimine l’uccisione dello schiavo altrui (e non più solo come danneggiamento); si decise che il dominus fosse punito per l’uccisione del proprio schiavo o che abbandonasse lo schiavo malato. In quest’epoca iniziò ad essere tutelata la condizione delle schiave dall’essere adibite alla prostituzione, con l’inserimento di una clausola che vietava di vendere o acquistare una schiava per farla prostituire. Adriano stabilì che la schiava acquistasse la libertà qualora il venditore, dopo aver apposto la clausola, tollerasse che il compratore la prostituisse. La capacità di agire degli schiavi, la regolamentazione del peculium e la responsabilità patrimoniale del dominus Gli sotto alcuni profili erano considerati oggetti, mentre sotto altri erano persone; se erano puberi e sani di mente, gli veniva riconosciuta la piena capacità di intendere e di volere e i dominus si servivano di loro, incaricandoli di svolgere attività e affidando loro una somma di danaro o di beni detti peculium, della quale il servus poteva liberamente disporre, anche se la proprietà restava del dominus. Tutti gli acquisti compiuti gestendo il peculium si producevano in capo al padrone, ma questo creava problemi a terzi, in quanto il servus non aveva patrimonio e i creditori non potevano rivalersi su di lui. Il pretore, per far si che ci si potesse rivalere nei confronti del dominus, introdusse le actiones adiecticiae qualitatis; queste azioni erano l’actio quod iussu, l’actio de peculio et de in rem verso, l’actio institoria e l’actio exercitoria, nonché l’actio tributoria. Con un espediente, nella intentio della formula veniva indicato il nome del servus, mentre nella condemnatio quello del dominus, e così facendo era costretto a rispondere con il suo patrimonio dei debiti contratti dal servus, entro vari limiti in base all’actio usata. Nella actio de peculio, il dominus rispondeva solo entro il limite del peculium; la responsabilità poteva essere totale, quando aveva preposto il servus ad un’attività commerciale terrestre (il servus come institor) o quando lo schiavo, da lui incaricato di un’attività marittima, avesse agito come armatore (exercitor); in questi casi nei confronti del dominus si esperiva con la actio institoria (attività terrestre) o con la actio exercitoria (marittima). Inoltre il dominus rispondeva per l’intero quando aveva autorizzato lo schiavo a concludere un determinato atto giuridico, attraverso la actio quod iussu. Per quanto riguarda invece i delitti del ius civile commessi dallo schiavo, il dominus poteva continuare a scegliere se difenderlo oppure farne la noxae deditio; quest’ultima poteva essere fatta anche dopo la condanna, mentre prima solo all’inizio del processo. Tra liberi e schiavi: addicti e auctorati Oltre agli schiavi, esistevano persone formalmente di stato libero, ma che in sostanza erano in schiavitù; questi erano gli addicti; la addictio non era fonte di schiavitù, ma coloro che la subivano venivano a trovarsi fisicamente vincolati a colui al quale erano stati assegnati. Oltre al fur manifestus, vi era il caso del debitore che aveva subito la manus iniectio, fisicamente vincolato al suo creditore, che poteva tenerla legato, rinchiuderlo nel carcere domestico, costringerlo a lavorare per lui e sottoporlo a punizioni anche fisiche; gli addicti potevano pagare il loro debito lavorando per il debitore, ma non esisteva una norma che garantiva il rilascio dell’addictus, che dipendeva quindi dalla volontà del creditore. Nella stessa posizione degli addicti si trovavano gli auctorati, coloro che si vincolavano a una persona che si occupava di organizzare le loro esibizioni come gladiatori. Il leasing di gladiatori Dopo essere stati addestrati in apposite scuole, i gladiatori venivano mandati a combattere nelle arene. Il contratto che li costringeva a combattere veniva concluso tra chi li aveva addestrati (o il dominus) e chi organizzava lo spettacolo; l’accordo fu oggetto di una lunga discussione, infatti alcuni ritenevano che i gladiatori venissero dati in locazioni, altri che invece sostenevano la vendita. La conclusione fu la stipula della locatio­conductio, per quelli che uscivano indenni dal combattimento, mentre per chi era stato ucciso o sopravvissuto in condizioni tali da compromettere la capacità di combattere era la vendita. 3. Cittadini e stranieri In quest’epoca, grazie al ius gentium e al praetor peregrinus, agli stranieri venne concessa protezione giuridica anche individuale, indipendente dall’esistenza di accordi internazionali (come in età arcaica); tra i vari espedienti vi era la fictio civitatis, ossia l’invito al giudice a giudicare come se la parte che chiedeva tutela civis esset (fosse cittadino); l’usucapione, però, era concessa solo ai romani e di conseguenza i peregrini non potevano avere la proprietà peregrina. I peregrini erano tutelati, inoltre, dal diritto della comunità cui appartenevano; se questa era rimasta autonoma questo diritto veniva applicato dai giudici della comunità stessa, mentre se invece la comunità aveva resistito a oltranza alla conquista romana ed era stata infine costretta ad arrendersi, a discrezione i suoi componenti (peregrini dediticii) avevano capacità solo rispetto al ius gentium e agli istituti pretori non riservati ai romani. I latini continuarono ad esistere, ma mentre i prisci diminuivano man mano e scomparvero quando la cittadinanza fu estesa a tutti gli italici, i latini coloniarii erano numerosi, sia per l’alto numero di colonie dedotte, sia per l’equiparazione a questi latini degli schiavi manomessi in base alle leggi Iunia Norbana e Aelia Sentia. a) Acquisto e perdita della cittadinanza romana Secondo le regole del ius civile il figlio nato da iustae nuptiae seguiva la condizione del padre al momento del concepimento, mentre in mancanza di iustae nuptiae seguiva la condizione della madre al momento della nascita; quindi la cittadinanza si acquistava con la nascita da padre cittadino e da madre a questi unita da iustae nuptiae; in età preclassica una lex Minicia stabilì che il figlio nato da genitori che avevano un diverso status civitatis avesse lo status del genitore in condizione più sfavorevole, ma dopo la guerra sociale (91­89 a.C.) una serie di provvedimenti facilitò il conseguimento della cittadinanza agli stranieri; un senatoconsulto voluto da Adriano, nel II secolo, riconosceva la cittadinanza al figlio di una cittadina romana e di un latino; un altro senatoconsulto regolò la situazione dei romani che credendo di essere peregrini avessero spostato una peregrina e dei peregrini che credendosi romani avevano sposato una romana; in questi casi potevano dimostrare la causa del proprio errore (erroris causae probatio), e in caso di riuscita, ottenere la cittadinanza romana per il coniuge o per sé, e per il figlio. Diventava ovviamente romano, il latino che esercitava il ius migrandi. La perdita della cittadinanza romana, derivava dalla perdita della libertà, dalla partecipazione a una colonia latina, dall’acquisto di cittadinanza in un’altra comunità e di alcune condanne; tra quest’ultime vi era la aqua et igni interdictio, la deportatio e la condanna ai lavori forzati perpetui. Concessioni collettive A partire dalla guerra sociale, le concessioni collettive di cittadinanza si susseguirono rapidamente; alla fine di questa guerra la cittadinanza venne estesa a tutti gli italici, mentre dal 212 d.C. venne estesa, grazie alla Constitutio Antoniana, a tutti gli abitanti dell’Impero, ad eccezione dei dediticii. 4. Sui iuris e alieni iuris a) La capacità di agire dei figli, il peculium e la responsabilità patrimoniale del paterfamilias Fatta salva la transitorietà della loro condizione, l’incapacità patrimoniale dei figli era identica a quella degli schiavi e poneva gli stessi problemi. Anche ai figli si usava concedere un peculium e anche per i debiti contratti dai filii il pretore concedeva actiones adiecticiae qualitatis, per consentire ai terzi di recuperare il dovuto. Con Augusto, accanto al peculium concesso dal pater (profecticium) venne introdotto il peculium castrense (militare), che comprendeva ciò che il figlio acquistava durante il servizio militare, e quindi la paga, il bottino, e anche eredità e legati ricevuti da compagni d’arme; quel che è più importante a proposito di questo peculium, è il fatto che Augusto ammise che il filiusfamilias potesse disporne in testamento; il peculium castrense assunse la configurazione di un patrimonio autonomo, che tornava al pater solo se il figlio moriva senza averlo disperso e senza averne disposto mortis causa. b) La capacità delle donne: la tutela muliebre La tutela muliebre si indebolì nel tempo sino a scomparire in età imperiale. L’alto numero di uomini morti in guerra, aveva reso molte donne sui iuris ed economicamente indipendenti; e anche quelle soggette a potestà, non lo erano comunque nei fatti; gli uomini, impegnati nelle campagne e preoccupazioni belliche, avevano meno tempo per controllare le donne. c) I minori di 25 anni Sul finire del secolo III a.C. una lex Laetoria o Plaetoria de circumscriptione adulescentium stabilì una pena pecuniaria a carico di chi avesse indotto una persona sui iuris minore di 25 anni a concludere un negozio che pregiudicava i suoi interessi. Il pretore intervenne concedendo una difesa (exceptio) al minore al quale veniva chiesto in via giudiziale l’adempimento dell’impegno assunto; successivamente il pretore intervenne anche qualora il minore avesse già compiuto l’atto pregiudizievole, concedendogli una restitutio in integrum. In considerazione che gli atti del minore di 25 anni rischiavano di essere impugnati secondo il ius honorarium, vennero nominati dei curatori, che divennero permanenti con Marco Aurelio. 5. Soggetti diversi dalla persona fisica In questo periodo la “persona giuridica” non esisteva secondo l’accezione moderna; tuttavia, da un punto di vista giuridico, il populus romanus era la personificazione della collettività dei cittadini. Esso possedeva l’ager publicus, e nello svolgimento delle diverse attività giuridiche era rappresentato dai suoi magistrati; con il Principato, accanto al populus, si affianco il princeps, che se pur persona fisica, era la personificazione giuridica della comunità. Accanto al suo patrimonio personale, il princeps possedeva il fiscus, patrimonio formato dai beni che facevano capo a lui in forza della sua carica, e che al momento in cui questa cessava non passavano ai suoi eredi personali, ma al nuovo princeps. I municipia e le coloniae agivano come soggetti non solo nel campo del diritto pubblico, ma anche in quello privato; vi erano inoltre una serie di associazioni (collegia), che nacquero in questo periodo, come i collegia fullonum (associazioni di lavandai), i collegia pistorum (panettieri); ovviamente per queste associazioni non era possibile parlare di persone giuridiche, nel senso moderno, ma il loro porsi nel diritto, prefigurò con il tempo l’evolversi di questo concetto, cioè di persona giuridica. Dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano 1. Liberi e schiavi: declino e fine del mondo di produzione schiavistico In età postclassica il numero degli schiavi era fortemente diminuito e la causa di ciò erano state in primo luogo la fine delle grandi guerre di conquista e anche, in misura minore, la diffusione tra i cristiani della pratica di manomettere i propri schiavi, facendo aumentare il prezzo d’acquisto di questi. Era quindi diventato interesse del padrone non diminuire il suo patrimonio sottoponendo i suoi schiavi a eccessive fatiche. Il lavoro servile era diventato costoso e spesso i proprietari terrieri utilizzarono frequentemente il lavoro salariato dei liberi, economicamente più conveniente. 2. Mutamento della condizione servile: il cristianesimo e la legislazione imperiale A determinare il mutamento della condizione servile aveva sensibilmente contribuito anche la dottrina cristiana, che oltre ad invitare a liberare gli schiavi, esortava a trattarli con umanità, e questo, oltre alla pratica sociale, influenzò anche la legislazione imperiale. a) Tutela della vita, della famiglia e della dignità degli schiavi Tra i provvedimenti più significativi in materia si può ricordare, in primis, la costituzione di Costantino (319) che stabilì che il dominus che uccideva il proprio schiavo fosse condannato come omicida; sempre Costantino, nel 334, stabilì che qualora si facesse luogo a una divisione ereditaria che comportava la divisione di appezzamenti di terra, questa dovesse essere fatta in modo da non separare le famiglie degli schiavi e dei coloni. Nelle Istituzioni di Giustiniano si legge inoltre che, “al nostro tempo a nessun uomo che vive sotto il nostro impero è lecito infierire sui suoi servi senza una causa stabilita dalla legge e oltre misura”. In questo periodo si giunse a stabilire che qualunque cittadino potesse rivendicare come libera la schiava costretta a prostituirsi, senza dover affrontare alcuna spesa processuale. Anche con l’instaurarsi del Cristianesimo come religione di Stato, non vi fu mai l’abolizione della schiavitù, che continuava ad essere un istituto iuris gentium, ma si riconobbe che essa era contraria al diritto naturale, in quanto all’inizio tutti gli uomini nascevano liberi. 3. La capacità patrimoniale dei servi e il processo di libertà Si affermò il principio secondo il quale la titolarità del peculium spettava allo schiavo; dal 422, una volta assodato che lo schiavo non avesse debiti verso il dominus, poteva essere esperita direttamente nei suoi confronti un’actio utilis de peculio; questo principio venne recepito nel diritto giustinianeo. A partire dal IV secolo gli schiavi potevano difendersi da soli senza bisogno dell’adsertor libertatis. Nel 393 si stabilì che chi venisse rivendicato come schiavo dopo aver vissuto come libero per 20 anni, ovvero dopo aver ricoperto una carica pubblica senza che il preteso dominus rivendicasse il suo diritto, potesse difendersi da solo, e che se era in buona fede acquistasse la libertà. Giustiniano nel 528 abolì la figura dell’adsertor e consentì, a tutti coloro della cui condizione servile si discuteva, di difendersi personalmente in giudizio. 4. Le fonti della schiavitù Diminuito il flusso dei prigionieri di guerra, in età postclassica la fonte della schiavitù più rilavante era la nascita da madre schiava. Si affermò il principio secondo il quale il figlio nasceva libero se la madre era libera al momento del concepimento, ovvero se era stata libera in qualunque momento nel periodo decorso tra il concepimento e la nascita del figlio. Nel 531­534 Giustiniano abrogò il senatoconsulto Claudianum, in forza del quale la donna che contro il volere del padrone e contro i suoi inviti a interromperla manteneva una relazione con uno schiavo altrui poteva diventare schiava del dominus di questi; nel 535 stabilì che la condanna ad metalla non comportasse più la perdita dello status libertatis. 5. L’acquisto dello status libertatis Vennero riconosciute numerose ipotesi di acquisto della libertà da parte dello schiavo; ad esempio la libertà venne concessa agli schiavi come premio per aver denunciato crimini particolarmente gravi, oppure, nel 531, quando la schiava concubina del suo dominus in caso questi morisse senza lasciare testamento, diventasse libera insieme ai figli nati dall’unione. Diocleziano stabilì che lo schiavo che aveva vissuto 20 anni in buona fece come libero, acquistasse la libertà; Costantino diede valore alla manumissio in sacrosanctis ecclesiis, che si realizzava attraverso una dichiarazione di volontà del dominus alla presenza del vescovo e dei correligionari. Giustiniano inoltre abrogò una serie di provvedimenti restrittivi, quali la lex Fufia Caninia, che imponeva limiti alle manomissioni, disposizioni della lex Aelia Sentia, tranne per le manomissioni in frode ai creditori, e la categoria dei latini Iuniani. A questo punto qualunque manumissio aveva l’effetto di conferire libertà e cittadinanza romana. Giustiniano, nel 535, stabilì che lo schiavo abbandonato dal padrone, acquistasse automaticamente la libertà. 6. Le nuove forme di assoggettamento personale: il colonato Il ricorso al lavoro servile era diventato antieconomico e difficoltoso e per questo i proprietari terrieri ricorsero alla manodopera salariata, ma questo si scontrava con lo spopolamento delle campagne; in considerazione di ciò, il fisco vide le sue entrate diminuire e questo indusse gli imperatori a prendere provvedimenti tesi a limitare la libertà dei lavoratori agricoli e questi istituti fortemente limitativi della libertà personale configurarono il colonato. Nel 328 Costantino vietò a chi alienava un fondo di separare da questo, spostandoli altrove, i coloni che lo coltivavano; nel 365 una costituzione di Valentiniano e Valente stabilì che i servi, i liberti e i coloni imperiali, nonché i figli e i nipoti di questi che avessero tentato di abbandonare i fondi venissero restituiti al patrimonio dell’imperatore. Il legame tra coloni e terra divenne tale che sul finire del IV secolo, i coloni, anche se formalmente liberi, erano nei fatti servi terrae (schiavi della terra). I coloni il cui nome veniva iscritto nel registro fiscale accanto alla terra che coltivavano erano detti adscripticii. 7. Fonti del colonato Erano coloni coloro che nascevano da madre colona, anche se all’interno di un matrimonio con persona che non aveva questo status; nacque un problema in merito alla condizione dei figli di genitori coloni legati a fondi diversi e questo fu risolto da Giustiniano nella Novella 162 del 539 che stabilì, che qualora il figlio fosse unico esso spettasse al dominus della madre; qualora i figli fossero due essi venivano assegnati l’uno ad un dominus e l’altro a quello del padre, mentre in casi di figli dispari, quello di più erano assegnato al dominus del fondo materno. Si poteva diventare coloni anche per altri motivi, tra cui l’essere denunziati di mendicare, nonostante si avesse la forza e la capacità di lavorare, oppure, sul finire del secolo V, coloro che avevano vissuto 30 anni in condizione di coloni non potessero più lasciare il fondo e Giustiniano estese questa regola anche ai discendenti. 8. Liberazione dallo status di colono Anche se di fatto era molto difficile, teoricamente era riacquistare la libertà e poteva avvenire nei seguenti modi: possibile 1. l’atto con cui il dominus donava al colono la libertà, donandogli nel contempo il fondo al quale era legato; 2. l’assunzione di determinate cariche ecclesiastiche o dello stato monacale o aver esercitato per 30 anni la funzione di decurione o essere stato membro per 30 anni di corpora o collegia; 3. l’usucapione dello stato di libertà, chi aveva vissuto condizione di libero per 30 anni (o 20 per la colonia). in 9. Altre condizioni personali limitative della libertà Gli interessi che avevano portato alla limitazione della libertà personale dei coloni determinarono la limitazione della libertà di altre categorie di persone e tra di esse: 1. gli appartenenti ai collegia (o corpora), ossia coloro esercitavano una determinata attività, il cui esercizio considerato dallo Stato di pubblico interesse; che era 2. i decurioni (o curiales), ossia i membri del senato dei municipi, delle colonie e delle diverse città. La posizione sociale dei decurioni in principio era di privilegio, ma col tempo divenne sempre più piena di doveri (munera), tra i quali la riscossione dei tributi con l’obbligo di risponderne personalmente; in considerazione del fatto che tanti volevano evitare di assumere questa carica, furono introdotte varie regole che punivano chi si rifiutava e limitavano la capacità dei decurioni di disporre dei loro beni; 3. coloro che non erano di religione cristiana subirono varie limitazioni, tra cui quella di fare e succedere ad un testamento; i manichei, in particolare, erano incapaci di qualsiasi atto, sia inter vivos sia mortis causa. 10. Romani e peregrini Con Caracalla dal 212 tutti i sudditi dell’Impero acquisirono la cittadinanza romana, ad eccezione dei latini Iuniani, i latini Aeliani e i dediticii. Con Giustiniano vennero abolite queste categorie e tutti gli abitanti erano romani. Peregrini rimasero solo i barbari che vivevano al di là dei confini imperiali. 11. Acquisto e perdita della cittadinanza Vi furono poche e limitate variazioni; ad esempio nel 320 si stabilì che il figlio di una donna ingenua e di un servus del fisco avesse la cittadinanza latina. Ma i latini, grazie a Giustiniano ottennero la cittadinanza romana. La perdita della cittadinanza nel IV secolo divenne una pena autonoma, a carico ad esempio delle persone di alto rango che avessero fatto legittimare i figli nati dalla loro unione con donna di bassa condizione sociale e con una schiava. 12. Sui iuris e alieni iuris In questi secoli l’istituto familiare subì forti mutamenti dovuti, tra l’altro al venir meno del valore dei vincoli agnatizi in opposizione all’aumento di quelli basati sulla cognatio. a) I rapporti tra patres e filiifamilias Tra l’età postclassica e quella giustinianea il ius vitae ac necis venne abolito. Con Costantino tale diritto esisteva ancora, ma qualora il rapporto padre­figlio venisse in considerazione sotto il profilo criminale, gli imperatori cominciarono a punire extra ordinem i padri che abusavano del loro potere e si giunse a stabilire che il padre che avesse ucciso il figlio venisse punito con la poena cullei (quella prevista per i parricidi). Col tempo venne introdotto il principio secondo il quale la punizione delle infrazioni più gravi commesse dai figli doveva essere affidata ad appositi funzionari imperiali. Una costituzione del 365 specificò che il potere di correzione sui figli minori non era riconosciuto ai padri senza limiti (in immensum), infatti, se l’atrocità del comportamento esorbitava dai limiti del diritto di correzione familiare (ius domesticae emendationis) il potere di punire il figlio spettava agli organi dello Stato. Nel diritto giustinianeo scomparve la necis potestas. b) Capacità patrimoniale del filiifamilias In questo periodo si affermò la piena capacità patrimoniale dei filiifamilias; le regole in merito al peculium castrense, nell’età giustinianea venne estesa anche al peculium quasi castrense, durante il servizio a corte. Con Costantino si stabilì che il paterfamilias non potesse disporre né inter vivos né mortis causa dei beni che il filiusfamilias avesse eredito dalla madre (i bona materna); rimaneva comunque in vigore il principio dell’incapacità patrimoniale dei figli, ma alla morte del pater, questi potevano entrare in possesso anche dei bona materna; questo regime fu poi esteso anche ai beni lasciati dagli ascendenti materni (bona materna generis) e la regola dell’incapacità patrimoniale dei filiufamilias fu superata. c) Acquisto ed estinzione della patria potestas L’adoptio La adoptio avveniva con ogni probabilità davanti alla curia della città (ante curiam); sembra inoltre che nella parte orientale dell’impero fosse in uso e assai diffusa l’adozione per semplice scrittura privata, peraltro avversata ed esplicitamente vietata dalle costituzioni imperiali. Con Giustiniano si stabilì che l’adoptio dovesse venire compiuta dinanzi a un funzionario imperiale, alla presenza dell’adottato, oltre che del padre originario e dell’adottante. L’adrogatio In questa epoca, l’adrogatio era consentita solo ex rescripto principali, cioè per rescriptum principis. Diocleziano ammise che le donne sui iuris potessero adrogare, ribadendo però la regola principale che le donne non potevano essere titolari di patria potestas. Questa forma di adrogatio era consentita per consolare le donna dalla perdita dei suoi figli, attraverso la creazione di un legame di parentela. L’emancipatio Fino a Diocleziano, l’emancipatio era utilizzata nel suo antico e complesso rituale, ma con Costantino si realizzava con una semplice dichiarazione del paterfamilias alla presenza di un funzionario imperiale e del filius; all’inizio del VI secolo venne introdotta l’emancipazione per rescritto imperiale e nel 531 Giustiniano abolì l’antico rituale e nel 539 stabilì che il padre non potesse emancipare il figlio infantia maior senza il consenso di questi. d) La tutela: donne i impuberi La tutela si trasformò da potestas in munus (dovere) a vantaggio della persona che vi era sottoposta; tra la fine del III e l’inizio del IV secolo scomparve la tutela muliebre, mentre perdurò la tutela legittima sugli impuberi, ma prevalse il legame cognatizio rispetto a quello agnatizio. I tutori non potevano alienare alcun bene di valore del pupillo (le c.d. res mancipi) e Giustiniano stabilì che essi potessero riscuotere i crediti del pupillo solo se autorizzati dal magistrato. In questo periodo tanti atti compiuti dal tutore producevano effetti in capo al pupillo e quindi, quando usciva di tutela, l’ex pupillo poteva esperire delle actiones utiles nei confronti di terzi. e) La curatela: i minori di 25 anni La posizione dei minori di 25 anni venne equiparata a quella degli impuberi, infatti alla sua incapacità di amministrare i suoi beni si accompagnava oramai la presenza fissa del curatore che in pratica svolgeva le stesse funzioni del tutore per gli impuberi. Giustiniano ribadì che il minore di 25 anni andava sottoposto alla curatela, ma che il curatore doveva essere di gradimento del minore. f) La curatela: i pazzi e i prodighi Secondo Giustiniano i furiosi erano sottoposti a curatela per tutta la vita, eccezion fatta per i lucida intervalla, ossia i periodi in cui riacquistavano le loro capacità mentali. 13. Esistenza delle persone fisiche Le regole più interessanti in materia riguardano l’individuazione del momento della morte; nel diritto giustinianeo si stabilì quale fosse la regola da applicare in casi di commorienza (di padre e figlio), e si agiva in presunzione iuris tantum, considerando premorto il genitore se il figlio era pubere, e premorto il figlio se questi era impubere. 14. Soggetti diversi dalla persona fisica Con il concentramento dei poteri nella figura del princeps e con la trasformazione del principato in dominato, la figura del populus romanus perse praticamente ogni significato, mentre importanza sempre maggiore acquistava il fiscus, nel quale erano arrivate a confluire anche le entrate che una volta facevano capo all’aerarium populi romani. In questo periodo venne riconosciuta la capacità dei municipia, delle coloniae e delle civitates, alle quali, nel 469, si riconobbe la capacità di essere istituite eredi. 5. Famiglia e parentela A.Questioni di termini e questioni di sostanza 1. La familia. Diverse accezioni del termine Nei primi secoli della sua storia, la cellula fondamentale della società romana era la familia, un gruppo di persone la cui composizione era diversa non solo da quella della gens, ma anche dalla famiglia attuale; gli appartenenti alla familia, non vantavano ascendenti comuni come i membri di una gens, mentre dall’altro non erano necessariamente unite da vincoli di matrimonio o di sangue, come la famiglia attuale. Tutto ciò che accomunava tutti i membri della familia era la comune sottoposizione a un paterfamilias, che esercitava il suo potere, sia su quelli di stato libero, sia su quelli in condizione servile; avere un paterfamilias non era condizione necessaria per avere una familia; infatti chi non aveva ascendenti maschi era capo di una famiglia, qualunque fosse la sua età, ad eccezione delle donne. Riferendoci al ristretto gruppo familiare si parla di familia proprio iure, mentre se la si estende ai parenti in linea maschile (adgnati) si parla di familia communi iure, cioè quando alla morte del pater, i figli formano varie familiae, ma il fatto che siano stati sottoposti alla stessa potestas li considererà membri di una familia communi iure. La familia communi iure non si estendeva all’infinito, infatti agli effetti giuridici i vincoli di parentela avevano rilevanza solo entro il sesto grado. 2. La parentela La adgnatio era la sola parentela originariamente rilevante ai fini giuridici; essa legava coloro che discendevano in linea maschile da un capostipite maschio comune, vivo o morto, o che erano sottoposti in condizione di discendenti, indipendentemente dai vincoli di sangue, e quindi anche i figli adottivi o le mogli in manu. Poteva legare due persone sia in linea retta che in linea collaterale; in linea retta univa gli ascendenti ai discendenti (padre e figlio parenti di primo grado, nonno e nipote di secondo ecc.); in linea collaterale il grado della adgnatio si calcolava risalendo da uno dei due adgnati al capostipite comune, per poi scendere sino all’altro adgnatus, contando un grado per ogni passaggio sia in salita che in discesa (fratelli erano adgnati di 2° grado, cugini di 4°, zio e nipote di 3°, figli dei cugini di 6°); il 6° grado era il limite agnatizio di rilevanza giuridica. La parentela agnatizia, oltre che per nascita da iustae nuptiae, nasceva da tutti gli atti che facevano acquistare la patria potestas (adrogatio e adoptio) o la manus (conventio in manum). Il legame di sangue, che non era civilis, si definiva come cognatio e in età arcaica aveva poca rilevanza giuridica, mentre fino all’intervento del pretore non aveva rilievo successorio. 3. La familia proprio iure. Struttura La familia proprio iure appare come un’organizzazione patriarcale, patrilineare e patrilocale; a capo di ciascun gruppo familiare vi era un paterfamilias di cui i romani andavano fieri. La patria potestas romana aveva un elemento unico caratterizzante, cioè durava finché il paterfamilias era in vita; alla sua morte solo i discendenti immediati (i figli) e i discendenti di questi se l’ascendente era premorto. Solo costoro divenivano sui iuris, ossia soggetti di diritto, mentre tutti gli altri, restando alieni iuris, passavano sotto la potestas di un nuovo paterfamilias. 4. Capacità di diritto privato, capacità di diritto pubblico Essere sottoposto a un paterfamilias significava non essere titolare di alcun diritto; il pater era il soggetto al quale facevano capo tutti gli interessi del gruppo; i beni familiari erano di sua proprietà, i rapporti giuridici nascevano in capo a lui; se un suo sottoposto acquistava un bene, questo veniva acquistato per conto del pater, mentre se assumeva obblighi verso terzi, questi atti non vincolavano il paterfamilias; inoltre se un suo sottoposto commetteva un delitto, egli poteva liberarsi di ogni responsabilità con la noxae deditio, cedendo quindi il sottoposto in condizione di fatto di schiavitù alla parte lesa (ceduto in mancipio). Oggi diremmo che solo il paterfamilias aveva la capacità giuridica. L’unica differenza dei sottoposti era che quelli di stato libero avevano un’aspettativa normale di capacità (alla morte del pater), mentre per gli schiavi e le persone in causa mancipi, l’unico modo di essere liberi era data dalla manumissio compiuta dal pater. Nel diritto pubblico, invece, alla maggiore età (17 anni), i maschi acquistavano la capacità politica. a) Il nome familiare L’appartenenza alla familia era segnalata da un nome familiare detto cognomen; per i maschi vi era un nome personale, praenomen (Marco, Caio), inoltre i patrizi aveva anche un terzo nome, quello della gens, il nomen (Tullio, Giulio); a volte vi poteva essere un quarto appellativo per caratteristiche fisiche (Nasone, Barbato) o per gesta militari (Africano). Questo definiva il sistema dei tria nomina (tre nomi), dal quale erano escluse le donne. Esse venivano indicate con il nome della gens al femminile (Tullia, Giulia) e se vi erano più donne nella stessa famiglia si usava o Maior e Minor, oppure Prima, Secunda, Tertia, ecc. Secondo alcuni il praenomen femminile non sarebbe esistito, mentre per altri non poteva essere pronunciato per ragioni di pudicitia; ciò che è certo, era che nominare una donna era un atto socialmente irrispettoso. 5. Unità e molteplicità dei poteri paterni In età storica, i poteri paterni sui diversi componenti della famiglia erano: patria potestas sui figli; manus sulla moglie e sulle mogli dei figli; dominica potestas sugli schiavi; dominium ex iure Quiritium sulle cose. Si ritiene che questa differenziazione derivi dalla frantumazione di un potere unico, detto mancipium. B.Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. 1. La patria potestas a) Contenuto Il contenuto del potere paterno sui discendenti era ab origine illimitato, e cominciava dal momento in cui il filiusfamilias nasceva; il primo potere che il padre poteva esercitare su di lui era quello di decidere autonomamente e insindacabilmente se accettarlo come figlio o rifiutarlo ed esporlo, ossia abbandonarlo al suo destino. Questo gesto si compiva dopo che i neonati venivano deposti ai suoi piedi e lui poteva o sollevarli prendendoli nelle braccia o lasciarli per terra abbandonandoli. Un primo limite a questo potere venne da una lex regia di Romolo che stabilì una sanzione economica, per chi esponeva un figlio maschio o la figlia primogenita, che equivaleva a metà del patrimonio. Sui figli accolti nella familia il padre esercitava un potere tale che arrivava a comprendere il famoso ius vitae ac necis e questo ultimo potere si esercitava sui figli in relazione al sesso di questi. Sui maschi veniva esercitato di norma quando si erano macchiati di crimini contro lo Stato, tipo la perduellio (alto tradimento); per le femmine poteva essere esercitato in caso di perdita della pudicitia o in caso di stuprum (rapporto sessuale intrattenuto da una donna onesta al di fuori del matrimonio). Un altro potere del pater era quello di poter vendere i figli ad un altro paterfamilias, in una situazione di fatto diversa ma nella sostanza simile alla schiavitù, e veniva definita col termine in mancipio. Se dopo la vendita, il figlio veniva liberato dall’acquirente, questi ritornava sotto la potestas del pater originario; per perdere la patria potestas, bisognava vendere il figlio maschio per ben 3 volte; per le femmine non servivano le 3 vendite. b) Modi di acquisto Secondo Ulpiano, alla familia si apparteneva perché sottoposti alla patria potestas natura aut iure, cioè in base alla natura o al diritto. La nascita Il paterfamilias acquistava la patria potestas sui nati ex iustis nuptiis all’interno del gruppo familiare; questo era il modo naturale di acquistare la patria potestas. L’adozione Il modo di acquistare iure la patria potestas consisteva nel compimento di un atto che chiamiamo adozione e che consentiva al pater di crearsi artificialmente un figlio; le due forme previste erano l’adrogatio e l’adoptio. La più antica era l’adrogatio e consisteva in una solenne interrogazione con cui il paterfamilias adottante chiedeva a colui che doveva essere adottato se accettava di entrare nella sua familia; questo atto veniva compiuto innanzi ai comizi curiati; questa procedura solenne era data dal fatto che chi veniva adottato era un paterfamilias, che perdeva la posizione di sui iuris ed entrava nella familia dell’adottante in condizione di filius, portando con sé i suoi sottoposti e il suo patrimonio. Rinunciando con questo atto, al proprio culto familiare, l’adottato compiva una solenne cerimonia religiosa detta detestatio sacrorum, per placare i numi. L’adrogatio poteva essere compiuta solo dai maschi sui iuris; per la mancanza di capacità comiziale non potevano utilizzare questa forma né le donne né i maschi impuberi sui iuris. In età classica si affermò il principio che l’adottante fosse più vecchio dell’adottato. L’adoptio consisteva nel passaggio di un filiusfamilias da una familia a un’altra; venne introdotta dopo le XII Tavole, grazie ad una interpretazione giurisprudenziale, secondo il quale il padre che vendeva il figlio per 3 volte perdeva la patria potestas. L’adoptio veniva realizzata compiendo dapprima la emancipatio e quindi recandosi dinanzi al pretore, ove l’adottante rivendicava l’adottando (che doveva essere presente) come suo figlio, mentre l’ex padre taceva ritirandosi (in iure cedebat); il pretore, quindi, riconoscendo come legittima la rivendicazione dell’adottante, pronunciava l’addictio, dichiarazione che l’adottato era figlio dell’adottante. L’adoptio rompeva i vincoli agnatizi tra l’adottato e la famiglia di origine, con conseguenze sul piano ereditario; inoltre l’adoptio era accessibile, in veste di adottante, solo ai cittadini maschi. c) Cause di estinzione della patria potestas La morte Quando un paterfamilias moriva, i suoi discendenti immediati (figli e figlie, moglie in manu e discendenti di grado ulteriore, se gli intermedi erano premorti) diventano sui iuris; i discendenti di grado ulteriore restavano sotto la potestà del discendente intermedio, che diventava il nuovo paterfamilias. La caduta in prigionia Estingueva la patria potestas e valeva anche se in prigionia cadeva il filius. Il mutamento della cittadinanza Essendo la patria potestas legata alla stato di libertà e alla cittadinanza romana, se un pater cambiava cittadinanza (o il figlio), questa si estingueva. L’assunzione di carica sacerdotale Altra causa di estinzione della patria potestas era l’assunzione della carica di Flamen Dialis da parte del figlio o se la filia veniva accolta tra le virgines Vestales. L’emancipatio L’emancipatio era un modo volontario di estinzione della patria potestas; era il mezzo con cui un pater poteva rinunciare alla patria potestas, rendendo un figlio/a sui iuris ed era legato al fatto che se un pater vendeva il figlio per 3 volte perdeva la sua potestas. La procedura, complessa, consisteva nel vendere il figlio (mancipatio) presso una persona di fiducia in causa mancipi, che a sua volta manometteva il figlio che ritornava al padre. Alla terza mancipatio, l’acquirente anziché liberarlo lo vendeva al padre in causa mancipi, che a sua volta lo manometteva, divenendo il suo parens manumissor e acquistando sul figlio (ex ormai) il diritto di patronato. Per le figlie o i nipoti questa regola non valeva e si liberavano dopo una sola mancipatio. 2. La manus a) Modi di acquisto La manus sulle mogli, propria e dei figli, veniva acquistata a seguito della celebrazione del matrimonio, cerimonia nuziale, detta confarreatio. La confarreatio Solenne rito religioso riservato ai patrizi, che prendeva il nome da una focaccia di farro che gli sposi dividevano come simbolo della futura vita comune, rito effettuato davanti a dieci testimoni. Il rituale comprendeva inoltre altre solennità, tra cui l’unione della mano destra degli sposti, l’uso della pelle di pecora appositamente sacrificata per coprire il sedile su cui gli sposi sedevano durante la cerimonia, i tre giri rituali che dovevano compiere intorno all’altare andando verso destra, il velo rosso (flammaeum) che copriva il capo della sposa; altri riti erano la pronunzia da parte della sposa della celebre frase “Ubi tu Gaius ego Gaia”. La confarreatio nel momento stesso in cui costituiva il vincolo matrimoniale, operava un trasferimento di poteri personali, sottoponendo la moglie alla manus del marito o del paterfamilias di questi. La confarreatio cadde in desuetudine, ma l’inizio del matrimonio continuò ad essere accompagnato da riti nuziali che non trasferivano la donna nella familia del marito, ma vennero creati degli istituti appositi, quali la coemptio e l’usus. La coemptio La coemptio era un’applicazione della mancipatio ed era una forma di celebrazione del matrimonio per compera. In età storica, la coemptio aveva perso questo carattere ed era diventata una compravendita fittizia, che non faceva acquistare la donna, ma la manus su di lei. Visto che erano esclusi dalla confarreatio, alla coemptio sicuramente facevano ricorso i plebei e quando la prima cadde in disuso, la seconda venne utilizzata come atto costitutivo della manus anche dai patrizi per risolvere il problema sollevato dalla celebrazione di riti nuziali che non operavano la conventio (trasferimento della moglie nella famiglia del marito). L’usus Era una forma speciale di usucapione, che era uno dei modi per acquistare la proprietà su un bene, il cui termine era un anno per i beni mobili e due per quelli immobili. Dopo un anno di convivenza, qualora non fosse stata celebrata la coemptio, il marito usucapiva la manus sulla moglie. b) Condizione della moglie in manu Nella nuova famiglia la moglie si trovava in condizione di figlia presso il marito, se questi era sui iuris, e quindi alla morte di questi diventava sui iuris e concorreva alla sua eredità come erede legittima, insieme ai propri figli; se il marito era alieni iuris la donna era in manu del suocero, e quindi loco filiae presso di questi e loco sororis (in condizione di sorella) nei confronti del marito. c) I poteri del titolare della manus Secondo una lex regia, al marito era concesso uccidere la moglie in caso di adulterio o in caso ella avesse bevuto del vino. Questa norma era dettata anche dal fatto che la famiglia di origine della donna voleva evitare che il marito abusasse dei suoi poteri e quindi con una norma autoritativa si stabilivano i casi in cui esercitare il ius vitae ac necis. d) Modi di estinzione della manus La manus era un potere che si estingueva anche in caso di divorzio, ma ve n’erano altri: nel caso di matrimonio confarreato, la manus si estingueva a seguito di diffareatio, un divorzio celebrato con una cerimonia solenne, uguale e contraria a quella che aveva stretto il vincolo nuziale; nel caso di coemptio, per estinguere la manus era necessario che il divorzio fosse affiancato da una remancipatio, ossia una mancipatio uguale e contraria alla coemptio, con cui il marito o il padre di lui trasferivano la manus al pater originario; se la donna fosse entrata in manus attraverso l’usus, il marito o il padre di lui utilizzavano una procedura analoga a quella usata per dare in adozione un figlio, cioè il titolare della manus emancipava la moglie e dinanzi al magistrato il pater originario ne rivendicava la patria potestas; la manus si estingueva per morte, caduta in schiavitù e mutamento di cittadinanza del titolare; se il titolare era il marito, la donna diventava sui iuris, mentre se era un ascendente del marito, ella ricadeva sotto la potestà dell’ascendente superstite più anziano o del suo stesso marito, se non vi erano ascendenti intermedi. 3. I poteri del paterfamilias: la dominica potestas Il potere del paterfamilias sui sottoposti di stato servile era detto dominica potestas; il potere sullo schiavo si chiamava potestas, esattamente come il potere che il paterfamilias vantava sui figli, e il potere che il dominus vantava su di lui era avvicinato a un potere personale; la potestas sullo schiavo non era patria, ma dominica, che si avvicinava al dominium e sotto questo profilo lo schiavo si avvicinava ad una cosa e il potere su di lui era patrimoniale e non personale. C.Dalla metà del secolo III a.C. alla metà del secolo III d.C. 1. Le prospettive aperte dalla demografia sociale I cittadini romani, quali che fosse la loro età, erano sottoposti alla patria potestas sinché avevano un ascendente maschio vivente, e questa sottoposizione comprendeva, tra l’altro, la totale dipendenza economica; un filiusfamilias romano, anche se cinquantenne, era costretto a chiedere al padre financo il danaro per comprarsi una gomma da masticare. a) Effetti della patria potestas sui rapporti padre­figlio: la tesi della tensione Secondo parte della dottrina le caratteristiche di questa patria potestas avrebbero influito, oltre che sul piano giuridico, anche su quello emotivo tra padri e figli; questi ultimi erano sottomessi ai primi e la morte del pater rappresentava la libertà; i figli romani vivevano ossessionati dal parricidio, pratica che si realizzava alquanto spesso a Roma. I rapporti tra i membri della famiglia romana improntati all’unione creata dalla subordinazione al potere paterno, con le incapacità e le paure che ne derivavano. 2. Regole giuridiche e realtà sociale a confronto a) In materia di ius vitae ac necis L’affermazione che il ius vitae ac necis venisse esercitato raramente sembra essere contraddetto dalle fonti del diritto. Le norme della lex Iulia de adulteriis che limitavano il diritto del padre di uccidere la figlia adultera confermano che sino a quel momento, nella pratica, i padri esercitavano questo diritto, quantomeno sulle femmine. E con riferimento ai maschi, le attestazioni di casi in cui questo diritto venne esercitato non solo esistono, ma sono significative. Il timore del giudizio paterno era così forte da rendere insostenibile l’idea di affrontare a viso aperto il momento della resa dei conti e della vergogna (suicidio dei figli). Pensare, poi, che i padri esercitassero il ius vitae ac necis, non è necessario immaginare che fossero crudeli e disumani con i figli; a Roma il modello del potere pubblico si ispirava a quello del capofamiglia e questo comportava che per un padre uccidere un figlio fosse, oltre che un diritto, anche un obbligo. I padri romani, non erano per forza crudeli e forse soffrivano a mandare a morte un figlio, ma questo non impediva loro di fare quello che ritenevano giusto fare. b) In materia di subordinazione economica dei figli La prassi di dare ai figli un peculium e gli interventi pretori volti a rendere i padri responsabili dei debiti assunti dai filiifamilias nacquero per il problema dell’incapacità patrimoniale dei figli; la concessione del peculium e le norme che lo regolavano, se da un lato andarono a vantaggio dei figli, dall’altro svolgeva un ruolo tutt’altro che secondario a favore dei patres, che grazie a queste regole potevano servirsi dei figli per gestire il loro patrimonio. c) In materia di matrimonio Perché il matrimonio dei filiifamilias fosse valido era necessario anche il consenso paterno; fino all’età degli Antonini, i patresfamilias potevano anche interrompere il matrimonio dei figli indipendentemente dalla volontà di questi; solo attorno al secolo II d.C. i figli cominciarono a opporsi alla volontà dei padri. Contro i figli riluttanti era concesso ai padri di far ricorso a un interdictum de liberis ducendis; in un passo di Ulpiano si allude alla possibilità concessa al marito, di opporre una exceptio al suocero che aveva fatto ricorso all’interdictum. A Roma il matrimonio era una questione familiare dalle importanti conseguenze economiche e sociali e l’ideale di amore coniugale era un affetto ragionevole, non una passione (riservata alle amanti). Anche se la propaganda nazionale esaltava il matrimonio unico, non v’è alcun dubbio sul fatto che i divorzi quantomeno tra le classi abbienti fossero frequenti. A Roma, quantomeno tra le classi alte, esistevano numerose famiglie miste, matrimoni. composte dai coniugi e dai figli nati da successivi 3. La famiglia “mista”: passato e presente a confronto Oggi in molte società occidentali non esiste un solo modello di famiglia; anche dove resiste il modello della famiglia nucleare, accanto a queste famiglie, esistono quelle con un solo genitore, quelle composte da coniugi senza figli, quelle miste che uniscono figli di più matrimoni, e quelle di fatto. Qualcosa di simile esisteva anche nel mondo romano. L’incertezza e la mutevolezza dei contesti familiari in cui i figli crescevano, doveva inevitabilmente influire su questi rapporti in modo diverso da quello in cui influisce l’appartenenza a una famiglia nucleare. 4. Conclusioni La teoria che drammatizza gli effetti della patria potestas appare più convincente di quella che li minimizza. Nella realtà romana dell’età preclassica e classica esistevano diversi modelli di famiglia: la famiglia patriarcale, che continuava a sussistere; la famiglia nucleare, che tendeva ad emergere sia cristianesimo che per ragioni interne alla società pagana; per il la famiglia mista, tra le elites aristocratiche. D.Dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano 1. I cambiamenti e le loro premesse sociali ed etiche In questi secoli l’etica dei romani era profondamente cambiata, in conseguenza della progressiva cristianizzazione della società; la concezione evangelica, dove non vi era differenza tra le persone, aveva modificato profondamente i rapporti interpersonali e anche la concezione del matrimonio e della famiglia, addolcendo anche i rapporti tra il paterfamilias e i suoi sottoposti. 2. Metamorfosi della morale pagana o influsso cristiano? Nella società pagana, all’incirca tra l’età di Cicerone e quella degli Antonini, si era verificata una metamorfosi dei costumi sessuali del tutto autonoma dall’influsso cristiano, i cui fattori furono principalmente due: il passaggio da quella che viene definita un’aristocrazia concorrenziale a un’aristocrazia di servizio e l’autorepressione reattiva dei plebei. La vita della classe dirigente romana era cambiata. Per secoli i patresfamilias avevano dominato incontrastati i gruppi familiari in concorrenza reciproca, ma ora si ritrovavano ad essere sudditi del principe e uguali fra loro e questo potere sovrastante del regnante li portò a cambiare sia il loro stile di vita che la loro psicologia. La tradizionale autoritarietà del cittadino romano aveva subito un duro colpo; le persone con cui si trovava a trattare nella società, erano pari a lui, ed egli era tenuto al rispetto e non poteva più dare ordini come prima e questo portò a darsi una nuova regola, quella della rispettabilità. I patres avevano preso, da un canto, a trattare con maggior umanità gli schiavi, dall’altro, a rispettare la personalità, i desideri e l’autonomia dei figli adulti. La mentalità e il costume erano cambiati di conseguenza. 3. I nuovi limiti alla patria potestas Nel IV secolo d.C., gli imperatori stabilirono dei limiti all’esercizio dei poteri paterni; nel 323 Costantino affermò che il diritto di vita e di morte sui figli era ancora consentito, ma nel 395 fu stabilito che al padre spettasse solo un potere correzionale, e che qualora le infrazioni dei figli fossero di tal gravità da richiedere l’irrogazione di vere e proprie pene, queste venissero irrogate dallo Stato; nel Codice giustinianeo il ius vitae ac necis sparì. Sullo stesso filone vi furono vari provvedimenti in merito all’esposizione dei neonati, stabilendo che chi avesse esposto un figlio avrebbe perduto definitivamente la patria potestas su questi; si riconobbe la liceità della vendita di neonati, ma solo se conclusa a causa dell’insostenibile miseria. 4. La capacità patrimoniale dei filiifamilias In questo periodo ai filiifamilias venne progressivamente riconosciuta la piena capacità patrimoniale; due costituzioni di Costantino stabilirono che le norme in materia di peculium castrense venissero applicate anche ai beni poi definiti peculium quasi castrense e cioè ai beni acquisiti dai filiifamilias prestando servizio presso la corte imperiale. Una costituzione di Costantino, nel 319, stabilì che qualora un filiusfamilias avesse ereditato ab intestato dalla madre, il di lui pater, pur essendo titolare dei beni ereditati dal figlio (detti bona materna), non poteva disporne; 60 anni dopo questa regola venne estesa anche ai bona materna generis, cioè i beni che il figlio ereditava dagli ascendenti materni. Verso la metà del V secolo si affermò il principio che il padre avesse su questi beni solo l’usufrutto; Giustiniano stabilì che a questo regime fossero sottoposti tutti i beni che il filiufamilias avesse acquistato con il proprio lavoro o per liberalità di persona diversa dal padre. Il principio della piena e totale capacità dei figli non venne affermato neppure nel diritto giustinianeo. 5. Agnatio e cognatio Mentre diminuiva l’importanza dei rapporti familiari basati sull’agnatio, vennero acquistando sempre maggior peso i legami fondati sulla cognatio, sul sangue. L’adrogatio veniva ormai compiuta in forza di un rescritto imperiale (rescriptum principis); nel 291 Diocleziano e Massimiano, pur ribadendo che le donne non potevano esercitare la potestà personale sui figli, consentirono a una donna, che aveva perso i suoi, di adrogarne uno, per confortarsi della perdita subita. In quest’epoca si ammise anche che una donna sui iuris potesse essere adrogata e si stabilì che l’adrogante avesse l’usufrutto sui beni dell’adrogato. L’adoptio a partire dall’età di Diocleziano avveniva nelle regioni occidentali dell’Impero davanti alla curia della città (ante curiam) e in quelle orientali per semplice scrittura privata. Nel 530 Giustiniano abolì le antiche formalità, ma queste non erano in uso da secoli; nello stabilire che l’atto venisse compiuto dinanzi a un funzionario, Giustiniano richiese che a esso partecipasse, oltre all’adottante e al pater originario, anche l’adottando, del quale era necessario il consenso. L’emancipatio, fino a Diocleziano, avveniva formalmente secondo le antiche formalità, ma di fatto era ormai sufficiente una dichiarazione paterna, resa dinanzi a un funzionario imperiale, alla presenza del figlio; l’imperatore Anastasio, nel 502, ammise che si potessero emancipare per rescriptum principis i figli assenti. Nel 531 Giustiniano abolì le antiche formalità, stabilendo che fosse sufficiente una dichiarazione resa dal padre al competente funzionario, e alcuni anni dopo affermò il principio secondo il quale alla validità dell’atto era indispensabile il consenso del figlio. 6. Il matrimonio A. Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. 1. La capacità matrimoniale (conubium) Per poter contrarre un matrimonio legittimo (iustum matrimonium) gli sposi dovevano avere la capacità matrimoniale, il conubium; questa capacità era legata in primis allo stato di persone libere, mentre in caso di unione con o tra schiavi si parlava di contubernium; salvo eccezioni (stranieri) il conubium era anche legato alla cittadinanza romana; inoltre fino al 445 era vietato anche il matrimonio tra patrizi e plebei, quando un plebiscito concesse il reciproco conubium. Essere sui iuris o alieni iuris non inficiava il matrimonio, ma nel secondo caso era necessario il consenso dell’avente potestà. Infine il conubium era legato al raggiungimento della pubertà, che in un primo momento veniva accertata con una inspectio corporis, effettuata come rito collettivo nei santuari extra moenia (fuori dalle mura); successivamente questa certificazione divenne un fatto privato. a) Diritto e prassi Si pensa che le ragazze contraevano matrimonio in età giovanissima; alla pratica di accertare la pubertà si sostituì il regime di presunzione legata al compimento di una determinata età, i dodici anni. 2. Il fidanzamento (sponsalia) Il matrimonio era di norma preceduto da un periodo di fidanzamento, chiamato sponsalia; consisteva in una promessa di matrimonio fatta nella forma della sponsio, un solenne impegno verbale preso dal padre della futura sposa, su richiesta del futuro sposo o del padre di questi. Sembra che a Roma il fidanzamento era vincolante e che avrebbe mantenuto i suoi effetti obbligatori per alcuni secoli; anche quando perse carattere vincolante, il fidanzamento rimase un atto di grande valore sociale; per quanto riguarda l’età del fidanzamento, non vi era una norma di diritto che ciò normasse, ma posto che i futuri sposi dovevano capire quel che fanno, essi non dovevano avere meno di sette anni; in caso di alieni iuris, ovviamente erano i pater a decidere per loro. 3. I riti nuziali L’ipotesi che la confarreatio fosse l’unico rito nuziale che aveva rilevanza giuridica agli effetti della costituzione del vincolo matrimoniale era legata alla convinzione che essa fosse l’unica cerimonia religiosa propria della religione nazione dei romani; sappiamo che nei secoli V­IV i riti nuziali che a Roma appaiono come riti privati erano originariamente dei riti pubblici e questo induce a pensare che la loro privatizzazione si sia verificata a seguito del trasferimento alle famiglie del potere­dovere di certificare la pubertà, dapprima spettante al santuario. Quel che è certo è che solo la confarreatio trasferiva la donna nella famiglia del marito. 4. Doveri della moglie, poteri del marito I poteri del marito sulla moglie in manu erano analoghi a quelli paterni; se ella veniva meno ai suoi doveri, il marito aveva un potere che si estendeva fino al ius vitae ac necis, con la sola differenza che il marito poteva uccidere la moglie solo in due casi, ossia l’adulterio ovvero se la moglie avesse bevuto; sul primo caso i motivi sono ovvi, l’adulterio era colpa imperdonabile e lesiva dell’onore; per quanto riguarda il secondo caso si può immaginare che la donna bevendo del vino poteva perdere il controllo di sé e commettere più facilmente adulterio e comportarsi in modo disdicevole. a) Diritto e prassi A prescindere dell’esistenza di regole ferree di controllo sulle donne, quello che ci chiede è se poi queste regole venivano applicate alla lettera o vi fosse una certa tolleranza. Tipico è il caso di Ignazio Mecennio che uccise a bastonate la moglie che aveva bevuto, ma nonostante ciò non fu ritenuto colpevole di omicidio. Egli non compì un atto socialmente riprovato, ma sbagliò esecuzione, che nel caso delle donne sarebbe consistito nel farla morire di inedia nel carcere domestico. Egli però bastonò la moglie ed il caso fu sottoposto a Romolo che comunque lo assolse. 5. La nascita del matrimonio sine manu Il progressivo diradarsi del ricorso all’usus provocò il fenomeno della nascita del matrimonio sine manu, che ha origini molto antiche; una norma delle XII Tavole, infatti, stabilì che la moglie potesse evitare di passare in manu del marito allontanandosi ogni anno per tre notti dalla casa coniugale, prima che scadesse il termine dell’usus, e quindi impedendo che il termine dell’usucapione si compisse. Grazie a questo istituto, detto trinoctium o trinoctis usurpatio, la donna restava sotto la patria potestas paterna, ancorché regolarmente coniugata. 6. Lo scioglimento del matrimonio Il matrimonio si scioglieva per morte di ragioni dipendenti o indipendenti erano la perdita della libertà o della venir meno della volontà di questi e iuris, il venir meno della volontà del di uno dei coniugi e per una serie dalla loro volontà. Queste ragioni cittadinanza di uno dei coniugi, il infine, se gli sposi erano alieni loro paterfamilias. a) Il divorzio per volontà del marito Il divorzio era una causa di scioglimento dovuto al venir meno della volontà, di uno dei coniugi ovvero del paterfamilias di uno di questi; va precisato che in età arcaica la possibilità di divorziare era concessa solo al marito, che poteva chiederlo liberamente solo in alcuni casi espressamente previsti, e cioè, l’avvelenamento della prole (aborto volontario), la sottrazione delle chiavi (della cantina=vino) e l’adulterio; in caso mancasse un valido motivo, metà del patrimonio andava alla moglie e l’altra metà consacrata a Cerere. Le XII indicavano che il marito pronunziasse una frase, tua res tibi abeto (prenditi le tue cose); questa frase invitava la moglie a prendersi i propri oggetti personali. Questa formula non aveva effetti sulla manus, in quanto l’unico divorzio che produceva la sua estinzione era quello che scioglieva le nozze confarreate. b) Il divorzio per volontà del paterfamilias Anche il venir meno del consenso dei genitori portava allo scioglimento del matrimonio. 7. Rapporti patrimoniali fra coniugi In entrambi i casi di matrimonio, cum manu o sine manu, di norma si accompagnava lo spostamento di una certa quantità di beni, che il paterfamilias della donna trasferiva al marito, o al paterfamilias di questi; questi beni erano detti dote (dos), e contribuivano ad onera matrimonii ferenda, ossia a sostenere i pesi economici del matrimonio; nell’ipotesi di un matrimonio cum manu di una donna sui iuris, tutto il suo patrimonio passava al marito a titolo di dote. Questa dote andava restituita al momento dello scioglimento del matrimonio e per tutelare le donne da abbandoni ingiustificati si richiese che il marito facesse una solenne promessa al momento del matrimonio, con la quale si impegnava a restituire la dote in caso di divorzio ingiustificato; la dote serviva anche a garantire la sopravvivenza della donna divorziata, e venne chiamata res uxoria, le promessa cautio rei uxoriae. 8. Il concubinato Là dove esiste il matrimonio esiste anche il concubinato, che altro non è che un’unione tra un uomo e una donna, che non può essere riconosciuta come matrimonio o per mancanza dei requisiti di capacità o perché non è stato formalizzato come matrimonio attraverso la celebrazione di un rito nuziale; a volte non solo è tollerato, ma anche considerato un matrimonio di seconda classe. A Roma il concubinaggio e la posizione della concubina variò sensibilmente nel tempo; nell’età arcaica, il concubinato non era colpito da una particolare riprovazione e l’unica sanzione a carico della concubina era legata a una regola di carattere religioso, che le faceva divieto di accostarsi all’altare di Giunone (protettrice del matrimonio). B.Dalla metà del secolo III a.C. alla metà del secolo III d.C. 1. Il matrimonio a) Struttura giuridica A partire dal secolo II a.C. il matrimonio cum manu cadde in disuso; cadde in disuso oltre alla confarreatio, anche la coemptio e il matrimonio si contraeva sempre più spesso senza alcuna formalità costitutiva; l’inizio della convivenza non avveniva informalmente, ma continuava ad essere accompagnata da cerimonie solenni. Il costume prevedeva che, dopo che erano stati presi gli auspicii e che erano stati compiuti i sacrifici, nella casa della sposa venisse offerto un banchetto; la sposa veniva accompagnata in processione nella casa del marito (in domo deductio); giunta nella futura casa, la sposa ne varcava la soglia sulle braccia del marito e offriva agli dèi acqua e fuoco. Nessuna di queste celebrazioni aveva valore costitutivo, ma solo solennità sociali che consentivano di distinguere un matrimonio da un concubinato o in caso di contestazione della legittimità dei figli nati dall’unione; avevano dunque valore probatorio ma non costitutivo dell’unione. Altre prove dell’esistenza del matrimonio erano il fatto che la donna accompagnasse il marito in determinate occasioni dove solo le moglie erano ammesse. Il matrimonio esisteva quando due persone dotate di conubium, stabilivano una convivenza accompagnata dalla maritalis affectio, ossia l’intenzione di essere marito e moglie. b) Il problema del consenso Il matrimonio era ormai libero, nel senso che non richiedeva forme costitutive, ma era bastante la convivenza di due persone dotate di conubium accompagnata dalla affectio maritalis. Se gli sposi erano alieni iuris, era necessario la volontà dei loro paterfamilias, che iniziava a manifestarsi dalla sponsalia con la manifestazione della volontà. Se un filiusfamilias è obbligato dal padre a sposarsi il suo matrimonio è valido; il consenso filiale era previsto, ma era un consenso passivo, che non necessariamente comportava il desiderio di sposarsi o di sposare quella determinata persona. L’intenzione di considerare matrimonio la propria convivenza con persona di altro sesso nulla aveva a che fare con il rapporto affettivo con il coniuge; il matrimonio era liberamente scelto dai coniugi e basato esclusivamente sul solo consenso solo nel caso che questi fossero entrambi sui iuris. Amore e matrimonio A Roma amore e matrimonio erano due cose distinte; i romani infatti si sposavano per convenienza sociale o per dovere civico e il celibato era diffuso e celebre risulta un discorso del 131 a.C. del censore Metello Macedonico: “Se noi, o Quiriti, potessimo vivere senza mogli, nessuno di noi, certamente, accetterebbe le noie del matrimonio. Ma poiché la natura ha voluto da un canto che non si possa vivere con le mogli senza avere delle noie, e dall’altro che non si possa vivere senza di loro, è necessario preoccuparsi della tranquillità perpetua, invece che del piacere di breve durata”. L’unico argomento, quindi, che poteva convincere gli uomini a sposarsi era la necessità dello Stato. 2. La condizione femminile a) La posizione successoria e il ius honorarium La posizione successoria delle donne con il passare del tempo era migliorata grazie agli interventi dei pretori, che avevano modificato le regole del ius civile, dando vita ad una successione ereditaria detta bonorum possessio; avevano inoltre ammesso alla successione ab intestato una serie di persone che non avevano diritto di parteciparvi iure civili; questo aveva fatto si che le donne in manu si trovassero a poter ereditare contemporaneamente da due famiglie; si era ammesso, inoltre, che la moglie anche non in manu potesse succedere al marito. Nel nuovo regime matrimoniale la moglie, rimanendo nella famiglia di origine, diventava indipendente assai prima di quanto accadeva nel vecchio regime, in cui diventava sui iuris solo al momento della morte del marito. Se appartenevano a una famiglia agiata, le donne entravano in possesso di un loro patrimonio personale in età relativamente giovane; alle ricchezze ereditate dal padre, inoltre, aggiungevano quelle che potevano ereditare da altri parenti, oltre che dal marito; se poi aggiungiamo le continue guerre, con perdita di popolazione maschile, risulta chiaro che molti patrimoni finissero in mani femminili. Alla donna inoltre in materia di tutela era stata riconosciuta una capacità maggiore di prima e questo aveva reso molte donne indipendenti. b) La ricchezza femminile: la lex Oppia e la lex Voconia Questa ricchezza femminile iniziò ad essere contrastata, in particolare con la lex Oppia, del 215 a.C., che stabiliva che nessuna donna potesse avere più di mezza oncia d’ora; lo stile di vita di molte donne a Roma destava preoccupazioni e anche riprovazione negli uomini; quando nel 195 i tribuni della plebe Marco Fundanio e Lucio Valerio proposero l’abrogazione della lex Oppia, si oppose loro Catone sostenendo che la parità fosse una cosa inaudita. Comunque nel 169 a.C. si approvò la lex Voconia, anch’essa mirante a limitare questa situazione, che stabiliva che nessuna donna appartenente alla prima classe del censo potesse essere istituita come erede (patrimonio superiore ai 200.000 assi); la giurisprudenza stabilì che le sole adgnatae ammesse alla successione fossero quelle entro il secondo grado, cioè le sorelle. 3. La crisi del matrimonio Sul finire della Repubblica gli uomini erano spesso lontani,in guerra, in esilio, per ragioni politiche, o nelle province per governare; le mogli di norma restavano a Roma per gestire il patrimonio, per intrattenere i rapporti sociali e politici necessari, ma questa assenza era fonte di libertà per loro. Aggiungendo anche la crisi demografica, si cercò di incolpare di questa situazione le donne che desideravano essere più emancipate; ma al di là delle responsabilità, è certo che la famiglia era in crisi. a) La legislazione augustea sul matrimonio Augusto tentò di risolvere la crisi con interventi normativi, la lex Iulia de maritandis ordini bus, la lex Iulia de adulteriis e la lex Papia Poppea. La prima e la terza stabilirono che tutti gli uomini tra i 25 e i 60 anni e le donne tra i 20 e i 50 anni dovessero contrarre matrimonio; chi non lo faceva era considerato caelebs e come tale punito con la perdita di alcune capacità patrimoniali, ossia quella di ricevere eredità e legati. La legge stabilì inoltre che coloro che erano sposati ma senza figli (orbi) potessero ricevere per testamento solo la metà di quanto era stato loro destinato. Venne poi concessa l’esenzione della tutela iure libero rum (per diritto di figli) alle donne che avessero partorito tre figli, se nate libere, o quattro se liberte. b) La legislazione augustea sull’adulterio L’adulterio, con la lex Iulia de adulteriis, venne inteso come crimen e comprendeva tutte le relazioni extramatrimoniali intrattenute da una donna (eccezion fatta per il concubinato o se la donna era prostituta); la lex mirava a moralizzare verso i reati sessuali. Questi reati da reati puniti in forma privata, divenendo crimen, erano passati a reato pubblico, giudicato da un apposito tribunale (quaestio de adulteriis) e perseguibile su iniziativa non solo del marito o dei familiari interessati, ma di qualunque cittadino prendesse l’iniziativa di denunciare l’adultera. Il marito e il padre della donna avevano 60 giorni per denunciarla, intentando una accusatio adulterii; il marito che non lo facesse e che non ripudiasse la moglie poteva essere denunciato per lenocinio; scaduto il termine dei 60 giorni il diritto di accusa passava agli estranei, che potevano esercitarlo nel termine di 4 mesi; la pena era la relegatio insulam, sia per la donna che per il complice, accompagnata da pesanti sanzioni patrimoniali. In caso di flagranza all’interno delle mura domestiche la legge aveva stabilito che il madre e il marito potessero continuare a esercitare il ius occidendi solo in alcune circostanze. Il padre poteva uccidere la figlia e il complice, solo se li sorprendeva in casa sua o del genero e solo se li uccideva contemporaneamente; se avesse ucciso solo il complice, sarebbe stato accusato di omicidio. Il marito invece non poteva più uccidere la moglie adultera, ma solo il complice, a patto di sorprenderli in flagranza nelle mura domestiche e solo se questi appartenesse ad alcune categorie sociali meno nobili, come gli schiavi e i liberti o un infamis. 4. Inefficacia delle leggi augustee Le leggi augustee non produssero gli effetti desiderati; nel 42­43 d.C. la società viene descritta da Seneca come irrimediabilmente depravata e tra le prove di questa depravazione vi è l’abitudine delle donne di ricorrere a pratiche abortive. Giovenale sostiene che la lussuria è vizio di tutte, schiave e padrone. La lex Iulia sembra non venisse applicata, in quanto l’adulterio era una faccenda privata troppo radicata perché i romani accettassero un’intrusione dello Stato nelle loro questioni familiari; non accettavano che lo Stato stabilisse le regole della loro vita privata. 5. La nascita della nuova morale di coppia: regime politico e vita privata La soluzione della crisi della famiglia fu la conseguenza dei profondi mutamenti sociali e psicologici legati al cambiamento di regime politico; con il passaggio dalla repubblica al principato, il paterfamilias si trovò a essere nella società e nei confronti dell’autorità imperiale semplicemente uno dei tanti sudditi­funzionari; ora la sua immagine doveva essere quella del marito fedele, rispettoso, che non considerava la moglie una cosa di sua proprietà; ella doveva essere, ora, una compagna, un sostegno, una persona da rispettare e con la quale presentarsi in società. Alla fine del II secolo d.C. si era affermata, nel mondo pagano, una morale di coppia, simile a quella cristiana, grazie a due fattori, il primo è il passaggio da un’aristocrazia concorrenziale ad un’aristocrazia di servizio e il secondo è l’autorepressione reattiva dei plebei. 6. Etica matrimoniale e classi sociali La morale di coppia, nata tra le classi alte, non rimase però un fatto limitato ai più ricchi e potente, ma si diffuse anche tra i plebei; le classi più basse avrebbero visto nell’autorepressione, capace di rendere il loro comportamento simile a quello dei potenti, lo strumento del loro riscatto morale e sociale. Dimostrandosi capaci di autodeterminarsi essi confermavano il loro status di cittadini e di essere liberi. a) Regime politico, filosofia ed etica sessuale A rafforzare la nuova etica sessuale contribuì un altro non trascurabile fattore; tra i secoli I­II d.C. il sesso era visto come un serio pericolo per la salute; i medici dell’epoca venivano interpellati dai pazienti che accusavano sintomi preoccupanti, quali un affaticamento continuo, uno stato generale di disagio, un imprecisato malessere; le cause erano legate al cambiamento dello stile di vita dovuto al nuovo corso politico, in quanto la vita del funzionario era stressante, malsana. Inoltre i nobili romani erano abituati a vivere all’aria aperta, a prendersi cura della propria persona, cosa che ora veniva limitata tantissimo. I medici tentavano di risolvere questo problema consigliando di ridurre gli eccessi sessuali, diciamo che era la nuova regola sanitaria. L’aspirazione alla continenza, non nacque con il cristianesimo, ma era già presente nella società pagana. Nel secolo I, Musonio Rufo, insegnava che il sesso era riprovevole anche nel matrimonio, se non finalizzato alla riproduzione. La contrapposizione tra corpo e spirito, tra impulsi e ragione, non fu un’idea cristiana, ma era già presente nella società pagana, ed era regola di vita. 7. Lo scioglimento del matrimonio Il matrimonio poteva essere sciolto per volontà dei coniugi o per ragioni indipendenti dalla loro volontà. a) Scioglimento per volontà dei coniugi Data la nuova struttura del matrimonio, perché esso venisse sciolto, bastava che, venuta meno l’intenzione di essere marito e moglie, i coniugi cessassero di convivere. La libertà di divorzio, era ormai totale. Per gli uomini, sia dal punto di vista formale che sostanziale, mentre per le donne, con maggiori difficoltà concrete e con molti condizionamenti sociali ed economici. b) Scioglimento per ragioni diverse dalla volontà dei coniugi Le ragioni diverse dalla volontà dei coniugi che potevano portare allo scioglimento del matrimonio erano legate da un canto alla volontà del paterfamilias e dall’altro dal verificarsi di circostanze che portavano al venir meno del conubium. Volontà del paterfamilias Il venir meno di questa volontà continuava a portare allo scioglimento del matrimonio; con il passare del tempo lo sgretolarsi della patria potestas e la nuova concezione dei rapporti familiari fece sì che l’esercizio di questo diritto cominciasse a essere visto come un sopruso. L’idea che il matrimonio potesse essere sciolto dalla volontà di un terzo veniva considerata sempre più inaccettabile. Nella prassi giudiziaria, però, la volontà dei coniugi se in contrasto con quella paterna aveva la prevalenza su questa. A partire dall’età degli Antonini la volontà paterna cessò di essere una delle possibili cause di scioglimento del matrimonio. Venir meno del conubium Posto che uno dei requisiti per la validità del matrimonio era l’esistenza del conubium, se questa capacità veniva meno il matrimonio era sciolto; ciò avveniva in varie circostanze: se uno dei coniugi perdeva lo status libertatis (capitis deminutio maxima); questo si verificava come conseguenza della prigionia di guerra, oppure la servitus poenae, cioè la perdita della libertà a seguito di condanna penale; se uno dei coniugi perdeva la cittadinanza romana (capitis deminutio media), a meno che non avesse acquistato la cittadinanza in una comunità cui era stato concesso il conubium. C.Dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano Valorizzando il consenso dei coniugi come essenziale alla costituzione del vincolo, il cristianesimo si era incontrato con la tendenza interna al mondo pagano a limitare l’invadenza della patria potestas. Anche se i romani ritenevano che fosse loro dovere impegnarsi nel matrimonio, indipendentemente dalla loro religione, se erano pagani non potevano accettare l’idea che il consenso inizialmente dato fosse irrevocabile, come voleva la dottrina cristiana; una simile concezione era profondamente in contrasto con un principio di libertà al quale erano da troppo tempo e troppo profondamente legati. La politica legislativa imperiale tentò di affermare i principi cristiani senza contrastare troppo clamorosamente la mentalità romana. 1. Scioglimento del matrimonio In questo periodo una serie di disposizioni materia di scioglimento del matrimonio. stabilì nuove regole in a) Il divorzio Il tentativo di limitare il numero dei divorzi venne fatto in due direzioni; da un canto gli imperatori fecero del divorzio un atto formale, dapprima statuendo la necessità che chi intendeva divorziare inviasse al coniuge un libellus repudii e quindi, con Giustiniano, richiedendo la presenza di sette testimoni; dall’altro stabilendo una serie di circostanze in presenza delle quali il divorzio era sottoposto a delle penalità. I divorzi vennero così classificati: Ex iusta causa erano i divorzi che avevano luogo per iniziativa di uno solo dei coniugi, in casi tassativamente previsti dalla legge; i comportamenti considerati colpa erano diversi da maschio a femmina. Era colpa del marito l’aver tentato di prostituire la moglie, o il tenere notoriamente una concubina; colpa della moglie erano comportamenti come l’essersi recata ai banchetti o ai bagni senza il consenso del marito. La sanzione per l’adulterio era la reclusione della moglie adultera in convento; qualora queste circostanze mancassero, il ripudiante era sanzionato sia pecuniariamente con la perdita della dote e della donatio propter nuptias, sia con la statuizione della sua incapacità di contrarre un nuovo matrimonio prima di un certo lasso di tempo. Sine ulla causa erano i divorzi per iniziativa di una sola parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, e come i precedenti erano variamente puniti. Communi consensu erano i divorzi decisi concordemente dalle parti, senza giusto motivo; ma le sanzioni stabilite nel 542 a carico di divorziava communi consensu furono accolte con tale disfavore che di lì a pochi anni l’imperatore Giustino, successore di Giustiniano, si vide costretto a revocarle. b) Lo scioglimento per ragioni diverse dalla volontà dei coniugi A partire dal secolo III gli imperatori intervennero per eliminare un’antica causa di scioglimento per ragioni diverse dalla volontà dei coniugi, la perdita dello status libertatis e dello status civitatis. Con Giustiniano, pur confermando che la captivitas non consentiva il permanere del vincolo, Giustiniano cercò infatti di impedire che essa producesse immediatamente i suoi effetti, stabilendo che i matrimoni rimanessero in vita, e che il coniuge rimasto libero non potesse contrarre un nuovo matrimonio fino a che non si avesse avuto notizia certa della morte del captivus, ovvero per un periodo di cinque anni. Chi non rispettava questa regola veniva sottoposto a sanzioni pecuniarie, mentre per chi avesse rispettato, il matrimonio veniva sciolto bona gratia. Nel diritto giustinianeo si stabilì che i condannati ai lavori forzati (ad metalla) mantenessero lo status libertatis. Per quanto riguarda la cittadinanza, invece, la deportatio non scioglieva più il matrimonio. Sempre con riferimento alla perdita del conubium, venne regolato anche il caso dell’incestum superveniens, che si verificava se tra il marito e la moglie, successivamente al matrimonio, veniva a instaurarsi un rapporto di parentela; l’espediente fu ad esempio quello del suocero che emancipava il figlio prima di adottare la nuora. 2. L’adulterio Divenuto crimine con la lex Iulia, l’adulterio in età classica era stato punito con la relegatio in insulam dei colpevoli; quando la concezione cristiana di peccato venne tradotta dagli imperatori, la sanzione penale divenne, formalmente, di eccezionale crudeltà. Nel 339 si sostituì la relegatio in insulam con la pena di morte, eseguita bruciando al rogo gli adulteri o sottoponendoli alla poena cullei. Antonino Pio, pur tenendo fermo il principio che l’uccisione della moglie non era legittima, stabilì che il marito omicida venisse punito con una pena più lieve di quella prevista per questo reato. Marco Aurelio e Commodo confermarono questa disposizione e stabilirono che il marito che avesse ucciso il complice della moglie in assenza delle condizioni di tempo, luogo, e di persona previste dalla lex Iulia come requisito della sua impunità venisse a sua volta sottoposto a una pena più lieve di quella prevista per l’omicidio. Alessandro Severo stabilì che questa dovesse essere l’esilio. La lex Burgundionum, concesse al marito l’impunità sia per l’uccisione della moglie che del complice, mentre nella lex Wisogothorum il marito poteva uccidere la moglie se la scopriva in flagrante nelle mura domestiche. La violazione della fedeltà coniugale continuava a essere punita solo qualora a violarla fosse la moglie; il complice della moglie veniva punito per aver leso il diritto di un altro cittadino all’esclusività sessuale sulla propria moglie. Qualora un uomo sposato avesse rapporti sessuali con un’altra donna che non era tenuta alla fedeltà coniugale (prostituta o schiava), nei suoi confronti continuava a non essere prevista alcuna sanzione. Nonostante la predicazione cristiana, gli imperatori cristiani, nell’aggravare le pene per l’adulterio, continuarono dunque ad adeguarsi ai criteri della vecchia morale. Tutto quello che rischiava un marito, tradendo la moglie, era la perdita delle dilazioni di restituzione della dote e alcuni vantaggi patrimoniali legati al matrimonio. Nel 556 Giustiniano stabilì che all’adultera fosse evitata la morte, ma la pena consisteva nel chiuderla in un monastero, dal quale poteva uscire solo se il marito la perdonava entro due anni; se il perdono non arrivava o se il marito moriva prima della scadenza, ella era condannata alla reclusione per il resto della vita; l’adulterio fu il primo reato con una sanzione paragonabile all’ergastolo. Giustiniano ristabilì il principio che al marito poteva essere concessa l’impunità solo per l’uccisione del complice della moglie, e non anche per l’uccisione di questa; l’uccisione del complice richiedeva il rispetto di norme precise: il marito, venuto a sapere della relazione, doveva inviare all’amante della moglie tre successive diffide scritte, firmate da testimoni fededegni; solo dopo aver adempiuto a questa formalità, poteva ucciderlo impunemente, a condizione che lo avesse sorpreso in flagrante in casa propria, in casa della moglie, in una taberna o in una casa dei sobborghi. a) L’ironia dei dottori Questa regola giustinianea, trovò scarso riscontro, e nel De meleficiis dell’Aretino, viene ampiamente ridicolizzata. 3. L’omicidio per causa d’onore: dalla lex Iulia al Codice Rocco Al di là del ridicolo suscitato dalla richiesta delle tre diffide, la critica dei dottori alle disposizioni giustinianee non era infondata; la formalità burocratica delle tre diffide, mal si conciliava con quella che, quantomeno nella lex Iulia, avrebbe dovuto essere la ragione per cui, del tutto eccezionalmente, un omicidio non veniva punito, cioè lo stato d’ira, il moto incontrollabile dell’animo nel momento in cui il marito scopriva l’infedeltà della moglie. Dopo le tre diffide, la sorpresa non era certo più tale; quello che ora giustificava il suo gesto era qualcosa d’altro, la necessità di difendere il suo onore. Non è difficile cogliere la mentalità che porterà alla formulazione di un concetto giuridico nuovo e alla nascita di una figura di reato che è restata nei nostri codici fino al 1981, il c.d. delitto d’onore, normato all’art. 587 del Codice Rocco. 7. Atti e fatti giuridici. Il negozio giuridico 1. Gli atti e i fatti giuridici Le situazioni di vantaggio e di svantaggio nascono quando si comincia a ritenere che alcuni fatti o atti producano determinate conseguenze; i fatti e gli atti produttivi di queste conseguenze vengono chiamati fatti e atti giuridici. I fatti giuridici (factum) sono accadimenti naturali, che l’ordinamento prende in considerazione perché ritenuti produttivi di determinati effetti giuridici. Gli atti giuridici (actum) sono comportamenti umani consapevoli, produttivi di effetti giuridici; sono atti sia le azioni che le omissioni. Esempi di fatti giuridici sono la nascita, la morte e il decorso del tempo. La nascita è il presupposto di tipo naturalistico che determina il sorgere in capo al padre del potere sul figlio (patria potestas), ma per sorgere il diritto occorre che il figlio sia nato da iustum matrimonium e questo non è un fatto, ma un atto. La morte è un fatto che attribuisce ai discendenti immediati del pater defunto la condizione di sui iuris e la successione nel patrimonio paterno; se il padre avesse fatto testamento, al fatto della morte si aggiunge l’atto del testamento. Il decorso del tempo può determinare il sorgere o l’estinguersi di diritti, capacità o poteri personali. Ad esempio, il trascorrere di un anno era il tempo necessario perché il marito o il paterfamilias di questi acquistasse la manus sulla nupta in forza dell’usus; al compimento del 12° e 14° anno donne e uomini raggiungevano la pubertà, acquistando la capacità di agire. 2. Il negozio giuridico Gli atti giuridici vengono chiamati “negozi giuridici”, che sono al tempo stesso manifestazione di volontà e atto di autonomia privata, con cui uno o più soggetti pongono in essere un’attività che l’ordinamento riconosce idonea a determinare la nascita, la modificazione o l’estinzione di situazioni giuridiche; i negozi giuridici esistevano già nel mondo romano. 3. La giurisprudenza romana e i negozi I giuristi romani non elaborarono mai la categoria generale del negozio, in quanto esso ha un significato diverso e deriva da nec e otium, ossia negazione dell’ozio; visto che l’ozio per i romani non era un vizio ma il tempo da dedicare allo spirito e a se stessi, ne deriva che negozio significa “attività” e dunque qualcosa cui una parte della popolazione era costretta a dedicarsi per poter sopravvivere. In età classica, i romani presero in considerazione gli atti che oggi definiamo con questo termine, individuandoli come una specifica categoria all’interno degli atti giuridici. 4. Classificazione dei negozi giuridici Una prima distinzione viene effettuata in relazione soggettiva, cioè in base al numero delle parti coinvolte: alla struttura • negozio unilaterale, con manifestazione parte, ad esempio il testamento; • negozio bilaterale, con negozio concluso tra due parti, il cui esempio tipico è il contratto (1321 c.c.); • negozio plurilaterale, quando si hanno più parti che manifestano la loro volontà, ad esempio il contratto di società. di volontà di una sola Parte non va confusa con persona, e deve intendersi come centro di interessi; può accadere che una parte sia formata di più persone portatrici di interessi identici. In relazione alla loro funzione tipica (o causa) i negozi si distinguono in: • mortis causa, finalizzati a produrre dichiarante, come il testamento; • inter vivos, più numerosi, prevedono un risultato da realizzarsi durante la vita della parte o delle parti. effetti Sempre in relazione alla funzione si distinguono in: dopo la morte del • negozi a titolo oneroso, sempre almeno bilaterali, si hanno quanto una parte, per acquisire un diritto, un vantaggio o un beneficio accetta un correlativo sacrificio, come ad esempio la compravendita (emptio­venditio); • negozi a titolo gratuito, dove una parte consegue un vantaggio senza alcun corrispettivo, esempio il comodato. In relazione agli effetti avremo negozi: • a effetti reali, idonei a trasferire la proprietà e a costituire o estinguere diritti reali minori (servitù e usufrutto); per questi negozi la tutela è un’actio in rem; • a effetti obbligatori, idonei a costituire o estinguere obbligazioni; la tutela per questi negozi è un’actio in personam. I negozi si distinguono anche in causali o astratti in relazione al concetto di causa, oppure in formali e non formali in relazione alla forma. 5. Presupposti del negozio Perché un negozio sia valido sono necessari capacità di agire e la legittimazione. alcuni presupposti, la a) La capacità di agire La capacità di agire spettava agli adulti maschi sani di mente; i minori, le donne, i pazzi e i prodighi dovevano essere assistiti. b) La legittimazione La legittimazione a compiere un negozio spettava ai titolari degli interessi da esso regolati; nel diritto romano, di norma, non si poteva dare ad altri il potere di concludere un negozio giuridico al proprio posto, mentre si poteva conferire ad altri il potere di concludere negozi per proprio conto. La rappresentanza Vi è la distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta; nel primo caso gli effetti di quanto compiuto dal rappresentante si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato; in quella indiretta, il rappresentante diviene personalmente titolare di rapporti che, in forza di un rapporto interno, sarà successivamente tenuto a trasferire al rappresentato. Il diritto romano, anche se contrario, l’ammise in alcuni casi. Accadeva quando, ad esempio, si preponeva un soggetto alla gestione di tutto il patrimonio (procurator omnium bonorum) o si concludeva con lui un contratto di mandato (mandatum), che conferiva questo potere con riferimento a singoli negozi. Altre figure di rappresentanti erano il tutor impuberis, il curator prodigi o furiosi, il curator adulescentis (minori di 25 anni). Vi era inoltre il potere di concludere negozi per proprio conto da parte del paterfamilias che conferiva ad un servus o un filius la gestione di attività commerciali, terrestri o marittime; pur non avendo la capacità giuridica, queste persone avevano la capacità di agire e dunque l’ordinamento riconosceva la validità dei negozi da loro compiuti. Quanto agli effetti dei negozi compiuti la situazione era diversa a seconda che si trattasse di acquisto di diritto o assunzione di obblighi. Nel primo caso, la titolarità di questi spettava automaticamente al loro avente potestà; l’acquisto si produceva indipendentemente dal fatto che l’avente potestà volesse la conclusione del negozio, o ne fosse a conoscenza; l’autorizzazione paterna (iussum) era richiesta solo per l’acquisto di un’eredità o del possesso. Se dal negozio, invece, nascevano obbligazioni, il paterfamilias non veniva da esse vincolato; secondo il ius civile i sottoposti al pater non potevano peggiorare la sua situazione patrimoniale; il pretore, invece, fece si che il pater ne rispondesse, con la concessione delle adiecticiae qualitatis. L’idoneità dell’oggetto Perché il negozio sia valido, il bene o l’interesse oggetto del negozio deve avere taluni requisiti, ossia esistere in natura, essere suscettibile di ricevere il regolamento di interessi predisposto con il negozio. Deve trattarsi, quindi, di un bene in commercio, essere cioè suscettibile di rapporti di scambio ed economicamente valutabile; non sono scambiabili le res divini iuris, beni destinati al culto, le res comune omnium, beni che per loro natura sono di tutti, e le res publicae che sono di proprietà dello stato e destinate all’uso pubblico. L’oggetto deve essere infine determinato o determinabile mediante criteri che le parti hanno convenzionalmente stabilito. 6. Elementi essenziali Gli elementi essenziali, o costitutivi, si distinguono in generali o speciali a seconda che si riferiscano ad ogni tipo di negozio o siano necessari solo per alcuni negozi; sono elementi essenziali la manifestazione di volontà, la causa e il contenuto. a) La manifestazione o dichiarazione di volontà Poiché il negozio giuridico viene definito come manifestazione di volontà diretta a raggiungere determinati fini che l’ordinamento riconosce come leciti e quindi tutela, ne deriva che elemento centrale è proprio la volontà, che può essere espressa a parole ovvero in qualunque altro modo idoneo a comunicarla. Per buona parte del periodo classico si tendeva a ritenere che nei negozi formali la mancata corrispondenza tra volontà e manifestazione non dovesse pregiudicare che aveva fatto affidamento sull’esteriorità della manifestazione. Il problema della coerenza tra la volontà e la manifestazione di questa cominciò a porsi con riferimento ai negozi informali e in quelli del ius gentium. Secondo Celso, anche se il pensiero di chi parla è più importante e più forte della sua voce, tuttavia non si può ritenere che uno abbia detto qualcosa senza voce. Paolo sosteneva che, colui che dice una cosa diversa da quella che vuole, non dice né quel che la voce ha espresso, perché non lo vuole, né quel che vuole, perché non lo ha detto. Vi era differenza tra manifestazione di volontà e dichiarazione di volontà, in quanto la dichiarazione era solo uno degli aspetti esteriori che la manifestazione di volontà poteva assumere; quest’ultima poteva infatti consistere in un comportamento da cui si deduceva chiaramente la volontà del soggetto. La manifestazione di volontà può consistere anche in una dichiarazione (manifestazione espressa). Anche il silenzio valeva come manifestazione di volontà, ma solo eccezionalmente, come nel caso dell’alienante che di fronte alla dichiarazione dell’acquirente di essere proprietario taceva. La dichiarazione di volontà poteva essere recettizia o non recettizia; la prima era quando la sua efficacia era subordinata al fatto che il destinatario ne venisse a conoscenza, non lo era in caso contrario. Interpretazione della volontà negoziale Il problema della coerenza tra la volontà e la sua manifestazione cominciò a porsi con riferimento ai negozi informali e a quelli del ius gentium; una volta entrata in uso per questi negozi, l’indagine sulla corrispondenza tra volontà e manifestazione si estese anche ad altri negozi. Prima non vi era spazio per la ricerca di una volontà negoziale diversa da quella che la formula esprimeva; si aveva quindi esclusivamente riguardo al valore tipico della dichiarazione e non alla volontà soggettiva eventualmente diversa. Veniva in genere preferito un significato che salvasse l’asso rispetto a uno che ne avrebbe comportato la nullità, soprattutto in materia testamentaria. Altri criteri di interpretazione della volontà negoziale erano quelli che facevano riferimento alla buona fede e all’equità. Vi erano poi criteri specifici di alcuni negozi, così in materia di manomissioni prevaleva l’interpretazione che comportava l’acquisto della libertà. b) La causa La causa di un negozio è la funziona sociale obiettiva, ovvero lo scopo pratico tipico di quel negozio, l’obiettivo ultimo e determinante di esso; essa è da tenere distinta dai motivi, che molto spesso non vengono estrinsecati dalle parti e generalmente sono irrilevanti per l’ordinamento. L’unico caso in cui rilevano è l’ipotesi in cui questi siano illeciti e comuni alle parti e in questo caso la causa è nulla e ciò comporta la nullità dell’intero negozio (se compro un oggetto la causa è lo scambiare bene con denaro). Nel diritto romano il sistema negoziale era tipico, cioè l’ordinamento ricollegava effetti giuridici solo a determinati negozi specificamente previsti; l’individuazione di questi negozi avveniva attraverso la specificazione della forma o della causa. Con riferimento, appunto, alla causa i negozi sono causali o astratti; nel primo caso la causa influisce sulla struttura stessa del negozio ed essi sono destinati ad avere effetti rispondenti a una funzione sociale ed economica riconosciuta dall’ordinamento; nel secondo caso la causa, pur presente, non emerge dalla struttura del negozio e può variare secondo le circostanze. Tipico caso di negozio astratto era la mancipatio, che trasferiva la proprietà di un bene a prescindere dalla causa per cui ciò avveniva. c) Il contenuto La particolarità del negozio giuridico, rispetto agli altri atti leciti, sta nel fatto che esso contiene un regolamento di interessi che l’ordinamento riconosce come valido e a cui pertanto collega gli effetti voluti dalle parti; questo regolamento di interessi è il contenuto del negozio giuridico e si concretizza nelle prestazioni cui le parti si obbligano. Per oggetto si intende il bene materiale di cui attraverso il negozio si dispone o più in generale gli interessi che con il negozio giuridico vengono regolati. 7. Elementi essenziali speciali a) La forma In alcuni negozi (quelli formali) la manifestazione di volontà deve rivestire una determinata forma; quando è prescritto l’uso di una forma determinata perché il negozio sia efficace, si parla di forma costitutiva o ad substantiam; nei casi in cui la forma è prescritta solo per svolgere una funzione probatoria, si parla di forma ad probationem. Nel diritto romani i negozi erano in gran parte formali; l’antico ius civile conosceva solo forme costitutive tipiche, costitutive perché necessarie per l’esistenza e la validità dell’atto, tipiche perché a determinati tipi di negozi corrispondeva una determinata forma a quelli soli applicabile. Accanto alle forme tipiche si diffonde una forma generica, suscettibile di essere applicata a diversi negozi giuridici, la scrittura; questa forma, tranne nel caso del nomen transcripticium, non ha carattere costitutivo ma meramente probatorio. 8. Elementi accidentali Con l’espressione elementi accidentali del negozio giuridico si indicano delle clausole che non sono essenziali alla sua esistenza ma che, se vengono inserite per decisione delle parti, hanno influenza sulla sua efficacia. Queste clausole sono condizione, temine e modo. a) La condizione (condicio) La condizione è una clausola negoziale con la quale le parti subordinano l’efficacia del negozio giuridico al verificarsi di un evento futuro e obiettivamente incerto; se dipende dal verificarsi di un evento la condizione è detta positiva, se invece dipende dal suo non verificarsi è detta negativa. Quando dall’evento futuro e incerto discende il sorgere degli effetti del negozio la condizione è detta sospensiva, mentre quando da esso discende il cessare di questi effetti la condizione è risolutiva. I romani conoscevano bene quelle sospensive. Nel diritto romano la condizione non poteva essere imposta a tutti i negozi; a causa del formalismo imposto alla dichiarazione o manifestazione della volontà, essa non poteva essere apposta ad alcuni negozi dello ius civile, detti actus legitimi. Tra questi negozi vi è la mancipatio, la in iure cessio, la confarreatio, la acceptilatio e la expensilatio. L’eventuale inserzione di una condizione in questo tipo di negozi avrebbe comportato la loro nullità. Il motivo per cui la condizione non poteva essere apposta agli actus legitimi è duplice e dipende dal tipo di atto; alcuni di essi, ad esempio la hereditatis actio, avevano effetti immediati; altri, quali la mancipatio e la in iure cessio, richiedevano la dichiarazione dell’esistenza attuale di una certa circostanza. Le condiciones iuris A volte il verificarsi degli effetti di un negozio era subordinato a un evento futuro e incerto previsto dal diritto; ad esempio l’acquisto di un legato era subordinato all’acquisto dell’eredità da parte degli eredi testamentari, e la costituzione di dote era subordinata al matrimonio; in questi casi si parlava di condicio iuris. Caratteristiche degli eventi previsti dalla condizione Perché la condizione fosse validamente apposta essa doveva avere alcune caratteristiche; in primis doveva essere obiettivamente incerta, ossia non poteva e non può essere definita condizione la clausola con cui gli effetti negoziali vengono subordinati a una circostanza di fatto presente o passata, ma ignorata da chi compie il negozio. Questo non significava però che la condizione dovesse dipendere solo dal caso; accanto alle condizioni che dipendevano solo da questo (dette causali) erano ammesse anche quelle che dipendevano parzialmente dalla volontà delle parti (chiamate dall’era postclassica ad oggi, potestative). Non era ammessa però la condizione meramente potestativa, dipendente dalla mera volontà della parte obbligata, pena la nullità del negozio. Le condizioni potevano infine dipendere sia dal caso che dalla volontà delle parti (condizioni miste). La condizione, poi, doveva essere realizzabile, l’evento non doveva essere impossibile; la mancanza di una seria volontà negoziale rendeva il negozio nullo; secondo i sabiniani, la condizione impossibile apposta a un testamento si considerava non apposta e questa regola venne poi estesa a tutti i negozi mortis causa. Infine, la condizione doveva essere lecita e non doveva essere contraria al buon costume (contra bonos mores); l’apposizione di questo tipo di condizioni rendeva nulli i negozi inter vivos e veniva considerata non apposta nei negozi mortis causa. Le condizioni sospensive Quando un negozio è sottoposto a una condizione sospensiva esso produce i suoi effetti solo se e nel momento in cui l’evento previsto come condizione si verifica (condizione positiva) o non si verifica (condizione negativa). Quando non si sapeva se l’evento si sarebbe verificato i romani dicevano che condicio pendet (la condizione pende), quando l’evento si verificava allora condicio exstat (la condizione esiste) e quando, infine, vi era la certezza che l’evento non si sarebbe verificato si diceva condicio deficit (la condizione manca). La parte non aveva un diritto, ma un’aspettativa di acquisto del diritto, una spes (speranza). Un problema particolare sorse con riferimento alle condizioni negative, di regola apposte ai negozi mortis causa, e in particolare ai legati. Tra i secoli II­I a.C., si ammise che il legato avesse subito effetti, se il legatario si impegnava con stipulatio a restituire la cosa ricevuta in legato qualora si fosse verificato l’evento previsto nella condizione; essendo stata suggerita dal giurista Mucio Scevola, questa stipulatio venne chiamata cautio Muciana. Quando la condizione si realizzava, il negozio produceva i suoi effetti, di regola a partire da quel momento; in altre parole l’efficacia del negozio non era retroattiva. Gli espedienti per produrre gli effetti della condizione risolutiva Il diritto romano non conosceva a pieno la condizione risolutiva, al cui verificarsi cessavano gli effetti del negozio. I giuristi classici elaborarono un sistema per raggiungere indirettamente gli stessi effetti; essi configurarono il negozio come puro, ma accompagnato da un patto risolutivo sottoposto a condizione sospensiva. In pendenza della condizione sospensiva questo negozio produceva i suoi effetti, ma all’avverarsi di questa si producevano gli effetti del patto risolutivo. Caso tipico è la compravendita con lex commissoria, quando il venditore si riserva di recedere dal contratto se il compratore non gli paga il prezzo. Dies cedens e dies veniens Escogitare un rimedio che agiva di fatto come una condizione risolutiva, fu quello dei legati sottoposti alla condicio iuris dell’acquisto dell’eredità da parte degli eredi testamentari. Il legato veniva acquistato al momento dell’apertura della successione (dies legati cedit); i diritti che ne nascevano tuttavia non potevano essere esercitati sino al momento dell’accettazione (dies legati venit); la mancata accettazione dell’eredità diventava una condizione risolutiva. b) Il termine Il termine è un evento futuro ma certo, dal quale, si fa decorrere l’inizio o la fine degli effetti del negozio; si distingue perciò un termine sospensivo o meglio iniziale dal quale si fanno decorrere gli effetti del negozio da un termine risolutivo o meglio finale dal quale si fanno cessare gli effetti del negozio. Il termine può essere fissato in modo del tutto certo e si parlerà di dies certuna an, certus quando (è certo sia che l’evento si realizzerà sia il momento in cui si realizzerà); al contrario può essere fissato con riferimento ad un evento certo e futuro ma non cronologicamente precisabile e si parla quindi di dies certus an, incertus quando (è certo che l’evento si verificherà, ma non si sa quando). Per quanto riguarda la disciplina del negozio in pendenza dei termini, bisogna tener presente che nel caso del dies, è certo che l’evento si verifichi; di conseguenza anche prima della scadenza del termine il rapporto è trasmissibile agli eredi sia dal lato attivo che da quello passivo. c) Il modo (modus) È una clausola, chiamata modus solo in età giustinianea, apponibile solo ai negozi di liberalità sia inter vivos che mortis causa; essa consiste in un peso o in un onere che il disponente pone a carico del beneficiario, quest’ultimo, tenuto a destinare tutto o parte del lascito a uno scopo particolare, quale per esempio erigere un monumento, o festeggiare una determinata ricorrenza, ma per il diritto classico era solo un obbligo morale e non giuridico. Si pose il problema di come costringere l’onerato ad adempiere; la giurisprudenza escogitò vari mezzi, di cui uno dei più diffusi consisteva nell’imporre al beneficiario del negozio di impegnarsi ad adempiere il modus con una cautio. Per rendere vincolante il modus, si imponeva al donatario di pagare una somma di denaro a titolo di pena se l’adempimento non fosse portato a compimento. 9. Invalidità, inesistenza e inefficacia del negozio giuridico. Principi generali E’ inefficace il negozio giuridico che per qualsiasi motivo non produce i suoi effetti tipici; l’inefficacia può essere momentanea, come nel caso di negozio sottoposto a termine iniziale, o definitiva, come nel caso di negozio nullo. Inesistente invece è l’atto negoziale che non può neppure essere considerato un negozio in quanto privo dei requisiti minimi necessari per rientrare in questa categoria. Invalido è il negozio che presenta dei vizi; dall’invalidità discendono due categorie, la nullità e l’annullabilità; la prima è un’invalidità più grave dovuta alla mancanza di un elemento costitutivo del negozio ed è considerato incapace di produrre i suoi effetti tipici e può produrre solo effetti di altro ordine. L’annullabilità è un’invalidità meno grave e si verifica quando uno degli elementi del negozio è viziato; resta comunque idoneo a produrre i suoi effetti, ma le parti possono intervenire o per impedire la loro realizzazione o al contrario per sanare i vizi e convalidare il negozio. Nel diritto romano il ius civile conosceva solo due possibilità; un negozio o era perfetto, in quanto dotato di tutti gli elementi essenziali, o era nullo perché privo di un elemento essenziale o perché contrario ad una norma dell’ordinamento. Gli eventuali vizi rilevavano nell’ambito del ius honorarium, infatti il pretore poteva paralizzare gli effetti del negozio attraverso istituti quali l’exceptio o la restitutio in integrum. La nullità corrisponderebbe all’invalidità iure civili, mentre l’annullabilità all’invalidità iure praetorio. 10. Anomalie della volontà Può accadere che manchi completamente una volontà negoziale giuridicamente apprezzabile, come nel caso di negozio posto in essere dall’impubere o dal furioso, ed in questi casi l’ordinamento romano riteneva nullo il negozio. Può accadere inoltre che la volontà negoziale sia viziata nel procedimento di formazione; è il caso dei vizi della volontà che iure civili non influivano sulla validità del negozio, ma rilevavano iure honorario. Infine, vi è il caso dell’accordo simulatorio nel quale vi è contrasto tra la dichiarazione e l’effettiva volontà dei dichiaranti; si ha un negozio simulato quando due parti di comune accordo, dichiarano di porre in essere un negozio, ma in realtà vogliono che si realizzi un negozio diverso da quello dichiarato. Si parla di negozio dissimulato, invece, quando è effettivamente voluto e risultante dall’accordo fra le parti. I giuristi romani non giunsero a formulare una teoria generale della simulazione, ma negarono valore al negozio simulato; tuttavia, si posero caso per caso il problema del negozio dissimulato, analizzando se in esso sussistessero gli elementi essenziali alla sua validità; ad esempio un negozio che dissimulava una donazione fra coniugi era nullo per illiceità della causa. 11. Cause di invalidità Le cause di invalidità possono riguardare sia i presupposti del negozio giuridico sia gli elementi costitutivi e possono comportare sia la nullità sia l’annullabilità del negozio; qualora mancasse uno dei presupposti (capacità di agire o legittimazione ad agire) il negozio era nullo iure civili; la nullità si verifica per mancanza assoluta di volontà negoziale. Se la volontà era stata viziata da inganno o violenza, gli effetti negoziali si realizzavano per il ius civile, ma si poteva chiedere al pretore l’annullamento del negozio. 12. Vizi della volontà I vizi della volontà sono errore, violenza e dolo e influiscono sul processo di formazione della volontà o sulla dichiarazione. a) L’errore Si tratta di una deviazione dal vero inconsapevole e spontanea che può dipendere da svista, incomprensione o ignoranza su una circostanza inerente il negozio. I giuristi romani si occuparono dell’errore negoziale; il problema principale consisteva nello stabilire come tutelare da un canto la volontà individuale di colui che aveva posto in essere il negozio e dall’altro il valore tipico ed oggettivo della dichiarazione; l’errore era considerato rilevante e conseguentemente il negozio inefficace quando l’errore cadeva sul tipo di negozio che le parti intendevano compiere nonché in caso di negozi in cui l’indicazione della persona aveva rilevanza particolare. Era considerato rilevante l’errore che riguardava l’oggetto del negozio, sia l’identità fisica del ben (error in corpore) sia le sue qualità essenziali (error in substantia); non era considerato rilevante l’errore che cadeva sull’esistenza o sull’interpretazione di norme giuridiche (error iuris), tranne che si trattasse di persone gravemente ignoranti, donne, minori di 25 anni e i militari. b) La violenza (METUS) Il timore generato dall’altrui violenza era definito metus; nel diritto romano la violenza fisica (vis absoluta) probabilmente comportava la nullità del negozio mancando in questi casi non solo la volontà ma anche una sua vera manifestazione. Molto numerosi i casi di ipotesi in merito alla violenza morale (metus), cui si poteva porre rimedio ricorrendo ai mezzi di tutela introdotti dal pretore, quali l’actio metus, la integrum restitutio e l’exceptio metus. Se il negozio era stato eseguito, il contraente vittima della violenza poteva agire intentando l’actio metus, che comportava una pena pari al quadruplo del pregiudizio arrecato se intentato entro l’anno oppure pari al simplum se intentata dopo l’anno; l’actio metus era azione arbitraria e poteva essere esperita sia contro l’autore della violenza sia contro terzi che avessero tratto vantaggio dalla violenza. Nel caso in cui il negozio non fosse stato ancora eseguito, colui che veniva convenuto per il suo adempimento, qualora avesse concluso un negozio per effetto di violenza, poteva opporre una exceptio metus all’azione che gli veniva intentata. Si poteva far ricorso solo qualora la minaccia fosse grave, seria e ingiusta; se il male minacciato era carente di questi requisisti, la violenza non veniva considerata rilevante. c) Il dolo Il dolo in ambito negoziale indica gli artifici e i raggiri posti in essere nel corso delle trattative per indurre una parte in errore così che questa compia un negozio per le svantaggioso; dal dolo negoziale, dolus malus, bisogna distinguere l’ipotesi in cui siano state utilizzate le usuali astuzie tollerate dal costume, considerate dolus bonus. Dal punto di vista del ius civile, in caso di dolo, il negozio era valido ed efficace, e la repressione era affidata al pretore. Per tutelare la vittima del raggiro furono introdotte un’actio de dolo e un’exceptio dolis; la prima poteva essere esperita quando il negozio era già stato eseguito, la seconda era opponibile dalla vittima dei raggiri citata in giudizio per l’adempimento. L’actio de dolo era pena e prevedeva a carico dell’autore del dolo una condanna in simplum commisurata al danno dubito dall’attore; essa comportava l’infamia del condannato, quest’ultima, concessa solo in mancanza di altri mezzi di tutela. 8. Difesa ed esercizio dei diritti A. Dalla nascita di Roma alla metà del secolo III a.C. 1. Il processo, nozioni generali Perché un soggetto possa soddisfare gli interessi che l’ordinamento gli riconosce è necessaria la cooperazione degli altri consociati. È necessario cioè, che questi riconoscano la sua situazione di vantaggio, e che si comportino di conseguenza. La comunità politica, sin dal momento della sua nascita, si assume il compito di accertare l’effettiva titolarità dei diritti e la possibilità che essi vengano esercitati dal loro titolare. L’insieme dei mezzi organizzati a questo scopo viene detto processo; se lo scopo del processo è quello di superare l’incertezza sulla esistenza o la titolarità di un diritto esso viene definito processo di cognizione; se l’obiettivo è quello di superare la resistenza opposta all’attuazione di un diritto il processo è detto di esecuzione. 2. Processo privato e processo pubblico Nel diritto romano, il tipo di processo privato volto a regolare interessi privati, l’iniziativa spettava ai titolari degli interessi; colui che prendeva questa iniziativa veniva chiamato actor (attore), colui nei cui confronti essa veniva presa era chiamato reus (convenuto). In contrapposizione al processo privato, il processo rivolto a difendere interessi di tutta la collettività veniva chiamato pubblico e a esso si faceva ricorso di fronte a comportamenti, detti crimina, che rappresentavano un pericolo per la sopravvivenza stessa della vita associata. Lo scopo del processo pubblico era quello di infliggere una poena a chi aveva violato una norma giuridica il cui rispetto era considerato necessario per il bene comune; in origine la pena era la morte. L’impulso alla celebrazione di un processo pubblico doveva provenire da un organo dello Stato. Nel nostro diritto odierno il processo privato corrisponde all’incirca al processo civile, e quello pubblico al processo penale; i romani ritenevano che alcuni illeciti penali (delicta, delitti), in quanto lesivi di interessi esclusivamente privati, fossero perseguibili a iniziativa di parte nelle forme del processo privato, la cui pena consisteva sempre in una somma di danaro per l’attore. 3. Le origini del processo: la regolamentazione precittadina dell’autodifesa Prima della nascita della civitas, la convivenza sociale era regolata da due sistemi di norme. Le prime riguardavano i rapporti interni ai diversi gruppi di tipo familiare e prevedevano la soggezione assoluta dei componenti del gruppo all’autorità del suo capo, il paterfamilias; qualora uno dei componenti del gruppo non rispettasse le regole interne, il paterfamilias esercitava nei suoi confronti un potere disciplinare che comprendeva anche il ius vitae ac necis. Il secondo sistema di regole riguardava i rapporti tra appartenenti a gruppi diversi e prevedeva che chi riteneva di avere subito un torto da persona appartenente ad altro gruppo ricorresse alla forza privata per farsi vendetta; chi si riteneva offeso era tenuto socialmente a reagire e se non lo avesse fatto, la considerazione di cui egli godeva sarebbe diminuita, così come quella del gruppo familiare cui apparteneva. Unica alternativa alla vendetta era una compensazione in beni o in danaro che consentiva all’offeso di rinunciare onorevolmente a usare la forza. L’uso della forza in funzione vendicativa venne sottoposto a un controllo sociale, teso a evitare o comunque a minimizzarne gli effetti negativi; una di queste regole fu la c.d. legge del taglione, che stabiliva che colui che ricorreva alla forza doveva infliggere all’offensore lo stesso male che questi gli aveva inflitto; nelle XII Tavole si legge “si membrum rupsit ni cum eo pacit talio esto” (se è stato rotto un membro, e le parti non siano addivenute a un accordo, si faccia luogo al taglione); da questa regola si evince che vietava la vendetta quando tra le parti si era raggiunto un accordo, con una compensazione, dapprima in beni e poi in denaro. Altre volte la collettività imponeva limiti di tipo diverso, come nel caso del fur manifestus, dove viene precisato che il ladro poteva essere ucciso solo se era di notte o se si difendeva con le armi. Inoltre chi usava la forza doveva farlo seguendo un rituale ben preciso, pronunziando parole e compiendo gesti prestabiliti, che non potevano in alcun modo essere modificati. 4. L’intervento della civitas La civitas intervenne sia sulle norme che regolavano i rapporti interni ai gruppi familiari sia su quelle interfamiliari e lo fece in modi diversi. I poteri dei patresfamilias sui sottoposti rimasero sostanzialmente immutati, ma vi furono alcune limitazioni, tra cui il divieto del padre di esporre i figli maschi e le primogenite oppure quello che limitò le ipotesi in cui il marito poteva uccidere impunemente la moglie. Diversi e assai più significativi furono gli interventi in materia di rapporti inferfamiliari; la civitas individuò i comportamenti che autorizzavano l’uso della forza e non come prima che la valutazione dei comportamenti lesivi di un interesse dipendeva esclusivamente da chi li subiva; inoltre la civitas nel ribadire la necessitò delle formule verbali e dei gesti già in uso stabilì che queste formalità venissero compiute dinanzi al magistrato cittadino (rex) e presero il nome di legis actiones. a) La teoria arbitrale Secondo una teoria, le origini del processo andrebbero ricercate nella pratica di ricorrere spontaneamente a un arbitro imparziale, accettando di sottomettersi alla sua decisione; con il passare del tempo il ricorso all’arbitrato privato sarebbe stato sempre più favorito e reso obbligatorio; contro questa teoria esistono numeri argomenti, tra i quali, la considerazione che proprio nell’epoca più antica, accanto al giudice unico, il magistrato (cioè il rex) esistevano dei collegi giudicanti stabili (i centumviri e i decemviri), che difficilmente potevano trarre le loro origini e i loro poteri da un’investitura privata. 5. Prime forme processuali: LE LEGIS ACTIONES Il diritto romano conobbe tre formule di processo, il più antico in uso sino al II secolo a.C. era quello detto per legis actiones, il secondo, nato nel tribunale del magistrato giusdicente era quello per formulas; infine il terzo nato in età classica ma affermatosi in età imperiale sino a sostituire quello formulare fu la cognitio extra ordinem. Legis actio significa “modo di agire secondo la legge”; anche se le origini sono certamente consuetudinarie la loro evoluzione fu infatti in gran parte risultato di interventi autoritativi, a partire dalle XII Tavole. Le legis actiones erano esperibili solo dai patresfamilias e solo per la tutela di rapporti previsti dal ius civile, ed erano cinque e tipiche; ciascuna di esse aveva una sua struttura formale e serviva a tutelare una determinata situazione. a) Legis actiones con funzione di cognizione Le legis actiones con funzione di cognizione era tre, la legis actio sacramento nelle due forme in rem e in personam, la legis actio per iudicis arbitrive postulationem e la legis actio per condictionem. La legis actio sacramento ACTIO GENERALIS Fu la forma più antica di processo di cognizione e a seconda del diritto che con essa s’intendeva far valere, poteva essere esperita nella forma in rem o in quella in personam. La legis actio sacramento in rem (REI VINDICATIO) Poteva essere utilizzata per far valere il diritto di proprietà nonché potestà o signorie relative a rapporti di tipo familiare o ereditario; essa serviva anche ad accertare lo stato di una persona, quando qualcuno sosteneva che si trattava di persona libera e altri invece sosteneva che era di stato servile e di sua proprietà; venne poi usata anche a tutela delle servitù prediali e dell’usufrutto. La procedura aveva inizio dopo che l’attore aveva portato in ius, davanti al rex, la persona o la cosa su cui avanzava una pretesa; in un primo momento, se questa persona o questa cosa si trovavano in possesso di altri, l’attore se ne impossessava; se nessuno contestava la pretesa dell’attore, il magistrato lo autorizzava a portare con sé la persona o la cosa. In un momento successivo, si stabilì che ambedue i contendenti dovessero essere presenti; colui che prendeva l’iniziativa di lege agere, doveva vocare in ius (chiamare in giudizio) colui nei cui confronti voleva agire; l’atto era chiamato ius vocatio (chiamata in giudizio) ed era regolato dalle XII Tavole, che imponevano al vocatus l’obbligo di seguire in ius l’attore e in caso di rifiuto, l’attore, dopo aver chiamato dei testimoni, poteva trascinarlo con la forza dinanzi al magistrato. Il vocatus poteva evitare di seguire immediatamente l’attore presentando un vindex, che garantiva che egli si sarebbe presentato in un giorno stabilito, e in mancanza ne subiva personalmente le conseguenze. Se ad esempio si contestava la proprietà di uno schiavo, l’attore davanti al magistrato (rex e poi il pretore), toccando con una bacchetta, vindicta, lo schiavo dichiarando di esserne il proprietario e pronunciando una frase solenne; se nessuno contestava questa dichiarazione il magistrato autorizzava l’attore a portarsi via lo schiavo, altrimenti il convenuto avrebbe fatto una controvindicatio, affermando con analoghi gesti e parole che lo schiavo era suo; a questo punto le parti simulavano un inizio di lotta interrotta dall’ordine del magistrato e dopo essersi chieste e date spiegazioni rituali dei loro comportamenti, le parti si sfidavano a prestare un sacramentum, un solenne giuramento in nome della divinità; in principio il sacramentum era un giudizio divino e per paura di questo giudizio chi ammetteva il falso, desisteva; con il tempo però il carattere religioso si perse e le parti depositavano un certo numero di animali, sostituiti poi dalla lex Aternia Tarpeia con una somma di denaro di 50 o 500 assi. Nel momento in cui il sacramentum veniva prestato, il magistrato assegnava il possesso interinale della cosa a colui che sembrava avere ragioni più convincenti e imponeva a costui di presentare dei garanti (praedes litis et vindiciarum); infine il magistrato decideva la lite stabilendo quale tra i due sacramenta fosse iustum e quale iniustum; la decisione era indiretta in quanto non riguardava direttamente la situazione giuridica controversa, ma la verità del giuramento; colui che aveva giurato il vero riprendeva il suo denaro, l’altro lo perdeva e veniva usato per scopi religiosi; in età repubblicana la somma del perdente veniva versata all’erario. Se il sacramentum di chi aveva il possesso interinale della cosa risultava iniustum e se la cosa non veniva consegnata al vincitore, questi, dopo aver agito contro i praedes litis et vindiciarum per la sua valutazione, procedeva nei loro confronti all’esecuzione nella forma della manus iniectio. In età repubblicana, il giudizio sul sacramentum venne affidato a persona diversa dal magistrato, uno iudex; il processo si svolgeva in due fasi, la prima detta in iure davanti al magistrato, la seconda, apud iudicem davanti al giudice privato. La fase in iure, dopo l’indicazione della persona o delle persone incaricate di giudicare, terminava con un atto chiamato litis contestatio; nel processo per legis actiones esso consisteva nell’invito fatto dalle parti ai presenti di essere testimoni di quello cui avevano assistito; la formula rituale era testes estote (siate testimoni). Il giudizio sulla lite aveva valore solo tra le parti e quindi una terza persona poteva esperire nei confronti del vincitore una nuova legis actio sacramento, nella stessa forma. La legis actio sacramento in personam In questa legis actio, a differenza che in quella in rem, colui che esperiva l’azione avanzava una pretesa in danaro nei confronti della controparte; l’actor affermava la sua ragione, pronunziando una formula solenne “affermo che tu mi devi dare”, seguita dall’indicazione di una somma di danaro; questa dichiarazione veniva chiamata intentio ed in principio la somma richiesta era la poena prevista per un delitto, mentre in seguito fu il debito nato da un accordo; questa legis actio veniva usata per tutti i debiti per cui non era prevista un’altra specifica legis actio. Se il convenuto riconosceva il debito, la sua confessione (confessio in iure) era equiparata a un iudicatum, una pronunzia del giudice; se invece negava, l’attore lo sfidava al sacramentum; se infine non riconosceva, ma neppure negava, rimanendo in silenzio, l’attore continuava il rito pronunciando un’intimazione e successivamente esercitava la manus iniectio. Se il sacramentum veniva dichiarato iustum, il magistrato autorizzava la ductio del convenuto, che veniva portato nella prigione domestica dell’attore; se necessario, alla ductio seguiva un nuovo processo per stabilire l’ammontare del debito, e quindi l’esecuzione nella forma della manus iniectio. La legis actio per iudicis arbitrive postulationem Questa legis actio nacque per far valere alcune ragioni tassativamente previste; per le XII Tavole, veniva utilizzata per la tutela dei crediti nascenti da sponsio e per celebrare i giudizi relativi alla divisione d’eredità fra coeredi (actio familiae erciscundae); poi una lex Licinia stabilì che l’applicabilità della legis actio per iudicis arbitrive postulationem ai giudizi divisori fra condomini (actio communi dividundo). Il rito, riferendoci al credito da sponsio, iniziava con l’attore che affermava che il convenuto doveva dargli una somma di danaro in base alla sponsio; se il convenuto negava, l’attore, sempre con formule rituali, chiedeva al pretore di nominare un giudice; nei giudizi divisori, anziché un giudice, le parti chiedevano di nominare un arbitro (arbiter), cioè un tecnico in grado di operare la divisione; infine la pronunzia della sentenza spettava al giudice o all’arbitro. La legis actio per iudicis arbitrive postulationem si distingueva dalla legis actio sacramento per una maggior snellezza, per la sua totale laicità e per la mancanza del rischio economico connesso al sacramentum. La legis actio per condictionem Questa legis actio fu introdotta nella seconda metà del secolo III a.C. da una lex Silia; essa fu istituita per tutelare i crediti di somme determinate di danaro (certa pecunia), e di lì a poco fu estesa da una lex Calpurnia ai crediti di cose determinate (certa res). Il vantaggio offerto dalla nuova legis actio era in primo luogo quello di non costringere a prestare il sacramentum, ed inoltre la legis actio per condictionem non prevedeva che l’attore facesse riferimento al fatto giuridico da cui il suo credito era sorto, e questo eliminava la possibilità di errori. La procedura della legis actio per condictionem iniziava con l’attore che affermava il suo credito e chiedeva al convenuto se lo riconosceva o negava; se il convenuto ammetteva , la sua confessio in iure aveva l’effetto di una condanna, mentre in caso di negazione, l’attore gli rivolgeva un solenne invito in questi termini: “poiché neghi ti invito a presentarti dinanzi al magistrato entro trenta giorni per ricevere un giudice”; l’invito era detto condictio e successivamente la causa veniva decisa dal giudice o da un arbitro. b) Le legis actiones esecutive Le legis actiones esecutive erano due, la manus iniectio (sulla persona) e la pignoris capio (sui beni). La legis actio per manus iniectionem Descritta dalle XII Tavole e da Gaio, essa era consentita nei confronti di colui che era stato condannato al termine di una legis actiones di cognizione (iudicatus) e nei confronti di colui che nel corso di una di queste legis actiones non aveva contrastato la pretesa avversaria (confessus); a costoro si aggiunsero poi coloro nei cui confronti la legis actio per manus iniectionem era esperita pro iudicato, ossia nei confronti di coloro che per legge erano equiparati a un iudicatus o a un confessus. Il iudicatus aveva a sua disposizione trenta giorni detti giusti per adempiere l’obbligo impostogli dalla sentenza; scaduto quel termine, l’attore poteva trascinarlo in ius, e qui imponeva su di lui le mani pronunziando una frase solenne. Il convenuto non poteva allontanare da sé le mani e difendersi personalmente con la legis actio, ma poteva farlo in suo favore un vindex, che però prendeva il suo posto; in mancanza di questo intervento il magistrato autorizzava l’attore a condurre con sé il convenuto, che veniva rinchiuso nel carcere domestico, ove veniva tenuto in catene. Nel corso di 60 giorni, il debitore veniva condotto davanti al pretore nel comitium, dove per tre mercati successivi veniva esposto, con l’indicazione della somma da lui dovuta; se qualcuno pagava questa somma egli diventava suo schiavo, ma parenti e amici potevano riscattarlo restituendogli la libertà; se dopo tre mercati nessuno lo aveva riscattato o comprato, il debitore poteva essere venduto trans Tiberim, oppure poteva essere ucciso; se esistevano più creditore, questi potevano smembrare il cadavere e spartirsene i pezzi. La pignoris capio (o legis actio per pignoris capionem) A differenza della manus iniectio, questa esecuzione aveva luogo sui beni del debitore. Essa poteva essere compiuta ovunque, senza bisogno della presenza del magistrato; la pignoris capio era una legis actio, in quanto prevedeva la pronunzia di parole solenni, previste dalla legge; ad essa si faceva ricorso in casi stabiliti, previsti dalla legge o dai mores; secondo questi ultimi potevano farvi ricorso i soldati che non avevano ricevuto il pagamento dell’aes militare, vale a dire del loro stipendio, e i cavalieri che volevano ottenere il danaro necessario per acquistare il cavallo (aes equestre) e l’orzo che serviva ad alimentarlo (aes hordiarum); potevano far ricorso alla pignoris capio i publicani nei confronti dei debitori d’imposta. Le situazioni tutelate avevano un fondamento amministrativo e sacrale e non un vincolo di diritto privato. La pignoris capio consentiva di impossessarsi di beni di un’altra persona, per indurre quest’ultima a eseguire una prestazione il cui adempimento non poteva essere richiesto giudizialmente; se questa prestazione non veniva eseguita, allo scadere del termine per l’usucapione chi aveva fatto la pignoris capio acquistata la proprietà della cosa. B.Dalla metà del secolo III a.C. alla metà del secolo III d.C. 1. Crisi delle legis actiones Le ragioni che determinarono la crisi del processo per legis actiones furono più d’una; sicuramente l’eccessivo formalismo, in quanto sbagliare una parola corrispondeva a perdere la lite; queste actiones potevano essere esperite solo a tutela dei rapporti nascenti dal ius civile e di conseguenza i nuovi rapporti basati sulla bona fides, sorti in seguito all’accrescersi del commercio restavano esclusi dal loro campo di applicazione; inoltre, essendo le legis actiones riservati ai soli cittadini romani, non erano applicabili ai rapporti sempre più frequenti con stranieri; il processo che superò questi problemi fu quello formulare. 2. Caratteri e linee del processo formulare Emerge chiaramente che il processo per legis actiones e quello per formulas si differenziavano in primis per la diversità del potere sul quale si fondavano, in quanto mentre le legis actiones trovavano fondamento nei mores o nella legge, il processo formulare si fondava sull’imperium magistratuale. Altra importante novità era la possibilità di litigare per concepta verba; rispetto alle formule delle legis actiones, qui esse erano flessibili e venivano composte di volta in volta, utilizzando una serie di schemi ampiamente modificabili e adattabili alle diverse situazioni, in modo da riflettere le posizioni delle parti; grazie a queste caratteristiche la formula consentì di tutelare nuove situazioni ed il pretore, insieme alle parti, componeva una formula adatta al caso, che veniva poi utilizzata in casi analoghi. Con il passare del tempo si venne dunque un repertorio di formule, che il pretore rendeva pubbliche all’inizio del suo anno di carica, inserendole nell’editto; egli prometteva che, se si fossero presentate determinate situazioni degne di tutele, avrebbe concesso di agire in giudizio servendosi di una determinata formula, di cui pubblicava il testo; se nel corso dell’anno si presentavano situazioni nuove, il pretore poteva concedere formule non previste dall’editto, dette actiones ex decreto o ex edicto, o anche decretales. Altra caratteristica fondamentale del processo formula è la pecuniarietà della condanna, anche nel caso in cui li processo vertesse sull’esistenza di un diritto reale; in caso di rei vindicatio (rivendica della proprietà), il convenuto non veniva condannato alla restituzione, bensì al pagamento del valore della cosa; questa particolarità, che impediva al proprietario di soddisfare il suo interesse a riavere la cosa, è legata a diverse circostanze; la prima è che il praetor peregrinus non aveva né il potere di ordinare la restituzione di un bene, né quello di attribuirne la proprietà, ma poteva cercare di indurre chi la deteneva illegittimamente a restituirla, imponendogli, se non lo avesse fatto, il pagamento di una forte somma di danaro, derivante da una litis aestimatio. I rapporti dedotti in giudizio a seguito di sponsio avevano un contenuto patrimoniale. 3. La formula e le sue parti La formula determinava il compito e i poteri del giudice; si passò da una situazione in cui le formule venivano predisposte caso per caso a una situazione in cui i magistrati avevano a loro disposizione un certo numero di formule, che si tramandavano di editto in editto. Le partes formularum (struttura della formula) sono la demonstratio, la intentio, la adiudicatio, e la condemnatio. Nella sua espressione più semplice, la formula conteneva la intentio e la condemnatio. • Intentio La intentio era la parte della formula in cui l’attore esprime la sua pretesa; viene indicata la ragione fatta valere dall’attore e viene formulata come un’ipotesi, la cui veridicità dovrà poi essere verificata dal giudice. Classificazioni delle intentiones Le intentiones venivano classificate in certae, incertae, in factum e in ius. Intentiones certae e incertae Quelle certae si riferivano ad una determinata somma di denaro o determinata cosa, mentre le altre no; esempi di intentio certa sono quelli ove l’oggetto del rapporto è individuato in una determinata somma di denaro che l’attore sostiene essergli dovuta dal convenuto ovvero in un determinato schiavo che l’attore afferma essere suo; esempi di intentio incerta è quello ove non risulta determinato ciò che l’attore pretende dalla controparte. Intentiones in factum e in ius Erano in factum (factum conceptae, concepite in fatto) le formule più antiche, concesse dal pretore a tutela dei rapporti non ancora tutelati dal ius civile e si faceva riferimento a situazioni di fatto. Erano in ius le intentiones in cui si faceva riferimento a un rapporto tutelato dal ius civile, cioè, quelle in cui si faceva riferimento a un diritto soggettivo dell’attore ovvero a un obbligo giuridico del convenuto, indicato dal verbo tecnico oportere; esse vennero concesse, oltre che per i rapporti tutelati ab antiquo dal ius civile (ad esempio il mutuo), anche per quelli che avevano trovato tutela di fatto nel tribunale del pretore, e ai quali poi il diritto civile aveva riconosciuto effetti giuridici. • Demonstratio È quella parte della formula che viene inserita perché venga indicata la questione per la quale si agisce (ad esempio “posto che Aulo Agerio ha venduto uno schiavo a Numerio Negidio”); questa pars formulae serviva dunque a indicare i fatti da cui era nata la pretesa dedotta in giudizio, nei casi in cui l’intentio non dava al giudice elementi sufficienti per giudicare nella fondatezza della pretesa, ed era presente solo quanto l’intentio era incerta o quando la formula era, praticamente, priva di intentio, ossia nei giudizi divisori e nel caso dell’actio iniuriarum. • Condemnatio La condemnatio è quella parte della formula in cui si attribuisce al giudice il potere di condannare o di assolvere; anche la condemnatio può essere certa o incerta; nel primo caso segue una intentio certa, nella quale oggetto del rapporto dedotto in giudizio è una determinata somma di danaro, mentre è incerta quando spetta al giudice procedere alla determinazione dell’ammontare della condanna; la condemnatio si limita in questo caso a fornire il criterio in base al quale si dovrà procedere alla stima in danaro dell’oggetto della controversia (litis aestimatio). La condemnatio può essere inoltre cum taxatione o infinita a seconda che preveda o meno un ammontare massimo, fissato in una somma determinata di danaro, entro il quale il giudice può determinare concretamente la condanna; taxatio si ha, ad esempio, nell’actio iniuriarum, de peculio e de in rem verso. La condanna ovviamente era sempre pecuniaria e il potere di fare ciò veniva attribuito al giudice dal magistrato, e non dalle parti, che si erano limitate a consentire alla sua nomina al momento della litis contestatio. Vi erano inoltre formule composte solo da intentio, i c.d. praeiudicia, azioni di mero accertamento quali ad esempio quelle volte ad accertare lo status di una persona ovvero l’ammontare di una dote. Esempi di formule composte di sola intentio e condemnatio: • Formula dell’actio certae creditae pecuniae (a tutela del mutuo): Tizio sia giudice. Se risulta che Numerio Negidio deve dare diecimila sesterzi ad Aulo Augerio, tu giudice condanna Numerio Negidio a dare diecimila sesterzi ad Aulo Augerio. Se non risulta assolvilo; • Formula della rei vindicatio (a tutela della proprietà): Tizio sia giudice. Se risulta che il fondo Capenate, di cui si tratta, appartiene ad Aulo Agerio in base al diritto dei Quiriti e questo fondo non sarà restituito a Aulo Agerio, a quanto sarà il valore di quella cosa, a tanto tu giudice condanna Numerio Negidio nei confronti di Aulo Agerio. Se non risulta assolvilo. In questo caso le parole “quanto sarà il valore della cosa” alludono alla stima (aestimatio) in base alla quale verrà determinato il valore della res litigiosa (il bene per cui si discute). Le altri parti della formula sono la demonstratio e la adiudicatio che non sono presenti in tutte le formule. • Adiudicatio È quella parte della formula con la quale si permette al giudice di aggiudicare la cosa a uno fra i litiganti; essa è presente solo nei giudizi divisori (familiae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum – per la regolazione dei confini ­); l’attività di aggiudicare consisteva dunque nel convertire in proprietà solitaria una quota di beni comuni. Infine l’actio finium regundorum viene elencata insieme alle azioni divisorie perché per i romani non serviva solo a tracciare dei confini già esistenti, ma a determinare il luogo in cui questi passavano. 4. Altre parti della formula (PARTI ACCESSORIE) La formula poteva contenere anche altre clausole, quali la exceptio (eventualmente seguita da replicatio, duplicatio, triplicatio), la praescriptio e l’artbitratus de restituendo. a) Praescriptio Questa clausola era premessa alla formula e conteneva una precisazione dei limiti della controversia, e serviva a evitare che venissero dedotte in giudizio pretese che non si voleva venissero dedotte (ad esempio, “questa azione riguardi ciò di cui il termine è scaduto”). Oltre a questo tipo di praescriptiones, che data la loro funzione venivano chiamate pro actore (a favore dell’attore), esistevano anticamente anche delle praescriptiones pro reo, che ponevano dei limiti a vantaggio del convenuto; con il tempo queste praescriptiones si sono trasformate in eccezioni. b) Exceptio Era una clausola che veniva inserita tra la intentio e la condemnatio su richiesta del convenuto, quando costui, pur non negando le circostanze dalle quali nasceva la pretesa dell’attore, sosteneva l’esistenza di altre circostanze in conseguenza delle quali una sua condanna sarebbe stata iniqua. La exceptio si presentava come una condizione negativa alla condanna del convenuto, che si aggiungeva a quella positiva espressa nella intentio; la sua inserzione nella formula era resa necessaria dal fatto che, essendo i poteri del giudice delimitati dalla formula stessa, in mancanza di exceptio egli non avrebbe potuto tener conto delle circostanze in essa dedotte. c) Arbitratus de restituendo (clausola arbitraria) Questa clausola era un espediente che ovviava alla pecuniarietà della condanna, consentendo di ottenere la restituzione della cosa controversa; essa veniva inserita soprattutto nelle azioni in rem, e dal punto di vista formale si poneva come una condizione negativa della condemnatio; l’arbitratus de restituendo, infatti, subordinava la condanna del convenuto alla mancata restituzione della cosa. Le formule che contenevano un arbitratus de restituendo vengono definite arbitrariae, e alcune fonti definiscono arbitraria i iudicia (processi) imperniati sui simili formulae, accostandoli ai giudizi di buona fede; questo demandava al giudice il potere di stabilire quale comportamento del convenuto poteva essere considerato una restitutio. 5. Le azioni nel processo formulare e loro classificazione Nell’espressione legis actiones la parola actio indicava uno dei cinque modelli processuali composti di atti e di parole, previsti a tutela di una serie di rapporti giuridici; nel processo formulare invece il numero delle actiones era assai più vasto, e coincideva con quello delle formule, vi era quindi un’azione per ogni situazione tutelata dal pretore. 6. Azioni civiles (civili) e azioni honorariae (onorarie) Erano civiles le azioni basate su una norma del diritto civile, honorariae quelle basate su diritto pretorio; le azioni onorarie si distinguevano in azioni con formula in factum e actiones utiles, quest’ultime azioni civili adattate dal pretore a fini diversi da quelli per cui erano previste. Queste azioni appartenevano a loro volta a due tipi diversi, le azioni con farmulae ficticiae e quelle con trasposizione di soggetti. 7. Azioni con formule ficticiae La formula di queste azioni era caratterizzata da una finzione (fictio) con la quale si affermava esistente un elemento di fatto inesistente, ovvero inesistente uno esistente; grazie a queste azioni il pretore tutelava situazioni analoghe a quelle tutelate dal ius civile, salvo, appunto, la mancanza o la presenza dell’elemento di fatto che si fingeva a seconda dei casi esistente o non esistente. Un esempio è l’actio Publiciana; se una res mancipi, dopo essere stata venduta, era stata consegnata con una semplice traditio e non con mancipatio o in iure cessio, il compratore non ne acquistava la proprietà ex iure Quiritium, se non dopo il tempo necessario all’usucapione; se prima che si compisse questo termine una terza persona si impossessava della cosa, il compratore non poteva esperire una rei vindicatio, poiché questa era l’azione tipica a difesa della proprietà quiritaria. Ritenendo che ciò fosse iniquo, il pretore concesse in questi casi un’actio ficticia, appunto l’actio Publiciana, che altro non era se non una rei vindicatio nella cui intentio si invitava il giudice a giudicare come se fosse già decorso il tempo dell’usucapione. 8. Azioni con formula con trasposizione di soggetti In queste azioni il pretore, d’accordo con le parti, inseriva nella condemnatio il nome di una persona diversa da quella nominata nella intentio e di conseguenza se accertava che il rapporto dedotto nella intentio era esistente in relazione alla persona ivi indicata, condannava la persona indicata nella condemnatio. Questo espediente fu utilizzato ad esempio nella responsabilità adiettizia. Quando una persona era sostituita in giudizio da un cognitor o un procurator, così come quando un minore sui iuris era rappresentato dal tutore, la formula portava nella intentio il nome dell’interessato, e nella condemnatio quello del sostituto; gli effetti che si producevano in capo al sostituto venivano poi trasferiti in capo all’interessato. Quando un filiusfamilias o uno schiavo contraeva un debito, il creditore non aveva alcuna tutela iure civili; poiché peraltro i filiifamilias e gli schiavi svolgevano spesso attività economica per conto dell’avente potestà, il pretore in alcuni casi rese costui responsabile dei loro debiti concedendo una formula in cui nella intentio si faceva riferimento al filius o al servo, e nella condemnatio al loro avente potestà. 9. Azioni stricti iuris (azioni di rigore) e azioni bonae fidei (di buona fede) Questa distinzione riguarda l’entità dei poteri che la formula conferiva al giudice; quando la formula faceva riferimento alla bona fides il giudice aveva una maggior discrezionalità, dovendo egli basare la sua decisione sulla valutazione complessiva della correttezza dei rapporti tra le parti relativamente alla questione dedotta in giudizio; egli poteva tener conto del dolus e del metus senza bisogno di exceptio doli o metus; poteva tener conto dei patti intercorsi fra le parti dopo il sorgere del rapporto dedotto in giudizio, e delle eventuali compensazioni legate a un credito del convenuto verso l’attore ex aedem re (nascente dalla stessa causa). Le azioni di buona fede erano l’actio empii et venditi, locati conducti, negotiorum gestorum, mandati, depositi, fiduciae, pro socio, tutelae, rei uxoriae, commodati, pigneraticia, familiae erciscundae e communi dividundo. Nelle actiones stricti iuris invece il giudice era strettamente vincolato dalla formula ed un tipico esempio è l’actio certae creditae pecuniae, nella cui formula era già determinato l’ammontare della condanna; il giudice non poteva tener conto delle circostanze eventualmente fatte valere dal convenuto, se queste non erano state dedotte in una exceptio. a) Azioni in personam e azioni in rem Le azioni in personam tutelavano un diritto di credito, quelle in rem invece i diritti reali; il carattere in personam o in rem di un’azione risulta alla lettura della sua intentio. Essendo l’actio in personam a tutela di un diritto di credito, il vincolo corrispondente grava sin dall’inizio su una o più persone predeterminate, il cui nome compare nella intentio, insieme all’indicazione del comportamento cui questa o queste persone sono tenute nei confronti dell’attore; questo comportamento è indicato da tre verbi, dare, facere, praestare. Dare e facere indicavano dare e fare, mentre praestare, significava in origine garantire, ma poi indicò qualunque azione diversa dal dare o dal fare. Nelle actiones in rem, il nome della persona nei cui confronti il diritto viene fatto valere non compare nella intentio e dipende dal fatto che nei diritti reali, la controparte non è predeterminata sin dal momento in cui nasce il diritto, ma viene individuata solo nel momento in cui quivis de populo (una qualunque persona) tiene un comportamento contrario al pacifico esercizio del diritto difeso dall’actio; il nome della controparte compare solo nella condemnatio. a) Azioni poenales (penali) e azioni reipersecutoriae (reipesecutorie) Le azioni penali venivano intentate contro chi aveva commesso un illecito privato (delictum) civile o pretorio, ed erano volte a infliggere una poena, che spettava all’attore a titolo di riparazione del torto. Le azioni reipersecutorie erano invece rivolte a reintegrare un interesse leso. Le actiones in rem, quelle in personam nascenti da atti leciti, e quelle nascenti da delitti o da illeciti pretori, erano esperite per ottenere non una poena, ma la reintegrazione dell’interesse leso. Le azioni penali e reipersecutorie potevano anche essere cumulabili. Vi erano poi le azioni con cui rem et poenam persequimur (si reintegrava l’interesse leso e si infliggeva una pena); erano le azioni in cui la pena era in simplum, ma se il convenuto negava e veniva condannato, la condanna era in duplum ed in questo caso, il duplum punisce il comportamento processuale scorretto. Vi erano poi le azioni penali che rei persecutionem continent (contengono la rei persecutio), cioè ottenevano anche il risultato di risarcire il danno; era il caso dell’actio legis Aquiliae (per il damnum iniuria datum) con cui non concorreva alcuna azione reipersecutoria. 10. Azioni con formula in bonum et aequum Queste azioni erano caratterizzate nella condemnatio dalla clausola quod aequius melius esse videbitur, in base al quale il giudice era invitato a stabilire l’ammontare della condanna tenendo presente i criteri dell’equità; non conferiva al giudice poteri discrezionali sull’intero rapporto dedotto in giudizio, ma gli lasciare un potere illimitato di valutare equamente l’ammontare della condanna, che poteva essere così irrilevante da essere sostanzialmente un’assoluzione. 11. Svolgimento del processo. La fase in iure a) Adempimenti preliminari. Editio actionis (stragiudiziale), in ius vocatio e vadimonium Chi voleva esperire un’azione giudiziaria, doveva in primo luogo comunicare all’avversario la sua intenzione; questo avveniva con un atto detto editio actionis, consistente nel condurre l’avversario dinanzi all’albo ove era esposto l’editto del pretore, e indicargli la formula che si intendeva chiedere al magistrato. Altro modo di compiere la editio actionis era quello di scrivere la formula cui si intendeva far ricorso su un libellus (biglietto) che si consegnava all’avversario, e bisognava anche consegnare copia dei documenti (instrumenta) su cui si basava la pretesa. Dopodiché l’attore doveva vocare in ius il convenuto, quindi in pubblico, invitarlo a seguirlo davanti al magistrato; se l’attore non riusciva a effettuare la in ius vocatio il pretore autorizzava l’immissione dell’attore nel possesso del patrimonio della controparte (missio in bona) cui poteva seguire la vendita dei beni. Il vocatus era tenuto a seguire immediatamente l’attore in ius; questa comparizione poteva essere evitata da un vindex che garantisse la comparizione del convenuto nel giorno successivamente fissato dal pretore; in caso di sua mancata presentazione poteva essere esperita un’azione pretoria, con conseguente condanna a pagare una cifra equiparata. Il vocatus che rifiutava di seguire l’attore e non presentava un vindex poteva essere trascinato in ius con la forza. Tra le persone di stato sociale più elevato in luogo della in ius vocatio si preferiva far ricorso la vadimonium; richiamava l’antica pratica di presentare dei vades che garantivano la presenza del convenuto a una seconda udienza, se il processo non si era risolta in una sola seduta; esso consisteva in un invito a comparire all’ora prefissata di un certo giorno, accompagnato da stipulatio, con cui veniva invitato a presentarsi in ius si impegnava a pagare una certa somma di danaro, detta summa vadimonii, qualora non si fosse presentato. b) La editio actionis giudiziale e la postulatio actionis Giunto in iure, l’attore dopo aver ripetuto la editio, chiedeva al magistrato di concedergli l’actio desiderata (postulatio actionis); il convenuto poteva quindi ammettere la fondatezza di questa pretesa con una confessio in iure, che, nel caso la pretesa riguardasse una somma di danaro, equivaleva sin dal tempo delle XII Tavole a una condanna; nel caso invece di confessio riguardante un oggetto diverso da una somma di danaro, era necessario proseguire l’azione per valutare la cosa. Poteva anche accadere che il convenuto si limitasse a non difendersi (indefensio), senza assentire o negare; se si trattava di actio in rem il magistrato garantiva all’attore l’esercizio di fatto della pretesa vantata; se invece si trattava di actio in personam, il magistrato autorizzava l’esecuzione concedendo all’attore l’immissione nel possesso di tutti i beni del convenuto (missio in bona indefensi) cui poteva seguire la vendita degli stessi (bonorum venditio). Infine poteva accadere che il convenuto contestasse in fatto le affermazioni dell’attore o in diritto la fondatezza della sua pretesa, chiedendo al magistrato di non accordare l’azione (denegatio actionis), ovvero di apportare modifiche alla formula richiesta dall’attore. Alcune persone non potevano compiere la postulatio actionis, e più in generale non potevano postulare; essi erano i minori di 17 anni e i sordi, le cui postulationes venivano avanzate da un advocatus, persone capaci di postulare pro aliis, ossia fare domande in iure per conto degli altri. c) Il divieto di postulare pro aliis Il divieto di postulare per omosessuali e donne, ha una spiegazione; per gli omosessuali si fa presente che era considerata riprovevole solo l’omosessualità passiva, mentre per quanto riguarda le donne è legato al fatto che presentarsi in tribunale era contrario al dovere femminile della pudicitia. d) I rappresentanti processuali Le persone fisiche dotate di capacità giuridica e di agire potevano farsi sostituire da un cognitor o da un procurator omnium bonorum ovvero procurator ad litem. Il cognitor, che era un rappresentante diretto, doveva essere nominato con una dichiarazione formale diretta alla parte avversa. Il procurator era un rappresentante indiretto e poteva essere nominato senza alcuna formalità; poteva essere costituito con semplice mandato e all’insaputa dell’avversario; all’inizio della lite doveva fornire le garanzie (cautiones) in merito alla non riproposizione dell’azione e all’adempimento di quanto statuito nella sentenza. e) La causae cognitio, la dazione della formula (datio iudicii) e la dazione del giudice (datio iudicis) Dopo aver ricevuto la postulatio actionis il magistrato compiva una causae cognitio, una somma valutazione sulla base della quale il magistrato decideva se concedere o negare l’azione. Se l’azione veniva concessa, le parti discutevano il testo della formula con il magistrato, che, valutava se e quali eccezioni ed eventuali altre clausole inserire, e sceglieva la persona o le persone che avrebbero deciso la lite. L’organo giudicante poteva essere un giudice singolo (iudex unus) o un collegio di recuperatores, questi ultimi nominati nei processi di maggior importanza pubblica. Tanto il iudex unus che i recuperatores erano scelti da liste ufficiali ed erano sempre e solo senatori, ovvero anche cavalieri; gli arbitri, invece, venivano scelti su indicazioni delle parti. La concessione della formula nella configurazione assunta nel caso concreto e la nomina del giudice avvenivano con due decreti, rispettivamente chiamati dare iudicium e dare iudicem. f) La litis contestatio e i suoi effetti La fase in iure terminava con la litis contestatio, che si compiva nel momento in cui l’attore leggeva al convenuto la formula concessa dal magistrato (dictare iudicium) e il convenuto l’accettava (accipere o suscipere iudicium). La litis contestatio era un negozio giuridico, la cui conclusione era necessaria perché la clausola venisse differita all’organo giudicante e produceva una serie di effetti: Rem in iudicium deducere, che comportava che i termini della controversia su cui il giudice doveva esprimersi non potessero più essere modificati e che gli eventi successivi non potessero più essere presi in considerazione; Impedire che sulla res in iudicium deducta si instaurasse un nuovo processo; agiva in modo diverso nei diversi tipi di azione; nelle actiones in personam con formula in ius fatte valere in iudicium legitimum essa agiva in forma del diritto civile; nella actiones in personam con formula in factum, nonché in tutti i iudicia imperio contentia la regola agiva ope exceptionis, agiva solo in forza di una exceptio. 12. La fase apud iudiciem Questa fase aveva inizio quando le parti erano invitate a comparire dinanzi al giudice il dopodomani; se una delle parti non si presentava, il giudice, nel corso della prima udienza, decideva la causa a favore di quella presente; il iudicium doveva concludersi entro 18 mesi se era ligitimum ed entro il periodo di carica del magistrato se imperio continens. L’attività più importante del giudice era, in questo periodo, l’assunzione delle prove; all’attore toccava provare i fatti costitutivi del rapporto e al convenuto toccare provare i fatto che lo avevano estinto ovvero che rendevano iniqua la pretesa di farlo valere. a) Tipi di prove Le prove erano distinte in due categorie, le probationes artificiales e le probationes inartificiales; le prime dipendevano dall’arte dell’oratore, le altre esistevano indipendentemente da questa e comprendevano le regole giuridiche. Tra le probationes inartificiales, si possono ricordare la testimonianza e i documenti scritti e le testimonianze erano orali o date per iscritto (per tabulas); quelle scritte avevano meno efficacia di quelle orali. b) La pluris petitio Non era possibile condannare il convenuto nel caso in cui la pretesa dell’attore, enunciata nell’intentio, fosse maggiore di quella cui aveva effettivamente diritto; l’attore perdeva la lite e non poteva riproporla una seconda volta. Esistevano quattro tipi di pluris petitio ed erano re, tempore, loco, causa, a seconda che si chiedesse materialmente più di quanto effettivamente spettasse, o prima del termine, o in luogo diverso da quello in cui era dovuta la prestazione, o privando il convenuto di una scelta che gli sarebbe spettata; la pluris petitio era possibile solo nelle formule con intentio certa. Se vi era una pretesa diversa si poteva riproporre la pretesa corretta. 13. La sentenza e i suoi effetti Si trattava di un provvedimento conciso, modellato sul testo della formula, seguito dalla valutazione sulla fondatezza o meno della pretesa e a volte da una breve motivazione. Le sentenze erano orali e l’effetto di esse erano quello di decidere la lite in modo definitivo, in quanto nel processo formulare non esisteva appello; se qualcuno riproponeva la lite, il convenuto poteva opporre la exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. Ulteriore effetto della sentenza, se pronunziata in un iudicium legitimum, era quello di obbligare il condannato a eseguire il giudicato. 14. L’esecuzione La sentenza di condanna non aveva efficacia esecutiva, ma nasceva solo un obbligo a eseguire il provvedimento in capo al condannato, cui il magistrato intimava solennemente di pagare entro trenta giorni. Scaduto il termine l’attore poteva esperire un’actio iudicati secondo il normale iter, cioè tramite edictio actionis stragiudiziale e in ius vocatio; colui contro cui veniva esperita quest’azione poteva confessare il iudicatum ovvero resistere ed in quest’ultima ipotesi in caso di soccombenza era condannato in duplum. L’esecuzione a questo punto poteva avvenire in due forme, o sulla persona o sui beni. a) L’esecuzione sulla persona (ductio) L’esecuzione sulla persona esperibile al termine di un processo formulare era la ductio iussu praetoris, che aveva luogo a seguito di un’autorizzazione del magistrato, al quale l’attore chiedeva di potere condurre con sé il condannato; pur restando giuridicamente libero, questi veniva sottoposto al potere dell’attore, che era tenuto a provvedere al suo mantenimento. L’attore poteva trattarlo e servirsene come se fosse uno schiavo. b) L’esecuzione sul patrimonio (bonorum venditio) A partire dall’ultimo secolo della Repubblica il pretore introdusse una forma di esecuzione sul patrimonio, nata per risolvere il problema che si presentava quando un debitore moriva senza lasciare eredi; il primo intervento del magistrato era un provvedimento che autorizza il richiedente a prendere possesso del patrimonio del condannato (missio in bona); se il condannato tentava di ostacolare l’attore, questi poteva esperire nei suoi confronti un’actio in factum che portava a una condanna pecuniaria. Trascorsi trenta giorni, l’attore doveva comunicare l’avvenuto immissione nel possesso dei beni con un atto detto proscriptio bonorum. Questo consentiva agli altri creditori di chiedere a loro volta la immissione nel possesso dei beni e di partecipare alla successiva procedura di vendita del patrimonio (bonorum venditio); la bonorum venditio aveva dunque carattere concorsuale. In attesa della vendita il magistrato nominava curator bonorum uno dei creditori e alla vendita provvedeva un magister scelto dai creditori e approvato dal magistrato, il cui primo atto consisteva nello stabilire le condizioni della vendita con una lex venditionis. I creditori privilegiati erano detti privilegium exigendi, mentre gli altri erano chiamati creditori chirographarii (in età postclassica). La vendita avveniva tramite un’asta. Sul debitore cadeva l’infamia, ma per evitarla, poteva abbandonare volontariamente il suo patrimonio ai creditori (cessio bonorum), prima dell’asta. Chi acquistava i beni era un successore pretorio, e quindi non poteva esperire le azioni spettanti contro eventuali creditori del debitore insolvente e viceversa, ma per ovviare a questo problema, il pretore predispose due formule, Serviana e Rutiliana; la prima cui si ricorreva se il debitore era morto, era una formula ficticia in cui si fingeva che il bonorum emptor fosse erede del debitore; nel secondo caso si ricorreva quando il debitore era vivo, e conteneva una trasposizione di soggetti, nella intentio vi era il nome del debitore, nella condemnatio quello del bonorum emptor. c) Il pignus in causa iudicati captum Accanto alla bonorum venditio, che investiva l’intero patrimonio, vi era il pignus in causa iudicati captum, che consisteva nella presa di possesso a titolo di pegni di singoli beni del debitore, dietro autorizzazione del magistrato. La vendita la eseguiva direttamente l’attore e divenne applicazione generale nel processo della cognitio extra ordinem. 15. Altri provvedimenti dei magistrati Tra i provvedimenti che il magistrato poteva prendere per tutelare situazioni che egli riteneva meritevoli, vanno ricordate le restitutiones in integrum, le missiones in possessionem, le stipulationes praetoriae e gli interdicta. a) Gli interdicta L’interdictum era un ordine del magistrato che imponeva ad una parte di tenere un determinato comportamento; gli interdetti vennero introdotti nel periodo in cui il processo ordinario erano le legis actiones, e presumibilmente in un primo momento il pretore costringeva il destinatario a rispettare la sua ingiunzione, erano quindi esecutivi, ma quando successivamente divennero astratti, persero la loro esecutività. Il pretore che li emanava in forza della sua iurisdictio, non ricorreva più al suo imperium per farli rispettare; se il destinatario non rispettava l’ordine, l’attore doveva intentare un’azione (actio ex interdicto) destinata ad accertare l’esistenza dei presupposti di fatto che giustificavano l’interdetto stesso e l’inottemperanza all’ordine in esso contenuto. Gli interdictum erano distinti in proibitori, restitutori ed esibitori. Gli interdetti a tutela del possesso, si dividevano in adipiscendae (accertare), retinendae (conservare) e reciperandae (recuperare) possessionis; i primi erano proibitori, gli altri restitutori. a) IN INTEGRUM RESTITUTIO Era un provvedimento che ripristinava una situazione modificata da un fatto, un atto o un negozio giuridico secondo il ius civile, ma che secondo il pretore aveva creato uno stato di fatto ingiusto. La concessione avveniva dietro causa cognitio, cioè dopo che il pretore aveva valutato tutte le circostanze necessarie per giudicare sull’opportunità del provvedimento. Tra i mezzi usati vi era l’actio rescissoria, in cui si fingeva che non si fosse verificato il fatto che aveva recato pregiudizio all’attore (ad esempio rescissione atti compiuti dai minori di 25 anni, che avessero recato loro pregiudizio). b) CAUTIONES O STIPULATIONES PRETORIE Era una stipulatio imposta con decreto dal magistrato e con essa una persona prometteva di dare una determinata somma o di tenere un determinato comportamento. Gli edili curuli, che avevano competenza sui mercati, potevano imporre al venditore di prestare una stipulatio habere licere, con cui questi si obbligava a risarcire il compratore qualora il pacifico godimento della cosa venisse turbato; funzione analoga aveva la stipulatio duplae, con cui il venditore, in caso di evizione, si obbligava a versare al compratore il doppio del prezzo da questi pagato. Se erano garantite da terzi sponsores, le stipulazioni pretorie erano chiamate satisdationes, se non erano garantite erano dette repromissiones; cautiones invece quando venivano documentate. b) Le missiones in possessionem La missio in possessionem era un decretum con cui il magistrato autorizzava chi ne aveva fatto richiesta a prendere possesso di beni altrui; se riguardava l’intero patrimonio si parlava di missio in bona, di singoli beni invece missio in rem; questi provvedimenti potevano avere funzione cautelare ovvero coercitiva. 16. LA COGNITIO EXTRA ORDINEM Il processo formulare fu sostituito dal quello definito cognitio extra ordinem. a) Le cognitiones provinciali La procedura formulare non veniva applicata in tutte le province e anche là dove veniva applicata subiva profonde trasformazioni; prima che questo accadesse a Roma e in Italia, nelle province entrò in uso un tipo di processo che si svolgeva interamente dinanzi al magistrato o al funzionario imperiale cui la questione veniva sottoposta. Questo processo consisteva in una cognizione (cognitio) della causa da parte del magistrato o funzionario, che al termine di questa cognitio poteva emettere personalmente la sentenza. Nel processo per cognitiones le parti non si accordavano sui termini della lite e non partecipavano in alcun modo alla scelta del giudice e alla definizione dei suoi compiti. b) Le cognitiones extra ordinem a Roma Già all’inizio del principato, per tutelare gli istituti introdotti dal principe o dal Senato si faceva ricorso alle cognitiones anche a Roma. L’origine di questo processo a Roma, viene fatto risalire ad Augusto che aveva iniziato ad attribuirsi nel 30 a.C. il potere, tramite una legge, che lo autorizzava a giudicare su richiesta di una parte e questi poteri si estero dal 23 a.C. in forza della tribunicia potestas e dell’imperium proconsolare maius et infinitum, esercitandoli personalmente o delegandoli al pretore o ai consoli. Alla fine del secolo I d.C. entrò in uso tra i giudici la prassi di chiedere al principe un parere, che veniva dato con un rescriptum che in quella specifica causa era vincolante. C.Dall’anarchia militare alla morte di Giustiniano 1. La fine del processo formulare Nonostante il progressivo affermarsi delle cognitiones, la procedura formulare continuò ad essere applicata fino a verso la metà del secolo III d.C.; essa aveva tuttavia perduto molti dei suoi caratteri. L’abolizione di questa procedura avvenne nel 342, quando una costituzione di Costantino, Costanzo e Costante vietò il ricorso alle formule, definite mezzi insidiosi, che potevano indurre le parti in errore. 2. Generalizzazione delle cognitiones, i caratteri della cognitio postclassica Agli inizi del secolo IV, tutti i processi privati sia in provincia si a Roma venivano celebrati nella forma della cognitio, che ormai si svolgeva secondo un modello sostanzialmente uniforme; i principali aspetti innovativi di questa cognitio erano la citazione in giudizio, processo contumaciale, potere discrezionale del giudice, condanna in forma specifica, appello. a) La procedura Il processo veniva promosso da chi, affermando di esserne il titolare, chiedeva l’accertamento e la tutela di un diritto soggettivo. b) La citazione in giudizio A partire dalla fine del secolo III, l’atto introduttivo del processo, ossia la litis denuntiatio, consisteva in un atto scritto detto libellus notificato dall’attore al convenuto e contenente l’invito a comparire dinanzi al funzionario o al giudice da questi delegato. Una volta notificato il libellus, il convenuto poteva inviare un libello di replica (contradictionis) e le parti dovevano comparire dinanzi al giudice entro il termine di quattro mesi. Il dibattimento che seguiva, nel corso del quale aveva luogo l’assunzione delle prove, conduceva alla pronunzia di una sentenza che poteva essere anche contumaciale. La litis denuntiatio cadde in disuso, sostituita da un libelllus conventionis, che veniva inviato non dall’attore, ma dal funzionario, tramite un executor, al convenuto. Il termine per la presentazioni delle parti venne ridotto a 10 giorni, elevati a 20 da Giustiniano, entro i quali il convenuto poteva presentare il libellus contradictionis; al convenuto fu fatto obbligo di prestare una cautio iudicio sisti, garantita da un fideiussor ed in caso di rifiuto, l’executor poteva arrestarlo e trattenerlo a disposizione del giudice fino a che il processo non era giunto a termine. c) La nascita del processo contumaciale Il magistrato invitata il convenuto a presentarsi, tramite l’evocatio o denutiatio ex auctoritate; se questi non si presentava, il magistrato emanava tre edicta successivi, cui faceva seguito, se necessario, un quarto editto detto edictum perentorium, con cui rendeva noto al convenuto che avrebbe emesso la sentenza in sua assenza. Il convenuto che non si presentava nonostante questi editti veniva detto contumax; in questo processo, la cognitio si svolgeva anche in contumacia, e il giudice era tenuto a valutare pure gli eventuali elementi in favore del contumace. d) Il dibattimento Se compariva in giudizio, il convenuto poteva ammettere le ragioni dell’attore ovvero contestarle, ma mentre nei processi antecedenti, una confessio poneva fine al processo, nella cognitio era prova, in forza della quale il giudice condannava il convenuto. Se invece il convenuto intendeva contestare la pretesa dell’attore, dopo aver presentato il libellus contradictionis, si impegnava nella fase del processo denominata initium; in questa fase il convenuto poteva opporre le sue exceptiones, in quest’epoca dette praescriptiones (exceptio era l’affermazione da parte del convenuto di fatti o atti che potevano sostenere le sue ragioni). e) La litis contestatio Si riteneva in quest’epoca che la litis contestatio fosse avvenuto quando l’attore aveva fatto la sua narratio e il convenuto la sua contradictio, fissando i termini della lite. f) I poteri discrezionali del giudice e le nuove regole sul valore degli atti processuali L’introduzione di nuove regole, limitarono fortemente i poteri discrezionali del giudice, soprattutto in materia di assunzione e valutazione delle prove; in età postclassica il regime delle prove attrasse i giuristi, che sottoposero l’argomento a una regolamentazione volta innanzitutto a stabilire all’interno di esse una precisa gerarchia di valori; la prova documentale venne considerata superiore a quella testimoniale, invertendo così una tendenza che sino a quel momento aveva dato la prevalenza alla prova testimoniale; rimase in vigore l’onore della prova a carico di chi aveva interesse a dimostrarne l’esistenza. g) La sentenza. La nascita della esecuzione in ipsam rem Il giudice, emanando la sentenza al termine della cognitio, poteva liberamente stabilire l’ammontare della condanna, e a partire dal secolo III poteva pronunziare anche condanne non pecuniarie, cioè, oltre che a un dare, poteva condannare a un facere; le fonti cominciarono a parlare di un’esecuzione in ipsam rem. h) La nascita del secondo grado di giudizio (appello) Il moltiplicarsi delle cognitiones da parte di giudici diversi dal principe portò alla nascita di un istituto importantissimo, sino a quel momento sconosciuto al diritto romano, ove tutti i processi si erano sempre svolti in un unico grado di giudizio; questo istituto fu l’appello al principe, cui spettava il secondo grado di giudizio; successivamente questo appello fu delegato dall’imperatore al praefectus urbi, a quello praetorio o ad altri funzionari. 9. I rapporti giuridici e le obbligazioni Origini delle obbligazioni Le obbligazioni venivano da atto lecito o illecito; vi è un vincolo materiale da atto illecito (è il soggetto che compie un atto illecito) e la soluzione era la vendetta, l’applicazione della c.d. Legge del Taglione, che non poteva non passare attraverso il momento della presa di possesso della persona responsabile, però il creditore poteva accettare una compensazione pecuniaria, cioè il pagamento di una sanzione pecuniaria. Successivamente l’ordinamento intervenne affermando che era possibile solo la sanzione pecuniaria , in questa fase l’obbligazione viene intesa come vincolo potenziale. A. CONSIDERAZIONI STORICHE 1. Prima del vincolo giuridico: il VINCOLO MATERIALE Alle origini la pena è ero uno strumento che serviva per evitare il riscatto personale. Il vincolo materiale può derivare da atto illecito o da atto lecito. I vincoli materiali da atto lecito potevano derivare da accordi spontaneamente conclusi per regolare interessi privati (es. il paterfamilias si faceva prestare una derrata ­prodotto della terra di largo consumo, come cereali­ da un altro paterfamilias); a chi aveva interesse che l’impegno preso venisse rispettato si attribuì un potere materiale su colui che lo aveva assunto e questi si trovò ad essere assoggettato a un vincolo materiale, questo vincolo in alcuni casi era attuale, in altri era eventuale. Originariamente non nasceva un vincolo giuridico, ma un vincolo materiale, in forza del quale, colui al quale altri si aspettavano un determinato risultato veniva fisicamente assoggettato al potere di altra persona. Si cominciò a formare una sorta di catalogo di comportamenti delittuosi, il cui vincolo materiale nasceva da un comportamento illecito. Si riconobbe alla vittima un potere su chi aveva tenuto il comportamento delittuoso, autorizzandola a infliggere all’offensore il male che la civitas riteneva che costui avesse meritato e la vittima non agiva più come privato vendicatore ma come un “agente socialmente autorizzato”; i poteri erano, infliggere all’offensore un male proporzionato al delitto commesso, tenerlo presso di sé, in condizione di fatto di schiavitù e ucciderlo. Le XII Tavole prevedevano che venisse messo a morte: ladro che agiva di notte; ladro che agiva di giorno se faceva uso di armi; ladro sorpreso in flagrante quando era uno schiavo; colui che di notte aveva tagliato l’altrui raccolto; chi si era magici; impossessato/danneggiato l’altrui raccolto con mezzi chi aveva spaventato o gettato il malocchio le messi del vicino con canti magici; chi aveva trasportato nel proprio campo le messi già raccolte del vicino; chi aveva incendiato un edificio e il covone di frumento a questo appoggiato. Alternativa alla morte: la pactio Le XII Tavole stabilirono che l’uccisione del ladro fosse legittima ma non obbligatoria; chi sorprendeva un ladro poteva accettare la compensazione che questi eventualmente gli offrisse al fine si aver salva la vita. Tutto quello che interessava era controllare la vendetta privata, affermando il suo diritto esclusivo di stabilire quali fossero i comportamenti che meritavano la morte; stabilito ciò la civitas non aveva ragione di vietare alle parti interessate di valutare se e a quali condizioni l’offesa poteva essere lavata evitando lo spargimento di sangue. Il potere di infliggere un male fisico diverso dalla morte Di fronte a comportamenti delittuosi considerati di minor gravità la civitas autorizzava la vittima a reagire infliggendo all’offensore un male fisico, diverso dalla morte, di cui ella stessa stabiliva inderogabilmente la misura (previsto anche nelle XII Tavole là dove regolano un’ipotesi di lesioni personali denominata rottura di un membro). Il potere di rendere proprio schiavo un delinquente Altre volte il potere conferito alla vittima consisteva nella possibilità di trattenere il delinquente presso di sé, in condizioni di schiavo ed erano: ladro di stato libero sorpreso in flagrante; colui a casa del quale era stata trovata la refurtiva, a seguito di perquisizione lance licioque. La nascita della pena privata Le tappe fondamentali del cammino percorso dalla civitas, che progressivamente sottopose a controllo l’uso della forza privata, furono quelle che stabilirono nell’ordine: Solo a lei spettava stabilire quali legittimavano una reazione fisica. erano i comportamenti che Il potere di determinare la misura della reazione non spettava più alla parte lesa, la quale poteva reagire solo nella misura stabilita dalla civitas stessa. Coloro che accettavano una composizione pecuniaria – a seguito di una pactio ­ non erano più sottoposti al potere della parte lesa di infliggere loro un male fisico o di privarli della libertà. La composizione pecuniaria era obbligatoria, di conseguenza le parti lese non potevano più usare la forza fisica. Sacer esto Di fronte ad alcuni comportamenti considerati un illecito religioso la civitas non conferì alla vittima un potere sul delinquente, bensì la dichiarazione di sacertà di questi, la consacrazione agli dèi (sacratio). A seguito della dichiarazione di sacertà il delinquente (homo sacer) poteva essere ucciso impunemente da chiunque decidesse di farlo. 1. PRESTAZIONE: REQUISITI La prestazione è il comportamento che il debitore deve tenere nei confronti del creditore in forza del rapporto obbligatorio che esiste tra loro. Requisiti perché l’obbligazione sia valida: Prestazione deve essere possibile: deve avere a oggetto una cosa esistente in natura (possibilità fisica o naturale) e rientrare nella categoria delle res in commercio (possibilità giuridica). Prestazione deve essere lecita: non contraria alle norme del diritto o del buon costume. Prestazione deve essere determinata (parti precisano il contenuto della prestazione) o determinabile (per stabilire contenuto della prestazione si fa riferimento a elementi esterni al negozio). Prestazione deve essere valutabile economicamente; questo dipende dalla necessità di sostituire la prestazione non adempiuta con il suo equivalente in danaro, secondo il principio per cui la condanna deve essere sempre pecuniaria. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI a) I contratti reali Sono il mutuo e la indebiti solutio; Gaio riteneva che un contratto venisse concluso re solo quando la dazione della cosa comportava il trasferimento della proprietà di questa. Il mutuo Nel momento in cui il danaro o le cose venivano prestati si confondevano con il patrimonio di chi li riceveva, diventando di sua proprietà. La nascita dell’obbligazione discendeva dall’accordo, dal trasferimento della proprietà della cosa e dal riconoscimento della utilità della funzione economico sociale del negozio. Totale autonomia rispetto alle esigenze sociali: enorme diffusione del prestito a interessi, anche se rimase sempre gratuito. Accanto al mutuo le parti concludevano un secondo contratto, una stipulatio (accessibile anche agli stranieri) con la quale il debitore si impegnava a pagare gli interessi; se al momento della restituzione del capitale il mutuatario non pagava gli interessi il mutuante per ottenerli poteva agire nei suoi confronti con un’actio ex stipulatu. Rimase in uso prevalentemente nei casi in cui il prestito era veramente gratuito. Dal mutuo nascevano obbligazioni a carico solo di una parte, esso era infatti un contratto unilaterale. Tutelato con l’actio certae creditae pecuniae. Il foenus nauticum o pecunia traiecticia È un contratto autonomo diverso dal mutuo, grazie al quale era consentito prevedere il pagamento di interessi (considerato spesso un tipo particolare di mutuo). Grazie ad esso chi si dedicava al commercio marittimo poteva ottenere del denaro a credito ed era tenuto a restituirlo solo nel caso che il viaggio fosse andato a buon fine. Il rischio della navigazione era a carico del creditore, il quale, in cambio dell’assunzione di tale rischio aveva diritto al pagamento di interessi elevati. La nascita di questo istituto in Grecia e la sua ricezione a Roma sono legate ai problemi creati alla navigazione dalla presenza di bande di pirati che rendevano le intraprese marittime pericolosissime. Il deposito (CONTRATTO REALE) È un contratto gratuito che si realizzava quando una persona – deponente ­ consegnava una cosa mobile a un’altra persona – depositario ­ e questa si impegnava a restituirla allo scadere di un certo termine o a richiesta del deponente; non si trasferiva né la proprietà né il possesso della cosa, il depositario era solo un detentore, non poteva usare la cosa, e se la usava commetteva il delitto di furto d’uso, tutelata con l’actio furti oltre che con l’actio depositi. È un contratto “imperfettamente” bilaterale: le obbligazioni sorgevano solo in capo al depositario (conservare la cosa, non usarla, restituirla non deteriorata, con frutti e accessioni), mentre il deponente poteva essere obbligato solo in determinate circostanze, solo quando il depositario avesse dovuto sostenere delle spese necessarie alla conservazione della cosa o avesse ricevuto danni dalla cosa depositata e il depositario poteva esercitare un’actio depositi contraria. In capo al depositario non nasceva l’obbligo della custodia in quanto il contratto era concluso nell’interesse esclusivo del deponente; l’obbligo nasceva se il contratto veniva concluso nell’interesse esclusivo di chi riceveva la cosa, e doveva rispondere per furto, perimento, danneggiamento anche se non determinati da un suo comportamento negligente. Il deposito “necessario” o “miserabile” Si ricorreva in occasioni di gravi calamità naturali, politiche o private. Se depositario profittava della situazione miserevole in cui si trovava il deponente, l’azione nei suoi confronti portava a condanna pari al doppio del valore della cosa. Vi era responsabilità per mancata restituzione solo in caso di dolo. Il sequestro È il caso della cosa di cui era incerto chi fosse il proprietario, consegnata a persona incaricata di conservarla in attesa che la questione della proprietà venisse chiarita. Il depositario non era tenuto a restituire la cosa a richiesta, ma solo quando la lite fosse risolta o l’esito della scommessa verificato; egli non era un semplice detentore ma era possessore della cosa. Il deposito irregolare È un contratto con cui una parte depositava presso l’altra una quantità di cose fungibili (di regola danaro) con l’accordo che il depositario ne restituisse a richiesta l’equivalente (tantundem eiusdem generis). Il depositario acquistava la proprietà delle cose consegnatigli; egli non era persona che ne aveva fatto richiesta per sua necessità, bensì persona che maneggiava grandi capitali, investendoli e facendoli fruttare, inserendo anche gli interessi nell’accordo. La restituzione aveva luogo quando deponente la richiedeva, non si stabiliva un termine. Il comodato È il contratto di prestito d’uso (diverso da mutuo che è prestito di consumo). Si realizzava quando una parte – comodante ­ trasferiva all’altra – comodatario ­ una cosa inconsumabile affinché questi la usasse e la restituisse nelle stesse condizioni in cui l’aveva ricevuta. Non comporta il passaggio né della proprietà né nel possesso della cosa. Il vincolo nasceva dalla consegna della cosa. Era un contratto gratuito e imperfettamente bilaterale: le obbligazioni sorgevano solo a carico del comodatario, ma qualora egli avesse dovuto sostenere delle spese di straordinaria manutenzione o avesse subito dei danni dalla cosa comodata sorgeva l’obbligo del comodante di risarcirlo. Veniva concluso nell’interesse del comodatario, che poteva così usare per un certo tempo una cosa non sua. La tutela concessa era un’azione in factum e quindi un’azione di buona fede in ius. Il pegno In età classica era un diritto reale su cosa altrui, in funzione di garanzia. Veniva costituito mediante il trasferimento del possesso di una cosa corporale, a garanzia di un debito proprio o altrui; da questa consegna nasceva l’obbligo, in chi riceveva la cosa di custodirla e restituirla nel momento in cui il suo credito fosse soddisfatto, o si fosse comunque estinto. Qualora il credito non venisse soddisfatto, il creditore pignoratizio aveva il diritto di vender la cosa, di trattenere l’equivalente del suo credito e di restituire l’eccesso. Era un contratto reale e imperfettamente bilaterale: la possibilità che sorgessero obbligazioni a carico di chi aveva dato la cosa in pegno era legata all’eventualità che il creditore pignoratizio avesse sostenuto spese o subito danni. La tutela per il creditore pignoratizio era l’actio pigneraticia in personam. La fiducia In età classica le ragioni per le quali si ricorreva a questo istituto erano: fiducia cum amico: i beni venivano trasferiti a un amico in caso di guerra, tumulti sociali o altri eventi che impedivano di vegliare sul proprio patrimonio; fiducia cum creditore: il trasferimento di beni fatto da un debitore al suo creditore con l’accordo che i beni sarebbero stati ritrasferiti al debitore nel momento in cui questi avesse soddisfatto il debito; garantiva quindi il creditore da eventuali inadempienze. La fiducia divenne un contratto che le parti concludevano compiendo una mancipatio nel cui formulario venivano inserite alcune parole solenni, legate alla natura fiduciaria dell’atto. CONTRATTI VERBALI Secondo Gaio erano contratte verbis le obbligazioni che nascevano ex interrogatione et responsione, e in effetti in un’interrogazione e in una congrua risposta consisteva ai suoi tempi la stipulatio. Esistevano anche obbligazioni (la dotis dictio e la promissio iurata liberti) la cui nascita dipendeva dalla pronunzia di parole solenni che non consistevano in una domanda e una risposta. La stipulatio/SPONSIO La struttura originaria rimase immutata, e perché nascesse un’obbligazione si continuò a chiedere che a una domanda del creditore il debitore desse una risposta congrua e immediata. Con il passare del tempo all’interno di questo schema si ammise che, oltre a verbo spondere (riservato ai cittadini romani), venissero utilmente usati anche altri verbi. Il fatto che l’obbligazione nascesse dalla pronunzia dei verba faceva sì che anche in epoca classica il negozio fosse astratto, che la causa del negozio non avesse rilevanza. In età repubblicana nacque l’abitudine di redigere un documento scritto nel quale venivano indicati i termini dell’accordo: semplificava la conclusione del contratto, consentendo a chi interrogava di limitarsi a far riferimento a quanto in esso scritto. Ci si poteva obbligare a qualunque tipo di prestazione e dare tutela a varie operazioni commerciali ed economiche. A tutela delle stipulationes certi veniva concessa un’actio certae pecuniae; per quelle incerti, invece vi era l’actio incerti ex stipulatu. La dotis dictio Era il modo in cui poteva essere costituita una dote, attraverso una promessa unilaterale da parte della donna che andava a nozze, del suo paterfamilias o anche di un debitore della donna, da lei delegato a far questo. La promessa era rivolta al futuro marito e prevedeva la pronunzia delle parole: dotem tibi dico o dotem tibi erit e seguite dalla menzione delle cose che andavano a far parte della dote stessa, facendo nascere così un credito del marito. La promissio iurata o ius iurandum liberti Era una solenne promessa, fatta dallo schiavo manomesso che si obbligava a compiere al dominus che lo aveva liberato determinati servigi. Questa promessa veniva fatta precedere da un giuramento avente analogo contenuto che lo schiavo prestava prima della manomissione. Il giuramento aveva la funzione di impegnare lo schiavo evitando che dopo la manomissione egli deludesse le aspettative del padrone. A tutela del patrono – se le promesse non avevano carattere vessatorio­ il pretore concesse un’actio operarum. CONTRATTI CONSENSUALI Erano contratti informali che si basavano solo sul consenso dei due soggetti che stipulano che il contratto. Non viene meno il carattere della tipicità contrattuale, ma la tipicità è insita nella causa del contratto. La compravendita (emptio­venditio) È il più importante accordo in forza del quale il venditore si obbliga a trasferire il pacifico godimento di una cosa e il compratore si obbliga a versargli il denaro. Nel nostro ordinamento all’art. 1470, il c.c. sancisce che “La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”; nel diritto romano è diverso, in quanto c’è solo l’obbligo di trasferire il pacifico godimento di una cosa e non vi è trasferimento di proprietà. La compravendita nasce per regolare i rapporti tra romani e stranieri: gli stranieri non potevano acquistare la proprietà in quanto era un diritto solo dei romani, così le vendite tra romani e stranieri avvenivano tramite contratti consensuali perché c’era solo il trasferimento del pacifico godimento e non della proprietà. Gli oggetti della compravendita erano la merce (merx) e il prezzo (pretium). La cosa che si vende deve avere un prezzo certo e determinabile in denaro e deve essere in commercio. La compravendita poteva avere ad oggetto qualunque cosa corporale o incorporale che avesse un valore economico (anche diritti soggettivi aventi contenuto patrimoniale). Il compratore deve trasferire la proprietà del danaro individuato come prezzo e il venditore deve trasferire il pacifico godimento, e ha l’obbligo di consegnare la cosa ed il suo possesso. La tutela era rappresentata dalla actio empti se intentata dal venditore, e dalla actio venditi se promossa dal compratore. Il trasferimento di res mancipi, avviene ovviamente tramite mancipatio. Il compratore che aveva ricevuto una res mancipi con semplice traditio, poteva esercitare l’actio Publiciana, che altri non è che un adattamento della rei vindicatio. Il venditore doveva fornire due garanzie: per evizione: è il caso in cui un compratore fosse stato citato in giudizio da un terzo che assumesse di essere lui il proprietario, prima che si compisse il termine per l'usucapione e di fronte alla rei vindicatio del terzo fosse rimasto soccombente o evitto (con la conseguenza di dovergli restituire la cosa). Il venditore doveva rispondere di questa evizione e rimborsare il compratore che ha subito l’evizione; la tutela era fornita prima dalla satisdatio secundum mancipium (obbligo del venditore tramite stipulatio), poi sostituita da una stipulatio habere licere (obbligo del venditore a pagare il valore della cosa), per finire poi con la stipulatio duplae, dove il venditore si obbligava a pagare in duplum. per vizi occulti: se un venditore vendeva una cosa con vizi senza dichiararlo veniva considerato un comportamento non corretto. All’inizio non si poteva far nulla, poi grazie agli edili curuli la garanzia era prevista come obbligatoria e implicita, essi emanarono due editti (relativi l’uno alla compravendita di schiavi e l’altro a quella di animali da sella e soma, poi esteso a buoi e altri quadrupedi domestici) i quali obbligavano il venditore a indicare a voce o su cartelli i difetti della merce offerta in vendita. In mancanza, il compratore poteva esperire entro 6 mesi un’actio redhibitoria (restituire) con la quale, restituendo la merce, otteneva la restituzione del prezzo; ovvero, in alternativa, un’actio aestimatoria o quanti minoris (fare stima della cosa), esperibile entro 1 anno, con la quale poteva ottenere la rivalutazione del prezzo e cioè il rimborso di quanto pagato in eccesso. Clausole che accompagnavano la compravendita: lex commissoria: prevedeva che la cosa tornasse di proprietà del venditore qualora il compratore non pagasse il prezzo entro un termine pattuito; in diem addictio: prevedeva che il contratto avesse efficacia solo se il venditore non avesse ricevuto un’offerta migliore entro un termine stabilito; pactum displicentiae: dava al compratore la possibilità di rendere la merce che non fosse stata di suo gradimento, ricevendo in cambio la restituzione del prezzo. La locazione (locatio­conductio) Il locatore deve trasferire al conduttore una cosa per un certo periodo di tempo. Nella locatio­conductio a pagare la mercede non è sempre chi riceve la cosa. La tutela era l’actio locati e l’actio conducti. Le varie forme di locatio­conductio sono: locatio conductio rei: un soggetto dà una cosa ad un altro soggetto, e questo ultimo è colui che paga. Il locatore deve consegnare la cosa e metterla a disposizione per un periodo temporaneo (diverso da compravendita per la quale è per un periodo eterno); locatio conductio operis: il locatore trasferisce al conduttore una cosa, affinché egli svolga un’attività lavorativa per raggiungere un risultato (oggi contratto d’appalto, art. 1675 e seg. c.c.), la mercede è pagata al conduttore dal locatore, in quanto il conduttore deve consegnare la cosa ed eseguire il lavoro; locatio conductio operarum: il locatore (mercenarius) si obbliga a mettere a disposizione di altra persona (il conduttore) la propria attività lavorativa (opere) per un certo periodo di tempo in cambio di una mercede (normalmente somma di danaro). Nelle prestazioni intellettuali la mercede è detta honorarium. Lex Rhodia: è un caso particolare di locatio­conductio e si applicava ai trasporti marittimi; in questo caso il rischio si ripartiva proporzionalmente tra tutti i locatori che avevano imbarcato le merci; i locatori delle merci perdute avrebbero agito con l’actio locali contro il trasportatore, e costui a sua volta avrebbe agito con l’actio conducti in via di rivalsa contro i locatori delle merci che si erano salvate. La società (societas) Il contratto consensuale di società nacque nel ius gentium, come strumento del commercio internazionale e fu tutelata verso la metà del II sec. a.C. nel tribunale del pretore peregrino. Consisteva nell’impegno, assunto da due o più persone, di mettere in comune dei beni per raggiungere un risultato vantaggioso. Il consortium ercto non cito (comproprietà di una cosa) era usato nell’età più antica, dove due persone avevano in comproprietà (proprietà comune) dei beni e se ci fossero state delle perdite venivano divise tra i soci e i guadagni venivano divisi a seconda di quanto fosse stato conferito dal singolo socio. La società leonina rappresenta un punto limite in quanto prevede che un socio abbia solo vantaggi e mai svantaggi, è quindi nulla. E’ possibile una società per un solo negozio o affare, terminato il quale, la società cessa di esistere. La società romana è un accordo tra i soci; la società non ha rilevanza ma è fonte di obbligazioni a carico di più soggetti – i soci ­, ed il soggetto agisce come persona singola, i contratti conclusi devono dare vantaggi da suddividere tra tutti i soci; la società moderna è diversa, in quanto essa è soggetto di diritto, ha personalità giuridica e responsabilità patrimoniale. Le obbligazioni che nascevano dall’attività svolta nel comune interesse sorgevano per intero in capo a chi aveva agito; colui che aveva agito per incarico degli altri poteva agire con l’actio mandati, mentre se l’incarico non era stato esplicito, con l’actio negotiorum gestorum. La società si estingueva per: recesso unilaterale di uno dei soci ed aveva effetto nel momento in cui altri gli soci ne venivano a conoscenza; morte di rapporto; uno dei soci e gli eredi non succedevano in questo capitis deminutio di uno dei soci; bonorum venditio, con conseguente vendita all’asta del patrimonio di uno dei soci a causa della sua insolvenza. Il mandato (mandatum) Era un contratto gratuito nella sua essenza, il mandante incaricava il mandatario di eseguire un’attività ed egli si impegnava a compierla gratuitamente. Il mandato è diverso dalla locatio operis in quanto deve essere stipulato nell’interesse del mandante o di un terzo, ma mai nell’interesse del mandatario. Se il mandatario voleva essere pagato il contratto era di locatio operis. Il mandato è fonte di obbligazioni in quanto il mandatario ha l’obbligo di trasferire gli effetti giuridici da lui compiuti al mandante; il contratto è imperfettamente bilaterale e la rappresentanza non è diretta. Il mandato si estingueva naturalmente per espletamento dell’incarico e, posto che si fondava sulla fiducia, si estingueva per rinunzia o revoca del mandatario (se l’esecuzione del mandato non aveva avuto inizio) e per morte o per capitis deminutio di una delle parti (se il mandatario non aveva già dato inizio all’esecuzione). 1. Estinzione delle obbligazioni La prestazione è il contenuto dell’obbligazione, e vi sono varie tipologie, quelle del “dare” e quelle del “fare”; la prestazione deve avere un valore economico in danaro, se non vi è questa valutazione (interesse) il contratto è nullo; deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile. Lo scioglimento di un vincolo giuridico potenziale si identifica con il termine solutio. E’ importante il luogo (domicilio del debitore) e il tempo, se non c’è termine si presume immediatamente (prestazione immediata). a) Gli atti estintivi Atti estintivi secondo il ius civile che agivano ipso iure. • Adempimento: ad adempiere poteva essere il debitore o qualunque terzo; in caso di obligatio da stipulatio, il pagamento poteva essere fatto a due personaggi, l’adiectus solutionis causa e l’adstipulator; il primo era quello il cui nome erano previsto nella formula della stipulatio, mentre il secondo era una persona di fiducia del creditore principale. Si poteva adempiere anche con una datio in solutum, ossia una prestazione diversa da quella dovuta, ma in caso di contestazione si doveva opporre exceptio in quanto da la datio, da sola, non estingueva l’obbligazione. • Acceptilatio: : atto (estintivo) composto da una domanda e dalla rispettiva risposta attraverso cui il debitore chiedeva al creditore se avesse ricevuto quello che aveva promesso, e quest'ultimo rispondeva affermativamente. Si trattava di un istituto simmetrico e contrario alla sponsio e stipulatio in quanto veniva utilizzato per estinguere le obbligazioni sorte da questi contratti. In età classica veniva usato come modo di estinzione delle obbligazioni anche se debitore non aveva adempiuto. • Stipulatio Aquiliana: si fondevano tutti i debiti di una persona verso l’altra in una sola obbligazione da stipulatio. • Solutio per aes et libram: atto formale con cui il debitore dichiarava solennemente di liberarsi dal potere del creditore in presenza di 5 testimoni, gettando sulla bilancia il bronzo; quando venne abolito il nexum divenne un modo per distinguere formalmente le obbligazioni. Utilizzata in questa epoca per estinguere il legato per damnationem. • Novatio (novazione): trasferimento e trasfusione di un precedente debito in un’altra obbligazione, con la necessità che vi fosse un qualcosa di nuovo, ad esempio il mutamento dei soggetti; fenomeno analogo era il nomen transcripticium. • Litis contestatio. • Impossibilità oggettiva della prestazione: quando la prestazione diventava impossibile per cause non imputabili al debitore, l’obbligazione era estinta; nulla però poteva rendere impossibile la prestazione quando si trattava di beni fungibili o denaro. Atti estintivi secondo il ius praetorium agenti ope exceptionis. • Acceptilatio expensilatio. • Pactum de non petendo: patto nel quale il creditore si impegna a non richiedere più l’adempimento del debitore. Nel caso in cui il creditore avesse richiesto lo stesso l’adempimento, il debitore avrebbe opposto l’exceptio pacti conventi. Potevano essere in rem, quando il creditore o il concreditore assumeva l'impegno che la prestazione non sarebbe stata richiesta, oppure in personam, quando il concreditore assumeva l'impegno che la prestazione non sarebbe stata richiesta al singolo condebitore con il quale stringeva il patto. • Morte : la morte del debitore estingueva le obbligazioni da delitto e anche quelle dello sponsor e del fidepromissor; la morte di uno dei contraenti estingueva società e mandati. • Capitis letterale: deminutio: quella serviva maxima a sciogliere estingueva il tutti vincolo i rapporti da e quindi anche le obbligazioni. • Con cursus causarum: quando un creditore che poteva pretendere una determinata cosa in forza di un rapporto giuridico, si ritrovava ad aver ricevuto quella cosa ad altro titolo. • Compensazione: compensazione giudiziale in quanto la sanzione era sempre pecuniaria; stabilita da Giustiniano, era l'imputazione in pagamento di ciò che il creditore deve a sua volta al debitore; si poteva opporre solo da parte dei banchieri (argentarii) e del bonorum emptor (colui che aveva comprato qualcosa dal debitore); comportava altresì la cessazione della mora, della decorrenza degli interessi e di tutte le altre obbligazioni accessorie. Requisito indispensabile era l'omogeneità degli oggetti: le due prestazioni dovevano avere per oggetto cose fungibili della stessa specie. Non si poteva opporre la compensazione contro i crediti del fisco, i mutui e i legati a favore dei municipia, i crediti nascenti da deposito, violenza, furto. Oggi la compensazione legale è automatica se debiti o crediti hanno come oggetto somme di denaro. • Confusione: concentrazione nella stessa persona della qualità di creditore e debitore, dovuta ad un evento giuridico; l'ipotesi più ricorrente era la confusio per successione nel credito, sia mortis causa che inter vivos. Si legge infatti nelle fonti che «se l'erede continuasse ad essere credito verso il debitore e in seguito lo stesso creditore morisse, il legato sarebbe estinto: e ciò è vero, poiché l'obbligazione si estingue allo stesso modo per confusione e per solutio»; la confusione operava quindi ipso iure l'estinzione dell'obbligazione, senza ulteriori formalità. • Contrarius consensus: mutuo dissenso, solo per contratti consensuali e solo se non ha avuto inizio la prestazione. • Decorso del tempo: : se il debitore non richiede la prestazione per un determinato lasso di tempo subentra la prescrizione; nel diritto romano esisteva solo per le azioni penali e il periodo di tempo era di 1 anno, le azioni civili sono rimaste imprescrittibili fino al V sec. quando Teodosio introdusse la prescrizione per 30 anni (nel nostro ordinamento: 5 o 10 anni).