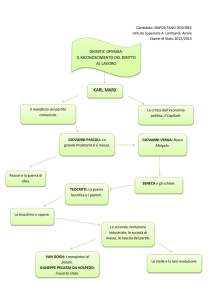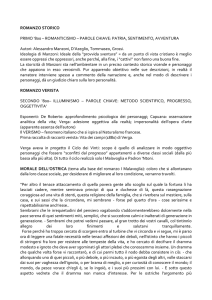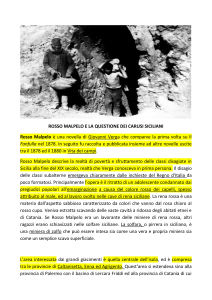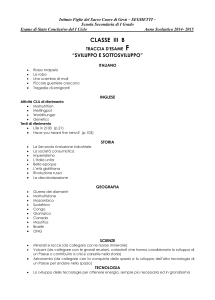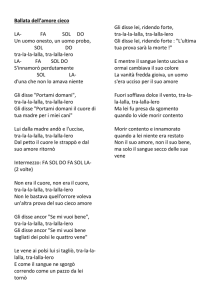caricato da
common.user8020
Testi Esame di Stato Italiano 2019-2020

ALLEGATO 3 Estratto dal programma di Lingua e Letteratura Italiana Esame di Stato 2019-2020 Testi per il colloquio 1 “L’infinito” (G. Leopardi) 2 “La sera del dì di festa” (G. Leopardi) 3 “A Silvia” (G. Leopardi) 4 “La quiete dopo la tempesta” (G. Leopardi) 5 “Il sabato del villaggio” (G. Leopardi) 6 “Il passero solitario” (G. Leopardi) 7 “A se stesso” (G. Leopardi) 8 “Rosso Malpelo” (G. Verga) 9 “La Lupa” (G. Verga) 10 e 11 “Come le dita della mano”, dal cap. I de “I Malavoglia” (G. Verga) 12 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”, dal cap. XV de “I Malavoglia” (G. Verga) 13 “La Morte di Mastro don Gesualdo” dal libro IV di “Mastro don Gesualdo” (G. Verga) 14 “Il conte Andrea Sperelli” dal cap. I, libro II de “Il piacere” (G. D’Annunzio) 15 “La prosa notturna” dal “Notturno” (G. D’Annunzio) 16 “La pioggia nel pineto” (G. D’Annunzio) 17 “Qui giacciono i miei cani” (G. D’Annunzio) 18 “Arano” (G. Pascoli) 19 “Novembre” (G. Pascoli) 20 “Temporale” (G. Pascoli) 21 “Il lampo” (G. Pascoli) 22 “X agosto” (G. Pascoli) 23 “L’assiuolo” (G. Pascoli) 24 “Italy” (cap.III, vv. 1-25; cap. IV, vv. 17-25) (G. Pascoli) 25 “Italy” (cap. VI, vv. 1-25; VII 7-25; VIII 7-18 ) (G. Pascoli) 26 “Il gelsomino notturno” (G. Pascoli) 27 “Prefazione” e “Preambolo” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) 28 “La morte del padre” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) 29 “La salute “malata” di Augusta” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) 30 “La profezia di un’apocalisse cosmica” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) 31 “Ciàula scopre la luna” (L. Pirandello) 32 “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, dai capp. VIII e IX de “Il Fu Mattia Pascal” (L. Pirandello) 33 “Non mi saprei proprio dire ch’io mi sia” dal cap. XVIII de “Il fu Mattia Pascal” (L. Pirandello) 34 “Veglia” (G. Ungaretti) 35 “San Martino del Carso” (G. Ungaretti) 36 “Viatico” (C. Rebora) 37 “Voce di vedetta morta” (C. Rebora) 38 “Mio padre è stato per me l’assassino” (U. Saba) 39 “La confessione alla madre” da “Ernesto” (U. Saba) 40 “Meriggiare pallido e assorto “(E. Montale) 41 “Spesso il male di vivere ho incontrato” (E. Montale) 1- “L’infinito” (G. Leopardi) Sempre caro mi fu quest'ermo colle, E questa siepe, che da tanta parte Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati Spazi di là da quella, e sovrumani Silenzi, e profondissima quiete Io nel pensier mi fingo; ove per poco Il cor non si spaura. E come il vento Odo stormir tra queste piante, io quello Infinito silenzio a questa voce Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, E le morte stagioni, e la presente E viva, e il suon di lei. Così tra questa Immensità s'annega il pensier mio: E il naufragar m'è dolce in questo mare. 2- “La sera del dì di festa” (G. Leopardi) Dolce e chiara è la notte e senza vento, E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti Posa la luna, e di lontan rivela Serena ogni montagna. O donna mia, Già tace ogni sentiero, e pei balconi Rara traluce la notturna lampa: Tu dormi, che t'accolse agevol sonno Nelle tue chete stanze; e non ti morde Cura nessuna; e già non sai nè pensi Quanta piaga m'apristi in mezzo al petto. Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno Appare in vista, a salutar m'affaccio, E l'antica natura onnipossente, Che mi fece all'affanno. A te la speme Nego, mi disse, anche la speme; e d'altro Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. Questo dì fu solenne: or da' trastulli Prendi riposo; e forse ti rimembra In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti Piacquero a te: non io, non già, ch'io speri, Al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo Quanto a viver mi resti, e qui per terra Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi In così verde etate! Ahi, per la via Odo non lunge il solitario canto Dell'artigian, che riede a tarda notte, Dopo i sollazzi, al suo povero ostello; E fieramente mi si stringe il core, A pensar come tutto al mondo passa, E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito Il dì festivo, ed al festivo il giorno Volgar succede, e se ne porta il tempo Ogni umano accidente. Or dov'è il suono Di que' popoli antichi? or dov'è il grido De' nostri avi famosi, e il grande impero Di quella Roma, e l'armi, e il fragorio Che n'andò per la terra e l'oceano? Tutto è pace e silenzio, e tutto posa Il mondo, e più di lor non si ragiona. Nella mia prima età, quando s'aspetta Bramosamente il dì festivo, or poscia Ch'egli era spento, io doloroso, in veglia, Premea le piume; ed alla tarda notte Un canto che s'udia per li sentieri Lontanando morire a poco a poco, Già similmente mi stringeva il core. 3- “A Silvia” (G. Leopardi) Silvia, rimembri ancora Quel tempo della tua vita mortale, Quando beltà splendea Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, E tu, lieta e pensosa, il limitare Di gioventù salivi? Sonavan le quiete Stanze, e le vie dintorno, Al tuo perpetuo canto, Allor che all'opre femminili intenta Sedevi, assai contenta Di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso: e tu solevi Così menare il giorno. Io gli studi leggiadri Talor lasciando e le sudate carte, Ove il tempo mio primo E di me si spendea la miglior parte, D'in su i veroni del paterno ostello Porgea gli orecchi al suon della tua voce, Ed alla man veloce Che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, Le vie dorate e gli orti, E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. Lingua mortal non dice Quel ch'io sentiva in seno. Che pensieri soavi, Che speranze, che cori, o Silvia mia! Quale allor ci apparia La vita umana e il fato! Quando sovviemmi di cotanta speme, Un affetto mi preme Acerbo e sconsolato, E tornami a doler di mia sventura. O natura, o natura, Perchè non rendi poi Quel che prometti allor? perchè di tanto Inganni i figli tuoi? Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, Da chiuso morbo combattuta e vinta, Perivi, o tenerella. E non vedevi Il fior degli anni tuoi; Non ti molceva il core La dolce lode or delle negre chiome, Or degli sguardi innamorati e schivi; Nè teco le compagne ai dì festivi Ragionavan d'amore Anche peria fra poco La speranza mia dolce: agli anni miei Anche negaro i fati La giovanezza. Ahi come, Come passata sei, Cara compagna dell'età mia nova, Mia lacrimata speme! Questo è quel mondo? questi I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi Onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte dell'umane genti? All'apparir del vero Tu, misera, cadesti: e con la mano La fredda morte ed una tomba ignuda Mostravi di lontano. 4- “La quiete dopo la tempesta” (G. Leopardi) Passata è la tempesta: Odo augelli far festa, e la gallina, Tornata in su la via, Che ripete il suo verso. Ecco il sereno Rompe là da ponente, alla montagna; Sgombrasi la campagna, E chiaro nella valle il fiume appare. Ogni cor si rallegra, in ogni lato Risorge il romorio Torna il lavoro usato. L'artigiano a mirar l'umido cielo, Con l'opra in man, cantando, Fassi in su l'uscio; a prova Vien fuor la femminetta a còr dell'acqua Della novella piova; E l'erbaiuol rinnova Di sentiero in sentiero Il grido giornaliero. Ecco il Sol che ritorna, ecco sorride Per li poggi e le ville. Apre i balconi, Apre terrazzi e logge la famiglia: E, dalla via corrente, odi lontano Tintinnio di sonagli; il carro stride Del passegger che il suo cammin ripiglia. Si rallegra ogni core. Sì dolce, sì gradita Quand'è, com'or, la vita? Quando con tanto amore L'uomo a' suoi studi intende? O torna all'opre? o cosa nova imprende? Quando de' mali suoi men si ricorda? Piacer figlio d'affanno; Gioia vana, ch'è frutto Del passato timore, onde si scosse E paventò la morte Chi la vita abborria; Onde in lungo tormento, Fredde, tacite, smorte, Sudàr le genti e palpitàr, vedendo Mossi alle nostre offese Folgori, nembi e vento. O natura cortese, Son questi i doni tuoi, Questi i diletti sono Che tu porgi ai mortali. Uscir di pena E' diletto fra noi. Pene tu spargi a larga mano; il duolo Spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto Che per mostro e miracolo talvolta Nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana Prole cara agli eterni! assai felice Se respirar ti lice D'alcun dolor: beata Se te d'ogni dolor morte risana. 5- “Il sabato del villaggio” (G. Leopardi) La donzelletta vien dalla campagna, In sul calar del sole, Col suo fascio dell'erba; e reca in mano Un mazzolin di rose e di viole, Onde, siccome suole, Ornare ella si appresta Dimani, al dì di festa, il petto e il crine. Siede con le vicine Su la scala a filar la vecchierella, Incontro là dove si perde il giorno; E novellando vien del suo buon tempo, Quando ai dì della festa ella si ornava, Ed ancor sana e snella Solea danzar la sera intra di quei Ch'ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria imbruna, Torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre Giù da' colli e da' tetti, Al biancheggiar della recente luna. Or la squilla dà segno Della festa che viene; Ed a quel suon diresti Che il cor si riconforta. I fanciulli gridando Su la piazzuola in frotta, E qua e là saltando, Fanno un lieto romore: E intanto riede alla sua parca mensa, Fischiando, il zappatore, E seco pensa al dì del suo riposo. Poi quando intorno è spenta ogni altra face, E tutto l'altro tace, Odi il martel picchiare, odi la sega Del legnaiuol, che veglia Nella chiusa bottega alla lucerna, E s'affretta, e s'adopra Di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno, Pien di speme e di gioia: Diman tristezza e noia Recheran l'ore, ed al travaglio usato Ciascuno in suo pensier farà ritorno. Garzoncello scherzoso, Cotesta età fiorita E' come un giorno d'allegrezza pieno, Giorno chiaro, sereno, Che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio; stato soave, Stagion lieta è cotesta. Altro dirti non vo'; ma la tua festa Ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 6- “Il passero solitario” (G. Leopardi) D'in su la vetta della torre antica, Passero solitario, alla campagna Cantando vai finchè non more il giorno; Ed erra l'armonia per questa valle. Primavera dintorno Brilla nell'aria, e per li campi esulta, Sì ch'a mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti; Gli altri augelli contenti, a gara insieme Per lo libero ciel fan mille giri, Pur festeggiando il lor tempo migliore: Tu pensoso in disparte il tutto miri; Non compagni, non voli, Non ti cal d'allegria, schivi gli spassi; Canti, e così trapassi Dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia Al tuo costume il mio! Sollazzo e riso, Della novella età dolce famiglia, E te german di giovinezza, amore, Sospiro acerbo de' provetti giorni Non curo, io non so come; anzi da loro Quasi fuggo lontano; Quasi romito, e strano Al mio loco natio, Passo del viver mio la primavera. Questo giorno ch'omai cede alla sera, Festeggiar si costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, Odi spesso un tonar di ferree canne, Che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa La gioventù del loco Lascia le case, e per le vie si spande; E mira ed è mirata, e in cor s'allegra. Io solitario in questa Rimota parte alla campagna uscendo, Ogni diletto e gioco Indugio in altro tempo: e intanto il guardo Steso nell'aria aprica Mi fere il Sol che tra lontani monti, Dopo il giorno sereno, Cadendo si dilegua, e par che dica Che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo augellin, venuto a sera Del viver che daranno a te le stelle, Certo del tuo costume Non ti dorrai; che di natura è frutto Ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza La detestata soglia Evitar non impetro, Quando muti questi occhi all'altrui core, E lor fia voto il mondo, e il dì futuro Del dì presente più noioso e tetro, Che parrà di tal voglia? Che di quest'anni miei? che di me stesso? Ahi pentirommi, e spesso, Ma sconsolato, volgerommi indietro. 7- “A se stesso” (G. Leopardi) Or poserai per sempre, Stanco mio cor. Perì l'inganno estremo, Ch'eterno io mi credei. Perì. Ben sento, In noi di cari inganni, Non che la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre. Assai Palpitasti. Non val cosa nessuna I moti tuoi, nè di sospiri è degna La terra. Amaro e noia La vita, altro mai nulla; e fango è il mondo. T'acqueta omai. Dispera L'ultima volta. Al gener nostro il fato Non donò che il morire. Omai disprezza Te, la natura, il brutto Poter che, ascoso, a comun danno impera, E l'infinita vanità del tutto. 8- “Rosso Malpelo” (G. Verga) Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, allorché se lo trovavano a tiro. Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra, e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincantucciarsi col suo corbello fra le gambe, per rosicchiarsi quel po' di pane bigio, come fanno le bestie sue pari, e ciascuno gli diceva la sua, motteggiandolo, e gli tiravan dei sassi, finché il soprastante lo rimandava al lavoro con una pedata. Ei c'ingrassava, fra i calci, e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio, senza osar di lagnarsi. Era sempre cencioso e sporco di rena rossa, che la sua sorella s'era fatta sposa, e aveva altro pel capo che pensare a ripulirlo la domenica. Nondimeno era conosciuto come la bettonica per tutto Monserrato e la Caverna, tanto che la cava dove lavorava la chiamavano «la cava di Malpelo», e cotesto al padrone gli seccava assai. Insomma lo tenevano addirittura per carità e perché mastro Misciu, suo padre, era morto in quella stessa cava. Era morto così, che un sabato aveva voluto terminare certo lavoro preso a cottimo, di un pilastro lasciato altra volta per sostegno dell'ingrottato, e dacché non serviva più, s'era calcolato, così ad occhio col padrone, per 35 o 40 carra di rena. Invece mastro Misciu sterrava da tre giorni, e ne avanzava ancora per la mezza giornata del lunedì. Era stato un magro affare e solo un minchione come mastro Misciu aveva potuto lasciarsi gabbare a questo modo dal padrone; perciò appunto lo chiamavano mastro Misciu Bestia, ed era l'asino da basto di tutta la cava. Ei, povero diavolaccio, lasciava dire, e si contentava di buscarsi il pane colle sue braccia, invece di menarle addosso ai compagni, e attaccar brighe. Malpelo faceva un visaccio, come se quelle soperchierie cascassero sulle sue spalle, e così piccolo com'era aveva di quelle occhiate che facevano dire agli altri: - Va là, che tu non ci morrai nel tuo letto, come tuo padre -. Invece nemmen suo padre ci morì, nel suo letto, tuttoché fosse una buona bestia. Zio Mommu lo sciancato, aveva detto che quel pilastro lì ei non l'avrebbe tolto per venti onze, tanto era pericoloso; ma d'altra parte tutto è pericolo nelle cave, e se si sta a badare a tutte le sciocchezze che si dicono, è meglio andare a fare l'avvocato. Dunque il sabato sera mastro Misciu raschiava ancora il suo pilastro che l'avemaria era suonata da un pezzo, e tutti i suoi compagni avevano accesa la pipa e se n'erano andati dicendogli di divertirsi a grattar la rena per amor del padrone, o raccomandandogli di non fare la morte del sorcio. Ei, che c'era avvezzo alle beffe, non dava retta, e rispondeva soltanto cogli «ah! ah!» dei suoi bei colpi di zappa in pieno, e intanto borbottava: - Questo è per il pane! Questo pel vino! Questo per la gonnella di Nunziata! - e così andava facendo il conto del come avrebbe speso i denari del suo appalto, il cottimante! Fuori della cava il cielo formicolava di stelle, e laggiù la lanterna fumava e girava al pari di un arcolaio. Il grosso pilastro rosso, sventrato a colpi di zappa, contorcevasi e si piegava in arco, come se avesse il mal di pancia, e dicesse ohi! anch'esso. Malpelo andava sgomberando il terreno, e metteva al sicuro il piccone, il sacco vuoto ed il fiasco del vino. Il padre, che gli voleva bene, poveretto, andava dicendogli: - Tirati in là! oppure: - Sta attento! Bada se cascano dall'alto dei sassolini o della rena grossa, e scappa! - Tutt'a un tratto, punf! Malpelo, che si era voltato a riporre i ferri nel corbello, udì un tonfo sordo, come fa la rena traditora allorché fa pancia e si sventra tutta in una volta, ed il lume si spense. L'ingegnere che dirigeva i lavori della cava, si trovava a teatro quella sera, e non avrebbe cambiato la sua poltrona con un trono, quando vennero a cercarlo per il babbo di Malpelo che aveva fatto la morte del sorcio. Tutte le femminucce di Monserrato, strillavano e si picchiavano il petto per annunziare la gran disgrazia ch'era toccata a comare Santa, la sola, poveretta, che non dicesse nulla, e sbatteva i denti invece, quasi avesse la terzana. L'ingegnere, quando gli ebbero detto il come e il quando, che la disgrazia era accaduta da circa tre ore, e Misciu Bestia doveva già essere bell'e arrivato in Paradiso, andò proprio per scarico di coscienza, con scale e corde, a fare il buco nella rena. Altro che quaranta carra! Lo sciancato disse che a sgomberare il sotterraneo ci voleva almeno una settimana. Della rena ne era caduta una montagna, tutta fina e ben bruciata dalla lava, che si sarebbe impastata colle mani, e dovea prendere il doppio di calce. Ce n'era da riempire delle carra per delle settimane. Il bell'affare di mastro Bestia! Nessuno badava al ragazzo che si graffiava la faccia ed urlava, come una bestia davvero. - To'! - disse infine uno. - È Malpelo! Di dove è saltato fuori, adesso? - Se non fosse stato Malpelo non se la sarebbe passata liscia... Malpelo non rispondeva nulla, non piangeva nemmeno, scavava colle unghie colà, nella rena, dentro la buca, sicché nessuno s'era accorto di lui; e quando si accostarono col lume, gli videro tal viso stravolto, e tali occhiacci invetrati, e la schiuma alla bocca da far paura; le unghie gli si erano strappate e gli pendevano dalle mani tutte in sangue. Poi quando vollero toglierlo di là fu un affar serio; non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato, e dovettero afferrarlo pei capelli, per tirarlo via a viva forza. Però infine tornò alla cava dopo qualche giorno, quando sua madre piagnucolando ve lo condusse per mano; giacché, alle volte, il pane che si mangia non si può andare a cercarlo di qua e di là. Lui non volle più allontanarsi da quella galleria, e sterrava con accanimento, quasi ogni corbello di rena lo levasse di sul petto a suo padre. Spesso, mentre scavava, si fermava bruscamente, colla zappa in aria, il viso torvo e gli occhi stralunati, e sembrava che stesse ad ascoltare qualche cosa che il suo diavolo gli susurrasse nelle orecchie, dall'altra parte della montagna di rena caduta. In quei giorni era più tristo e cattivo del solito, talmente che non mangiava quasi, e il pane lo buttava al cane, quasi non fosse grazia di Dio. Il cane gli voleva bene, perché i cani non guardano altro che la mano che gli dà il pane, e le botte, magari. Ma l'asino, povera bestia, sbilenco e macilento, sopportava tutto lo sfogo della cattiveria di Malpelo; ei lo picchiava senza pietà, col manico della zappa, e borbottava: - Così creperai più presto! Dopo la morte del babbo pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo, e lavorava al pari di quei bufali feroci che si tengono coll'anello di ferro al naso. Sapendo che era malpelo, ei si acconciava ad esserlo il peggio che fosse possibile, e se accadeva una disgrazia, o che un operaio smarriva i ferri, o che un asino si rompeva una gamba, o che crollava un tratto di galleria, si sapeva sempre che era stato lui; e infatti ei si pigliava le busse senza protestare, proprio come se le pigliano gli asini che curvano la schiena, ma seguitano a fare a modo loro. Cogli altri ragazzi poi era addirittura crudele, e sembrava che si volesse vendicare sui deboli di tutto il male che s'immaginava gli avessero fatto gli altri, a lui e al suo babbo. Certo ei provava uno strano diletto a rammentare ad uno ad uno tutti i maltrattamenti ed i soprusi che avevano fatto subire a suo padre, e del modo in cui l'avevano lasciato crepare. E quando era solo borbottava: - Anche con me fanno così! e a mio padre gli dicevano Bestia, perché egli non faceva così! - E una volta che passava il padrone, accompagnandolo con un'occhiata torva: - È stato lui! per trentacinque tarì! - E un'altra volta, dietro allo Sciancato: E anche lui! e si metteva a ridere! Io l'ho udito, quella sera! Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto, venuto a lavorare da poco tempo nella cava, il quale per una caduta da un ponte s'era lussato il femore, e non poteva far più il manovale. Il poveretto, quando portava il suo corbello di rena in spalla, arrancava in modo che gli avevano messo nome Ranocchio; ma lavorando sotterra, così Ranocchio com'era, il suo pane se lo buscava. Malpelo gliene dava anche del suo, per prendersi il gusto di tiranneggiarlo, dicevano. Infatti egli lo tormentava in cento modi. Ora lo batteva senza un motivo e senza misericordia, e se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggiore accanimento, dicendogli: - To', bestia! Bestia sei! Se non ti senti l'animo di difenderti da me che non ti voglio male, vuol dire che ti lascerai pestare il viso da questo e da quello! O se Ranocchio si asciugava il sangue che gli usciva dalla bocca e dalle narici: - Così, come ti cuocerà il dolore delle busse, imparerai a darne anche tu! Quando cacciava un asino carico per la ripida salita del sotterraneo, e lo vedeva puntare gli zoccoli, rifinito, curvo sotto il peso, ansante e coll'occhio spento, ei lo batteva senza misericordia, col manico della zappa, e i colpi suonavano secchi sugli stinchi e sulle costole scoperte. Alle volte la bestia si piegava in due per le battiture, ma stremo di forze, non poteva fare un passo, e cadeva sui ginocchi, e ce n'era uno il quale era caduto tante volte, che ci aveva due piaghe alle gambe. Malpelo soleva dire a Ranocchio: - L'asino va picchiato, perché non può picchiar lui; e s'ei potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi -. Oppure: - Se ti accade di dar delle busse, procura di darle più forte che puoi; così gli altri ti terranno da conto, e ne avrai tanti di meno addosso -. Lavorando di piccone o di zappa poi menava le mani con accanimento, a mo' di uno che l'avesse con la rena, e batteva e ribatteva coi denti stretti, e con quegli ah! ah! che aveva suo padre. - La rena è traditora, - diceva a Ranocchio sottovoce; - somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, e se sei più forte, o siete in molti, come fa lo Sciancato, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre, ed egli non batteva altro che la rena, perciò lo chiamavano Bestia, e la rena se lo mangiò a tradimento, perché era più forte di lui -. Ogni volta che a Ranocchio toccava un lavoro troppo pesante, e il ragazzo piagnucolava a guisa di una femminuccia, Malpelo lo picchiava sul dorso, e lo sgridava: - Taci, pulcino! - e se Ranocchio non la finiva più, ei gli dava una mano, dicendo con un certo orgoglio: - Lasciami fare; io sono più forte di te -. Oppure gli dava la sua mezza cipolla, e si contentava di mangiarsi il pane asciutto, e si stringeva nelle spalle, aggiungendo: - Io ci sono avvezzo -. Era avvezzo a tutto lui, agli scapaccioni, alle pedate, ai colpi di manico di badile, o di cinghia da basto, a vedersi ingiuriato e beffato da tutti, a dormire sui sassi colle braccia e la schiena rotta da quattordici ore di lavoro; anche a digiunare era avvezzo, allorché il padrone lo puniva levandogli il pane o la minestra. Ei diceva che la razione di busse non gliel'aveva levata mai, il padrone; ma le busse non costavano nulla. Non si lamentava però, e si vendicava di soppiatto, a tradimento, con qualche tiro di quelli che sembrava ci avesse messo la coda il diavolo: perciò ei si pigliava sempre i castighi, anche quando il colpevole non era stato lui. Già se non era stato lui sarebbe stato capace di esserlo, e non si giustificava mai: per altro sarebbe stato inutile. E qualche volta, come Ranocchio spaventato lo scongiurava piangendo di dire la verità, e di scolparsi, ei ripeteva: - A che giova? Sono malpelo! - e nessuno avrebbe potuto dire se quel curvare il capo e le spalle sempre fosse effetto di fiero orgoglio o di disperata rassegnazione, e non si sapeva nemmeno se la sua fosse salvatichezza o timidità. Il certo era che nemmeno sua madre aveva avuta mai una carezza da lui, e quindi non gliene faceva mai. Il sabato sera, appena arrivava a casa con quel suo visaccio imbrattato di lentiggini e di rena rossa, e quei cenci che gli piangevano addosso da ogni parte, la sorella afferrava il manico della scopa, scoprendolo sull'uscio in quell'arnese, ché avrebbe fatto scappare il suo damo se vedeva con qual gente gli toccava imparentarsi; la madre era sempre da questa o da quella vicina, e quindi egli andava a rannicchiarsi sul suo saccone come un cane malato. Per questo, la domenica, in cui tutti gli altri ragazzi del vicinato si mettevano la camicia pulita per andare a messa o per ruzzare nel cortile, ei sembrava non avesse altro spasso che di andar randagio per le vie degli orti, a dar la caccia alle lucertole e alle altre povere bestie che non gli avevano fatto nulla, oppure a sforacchiare le siepi dei fichidindia. Per altro le beffe e le sassate degli altri fanciulli non gli piacevano. La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel malarnese, come dicevano tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi dei calci e delle sassate da questo e da quello, finiscono col mettersi la coda fra le gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati, spelati e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto, cencioso e lercio com'era, non lo beffavano più, e sembrava fatto apposta per quel mestiere persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni ed anni senza uscirne mai più, ed in quei sotterranei, dove il pozzo d'ingresso è a picco, ci si calan colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva di più; se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani per aiutarsi colla fune, e doveva andare a portare a sua madre la paga della settimana. Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, e lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo all'azzurro del cielo, col sole sulla schiena, - o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava tutto il giorno per le belle strade di campagna; - o meglio ancora, avrebbe voluto fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo ai verde, sotto i folti carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma quello era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. E pensando a tutto ciò, narrava a Ranocchio del pilastro che era caduto addosso al genitore, e dava ancora della rena fina e bruciata che il carrettiere veniva a caricare colla pipa in bocca, e dondolandosi sulle stanghe, e gli diceva che quando avrebbero finito di sterrare si sarebbe trovato il cadavere del babbo, il quale doveva avere dei calzoni di fustagno quasi nuovi. Ranocchio aveva paura, ma egli no. Ei pensava che era stato sempre là, da bambino, e aveva sempre visto quel buco nero, che si sprofondava sotterra, dove il padre soleva condurlo per mano. Allora stendeva le braccia a destra e a sinistra, e descriveva come l'intricato laberinto delle gallerie si stendesse sotto i loro piedi all'infinito, di qua e di là, sin dove potevano vedere la sciara nera e desolata, sporca di ginestre riarse, e come degli uomini ce n'erano rimasti tanti, o schiacciati, o smarriti nel buio, e che camminano da anni e camminano ancora, senza poter scorgere lo spiraglio del pozzo pel quale sono entrati, e senza poter udire le strida disperate dei figli, i quali li cercano inutilmente. Ma una volta in cui riempiendo i corbelli si rinvenne una delle scarpe di mastro Misciu, ei fu colto da tal tremito che dovettero tirarlo all'aria aperta colle funi, proprio come un asino che stesse per dar dei calci al vento. Però non si poterono trovare né i calzoni quasi nuovi, né il rimanente di mastro Misciu; sebbene i pratici affermarono che quello dovea essere il luogo preciso dove il pilastro gli si era rovesciato addosso; e qualche operaio, nuovo al mestiere, osservava curiosamente come fosse capricciosa la rena, che aveva sbatacchiato il Bestia di qua e di là, le scarpe da una parte e i piedi dall'altra. Dacché poi fu trovata quella scarpa, Malpelo fu colto da tal paura di veder comparire fra la rena anche il piede nudo del babbo, che non volle mai più darvi un colpo di zappa, gliela dessero a lui sul capo, la zappa. Egli andò a lavorare in un altro punto della galleria, e non volle più tornare da quelle parti. Due o tre giorni dopo scopersero infatti il cadavere di mastro Misciu, coi calzoni indosso, e steso bocconi che sembrava imbalsamato. Lo zio Mommu osservò che aveva dovuto penar molto a finire, perché il pilastro gli si era piegato proprio addosso, e l'aveva sepolto vivo: si poteva persino vedere tutt'ora che mastro Bestia avea tentato istintivamente di liberarsi scavando nella rena, e avea le mani lacerate e le unghie rotte. - Proprio come suo figlio Malpelo! - ripeteva lo sciancato - ei scavava di qua, mentre suo figlio scavava di là -. Però non dissero nulla al ragazzo, per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. Il carrettiere si portò via il cadavere di mastro Misciu al modo istesso che caricava la rena caduta e gli asini morti, ché stavolta, oltre al lezzo del carcame, trattavasi di un compagno, e di carne battezzata. La vedova rimpiccolì i calzoni e la camicia, e li adattò a Malpelo, il quale così fu vestito quasi a nuovo per la prima volta. Solo le scarpe furono messe in serbo per quando ei fosse cresciuto, giacché rimpiccolire le scarpe non si potevano, e il fidanzato della sorella non le aveva volute le scarpe del morto. Malpelo se li lisciava sulle gambe, quei calzoni di fustagno quasi nuovi, gli pareva che fossero dolci e lisci come le mani del babbo, che solevano accarezzargli i capelli, quantunque fossero così ruvide e callose. Le scarpe poi, le teneva appese a un chiodo, sul saccone, quasi fossero state le pantofole del papa, e la domenica se le pigliava in mano, le lustrava e se le provava; poi le metteva per terra, l'una accanto all'altra, e stava a guardarle, coi gomiti sui ginocchi, e il mento nelle palme, per delle ore intere, rimuginando chi sa quali idee in quel cervellaccio. Ei possedeva delle idee strane, Malpelo! Siccome aveva ereditato anche il piccone e la zappa del padre, se ne serviva, quantunque fossero troppo pesanti per l'età sua; e quando gli aveano chiesto se voleva venderli, che glieli avrebbero pagati come nuovi, egli aveva risposto di no. Suo padre li aveva resi così lisci e lucenti nel manico colle sue mani, ed ei non avrebbe potuto farsene degli altri più lisci e lucenti di quelli, se ci avesse lavorato cento e poi cento anni. In quel tempo era crepato di stenti e di vecchiaia l'asino grigio; e il carrettiere era andato a buttarlo lontano nella sciara. - Così si fa, - brontolava Malpelo; - gli arnesi che non servono più, si buttano lontano -. Egli andava a visitare il carcame del grigio in fondo al burrone, e vi conduceva a forza anche Ranocchio, il quale non avrebbe voluto andarci; e Malpelo gli diceva che a questo mondo bisogna avvezzarsi a vedere in faccia ogni cosa, bella o brutta; e stava a considerare con l'avida curiosità di un monellaccio i cani che accorrevano da tutte le fattorie dei dintorni a disputarsi le carni del grigio. I cani scappavano guaendo, come comparivano i ragazzi, e si aggiravano ustolando sui greppi dirimpetto, ma il Rosso non lasciava che Ranocchio li scacciasse a sassate. - Vedi quella cagna nera, - gli diceva, - che non ha paura delle tue sassate? Non ha paura perché ha più fame degli altri. Gliele vedi quelle costole al grigio? Adesso non soffre più -. L'asino grigio se ne stava tranquillo, colle quattro zampe distese, e lasciava che i cani si divertissero a vuotargli le occhiaie profonde, e a spolpargli le ossa bianche; i denti che gli laceravano le viscere non lo avrebbero fatto piegare di un pelo, come quando gli accarezzavano la schiena a badilate, per mettergli in corpo un po' di vigore nel salire la ripida viuzza. - Ecco come vanno le cose! Anche il grigio ha avuto dei colpi di zappa e delle guidalesche; anch'esso quando piegava sotto il peso, o gli mancava il fiato per andare innanzi, aveva di quelle occhiate, mentre lo battevano, che sembrava dicesse: «Non più! non più!». Ma ora gli occhi se li mangiano i cani, ed esso se ne ride dei colpi e delle guidalesche, con quella bocca spolpata e tutta denti. Ma se non fosse mai nato sarebbe stato meglio -. La sciara si stendeva malinconica e deserta, fin dove giungeva la vista, e saliva e scendeva in picchi e burroni, nera e rugosa, senza un grillo che vi trillasse, o un uccello che venisse a cantarci. Non si udiva nulla, nemmeno i colpi di piccone di coloro che lavoravano sotterra. E ogni volta Malpelo ripeteva che la terra lì sotto era tutta vuota dalle gallerie, per ogni dove, verso il monte e verso la valle; tanto che una volta un minatore c'era entrato da giovane, e n'era uscito coi capelli bianchi, e un altro, cui s'era spenta la candela, aveva invano gridato aiuto per anni ed anni. - Egli solo ode le sue stesse grida! - diceva, e a quell'idea, sebbene avesse il cuore più duro della sciara, trasaliva. - Il padrone mi manda spesso lontano, dove gli altri hanno paura d'andare. Ma io sono Malpelo, e se non torno più, nessuno mi cercherà -. Pure, durante le belle notti d'estate, le stelle splendevano lucenti anche sulla sciara, e la campagna circostante era nera anch'essa, come la lava, ma Malpelo, stanco della lunga giornata di lavoro, si sdraiava sul sacco, col viso verso il cielo, a godersi quella quiete e quella luminaria dell'alto; perciò odiava le notti di luna, in cui il mare formicola di scintille, e la campagna si disegna qua e là vagamente - perché allora la sciara sembra più bella e desolata. - Per noi che siamo fatti per vivere sotterra, - pensava Malpelo, - dovrebbe essere buio sempre e da per tutto -. La civetta strideva sulla sciara, e ramingava di qua e di là; ei pensava: - Anche la civetta sente i morti che son qua sotterra, e si dispera perché non può andare a trovarli -. Ranocchio aveva paura delle civette e dei pipistrelli; ma il Rosso lo sgridava, perché chi è costretto a star solo non deve aver paura di nulla, e nemmeno l'asino grigio aveva paura dei cani che se lo spolpavano, ora che le sue carni non sentivano più il dolore di esser mangiate. - Tu eri avvezzo a lavorar sui tetti come i gatti, - gli diceva, - e allora era tutt'altra cosa. Ma adesso che ti tocca a viver sotterra, come i topi, non bisogna più aver paura dei topi, né dei pipistrelli, che son topi vecchi con le ali; quelli ci stanno volentieri in compagnia dei morti -. Ranocchio invece provava una tale compiacenza a spiegargli quel che ci stessero a far le stelle lassù in alto; e gli raccontava che lassù c'era il paradiso, dove vanno a stare i morti che sono stati buoni, e non hanno dato dispiaceri ai loro genitori. - Chi te l'ha detto? - domandava Malpelo, e Ranocchio rispondeva che glielo aveva detto la mamma. Allora Malpelo si grattava il capo, e sorridendo gli faceva un certo verso da monellaccio malizioso che la sa lunga. - Tua madre ti dice così perché, invece dei calzoni, tu dovresti portar la gonnella -. E dopo averci pensato un po': - Mio padre era buono, e non faceva male a nessuno, tanto che lo chiamavano Bestia. Invece è là sotto, ed hanno persino trovato i ferri, le scarpe e questi calzoni qui che ho indosso io -. Da lì a poco, Ranocchio, il quale deperiva da qualche tempo, si ammalò in modo che la sera dovevano portarlo fuori dalla cava sull'asino, disteso fra le corbe, tremante di febbre come un pulcin bagnato. Un operaio disse che quel ragazzo non ne avrebbe fatto osso duro a quel mestiere, e che per lavorare in una miniera, senza lasciarvi la pelle, bisognava nascervi. Malpelo allora si sentiva orgoglioso di esserci nato, e di mantenersi così sano e vigoroso in quell'aria malsana, e con tutti quegli stenti. Ei si caricava Ranocchio sulle spalle, e gli faceva animo alla sua maniera, sgridandolo e picchiandolo. Ma una volta, nel picchiarlo sul dorso, Ranocchio fu colto da uno sbocco di sangue; allora Malpelo spaventato si affannò a cercargli nel naso e dentro la bocca cosa gli avesse fatto, e giurava che non avea potuto fargli poi gran male, così come l'aveva battuto, e a dimostrarglielo, si dava dei gran pugni sul petto e sulla schiena, con un sasso; anzi un operaio, lì presente, gli sferrò un gran calcio sulle spalle: un calcio che risuonò come su di un tamburo, eppure Malpelo non si mosse, e soltanto dopo che l'operaio se ne fu andato, aggiunse: - Lo vedi? Non mi ha fatto nulla! E ha picchiato più forte di me, ti giuro! Intanto Ranocchio non guariva, e seguitava a sputar sangue, e ad aver la febbre tutti i giorni. Allora Malpelo prese dei soldi della paga della settimana, per comperargli del vino e della minestra calda, e gli diede i suoi calzoni quasi nuovi, che lo coprivano meglio. Ma Ranocchio tossiva sempre, e alcune volte sembrava soffocasse; la sera poi non c'era modo di vincere il ribrezzo della febbre, né con sacchi, né coprendolo di paglia, né mettendolo dinanzi alla fiammata. Malpelo se ne stava zitto ed immobile, chino su di lui, colle mani sui ginocchi, fissandolo con quei suoi occhiacci spalancati, quasi volesse fargli il ritratto, e allorché lo udiva gemere sottovoce, e gli vedeva il viso trafelato e l'occhio spento, preciso come quello dell'asino grigio allorché ansava rifinito sotto il carico nel salire la viottola, egli borbottava: - È meglio che tu crepi presto! Se devi soffrire a quel modo, è meglio che tu crepi! E il padrone diceva che Malpelo era capace di schiacciargli il capo, a quel ragazzo, e bisognava sorvegliarlo. Finalmente un lunedì Ranocchio non venne più alla cava, e il padrone se ne lavò le mani, perché allo stato in cui era ridotto oramai era più di impiccio che altro. Malpelo si informò dove stesse di casa, e il sabato andò a trovarlo. Il povero Ranocchio era più di là che di qua; sua madre piangeva e si disperava come se il figliuolo fosse di quelli che guadagnano dieci lire la settimana. Cotesto non arrivava a comprenderlo Malpelo, e domandò a Ranocchio perché sua madre strillasse a quel modo, mentre che da due mesi ei non guadagnava nemmeno quel che si mangiava. Ma il povero Ranocchio non gli dava retta; sembrava che badasse a contare quanti travicelli c'erano sul tetto. Allora il Rosso si diede ad almanaccare che la madre di Ranocchio strillasse a quel modo perché il suo figliuolo era sempre stato debole e malaticcio, e l'aveva tenuto come quei marmocchi che non si slattano mai. Egli invece era stato sano e robusto, ed era malpelo, e sua madre non aveva mai pianto per lui, perché non aveva mai avuto timore di perderlo. Poco dopo, alla cava dissero che Ranocchio era morto, ed ei pensò che la civetta adesso strideva anche per lui la notte, e tornò a visitare le ossa spolpate del grigio, nel burrone dove solevano andare insieme con Ranocchio. Ora del grigio non rimanevano più che le ossa sgangherate, ed anche di Ranocchio sarebbe stato così. Sua madre si sarebbe asciugati gli occhi, poiché anche la madre di Malpelo s'era asciugati i suoi, dopo che mastro Misciu era morto, e adesso si era maritata un'altra volta, ed era andata a stare a Cifali colla figliuola maritata, e avevano chiusa la porta di casa. D'ora in poi, se lo battevano, a loro non importava più nulla, e a lui nemmeno, ché quando sarebbe divenuto come il grigio o come Ranocchio, non avrebbe sentito più nulla. Verso quell'epoca venne a lavorare nella cava uno che non s'era mai visto, e si teneva nascosto il più che poteva. Gli altri operai dicevano fra di loro che era scappato dalla prigione, e se lo pigliavano ce lo tornavano a chiudere per anni ed anni. Malpelo seppe in quell'occasione che la prigione era un luogo dove si mettevano i ladri, e i malarnesi come lui, e si tenevano sempre chiusi là dentro e guardati a vista. Da quel momento provò una malsana curiosità per quell'uomo che aveva provata la prigione e ne era scappato. Dopo poche settimane però il fuggitivo dichiarò chiaro e tondo che era stanco di quella vitaccia da talpa, e piuttosto si contentava di stare in galera tutta la vita, ché la prigione, in confronto, era un paradiso, e preferiva tornarci coi suoi piedi. - Allora perché tutti quelli che lavorano nella cava non si fanno mettere in prigione? - domandò Malpelo. - Perché non sono malpelo come te! - rispose lo Sciancato. - Ma non temere, che tu ci andrai! e ci lascerai le ossa! Invece le ossa le lasciò nella cava, Malpelo come suo padre, ma in modo diverso. Una volta si doveva esplorare un passaggio che doveva comunicare col pozzo grande a sinistra, verso la valle, e se la cosa andava bene, si sarebbe risparmiata una buona metà di mano d'opera nel cavar fuori la rena. Ma a ogni modo, però, c'era il pericolo di smarrirsi e di non tornare mai più. Sicché nessun padre di famiglia voleva avventurarcisi, né avrebbe permesso che si arrischiasse il sangue suo, per tutto l'oro del mondo. Malpelo, invece, non aveva nemmeno chi si prendesse tutto l'oro del mondo per la sua pelle, se pure la sua pelle valeva tanto: sicché pensarono a lui. Allora, nel partire, si risovvenne del minatore, il quale si era smarrito, da anni ed anni, e cammina e cammina ancora al buio, gridando aiuto, senza che nessuno possa udirlo. Ma non disse nulla. Del resto a che sarebbe giovato? Prese gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino, e se ne andò: né più si seppe nulla di lui. Così si persero persin le ossa di Malpelo, e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo, ché hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi. 9- “La Lupa” (G. Verga) Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna - e pure non era più giovane - era pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labbra fresche e rosse, che vi mangiavano. Al villaggio la chiamavano la Lupa perché non era sazia giammai - di nulla. Le donne si facevano la croce quando la vedevano passare, sola come una cagnaccia, con quell'andare randagio e sospettoso della lupa affamata; ella si spolpava i loro figliuoli e i loro mariti in un batter d'occhio, con le sue labbra rosse, e se li tirava dietro alla gonnella solamente a guardarli con quegli occhi da satanasso, fossero stati davanti all'altare di Santa Agrippina. Per fortuna la Lupa non veniva mai in chiesa, né a Pasqua, né a Natale, né per ascoltar messa, né per confessarsi. - Padre Angiolino di Santa Maria di Gesù, un vero servo di Dio, aveva persa l'anima per lei. Maricchia, poveretta, buona e brava ragazza, piangeva di nascosto, perché era figlia della Lupa, e nessuno l'avrebbe tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua bella roba nel cassettone, e la sua buona terra al sole, come ogni altra ragazza del villaggio. Una volta la Lupa si innamorò di un bel giovane che era tornato da soldato, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse del notaro; ma proprio quello che si dice innamorarsi, sentirsene ardere le carni sotto al fustagno del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore calde di giugno, in fondo alla pianura. Ma lui seguitava a mietere tranquillamente, col naso sui manipoli, e le diceva: - O che avete, gnà Pina? - Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grilli, quando il sole batteva a piombo, la Lupa, affastellava manipoli su manipoli, e covoni su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza accostare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcagna di Nanni, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando: - Che volete, gnà Pina? Una sera ella glielo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aia, stanchi dalla lunga giornata, ed i cani uggiolavano per la vasta campagna nera: - Te voglio! Te che sei bello come il sole, e dolce come il miele. Voglio te! - Ed io invece voglio vostra figlia, che è zitella - rispose Nanni ridendo. La Lupa si cacciò le mani nei capelli, grattandosi le tempie senza dir parola, e se ne andò; né più comparve nell'aia. Ma in ottobre rivide Nanni, al tempo che cavavano l'olio, perché egli lavorava accanto alla sua casa, e lo scricchiolio del torchio non la faceva dormire tutta notte. - Prendi il sacco delle olive, - disse alla figliuola, - e vieni -. Nanni spingeva con la pala le olive sotto la macina, e gridava - Ohi! - alla mula perché non si arrestasse. - La vuoi mia figlia Maricchia? - gli domandò la gnà Pina. - Cosa gli date a vostra figlia Maricchia? - rispose Nanni. - Essa ha la roba di suo padre, e dippiù io le do la mia casa; a me mi basterà che mi lasciate un cantuccio nella cucina, per stendervi un po' di pagliericcio. - Se è così se ne può parlare a Natale - disse Nanni. Nanni era tutto unto e sudicio dell'olio e delle olive messe a fermentare, e Maricchia non lo voleva a nessun patto; ma sua madre l'afferrò pe' capelli, davanti al focolare, e le disse co' denti stretti: - Se non lo pigli, ti ammazzo! La Lupa era quasi malata, e la gente andava dicendo che il diavolo quando invecchia si fa eremita. Non andava più di qua e di là; non si metteva più sull'uscio, con quegli occhi da spiritata. Suo genero, quando ella glieli piantava in faccia, quegli occhi, si metteva a ridere, e cavava fuori l'abitino della Madonna per segnarsi. Maricchia stava in casa ad allattare i figliuoli, e sua madre andava nei campi, a lavorare cogli uomini, proprio come un uomo, a sarchiare, a zappare, a governare le bestie, a potare le viti, fosse stato greco e levante di gennaio, oppure scirocco di agosto, allorquando i muli lasciavano cader la testa penzoloni, e gli uomini dormivano bocconi a ridosso del muro a tramontana. In quell'ora fra vespero e nona, in cui non ne va in volta femmina buona, la gnà Pina era la sola anima viva che si vedesse errare per la campagna, sui sassi infuocati delle viottole, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si perdevano nell'afa, lontan lontano, verso l'Etna nebbioso, dove il cielo si aggravava sull'orizzonte. - Svegliati! - disse la Lupa a Nanni che dormiva nel fosso, accanto alla siepe polverosa, col capo fra le braccia. - Svegliati, ché ti ho portato il vino per rinfrescarti la gola -. Nanni spalancò gli occhi imbambolati, tra veglia e sonno, trovandosela dinanzi ritta, pallida, col petto prepotente, e gli occhi neri come il carbone, e stese brancolando le mani. - No! non ne va in volta femmina buona nell'ora fra vespero e nona! singhiozzava Nanni, ricacciando la faccia contro l'erba secca del fossato, in fondo in fondo, colle unghie nei capelli. - Andatevene! andatevene! non ci venite più nell'aia! Ella se ne andava infatti, la Lupa, riannodando le trecce superbe, guardando fisso dinanzi ai suoi passi nelle stoppie calde, cogli occhi neri come il carbone. Ma nell'aia ci tornò delle altre volte, e Nanni non le disse nulla. Quando tardava a venire anzi, nell'ora fra vespero e nona, egli andava ad aspettarla in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte - e dopo si cacciava le mani nei capelli, e le ripeteva ogni volta: - Andatevene! andatevene! Non ci tornate più nell'aia! Maricchia piangeva notte e giorno, e alla madre le piantava in faccia gli occhi ardenti di lagrime e di gelosia, come una lupacchiotta anch'essa, allorché la vedeva tornare da' campi pallida e muta ogni volta. - Scellerata! - le diceva. Mamma scellerata! - Taci! - Ladra! ladra! - Taci! - Andrò dal brigadiere, andrò! - Vacci! E ci andò davvero, coi figli in collo, senza temere di nulla, e senza versare una lagrima, come una pazza, perché adesso l'amava anche lei quel marito che le avevano dato per forza, unto e sudicio delle olive messe a fermentare. Il brigadiere fece chiamare Nanni; lo minacciò sin della galera e della forca. Nanni si diede a singhiozzare ed a strapparsi i capelli; non negò nulla, non tentò di scolparsi. - È la tentazione! - diceva; - è la tentazione dell'inferno! - Si buttò ai piedi del brigadiere supplicandolo di mandarlo in galera. - Per carità, signor brigadiere, levatemi da questo inferno! Fatemi ammazzare, mandatemi in prigione! non me la lasciate veder più, mai! mai! - No! - rispose invece la Lupa al brigadiere - Io mi son riserbato un cantuccio della cucina per dormirvi, quando gli ho data la mia casa in dote. La casa è mia; non voglio andarmene. Poco dopo, Nanni s'ebbe nel petto un calcio dal mulo, e fu per morire; ma il parroco ricusò di portargli il Signore se la Lupa non usciva di casa. La Lupa se ne andò, e suo genero allora si poté preparare ad andarsene anche lui da buon cristiano; si confessò e comunicò con tali segni di pentimento e di contrizione che tutti i vicini e i curiosi piangevano davanti al letto del moribondo. E meglio sarebbe stato per lui che fosse morto in quel giorno, prima che il diavolo tornasse a tentarlo e a ficcarglisi nell'anima e nel corpo quando fu guarito. Lasciatemi stare! - diceva alla Lupa - Per carità, lasciatemi in pace! Io ho visto la morte cogli occhi! La povera Maricchia non fa che disperarsi. Ora tutto il paese lo sa! Quando non vi vedo è meglio per voi e per me... Ed avrebbe voluto strapparsi gli occhi per non vedere quelli della Lupa, che quando gli si ficcavano ne' suoi gli facevano perdere l'anima ed il corpo. Non sapeva più che fare per svincolarsi dall'incantesimo. Pagò delle messe alle anime del Purgatorio, e andò a chiedere aiuto al parroco e al brigadiere. A Pasqua andò a confessarsi, e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciconi sui ciottoli del sacrato innanzi alla chiesa, in penitenza - e poi, come la Lupa tornava a tentarlo: - Sentite! - le disse, - non ci venite più nell'aia, perché se tornate a cercarmi, com'è vero Iddio, vi ammazzo! - Ammazzami, - rispose la Lupa, - ché non me ne importa; ma senza di te non voglio starci -. Ei come la scorse da lontano, in mezzo a' seminati verdi, lasciò di zappare la vigna, e andò a staccare la scure dall'olmo. La Lupa lo vide venire, pallido e stralunato, colla scure che luccicava al sole, e non si arretrò di un sol passo, non chinò gli occhi, seguitò ad andargli incontro, con le mani piene di manipoli di papaveri rossi, e mangiandoselo con gli occhi neri. - Ah! malanno all'anima vostra! - balbettò Nanni. 10- “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”, dal cap. I de “I Malavoglia” (G. Verga) Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce n'erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e delle tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia, erano passate senza far gran danno sulla casa del nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio; e padron 'Ntoni, per spiegare il miracolo, soleva dire, mostrando il pugno chiuso - un pugno che sembrava fatto di legno di noce - Per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro. Diceva pure, - Gli uomini son fatti come le dita della mano: il dito grosso deve far da dito grosso, e il dito piccolo deve far da dito piccolo. E la famigliuola di padron 'Ntoni era realmente diposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarant'ore; poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città; e così grande e grosso com'era filava diritto alla manovra comandata, e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avresse detto «sòffiati il naso» tanto che s'era tolta in moglie la Longa quando gli avevano detto «pìgliatela». Poi veniva la Longa, una piccina che badava a tessere, salare le acciughe, e far figliuoli, da buona massaia; infine i nipoti, in ordine di anzianità: 'Ntoni, il maggiore, un bighellone di vent'anni, che si buscava tutt'ora qualche scappellotto dal nonno, e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio, quando lo scappellotto era stato troppo forte; Luca, «che aveva più giudizio del grande» ripeteva il nonno; Mena (Filomena) soprannominata «Sant'Agata» perché stava sempre al telaio, e si suol dire «donna di telaio, gallina di pollaio, e triglia di gennaio»; Alessi (Alessio) un moccioso tutto suo nonno colui!; e Lia (Rosalia) ancora né carne né pesce. - Alla domenica, quando entravano in chiesa, l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron 'Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi, «perché il motto degli antichi mai mentì»: - «Senza pilota barca non cammina» - «Per far da papa bisogna saper far da sagrestano» - oppure - «Fa' il mestiere che sai, che se non arricchisci camperai» - «Contentati di quel che t'ha fatto tuo padre; se non altro non sarai un birbante» ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del nespolo prosperava, e padron 'Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale, se don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni, e che cospirava pel ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio, come spadroneggiava in casa propria. Padron 'Ntoni invece non lo conosceva neanche di vista Franceschello, e badava agli affari suoi, e soleva dire: «Chi ha carico di casa non può dormire quando vuole» perché «chi comanda ha da dar conto». Nel dicembre 1863, 'Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron 'Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che son quelli che possono aiutarci. Ma don Giammaria, il vicario, gli avea risposto che gli stava bene, e questo era il frutto di quella rivoluzione di satanasso che avevano fatto collo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. Invece don Franco lo speziale si metteva a ridere fra i peli della barbona, e gli giurava fregandosi le mani che se arrivavano a mettere assieme un po' di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, ché soldati non ce ne sarebbero stati più, e invece tutti sarebbero andati alla guerra, se bisognava. Allora padron 'Ntoni lo pregava e lo strapregava per l'amor di Dio di fargliela presto la repubblica, prima che suo nipote 'Ntoni andasse soldato, come se don Franco ce l'avesse in tasca; tanto che lo speziale finì coll'andare in collera. Allora don Silvestro il segretario si smascellava dalle risa a quei discorsi, e finalmente disse lui che con un certo gruzzoletto fatto scivolare in tasca a tale e tal altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia il ragazzo era fatto con coscienza, come se ne fabbricano ancora ad Aci Trezza, e il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di esser piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di ficodindia; ma i piedi fatti a pala di ficodindia ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata, in certe giornataccie; e perciò si presero 'Ntoni senza dire «permettete». La Longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere, trottando trafelata accanto al passo lungo del figliuolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna, e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandato i soldi per la carta. Il nonno, da uomo, non diceva nulla; ma si sentiva un gruppo nella gola anch'esso, ed evitava di guardare in faccia la nuora, quasi ce l'avesse con lei. Così se ne tornarono ad Aci Trezza zitti zitti e a capo chino. Bastianazzo, che si era sbrigato in fretta dal disarmare la Provvidenza, per andare ad aspettarli in capo alla via, come li vide comparire a quel modo, mogi mogi e colle scarpe in mano, non ebbe animo di aprir bocca, e se ne tornò a casa con loro. La Longa corse subito a cacciarsi in cucina, quasi avesse furia di trovarsi a quattr'occhi colle vecchie stoviglie, e padron 'Ntoni disse al figliuolo: - Va a dirle qualche cosa, a quella poveretta; non ne può più. Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei coscritti che andavano a Messina, e aspettarono più di un'ora, pigiati dalla folla dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno, e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano, col capo fuori dagli sportelli, come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate e il baccano erano tali che sembrava la festa di Trecastagni, e nella ressa e nel frastuono ci si dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima. - Addio 'Ntoni! - Addio mamma! - Addio! ricordati! ricordati! - Lì presso, sull'argine della via, c'era la Sara di comare Tudda, a mietere l'erba pel vitello; ma comare Venera la Zuppidda andava soffiando che c'era venuta per salutare 'Ntoni di padron 'Ntoni, col quale si parlavano dal muro dell'orto, li aveva visti lei, con quegli occhi che dovevano mangiarseli i vermi. Certo è che 'Ntoni salutò la Sara colla mano, ed ella rimase colla falce in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Alla Longa, l'era parso rubato a lei quel saluto; e molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tudda, nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. Poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole e qualche povero diavolo, che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato, senza saper perché. Quindi a poco a poco si sbrancarono anch'essi, e padron 'Ntoni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò due centesimi di acqua col limone. 12- “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno”, dal cap. XV de “I Malavoglia” (G. Verga) Alessi s'era tolta in moglie la Nunziata, e aveva riscattata la casa del nespolo. - Io non sono da maritare, - aveva tornato a dire la Mena; - maritati tu che sei da maritare ancora; - e cosi ella era salita nella soffitta della casa del nespolo, come le casseruole vecchie, e s'era messo il cuore in pace, aspettando i figliuoli della Nunziata per far la mamma. Ci avevano pure le galline nel pollaio, e il vitello nella stalla, e la legna e il mangime sotto la tettoia, e le reti e ogni sorta di attrezzi appesi, il tutto come aveva detto padron 'Ntoni; e la Nunziata aveva ripiantato nell'orto i broccoli ed i cavoli, con quelle braccia delicate che non si sapeva come ci fosse passata tanta tela da imbiancare, e come avesse fatti quei marmocchi grassi e rossi che la Mena si portava in collo pel vicinato quasi li avesse messi al mondo lei, quando faceva la mamma. Compare Mosca scrollava il capo, mentre la vedeva passare, e si voltava dall'altra parte, colle spalle grosse. - A me non mi avete creduto degno di quest'onore! - le disse alfine quando non ne poté più, col cuore pi£ grosso delle spalle. - Io non ero degno di sentirmi dir di sì! - No, compar Alfio! - rispose Mena la quale si sentiva spuntare le lagrime. - Per quest'anima pura che tengo sulle braccia! Non è per questo motivo. Ma io non son pi£ da maritare. - Perché non siete pi£ da maritare, comare Mena? - No! no! - ripeteva comare Mena, che quasi piangeva. - Non me lo fate dire, compare Alfio! Non mi fate parlare! Ora se io mi maritassi, la gente tornerebbe a parlare di mia sorella Lia, giacchè nessuno oserebbe prendersela una Malavoglia, dopo quello che è successo. Voi pel primo ve ne pentireste. Lasciatemi stare, che non sono da maritare, e mettetevi il cuore in pace. - Avete ragione, comare Mena! - rispose compare Mosca; a questo non ci avevo mai pensato. Maledetta la sorte che ha fatto nascere tanti guai! Così compare Alfio si mise il cuore in pace, e Mena seguitò a portare in braccio i suoi nipoti quasi ci avesse il cuore in pace anche lei, e a spazzare la soffitta, per quando fossero tornati gli altri, che c'erano nati anche loro, - come se fossero stati in viaggio per tomare! - diceva Piedipapera. Invece padron 'Ntoni aveva fatto quel viaggio lontano, più lontano di Trieste e d'Alessandria d'Egitto, dal quale non si ritorna più; e quando il suo nome cadeva nel discorso, mentre si riposavano, tirando il conto della settimana e facendo i disegni per l'avvenire, all'ombra del nespolo e colle scodelle fra le ginocchia, le chiacchiere morivano di botto, che a tutti pareva d'avere il povero vecchio davanti agli occhi, come l'avevano visto l'ultima volta che erano andati a trovarlo in quella gran cameraccia coi letti in fila, che bisognava cercarlo per trovarlo, e il nonno li aspettava come un'anima del purgatorio, cogli occhi alla porta, sebbene non ci vedesse quasi, e li andava toccando, per accertarsi che erano loro, e poi non diceva pi£ nulla, mentre gli si vedeva in faccia che aveva tante cose da dire, e spezzava il cuore con quella pena che gli si leggeva in faccia e non la poteva dire. Quando gli narrarono poi che avevano riscattata la casa del nespolo, e volevano portarselo a Trezza di nuovo, rispose di sì, e di sì, cogli occhi, che gli tornavano a luccicare, e quasi faceva la bocca a riso, quel riso della gente che non ride più, o che ride per l'ultima volta, e vi rimane fitto nel cuore come un coltello. Così successe ai Malavoglia quando il lunedì tornarono col carro di compar Alfio per riprendersi il nonno, e non lo trovarono pi£. Rammentando tutte queste cose lasciavano il cucchiaio nella scodella e pensavano e pensavano a tutto quello che era accaduto, che sembrava scuro scuro come ci fosse sopra l'ombra del nespolo. Ora, quando veniva la cugina Anna a filare un po' con le comari, aveva i capelli bianchi, e diceva che aveva perso il riso della bocca, perchè non aveva tempo di stare allegra, colla famiglia che aveva sulle spalle, e Rocco che tutti i giorni bisognava andare a cercare di qua e di là per le strade e davanti la bettola, e cacciarlo verso casa come un vitello vagabondo. Anche dei Malavoglia ce n'erano due vagabondi; e Alessi si tormentava il cervello a cercarli dove potevano essere, per le strade arse di sole e bianche di polvere, che in paese non sarebbero tornati pi£, dopo tanto tempo. Una sera, tardi, il cane si mise ad abbaiare dietro l'uscio del cortile, e lo stesso Alessi, che andò ad aprire, non riconobbe 'Ntoni il quale tornava colla sporta sotto il braccio, tanto era mutato, coperto di polvere, e colla barba lunga. Come fu entrato e si fu messo a sedere in un cantuccio, non osavano quasi fargli festa. Ei non sembrava pi£ quello, e andava guardando in giro le pareti, come non le avesse mai viste; fino il cane gli abbaiava, ché non l'aveva conosciuto mai. Gli misero fra le gambe la scodella, perché aveva fame e sete, ed egli mangiò in silenzio la minestra che gli diedero, come non avesse visto grazia di Dio da otto giorni, col naso nel piatto; ma gli altri non avevano fame, tanto avevano il cuore serrato. Poi 'Ntoni, quando si fu sfamato e riposato alquanto, prese la sua sporta e si alzò per andarsene. Alessi non osava dirgli nulla, tanto suo fratello era mutato. Ma al vedergli riprendere la sporta, si senti balzare il cuore dal petto, e Mena gli disse tutta smarrita: - Te ne vai? - Sì! - rispose 'Ntoni. - E dove vai? - chiese Alessi. - Non lo so. Venni per vedervi. Ma dacché son qui la minestra mi è andata tutta in veleno. Per altro qui non posso starci, ché tutti mi conoscono, e perciò son venuto di sera. Andrò lontano, dove troverò da buscarmi il pane, e nessuno saprà chi sono. Gli altri non osavano fiatare, perché ci avevano il cuore stretto in una morsa, e capivano che egli faceva bene a dir così. 'Ntoni continuava a guardare dappertutto, e stava sulla porta, e non sapeva risolversi ad andarsene. - Ve lo farò sapere dove sarò; - disse infine e come fu nel cortile, sotto il nespolo, che era scuro, disse anche: - E il nonno? Alessi non rispose; 'Ntoni tacque anche lui, e dopo un pezzetto: - E la Lia, che non l'ho vista? E siccome aspettava inutilmente la risposta, aggiunse colla voce tremante, quasi avesse freddo: - E' morta anche lei? Alessi non rispose nemmeno; allora 'Ntoni che era sotto il nespolo colla sporta in mano, fece per sedersi, poiché le gambe gli tremavano ma si rizzò di botto, balbettando: - Addio addio! Lo vedete che devo andarmene? Prima d'andarsene voleva fare un giro per la casa, onde vedere se ogni cosa fosse al suo posto come prima; ma adesso, a lui che gli era bastato l'animo di lasciarla, e di dare una coltellata a don Michele, e di starsene nei guai, non gli bastava l'animo di passare da una camera all'altra se non glielo dicevano. Alessi che gli vide negli occhi il desiderio, lo fece entrare nella stalla, col pretesto del vitello che aveva comperato la Nunziata, ed era grasso e lucente; e in un canto c'era pure la chioccia coi pulcini; poi lo condusse in cucina, dove avevano fatto il forno nuovo, e nella camera accanto, che vi dormiva la Mena coi bambini della Nunziata, e pareva che li avesse fatti lei. 'Ntoni guardava ogni cosa, e approvava col capo, e diceva - Qui pure il nonno avrebbe voluto metterci il vitello, qui c'erano le chiocce, e qui dormivano le ragazze, quando c'era anche quell'altra... - Ma allora non aggiunse altro, e stette zitto a guardare intorno, cogli occhi lustri. In quel momento passava la Mangiacarrubbe, che andava sgridando Brasi Cipolla per la strada, e 'Ntoni disse: - Questa qui l'ha trovato il marito; ed ora, quando avranno finito di quistionare, andranno a dormire nella loro casa. Gli altri stettero zitti, e per tutto il paese era un gran silenzio, soltanto si udiva sbattere ancora qualche porta che si chiudeva; e Alessi a quelle parole si fece coraggio per dirgli: - Se volessi anche tu ci hai la tua casa. Di là c'è apposta il letto per te. - No ! - rispose 'Ntoni. - Io devo andarmene. Là c'era il letto della mamma, che lei inzuppava tutto di lagrime quando volevo andarmene. Ti rammenti le belle chiacchierate che si facevano la sera, mentre si salavano le acciughe? e la Nunziata che spiegava gli indovinelli? e la mamma, e la Lia, tutti lì, al chiaro di luna, che si sentiva chiacchierare per tutto il paese, come fossimo tutti una famiglia? Anch'io allora non sapevo nulla, e qui non volevo itarci, ma ora che so ogni cosa devo andarmene. In quel momento parlava cogli occhi fissi a terra, e il capo rannicchiato nelle spalle. Allora Alessi gli buttò le braccia al collo. - Addio, - ripeté 'Ntoni. - Vedi che avevo ragione d'andarmene! qui non posso starci. Addio, perdonatemi tutti. E se ne andò colla sua sporta sotto il braccio; poi, quando fu lontano, in mezzo alla piazza scura e deserta, che tutti gli usci erana chiusi, si fermò ad ascoltare se chiudessero la porta della casa del nespolo, mentre il cane gli abbaiava dietro, e gli diceva col suo abbaiare che era solo in mezzo al paese. Soltanto il mare gli brontolava la solita storia lì sotto, in mezzo ai fariglioni, perché il mare non ha paese nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole, anzi ad Aci Trezza ha un modo tutto suo di brontolare, e si riconosce subito al gorgogliare che fa tra quegli scogli nei quali si rompe e par la voce di un amico. Allora 'Ntoni si fermò in mezzo alla strada a guardare il paese tutto nero, come non gli bastasse il cuore di staccarsene, adesso che sapeva ogni cosa, e sedette sul muricciuolo della vigna di massaro Filippo. Così stette un gran pezzo pensando a tante cose, guardando il paese nero e ascoltando il mare che gli brontalava lì sotto. E ci stette fin quando cominciarono ad udirsi certi rumori ch'ei conosceva, e delle voci che si chiamavano dietro gli usci, e sbatter d'imposte, e dei passi per le strade buie. Sulla riva, in fondo alla piazza, cominciavano a formicolare dei lumi. Egli levò il capo a guardare i Tre Re che luccicavano, e la Puddara che annunziava l'alba, come l'aveva vista tante volte. Allora tornò a chinare il capo sul petto, e a pensare a tutta la sua storia. A poco a poco il mare cominciò a farsi bianco, e i Tre Re ad impallidire, e le case spuntavano ad una ad una nelle vie scure, cogli usci chiusi, che si conoscevano tutte, e solo davanti alla bottega di Pizzuto c'era il lumicino, e Rocco Spatu colle mani nelle tasche che tossiva e sputacchiava. - Fra poco lo zio Santoro aprirà la porta - pensò 'Ntoni, - e si accoccolerà sull'uscio a cominciare la sua giornata anche lui. - Tornò a guardare il mare, che s'era fatto amaranto, tutto seminato di barche che avevano cominciato la loro giornata anche loro, riprese la sua sporta, e disse: - Ora è tempo d'andarsene, perché fra poco comincerà a passar gente. Ma il primo di tutti a cominciar la sua giornata è stato Rocco Spatu. 13 - “La morte di Mastro don Gesualdo” dal cap. XXI di “Mastro don Gesualdo” (G. Verga) L'avevano collocato in un quartierino al pian di sopra, poche stanze che chiamavano la foresteria, dove Isabella andava a vederlo ogni mattina, in veste da camera, spesso senza neppure mettersi a sedere, amorevole e premurosa, è vero, ma in certo modo che al pover'uomo sembrava d'essere davvero un forestiero. Essa alcune volte era pallida così che pareva non avesse chiuso occhio neppur lei. Aveva una certa ruga fra le ciglia, qualcosa negli occhi, che a lui, vecchio e pratico del mondo, non andavan punto a genio. Avrebbe voluto pigliarsi anche lei fra le braccia, stretta stretta, e chiederle piano in un orecchio: - Cos'hai?... dimmelo!... Confidati a me che dei guai ne ho passati tanti, e non posso tradirti!... Ma anch'essa ritirava le corna come fa la lumaca. Stava chiusa, parlava di rado anche della mamma, quasi il chiodo le fosse rimasto lì, fisso... accusando lo stomaco peloso dei Trao, che vi chiudevano il rancore e la diffidenza, implacabili! Perciò lui doveva ricacciare indietro le parole buone e anche le lagrime, che gli si gonfiavano grosse grosse dentro, e tenersi per sé i propri guai. Passava i giorni malinconici dietro l'invetriata, a veder strigliare i cavalli e lavare le carrozze, nella corte vasta quanto una piazza. Degli stallieri, in manica di camicia e coi piedi nudi negli zoccoli, cantavano, vociavano, barattavano delle chiacchiere e degli strambotti coi domestici, i quali perdevano il tempo alle finestre, col grembialone sino al collo, o in panciotto rosso, strascicando svogliatamente uno strofinaccio fra le mani ruvide, con le barzellette sguaiate, dei musi beffardi di mascalzoni ben rasi e ben pettinati che sembravano togliersi allora una maschera. I cocchieri poi, degli altri pezzi grossi, stavano a guardare, col sigaro in bocca e le mani nelle tasche delle giacchette attillate, discorrendo di tanto in tanto col guardaportone che veniva dal suo casotto a fare una fumatina, accennando con dei segni e dei versacci alle cameriere che si vedevano passare dietro le invetriate dei balconi, oppure facevano capolino provocanti, sfacciate, a buttar giù delle parolacce e delle risate di male femmine con certi visi da Madonna. Don Gesualdo pensava intanto quanti bei denari dovevano scorrere per quelle mani; tutta quella gente che mangiava e beveva alle spalle di sua figlia, sulla dote che egli le aveva dato, su l'Alìa e su Donninga, le belle terre che aveva covato cogli occhi tanto tempo, sera e mattina, e misurato col desiderio, e sognato la notte, e acquistato palmo a palmo, giorno per giorno, togliendosi il pane di bocca: le povere terre nude che bisognava arare e seminare; i mulini, le case, i magazzini che aveva fabbricato con tanti stenti, con tanti sacrifici, un sasso dopo l'altro. La Canziria, Mangalavite, la casa, tutto, tutto sarebbe passato per quelle mani. Chi avrebbe potuto difendere la sua roba dopo la sua morte, ahimè, povera roba! Chi sapeva quel che era costata? Il signor duca, lui, quando usciva di casa, a testa alta, col sigaro in bocca e il pomo del bastoncino nella tasca del pastrano, fermavasi appena a dare un'occhiata ai suoi cavalli, ossequiato come il Santissimo Sagramento, le finestre si chiudevano in fretta, ciascuno correva al suo posto, tutti a capo scoperto, il guardaportone col berretto gallonato in mano, ritto dinanzi alla sua vetrina, gli stallieri immobili accanto alla groppa delle loro bestie, colla striglia appoggiata all'anca, il cocchiere maggiore, un signorone, piegato in due a passare la rivista e prendere gli ordini: una commedia che durava cinque minuti. Dopo, appena lui voltava le spalle, ricominciava il chiasso e la baraonda, dalle finestre, dalle arcate del portico che metteva alle scuderie, dalla cucina che fumava e fiammeggiava sotto il tetto, piena di sguatteri vestiti di bianco, quasi il palazzo fosse abbandonato in mano a un'orda famelica, pagata apposta per scialarsela sino al tocco della campana che annunziava qualche visita - un'altra solennità anche quella. - La duchessa certi giorni si metteva in pompa magna ad aspettare le visite come un'anima di purgatorio. Arrivava di tanto in tanto una carrozza fiammante; passava come un lampo dinanzi al portinaio, che aveva appena il tempo di cacciare la pipa nella falda del soprabito e di appendersi alla campana; delle dame e degli staffieri in gala sguisciavano frettolosi sotto l'alto vestibolo, e dopo dieci minuti tornavano ad uscire per correre altrove a rompicollo; proprio della gente che sembrava presa a giornata per questo. Lui invece passava il tempo a contare le tegole dirimpetto, a calcolare, con l'amore e la sollecitudine del suo antico mestiere, quel che erano costate le finestre scolpite, i pilastri massicci, gli scalini di marmo, quei mobili sontuosi, quelle stoffe, quella gente, quei cavalli che mangiavano, e inghiottivano il denaro come la terra inghiottiva la semente, come beveva l'acqua, senza renderlo però, senza dar frutto, sempre più affamati, sempre più divoranti, simili a quel male che gli consumava le viscere. Quante cose si sarebbero potute fare con quel denaro! Quanti buoni colpi di zappa, quanto sudore di villani si sarebbero pagati! Delle fattorie, dei villaggi interi da fabbricare... delle terre da seminare, a perdita di vista... E un esercito di mietitori a giugno, del grano da raccogliere a montagne, del denaro a fiumi da intascare!... Allora gli si gonfiava il cuore al vedere i passeri che schiamazzavano su quelle tegole, il sole che moriva sul cornicione senza scendere mai giù sino alle finestre. Pensava alle strade polverose, ai bei campi dorati e verdi, al cinguettìo lungo le siepi, alle belle mattinate che facevano fumare i solchi!... Oramai!... oramai!... Adesso era chiuso fra quattro mura, col brusìo incessante della città negli orecchi, lo scampanìo di tante chiese che gli martellava sul capo, consumato lentamente dalla febbre, roso dai dolori che gli facevano mordere il guanciale, a volte, per non seccare il domestico che sbadigliava nella stanza accanto. [….] - Senti... Ho da parlarti... intanto che siamo soli... Ella gli si buttò addosso, disperata, piangendo, singhiozzando di no, di no, colle mani erranti che l'accarezzavano. L'accarezzò anche lui sui capelli, lentamente, senza dire una parola. Di lì a un po' riprese: - Ti dico di sì. Non sono un ragazzo... Non perdiamo tempo inutilmente. - Poi gli venne una tenerezza. - Ti dispiace, eh?... ti dispiace a te pure?... La voce gli si era intenerita anch'essa, gli occhi, tristi, s'erano fatti più dolci, e qualcosa gli tremava sulle labbra. - Ti ho voluto bene... anch'io... quanto ho potuto... come ho potuto... Quando uno fa quello che può... Allora l'attirò a sé lentamente, quasi esitando, guardandola fissa per vedere se voleva lei pure, e l'abbracciò stretta stretta, posando la guancia ispida su quei bei capelli fini. - Non ti fo male, di'?... come quand'eri bambina?... Gli vennero insieme delle altre cose sulle labbra, delle ondate di amarezza e di passione, quei sospetti odiosi che dei bricconi, nelle questioni d'interessi, avevano cercato di mettergli in capo. Si passò la mano sulla fronte, per ricacciarli indietro, e cambiò discorso. - Parliamo dei nostri affari. Non ci perdiamo in chiacchiere, adesso... Essa non voleva, smaniava per la stanza, si cacciava le mani nei capelli, diceva che gli lacerava il cuore, che gli pareva un malaugurio, quasi suo padre stesse per chiudere gli occhi. - Ma no, parliamone! - insisteva lui. - Sono discorsi serii. Non ho tempo da perdere adesso. - Il viso gli si andava oscurando, il rancore antico gli corruscava negli occhi. Allora vuol dire che non te ne importa nulla... come a tuo marito... Vedendola poi rassegnata ad ascoltare, seduta a capo chino accanto al letto, cominciò a sfogarsi dei tanti crepacuori che gli avevano dati, lei e suo marito, con tutti quei debiti... Le raccomandava la sua roba, di proteggerla, di difenderla: - Piuttosto farti tagliare la mano, vedi!... quando tuo marito torna a proporti di firmare delle carte!... Lui non sa cosa vuol dire! - Spiegava quel che gli erano costati, quei poderi, l'Alìa, la Canziria, li passava tutti in rassegna amorosamente; rammentava come erano venuti a lui, uno dopo l'altro, a poco a poco, le terre seminative, i pascoli, le vigne; li descriveva minutamente, zolla per zolla, colle qualità buone o cattive. Gli tremava la voce, gli tremavano le mani, gli si accendeva tuttora il sangue in viso, gli spuntavano le lagrime agli occhi: Mangalavite, sai... la conosci anche tu... ci sei stata con tua madre... Quaranta salme di terreni, tutti alberati!... ti rammenti... i belli aranci?... anche tua madre, poveretta, ci si rinfrescava la bocca, negli ultimi giorni!... 300 migliaia l'anno, ne davano! Circa 300 onze! E la Salonia... dei seminati d'oro... della terra che fa miracoli... benedetto sia tuo nonno che vi lasciò le ossa!... Infine, per la tenerezza, si mise a piangere come un bambino. - Basta, - disse poi. - Ho da dirti un'altra cosa... Senti... La guardò fissamente negli occhi pieni di lagrime per vedere l'effetto che avrebbe fatto la sua volontà. Le fece segno di accostarsi ancora, di chinarsi su lui supino che esitava e cercava le parole. - Senti!... Ho degli scrupoli di coscienza... Vorrei lasciare qualche legato a delle persone verso cui ho degli obblighi... Poca cosa... Non sarà molto per te che sei ricca... Farai conto di essere una regalìa che tuo padre ti domanda... in punto di morte... se ho fatto qualcosa anch'io per te... - Ah, babbo, babbo!... che parole! - singhiozzò Isabella. - Lo farai, eh? lo farai?... anche se tuo marito non volesse... Le prese le tempie fra le mani, e le sollevò il viso per leggerle negli occhi se l'avrebbe ubbidito, per farle intendere che gli premeva proprio, e che ci aveva quel segreto in cuore. E mentre la guardava, a quel modo, gli parve di scorgere anche lui quell'altro segreto, quell'altro cruccio nascosto, in fondo agli occhi della figliuola. E voleva dirle delle altre cose, voleva farle altre domande, in quel punto, aprirle il cuore come al confessore, e leggere nel suo. Ma ella chinava il capo, quasi avesse indovinato, colla ruga ostinata dei Trao fra le ciglia, tirandosi indietro, chiudendosi in sè, superba, coi suoi guai e il suo segreto. E lui allora sentì di tornare Motta, com'essa era Trao, diffidente, ostile, di un'altra pasta. Allentò le braccia, e non aggiunse altro. - Ora fammi chiamare un prete, - terminò con un altro tono di voce. - Voglio fare i miei conti con Domeneddio. Durò ancora qualche altro giorno così, fra alternative di meglio e di peggio. Sembrava anzi che cominciasse a riaversi un poco, quando a un tratto, una notte, peggiorò rapidamente. Il servitore che gli avevano messo a dormire nella stanza accanto l'udì agitarsi e smaniare prima dell'alba. Ma siccome era avvezzo a quei capricci, si voltò dall'altra parte, fingendo di non udire. Infine, seccato da quella canzone che non finiva più, andò sonnacchioso a vedere che c'era. - Mia figlia! - borbottò don Gesualdo con una voce che non sembrava più la sua. Chiamatemi mia figlia! - Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, - rispose il domestico, e tornò a coricarsi. Ma non lo lasciava dormire quell'accidente! Un po' erano sibili, e un po' faceva peggio di un contrabbasso, nel russare. Appena il domestico chiudeva gli occhi udiva un rumore strano che lo faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come uno che sbuffasse ed ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi accapponava la pelle. Tanto che infine dovette tornare ad alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e delle parolacce. - Cos'è? Gli è venuto l'uzzolo adesso? Vuol passar mattana! Che cerca? Don Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il servitore tolse il paralume, per vederlo in faccia. Allora si fregò bene gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un tratto. - Ohi! ohi! Che facciamo adesso? - balbettò grattandosi il capo. Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano, pensando se era meglio aspettare un po', o scendere subito a svegliare la padrona e mettere la casa sottosopra. Don Gesualdo intanto andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, cogli occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s'irrigidì e si chetò del tutto. La finestra cominciava a imbiancare. Suonavano le prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei cavalli, e picchiare di striglie sul selciato. Il domestico andò a vestirsi, e poi tornò a rassettare la camera. Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate, e s'affacciò a prendere una boccata d'aria, fumando. Lo stalliere, che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il capo verso la finestra. - Mattinata, eh, don Leopoldo? - E nottata pure! - rispose il cameriere sbadigliando. - M'è toccato a me questo regalo! L'altro scosse il capo, come a chiedere che c'era di nuovo, e don Leopoldo fece segno che il vecchio se n'era andato, grazie a Dio. - Ah... così... alla chetichella?... - osservò il portinaio che strascicava la scopa e le ciabatte per l'androne. Degli altri domestici s'erano affacciati intanto, e vollero andare a vedere. Di lì a un po' la camera del morto si riempì di gente in manica di camicia e colla pipa in bocca. La guardarobiera vedendo tutti quegli uomini alla finestra dirimpetto venne anche lei a far capolino nella stanza accanto. - Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure; non vi mangiamo mica... E neanche lui... non vi mette più le mani addosso di sicuro... - Zitto, scomunicato!... No, ho paura, poveretto... - Ha cessato di penare. - Ed io pure, - soggiunse don Leopoldo. Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel cristiano - uno che faceva della notte giorno, e non si sapeva come pigliarlo, e non era contento mai. - Pazienza servire quelli che realmente son nati meglio di noi... Basta, dei morti non si parla. - Si vede com'era nato... - osservò gravemente il cocchiere maggiore. - Guardate che mani! - Già, son le mani che hanno fatto la pappa!... Vedete cos'è nascer fortunati... Intanto vi muore nella battista come un principe!... - Allora, - disse il portinaio, - devo andare a chiudere il portone? - Sicuro, eh! È roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la cameriera della signora duchessa. 14 - “Il conte Andrea Sperelli” dal cap. II, libro I de “Il piacere” (G. D’Annunzio) Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà italica, in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare d'eletta cultura, d'eleganza e di arte. A questa classe, ch'io chiamerei arcadica perché rese appunto il suo più alto splendore nell'amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli Sperelli. L'urbanità, l'atticismo, l'amore delle delicatezze, la predilezione per gli studii insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata erano nella casa degli Sperelli qualità ereditarie. Un Alessandro Sperelli, nel 1466, portò a Federico d'Aragona, figliuolo di Ferdinando re di Napoli e fratello d'Alfonso duca di Calabria, il codice in foglio contenente alcune poesie « men rozze » de' vecchi scrittori toscani, che Lorenzo de' Medici aveva promesso in Pisa nel '65; e quello stesso Alessandro scrisse per la morte della divina Simonetta, in coro con i dotti del suo tempo, una elegìa latina, malinconica ed abbandonata a imitazion di Tibullo. Un altro Sperelli, Stefano, nel secolo medesimo, fu in Fiandra, in mezzo alla vita pomposa, alla preziosa eleganza, all'inaudito fasto borgognone; ed ivi rimase alla corte di Carlo il Temerario, imparentandosi con una famiglia fiamminga. Un figliuol suo, Giusto, praticò la pittura sotto gli insegnamenti di Giovanni Gossaert; e insieme col maestro venne in Italia, al seguito di Filippo di Borgogna ambasciator dell'imperator Massimiliano presso il papa Giulio II, nel 1508. Dimorò a Firenze, dove il principal ramo della sua stirpe continuava a fiorire; ed ebbe a secondo maestro Piero di Cosimo, quel giocondo e facile pittore, forte ed armonioso colorista, che risuscitava liberamente col suo pennello le favole pagane. Questo Giusto fu non volgare artista; ma consumò tutto il suo vigore in vani sforzi per conciliare la primitiva educazione gotica con il recente spirito del Rinascimento. Verso la seconda metà del secolo XVII la casata degli Sperelli si trasportò a Napoli. Ivi nel 1679 un Bartolomeo Sperelli pubblicò un trattato astrologico De Nativitatibus; nel 1720 un Giovanni Sperelli diede al teatro un'opera buffa intitolata La Faustina e poi una tragedia lirica intitolata Progne; nel 1756 un Carlo Sperelli stampò un libro di versi amatorii in cui molte classiche lascivie erano rimate con l'eleganza oraziana allora di moda. Miglior poeta fu Luigi, ed uomo di squisita galanteria, alla corte del re lazzarone e della regina Carolina. Verseggiò con un certo malinconico e gentile epicureismo, assai nitidamente; ed amò da fino amatore, ed ebbe avventure in copia, talune celebri, come quella con la marchesa di Bugnano che per gelosia s'avvelenò, e come quella con la contessa di Chesterfield che morta etica egli pianse in canzoni, odi, sonetti ed elegìe soavissime s ebbene un poco frondose. Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d'Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. Egli era, in verità, l'ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo campione d'una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d'una razza intelettuale. Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. La sua adolescenza, nutrita di studii varii e profondi, parve prodigiosa. Egli alternò, fino a vent'anni, le lunghe letture coi lunghi viaggi in compagnia del padre e poté compiere la sua straordinaria educazione estetica sotto la cura paterna, senza restrizioni e constrizioni di pedagoghi. Dal padre appunto ebbe il gusto delle cose d'arte, il culto passionato della bellezza, il paradossale disprezzo de' pregiudizii, l'avidità del piacere. Questo padre, cresciuto in mezzo agli estremi splendori della corte borbonica, sapeva largamente vi vere; aveva una scienza profonda della vita voluttuaria e insieme una certa inclinazione byroniana al romanticismo fantastico. Lo stesso suo matrimonio era avvenuto in circostanze quasi tragiche, dopo una furiosa passione. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Finalmente s'era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo, viaggiando con lui per tutta l'Europa. L'educazione d'Andrea era dunque, per così dire, viva, cioè fatta non tanto su i libri quanto in conspetto delle realità umane. Lo spirito di lui non era soltanto corrotto dall'alta cultura ma anche dall'esperimento; e in lui la curiosità diveniva più acuta come più si allargava la conoscenza. Fin dal principio egli fu prodigo di sé; poiché la grande forza sensitiva, ond'egli era dotato, non si stancava mai di fornire tesori alle sue prodigalità. Ma l'espansion di quella sua forza era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Ed egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzion progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere, quasi una progressiva rinunzia; e che il circolo gli si restringeva sempre più d'intorno, inesorabilmente sebben con lentezza. Il padre gli aveva dato, tra le altre, questa massima fondamentale: « Bisogna fare la propria vita, come si fa un'opera d'arte. Bisogna che la vita d'un uomo d'intelletto sia opera di lui. La superiorità vera è tutta qui. » Anche, il padre ammoniva: « Bisogna conservare ad ogni costo intiera la libertà, fin nell'ebrezza. La regola dell'uomo d'intelletto, eccola: - Habere, non haberi. » Anche, diceva: « Il rimpianto è il vano pascolo d'uno spirito disoccupato. Bisogna sopra tutto evitare il rimpianto occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove imaginazioni. » Ma queste massime volontarie, che per l'ambiguità loro potevano anche essere interpretate come alti criterii morali, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo, cioè, la cui potenza volitiva era debolissima. Un altro seme paterno aveva perfidamente fruttificato nell'animo di Andrea: il seme del sofisma. « Il sofisma » diceva quell'incauto educatore « è in fondo ad ogni piacere e ad ogni dolore umano. Acuire e moltiplicare i sofismi equivale dunque ad acuire e moltiplicare il proprio piacere o il proprio dolore. Forse, la scienza della vita sta nell'oscurare la verità. La parola è una cosa profonda, in cui per l'uomo d'intelletto son nascoste inesauribili ricchezze. I Greci, artefici della parola, sono infatti i più squisiti goditori dell'antichità. I sofismi fioriscono in maggior numero al secolo di Pericle, al secolo gaudioso. » Un tal seme trovò nell'ingegno malsano del giovine un terreno propizio. A poco a poco, in Andrea la menzogna non tanto verso gli altri quanto verso sé stesso divenne un abito così aderente alla conscienza ch'egli giunse a non poter mai essere interamente sincero e a non poter mai riprendere su sé stesso il libero dominio. Dopo la morte immatura del padre, egli si trovò solo, a ventun anno, signore d'una fortuna considerevole, distaccato dalla madre, in balia delle sue passioni e de' suoi gusti. Rimase quindici mesi in Inghilterra. La madre passò in seconde nozze, con un amante antico. Ed egli venne a Roma, per predilezione. Roma era il suo grande amore: non la Roma dei Cesari ma la Roma dei Papi; non la Roma degli Archi, delle Terme, dei Fòri, ma la Roma delle Ville, delle Fontane, delle Chiese. Egli avrebbe dato tutto il Colosseo per la Villa Medici, il Campo Vaccino per la Piazza di Spagna, l'Arco di Tito per la Fontanella delle Tartarughe. La magnificenza principesca dei Colonna, dei Doria, dei Barberini l'attraeva assai più della ruinata grandiosità imperiale. E il suo gran sogno era di possedere un palazzo incoronato da Michelangelo e istoriato dai Caracci, come quello Farnese; una galleria piena di Raffaelli, di Tiziani, di Domenichini, come quella Borghese; una villa, come quella d'Alessandro Albani, dove i bussi profondi, il granito rosso d'Oriente, il marmo bianco di Luni, le statue della Grecia, le pitture del Rinascimento, le memorie stesse del luogo componessero un incanto intorno a un qualche suo superbo amore. In casa della marchesa d'Ateleta sua cugina, sopra un albo di confessioni mondane, accanto alla domanda « Che vorreste voi essere? » egli aveva scritto « Principe romano ». Giunto a Roma in sul finir di settembre del 1884, stabilì il suo home nel palazzo Zuccari alla Trinità de' Monti, su quel dilettoso tepidario cattolico dove l'ombra dell'obelisco di Pio VI segna la fuga delle Ore. Passò tutto il mese di ottobre tra le cure degli addobbi; poi, quando le stanze furono ornate e pronte, ebbe nella nuova casa alcuni giorni d'invincibile tristezza. Era una estate di San Martino, una primavera de' morti, grave e soave, in cui Roma adagiavasi, tutta quanta d'oro come una città dell'Estremo Oriente, sotto un ciel quasi latteo, diafano come i cieli che si specchiano ne' mari australi. […] Aborrendo dal dolore per natura e per educazione, era vulnerabile in ogni parte, accessibile al dolore in ogni parte. Nel tumulto delle inclinazioni contraddittorie egli aveva smarrito ogni volontà ed ogni moralità. La volontà, abdicando, aveva ceduto lo scettro agli istinti; il senso estetico aveva sostituito il senso morale. 15 - “La prosa notturna” dal “Notturno” (G. D’Annunzio) Sento il sole dietro le imposte. Sento che c’è un’afa di marzo chiara e languida sul canale. Sento che è bassa marea. La primavera entra in me come un nuovo tossico. Ho le reni dolenti, in una sonnolenza rotta di sussulti e di tremori. Ascolto. Lo sciacquìo alla riva lasciato dal battello che passa. I colpi sordi dell’onda contro la pietra grommosa. Le grida rauche dei gabbiani, i loro scrosci chiocci, le loro risse stridenti, le loro pause galleggianti. Il battito di un motore marino. Il chioccolìo sciocco del merlo. Il ronzìo lùgubre d’una mosca che si leva e si posa. Il ticchettìo del pendolo che lega tutti gli intervalli. La gocciola che cade nella vasca del bagno. Il gemito del remo nello scalmo. Le voci umane nel traghetto. Il rastrello su la ghiaia del giardino. Il pianto d’un bimbo non racconsolato. Una voce di donna che parla e non s’intende. Un’altra voce di donna che dice: «A che ora? a che ora?» […] Dal bulbo dell’occhio, con una fitta improvvisa, rompe il giacinto violetto. Serro i denti. Sento le barbe aggrovigliate nel cervello. Sento distinte le membrane e le squame carnose. Il gambo s’allunga. Il fiore si compisce, s’infoltisce, s’appesantisce. È cupo, è quasi nero. Lo vedo. Chi me l’ha scerpato? Ho paura del mio grido folle. L’umore vischioso impiastra la compressa, mi cola giù per la gota. Il nero rispunta, con una fitta più acuta. Rinasce e si stronca e m’invesca. E io grido. Rigitta ancóra, si spezza ancóra. Oggi non ho più nell’occhio il giacinto cupo. Oggi ho nell’occhio non so che fiore villoso, tra rossigno e gialligno, simile all’orecchio di un cuccioletto. 16 - “La pioggia nel pineto” (G. D’Annunzio) Taci. Su le soglie del bosco non odo parole che dici umane; ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse. Piove su le tamerici salmastre ed arse, piove su i pini scagliosi ed irti, piove su i mirti divini, su le ginestre fulgenti di fiori accolti, su i ginepri folti di coccole aulenti, piove su i nostri vólti silvani, piove su le nostre mani ignude, su i nostri vestimenti leggieri, su i freschi pensieri che l’anima schiude novella, su la favola bella che ieri t’illuse, che oggi m’illude, o Ermione. Odi? La pioggia cade su la solitaria verdura con un crepitìo che dura e varia nell’aria secondo le fronde più rade, men rade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale che il pianto australe non impaura, né il ciel cinerino. E il pino 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ha un suono, e il mirto altro suono, e il ginepro altro ancóra, stromenti diversi sotto innumerevoli dita. E immersi noi siam nello spirto silvestre, d’arborea vita viventi; e il tuo vólto ebro è molle di pioggia come una foglia, e le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta, ascolta. L’accordo delle aeree cicale a poco a poco più sordo si fa sotto il pianto che cresce; ma un canto vi si mesce più roco che di laggiù sale, dall’umida ombra remota. Più sordo e più fioco s’allenta, si spegne. Sola una nota ancor trema, si spegne, risorge, trema, si spegne. Non s’ode voce del mare. Or s’ode su tutta la fronda crosciare l’argentea pioggia che monda, il croscio che varia secondo la fronda più folta, men folta. Ascolta. La figlia dell’aria è muta; ma la figlia del limo lontana, la rana, canta nell’ombra più fonda, chi sa dove, chi sa dove! E piove su le tue ciglia, Ermione. 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Piove su le tue ciglia nere sì che par tu pianga ma di piacere; non bianca ma quasi fatta virente, par da scorza tu esca. E tutta la vita è in noi fresca aulente, il cuor nel petto è come pèsca intatta, tra le pàlpebre gli occhi son come polle tra l’erbe, i denti negli alvèoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti or disciolti (e il verde vigor rude ci allaccia i mallèoli c’intrica i ginocchi) chi sa dove, chi sa dove! E piove su i nostri vólti silvani, piove su le nostre mani ignude, su i nostri vestimenti leggieri, su i freschi pensieri che l’anima schiude novella, su la favola bella che ieri m’illuse, che oggi t’illude, o Ermione. 100 105 110 115 120 125 17 - “Qui giacciono i miei cani” (G. D’Annunzio) Qui giacciono i miei cani gli inutili miei cani, stupidi ed impudichi, novi sempre et antichi, fedeli et infedeli all’Ozio lor signore, non a me uom da nulla. Rosicchiano sotterra nel buio senza fine rodon gli ossi i lor ossi, non cessano di rodere i lor ossi vuotati di medulla et io potrei farne la fistola di Pan come di sette canne i’ potrei senza cera e senza lino farne il flauto di Pan se Pan è il tutto e se la morte è il tutto. Ogni uomo nella culla succia e sbava il suo dito ogni uomo seppellito è il cane del suo nulla. 18 - “Arano” (G. Pascoli) Al campo, dove roggio nel filare qualche pampano brilla, e dalle fratte sembra la nebbia mattinal fumare, arano: a lente grida, uno le lente vacche spinge; altri semina; un ribatte le porche con sua marra paziente; ché il passero saputo in cor già gode, e il tutto spia dai rami irti del moro; e il pettirosso: nelle siepi s'ode il suo sottil tintinno come d'oro. 19 - “Novembre” (G. Pascoli) Gèmmea l’aria, il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, e del prunalbo l’odorino amaro senti nel cuore… Ma secco è il pruno, e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno, e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante sembra il terreno. Silenzio, intorno: solo, alle ventate, odi lontano, da giardini ed orti, di foglie un cader fragile. È l’estate, fredda, dei morti. 5 10 20 – “Temporale” (G. Pascoli) Un bubbolìo lontano... Rosseggia l'orizzonte, come affocato, a mare: nero di pece, a monte, stracci di nubi chiare: tra il nero un casolare: un'ala di gabbiano. 21 - “Il lampo” (G. Pascoli) E cielo e terra si mostrò qual era: la terra ansante, livida, in sussulto; il cielo ingombro, tragico, disfatto: bianca bianca nel tacito tumulto una casa apparì sparì d’un tratto; come un occhio, che, largo, esterrefatto, s’aprì si chiuse, nella notte nera. 5 21 – “X agosto” (G. Pascoli) San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto: l’uccisero: cadde tra spini: ella aveva nel becco un insetto: la cena de’ suoi rondinini. Ora è là, come in croce, che tende quel verme a quel cielo lontano; e il suo nido è nell’ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido: l’uccisero: disse: Perdono; e restò negli aperti occhi un grido: portava due bambole in dono… Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano in vano: egli immobile, attonito, addita le bambole al cielo lontano. E tu, Cielo, dall’alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh!, d’un pianto di stelle lo innondi quest’atomo opaco del Male! 5 10 15 20 23 – “L’assiuolo” (G. Pascoli) Dov’era la luna? Ché il cielo notava in un’alba di perla, ed ergersi il mandorlo e il melo parevano a meglio vederla. Venivano soffi di lampi da un nero di nubi laggiù; veniva una voce dai campi: chiù… Le stelle lucevano rare tra mezzo alla nebbia di latte: sentivo il cullare del mare, sentivo un fru fru tra le fratte; sentivo nel cuore un sussulto, com’eco d’un grido che fu. Sonava lontano il singulto: chiù… Su tutte le lucide vette tremava un sospiro di vento: squassavano le cavallette finissimi sistri d’argento (tintinni a invisibili porte che forse non s’aprono più?...); e c’era quel pianto di morte… chiù… 24 - “Italy”: cap.III, vv. 1-25; cap. IV, vv. 17-25) (G. Pascoli) E i figli la rividero alla fiamma del focolare, curva, sfatta, smunta. «Ma siete trista! siete trista, o mamma!» Ed accostando agli occhi, essa, la punta del pannelletto, con un fil di voce: «E il Cecco è fiero? E come va l'Assunta?» «Ma voi! Ma voi!» «Là là, con la mia croce». I muri grezzi apparvero col banco vecchio e la vecchia tavola di noce. Di nuovo, un moro, con non altro bianco che gli occhi e i denti, era incollato al muro, la lenza a spalla ed una mano al fianco: roba di là. Tutto era vecchio, scuro. S'udiva il soffio delle vacche, e il sito della capanna empiva l'abituro. Beppe sedé col capo indolenzito tra le due mani. La bambina bionda ora ammiccava qua e là col dito. Parlava, e la sua nonna, tremebonda, stava a sentire e poi dicea: «Non pare un luì quando canta tra la fronda?» Parlava la sua lingua d'oltremare: «... a chicken-house» «un piccolo luì...» «... for mice and rats» «che goda a cinguettare, zi zi» «Bad country, Ioe, your Italy!» Maria guardava. Due rosette rosse aveva, aveva lagrime lontane negli occhi, un colpo ad or ad or di tosse. La nonna intanto ripetea: «Stamane fa freddo!» Un bianco borracciol consunto mettea sul desco ed affettava il pane. Pane di casa e latte appena munto. Dicea: «Bambina, state al fuoco: nieva! nieva!» E qui Beppe soggiungea compunto: «Poor Molly! qui non trovi il pai con fleva!» 25 – “Italy”: cap. VI, vv. 1-25; VII 7-25; VIII 7-18 (G. Pascoli) Oh! no: non c'era lì né pie né flavour né tutto il resto. Ruppe in un gran pianto: «Ioe, what means nieva? Never? Never? Never?» Oh! no: starebbe in Italy sin tanto ch'ella guarisse: one month or two, poor Molly! E Ioe godrebbe questo po' di scianto! Mugliava il vento che scendea dai colli bianchi di neve. Ella mangiò, poi muta fissò la fiamma con gli occhioni molli. Venne, sapendo della lor venuta, gente, e qualcosa rispondeva a tutti Ioe, grave: «Oh yes, è fiero... vi saluta... molti bisini, oh yes... No, tiene un fruttistendo... Oh yes, vende checche, candi, scrima... Conta moneta: può campar coi frutti... Il baschetto non rende come prima... Yes, un salone, che ci ha tanti bordi... Yes, l'ho rivisto nel pigliar la stima...» Il tramontano discendea con sordi brontoli. Ognuno si godeva i cari ricordi, cari ma perché ricordi: quando sbarcati dagli ignoti mari scorrean le terre ignote con un grido straniero in bocca, a guadagnar danari per farsi un campo, per rifarsi un nido... Un campettino da vangare, un nido da riposare: riposare, e ancora gettare in sogno quel lontano grido: Will you buy... per Chicago e Baltimora, buy images... per Troy, Memphis, Atlanta, con una voce che te stesso accora: cheap!... nella notte, solo in mezzo a tanta gente; cheap! cheap! tra un urlerìo che opprime; cheap!... Finalmente un altro odi, che canta... Tu non sai come, intorno a te le cime sono dell'Alpi, in cui si arrossa il cielo: chi canta, è il gallo sopra il tuo concime. «La mi' Mèrica! Quando entra quel gelo, ch'uno ritrova quella stufa roggia per il gran coke, e si rià, poor fellow! O va per via, battuto dalla pioggia. Trova un farm. You want buy? Mostra il baschetto. Un uomo compra tutto. Anche, l'alloggia!» Diceva alcuno; ed assentiano al detto gli altri seduti entro la casa nera, più nera sotto il bianco orlo del tetto. Uno guardò la piccola straniera, prima non vista, muta, che tossì. «You like this country...» Ella negò severa: «Oh no! Bad Italy! Bad Italy!» Ghita diceva: «Mamma, a che filate? Nessuna fila in Mèrica. Son usi d'una volta, del tempo delle fate. Oh yes! filare! Assai mi ci confusi da bimba. Or c'è la macchina che scocca d'un frullo solo centomila fusi. Oh yes! Ben altro che la vostra rócca! E fila unito. E duole poi la vita e ci si sente prosciugar la bocca!» La mamma allora con le magre dita le sue gugliate traea giù più rare, perché ciascuna fosse bella unita. Vedea le fate, le vedea scoccare fusi a migliaia, e s'indugiava a lungo nel suo cantuccio presso il focolare. Diceva: «Andate a letto, io vi raggiungo». Vedea le mille fate nelle grotte illuminate. A lei faceva il fungo la lucernina nell'oscura notte. Ghita diceva: «Madre, a che tessete? Là può comprare, a pochi cents, chi vuole, cambrì, percalli, lustri come sete. E poi la vita dite che vi duole! C'è dei telari in Mèrica, in cui vanno ogni minuto centomila spole. E ce n'ha mille ogni città, che fanno ciascuno tanta tela in uno scatto, quanta voi non ne fate in capo all'anno». Dicea la mamma: «Il braccio ch'io ricatto bel bello, vuole diventar rotello. O figlia, più non è da fare, il fatto». 26 - “Il gelsomino notturno” (G. Pascoli) E s’aprono i fiori notturni , nell’ora che penso ai miei cari. Sono apparse in mezzo ai viburni Le farfalle crepuscolari. Da un pezzo si tacquero i gridi: là sola una casa bisbiglia. Sotto l’ali dormono i nidi , come gli occhi sotto le ciglia. Dai calici aperti si esala L’odore di fragole rosse. Splende un lume là nella sala. Nasce l’erba sopra le fosse. Un’ape tardiva sussurra Trovando già prese le celle. La Chioccetta per l’aia azzurra Va col suo pigolio di stelle. Per tutta la notte s’esala L’odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala; brilla al primo piano: s’è spento… È l’alba: si chiudono i petali Un poco gualciti ; si cova, dentro l’urna molle e segreta , non so che felicità nuova. 27 - “Prefazione” e “Preambolo” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) PREFAZIONE Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-analisi s'intende, sa dove piazzare l'antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arriccerranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l'autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui accumulate!... DOTTOR S. PREAMBOLO Vedere la mia infanzia? Più di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero arrivarci se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d'ogni genere, vere alte montagne: i miei anni e qualche mia ora. Il dottore mi raccomandò di non ostinarmi a guardare tanto lontano. Anche le cose recenti sono preziose per essi e sopra tutto le immaginazioni e i sogni della notte prima. Ma un po' d'ordine pur dovrebb'esserci e per poter cominciare ab ovo, appena abbandonato il dottore che di questi giorni e per lungo tempo lascia Trieste, solo per facilitargli il compito, comperai e lessi un trattato di psico-analisi. Non è difficile d'intenderlo, ma molto noioso. Dopo pranzato, sdraiato comodamente su una poltrona Club, ho la matita e un pezzo di carta in mano. La mia fronte è spianata perché dalla mia mente eliminai ogni sforzo. Il mio pensiero mi appare isolato da me. Io lo vedo. S'alza, s'abbassa... ma è la sua sola attività. Per ricordargli ch'esso è il pensiero e che sarebbe suo compito di manifestarsi, afferro la matita. Ecco che la mia fronte si corruga perché ogni parola è composta di tante lettere e il presente imperioso risorge ed offusca il passato. Ieri avevo tentato il massimo abbandono. L'esperimento finì nel sonno più profondo e non ne ebbi altro risultato che un grande ristoro e la curiosa sensazione di aver visto durante quel sonno qualche cosa d'importante. Ma era dimenticata, perduta per sempre. Mercé la matita che ho in mano, resto desto, oggi. Vedo, intravvedo delle immagini bizzarre che non possono avere nessuna relazione col mio passato: una locomotiva che sbuffa su una salita trascinando delle innumerevoli vetture; chissà donde venga e dove vada e perché sia ora capitata qui! Nel dormiveglia ricordo che il mio testo asserisce che con questo sistema si può arrivar a ricordare la prima infanzia, quella in fasce. Subito vedo un bambino in fasce, ma perché dovrei essere io quello? Non mi somiglia affatto e credo sia invece quello nato poche settimane or sono a mia cognata e che ci fu fatto vedere quale un miracolo perché ha le mani tanto piccole e gli occhi tanto grandi. Povero bambino! Altro che ricordare la mia infanzia! Io non trovo neppure la via di avvisare te, che vivi ora la tua, dell'importanza di ricordarla a vantaggio della tua intelligenza e della tua salute. Quando arriverai a sapere che sarebbe bene tu sapessi mandare a mente la tua vita, anche quella tanta parte di essa che ti ripugnerà? E intanto, inconscio, vai investigando il tuo piccolo organismo alla ricerca del piacere e le tue scoperte deliziose ti avvieranno al dolore e alla malattia cui sarai spinto anche da coloro che non lo vorrebbero. Come fare? È impossibile tutelare la tua culla. Nel tuo seno - fantolino! - si va facendo una combinazione misteriosa. Ogni minuto che passa vi getta un reagente. Troppe probabilità di malattia vi sono per te, perché non tutti i tuoi minuti possono essere puri. Eppoi - fantolino! - sei consanguineo di persone ch'io conosco. I minuti che passano ora possono anche essere puri, ma, certo, tali non furono tutti i secoli che ti prepararono. Eccomi ben lontano dalle immagini che precorrono il sonno. Ritenterò domani. 28 - “La morte del padre” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) Mia madre era morta quand'io non avevo ancora quindici anni. Feci delle poesie per onorarla ciò che mai equivale a piangere e, nel dolore, fui sempre accompagnato dal sentimento che da quel momento doveva iniziarsi per me una vita seria e di lavoro. Il dolore stesso accennava ad una vita più intensa. Poi un sentimento religioso tuttavia vivo attenuò e addolcì la grave sciagura. Mia madre continuava a vivere sebbene distante da me e poteva anche compiacersi dei successi cui andavo preparandomi. Una bella comodità! Ricordo esattamente il mio stato di allora. Per la morte di mia madre e la salutare emozione ch'essa m'aveva procurata, tutto da me doveva migliorarsi. Invece la morte di mio padre fu una vera, grande catastrofe. Il paradiso non esisteva più ed io poi, a trent'anni, ero un uomo finito. Anch'io! M'accorsi per la prima volta che la parte più importante e decisiva della mia vita giaceva dietro di me, irrimediabilmente. Il mio dolore non era solo egoistico come potrebbe sembrare da queste parole. Tutt'altro! Io piangevo lui e me, e me solo perché era morto lui. Fino ad allora io ero passato di sigaretta in sigaretta e da una facoltà universitaria all'altra, con una fiducia indistruttibile nelle mie capacità. Ma io credo che quella fiducia che rendeva tanto dolce la vita, sarebbe continuata magari fino ad oggi, se mio padre non fosse morto. Lui morto non c'era più una dimane ove collocare il proposito. Tante volte, quando ci penso, resto stupito della stranezza per cui questa disperazione di me e del mio avvenire si sia prodotta alla morte di mio padre e non prima. Sono in complesso cose recenti e per ricordare il mio enorme dolore e ogni particolare della sventura non ho certo bisogno di sognare come vogliono i signori dell'analisi. Ricordo tutto, ma non intendo niente. Fino alla sua morte io non vissi per mio padre. Non feci alcuno sforzo per avvicinarmi a lui e, quando si poté farlo senz'offenderlo, lo evitai. All'Università tutti lo conoscevano col nomignolo ch'io gli diedi di vecchio Silva manda denari. Ci volle la malattia per legarmi a lui; la malattia che fu subito la morte, perché brevissima e perché il medico lo diede subito per spacciato. Quand'ero a Trieste ci vedevamo sì e no per un'oretta al giorno, al massimo. Mai non fummo tanto e sì a lungo insieme, come nel mio pianto. Magari l'avessi assistito meglio e pianto meno! Sarei stato meno malato. Era difficile di trovarsi insieme anche perché fra me e lui, intellettualmente non c'era nulla di comune. Guardandoci, avevamo ambedue lo stesso sorriso di compatimento, reso in lui più acido da una viva paterna ansietà per il mio avvenire; in me, invece, tutto indulgenza, sicuro com'ero che le sue debolezze oramai erano prive di conseguenze, tant'è vero ch'io le attribuivo in parte all'età. Egli fu il primo a diffidare della mia energia e, - a me sembra, troppo presto. Epperò io sospetto, che, pur senza l'appoggio di una convinzione scientifica, egli diffidasse di me anche perché ero stato fatto da lui, ciò che serviva - e qui con fede scientifica sicura - ad aumentare la mia diffidenza per lui. Egli godeva però della fama di commerciante abile, ma io sapevo che i suoi affari da lunghi anni erano diretti dall'Olivi. Nell'incapacità al commercio v'era una somiglianza fra di noi, ma non ve ne erano altre; posso dire che, fra noi due, io rappresentavo la forza e lui la debolezza. Già quello che ho registrato in questi fascicoli prova che in me c'è e c'è sempre stato - forse la mia massima sventura - un impetuoso conato al meglio. Tutti i miei sogni di equilibrio e di forza non possono essere definiti altrimenti. Mio padre non conosceva nulla di tutto ciò. Egli viveva perfettamente d'accordo sul modo come l'avevano fatto ed io devo ritenere ch'egli mai abbia compiuti degli sforzi per migliorarsi. Fumava il giorno intero e, dopo la morte di mamma, quando non dormiva, anche di notte. Beveva anche discretamente; da gentleman, di sera, a cena, tanto da essere sicuro di trovare il sonno pronto non appena posata la testa sul guanciale. Ma, secondo lui, il fumo e l'alcool erano dei buoni medicinali. In quanto concerne le donne, dai parenti appresi che mia madre aveva avuto qualche motivo di gelosia. Anzi pare che la mite donna abbia dovuto intervenire talvolta violentemente per tenere a freno il marito. Egli si lasciava guidare da lei che amava e rispettava, ma pare ch'essa non sia mai riuscita ad avere da lui la confessione di alcun tradimento, per cui morì nella fede di essersi sbagliata. Eppure i buoni parenti raccontano ch'essa ha trovato il marito quasi in flagrante dalla propria sarta. Egli si scusò con un accesso di distrazione e con tanta costanza che fu creduto. Non vi fu altra conseguenza che quella che mia madre non andò più da quella sarta e mio padre neppure. Io credo che nei suoi panni io avrei finito col confessare, ma che poi non avrei saputo abbandonare la sarta, visto ch'io metto le radici dove mi soffermo. Mio padre sapeva difendere la sua quiete da vero pater familias. L'aveva questa quiete nella sua casa e nell'animo suo. Non leggeva che dei libri insulsi e morali. Non mica per ipocrisia, ma per la più sincera convinzione: penso ch'egli sentisse vivamente la verità di quelle prediche morali e che la sua coscienza fosse quietata dalla sua adesione sincera alla virtù. Adesso che invecchio e m'avvicino al tipo del patriarca, anch'io sento che un'immoralità predicata è più punibile di un'azione immorale. Si arriva all'assassinio per amore o per odio; alla propaganda dell'assassinio solo per malvagità. Avevamo tanto poco di comune fra di noi, ch'egli mi confessò che una delle persone che più l'inquietavano a questo mondo ero io. Il mio desiderio di salute m'aveva spinto a studiare il corpo umano. Egli, invece, aveva saputo eliminare dal suo ricordo ogni idea di quella spaventosa macchina. Per lui il cuore non pulsava e non v'era bisogno di ricordare valvole e vene e ricambio per spiegare come il suo organismo viveva. Niente movimento perché l'esperienza diceva che quanto si moveva finiva coll'arrestarsi. Anche la terra era per lui immobile e solidamente piantata su dei cardini. Naturalmente non lo disse mai, ma soffriva se gli si diceva qualche cosa che a tale concezione non si conformasse. M'interruppe con disgusto un giorno che gli parlai degli antipodi. Il pensiero di quella gente con la testa all'ingiù gli sconvolgeva lo stomaco. Egli mi rimproverava due altre cose: la mia distrazione e la mia tendenza a ridere delle cose più serie. In fatto di distrazione egli differiva da me per un certo suo libretto in cui notava tutto quello ch'egli voleva ricordare e che rivedeva più volte al giorno. Credeva così di aver vinta la sua malattia e non ne soffriva più. Impose quel libretto anche a me, ma io non vi registrai che qualche ultima sigaretta. In quanto al mio disprezzo per le cose serie, io credo ch'egli avesse il difetto di considerare come serie troppe cose di questo mondo. Eccone un esempio: quando, dopo di essere passato dagli studii di legge a quelli di chimica, io ritornai col suo permesso ai primi, egli mi disse bonariamente: - Resta però assodato che tu sei un pazzo. Io non me ne offesi affatto e gli fui tanto grato della sua condiscendenza, che volli premiarlo facendolo ridere. Andai dal dottor Canestrini a farmi esaminare per averne un certificato. La cosa non fu facile perché dovetti sottomettermi perciò a lunghe e minuziose disamine. Ottenutolo, portai trionfalmente quel certificato a mio padre, ma egli non seppe riderne. Con accento accorato e con le lacrime agli occhi esclamò: - Ah! Tu sei veramente pazzo! E questo fu il premio della mia faticosa e innocua commediola. Non me la perdonò mai e perciò mai ne rise. Farsi visitare da un medico per ischerzo? Far redigere per ischerzo un certificato munito di bolli? Cose da pazzi! Insomma io, accanto a lui, rappresentavo la forza e talvolta penso che la scomparsa di quella debolezza, che mi elevava, fu sentita da me come una diminuzione. […] Andammo al letto dell'ammalato. Con l'aiuto dell'infermiere egli girò e rigirò quel povero corpo inerte per un tempo che a me parve lunghissimo. Lo ascoltò e lo esplorò. Tentò di farsi aiutare dal paziente stesso, ma invano. - Basta! - disse ad un certo punto. Mi si avvicinò con gli occhiali in mano guardando il pavimento e, con un sospiro, mi disse: - Abbiate coraggio! È un caso gravissimo. Andammo alla mia stanza ove egli si lavò anche la faccia. Era perciò senza occhiali e quando l'alzò per asciugarla, la sua testa bagnata sembrava la testina strana di un amuleto fatta da mani inesperte. Ricordò di averci visti alcuni mesi prima ed espresse meraviglia perché non fossimo più ritornati da lui. Anzi aveva creduto che lo avessimo abbandonato per altro medico; egli allora aveva ben chiaramente dichiarato che mio padre abbisognava di cure. Quando rimproverava, così senz'occhiali, era terribile. Aveva alzata la voce e voleva spiegazioni. I suoi occhi le cercavano dappertutto. Certo egli aveva ragione ed io meritavo dei rimproveri. Debbo dire qui, che sono sicuro che non è per quelle parole che io odio il dottor Coprosich. Mi scusai raccontandogli dell'avversione di mio padre per medici e medicine; parlavo piangendo e il dottore, con bontà generosa, cercò di quietarmi dicendomi che se anche fossimo ricorsi a lui prima, la sua scienza avrebbe potuto tutt'al più ritardare la catastrofe cui assistevamo ora, ma non impedirla. Però, come continuò a indagare sui precedenti della malattia, ebbe nuovi argomenti di rimprovero per me. Egli voleva sapere se mio padre in quegli ultimi mesi si fosse lagnato delle sue condizioni di salute, del suo appetito e del suo sonno. Non seppi dirgli nulla di preciso; neppure se mio padre avesse mangiato molto o poco a quel tavolo a cui sedevamo giornalmente insieme. L'evidenza della mia colpa m'atterrò, ma il dottore non insistette affatto nelle domande. Apprese da me che Maria lo vedeva sempre moribondo e ch'io perciò la deridevo. Egli stava pulendosi le orecchie, guardando in alto. - Fra un paio d'ore probabilmente ricupererà la coscienza almeno in parte, - disse. - C'è qualche speranza dunque? - esclamai io. - Nessunissima! - rispose seccamente. - Però le mignatte non sbagliano mai in questo caso. Ricupererà di sicuro un po' della sua coscienza, forse per impazzire. Alzò le spalle e rimise a posto l'asciugamano. Quell'alzata di spalle significava proprio un disdegno per l'opera propria e m'incoraggiò a parlare. Ero pieno di terrore all'idea che mio padre avesse potuto rimettersi dal suo torpore per vedersi morire, ma senza quell'alzata di spalle non avrei avuto il coraggio di dirlo. - Dottore! - supplicai. - Non le pare sia una cattiva azione di farlo ritornare in sé? Scoppiai in pianto. La voglia di piangere l'avevo sempre nei miei nervi scossi, ma mi vi abbandonavo senza resistenza per far vedere le mie lagrime e farmi perdonare dal dottore il giudizio che avevo osato di dare sull'opera sua. Con grande bontà egli mi disse: - Via, si calmi. La coscienza dell'infermo non sarà mai tanto chiara da fargli comprendere il suo stato. Egli non è un medico. Basterà non dirgli ch'è moribondo, ed egli non lo saprà. Ci può invece toccare di peggio: potrebbe cioè impazzire. Ho però portata con me la camicia di forza e l'infermiere resterà qui. Più spaventato che mai, lo supplicai di non applicargli le mignatte. Egli allora con tutta calma mi raccontò che l'infermiere gliele aveva sicuramente già applicate perché egli ne aveva dato l'ordine prima di lasciare la stanza di mio padre. Allora m'arrabbiai. Poteva esserci un'azione più malvagia di quella di richiamare in sé un ammalato, senz'avere la minima speranza di salvarlo e solo per esporlo alla disperazione, o al rischio di dover sopportare - con quell'affanno! - la camicia di forza? Con tutta violenza, ma sempre accompagnando le mie parole di quel pianto che domandava indulgenza, dichiarai che mi pareva una crudeltà inaudita di non lasciar morire in pace chi era definitivamente condannato. Io odio quell'uomo perché egli allora s'arrabbiò con me. È ciò ch'io non seppi mai perdonargli. Egli s'agitò tanto che dimenticò d'inforcare gli occhiali e tuttavia scoperse esattamente il punto ove si trovava la mia testa per fissarla con i suoi occhi terribili. Mi disse che gli pareva io volessi recidere anche quel tenue filo di speranza che vi era ancora. Me lo disse proprio così, crudamente. Ci si avviava a un conflitto. Piangendo e urlando obbiettai che pochi istanti prima egli stesso aveva esclusa qualunque speranza di salvezza per l'ammalato. La casa mia e chi vi abitava non dovevano servire ad esperimenti per i quali c'erano altri posti a questo mondo! Con grande severità e una calma che la rendeva quasi minacciosa, egli rispose: - Io le spiegai quale era lo stato della scienza in quell'istante. Ma chi può dire quello che può avvenire fra mezz'ora o fino a domani? Tenendo in vita suo padre io ho lasciata aperta la via a tutte le possibilità. Si mise allora gli occhiali e, col suo aspetto d'impiegato pedantesco, aggiunse ancora delle spiegazioni che non finivano più, sull'importanza che poteva avere l'intervento del medico nel destino economico di una famiglia. Mezz'ora in più di respiro poteva decidere del destino di un patrimonio. Piangevo oramai anche perché compassionavo me stesso per dover star a sentire tali cose in simile momento. Ero esausto e cessai dal discutere. Tanto le mignatte erano già state applicate! Il medico è una potenza quando si trova al letto di un ammalato ed io al dottor Coprosich usai ogni riguardo. Dev'essere stato per tale riguardo ch'io non osai di proporre un consulto, cosa che mi rimproverai per lunghi anni. Ora anche quel rimorso è morto insieme a tutti i miei altri sentimenti di cui parlo qui con la freddezza con cui racconterei di avvenimenti toccati ad un estraneo. Nel mio cuore, di quei giorni, non v'è altro residuo che l'antipatia per quel medico che tuttavia si ostina a vivere. Più tardi andammo ancora una volta al letto di mio padre. Lo trovammo che dormiva adagiato sul fianco destro. Gli avevano posta una pezzuola sulla tempia per coprire le ferite prodotte dalle mignatte. Il dottore volle subito provare se la sua coscienza avesse aumentato e gli gridò nelle orecchie. L'ammalato non reagì in alcun modo. - Meglio così! - dissi io con grande coraggio, ma sempre piangendo. - L'effetto atteso non potrà mancare! - rispose il dottore. - Non vede che la respirazione s'è già modificata? Infatti, frettolosa e affaticata, la respirazione non formava più quei periodi che mi avevano spaventato. L'infermiere disse qualche cosa al medico che annuì. Si trattava di provare al malato la camicia di forza. Trassero quell'ordigno dalla valigia e alzarono mio padre obbligandolo a star seduto sul letto. Allora l'ammalato aperse gli occhi: erano foschi, non ancora aperti alla luce. Io singhiozzai ancora, temendo che subito guardassero e vedessero tutto. Invece, quando la testa dell'ammalato ritornò sul guanciale, quegli occhi si rinchiusero, come quelli di certe bambole. Il dottore trionfò: - È tutt'altra cosa; - mormorò. Sì: era tutt'altra cosa! Per me nient'altro che una grave minaccia. Con fervore baciai mio padre sulla fronte e nel pensiero gli augurai: - Oh, dormi! Dormi fino ad arrivare al sonno eterno! Ed è così che augurai a mio padre la morte, ma il dottore non l'indovinò perché mi disse bonariamente: - Anche a lei fa piacere, ora, di vederlo ritornare in sé! Quando il dottore partì, l'alba era spuntata. Un'alba fosca, esitante. Il vento che soffiava ancora a raffiche, mi parve meno violento, benché sollevasse tuttavia la neve ghiacciata. Accompagnai il dottore in giardino. Esageravo gli atti di cortesia perché non indovinasse il mio livore. La mia faccia significava solo considerazione e rispetto. Mi concessi una smorfia di disgusto, che mi sollevò dallo sforzo, solo quando lo vidi allontanare per il viottolo che conduceva all'uscita della villa. Piccolo e nero in mezzo alla neve, barcollava e si fermava ad ogni raffica per poter resistere meglio. Non mi bastò quella smorfia e sentii il bisogno di altri atti violenti, dopo tanto sforzo. Camminai per qualche minuto per il viale, nel freddo, a capo scoperto, pestando irosamente i piedi nella neve alta. Non so però se tanta ira puerile fosse rivolta al dottore o non piuttosto a me stesso. Prima di tutto a me stesso, a me che avevo voluto morto mio padre e che non avevo osato dirlo. Il mio silenzio convertiva quel mio desiderio ispirato dal più puro affetto filiale, in un vero delitto che mi pesava orrendamente. Poco dopo ero a letto, ma non seppi chiuder occhio. Guardavo nell'avvenire indagando per trovare perché e per chi avrei potuto continuare i miei sforzi di migliorarmi. Piansi molto, ma piuttosto su me stesso che sul disgraziato che correva senza pace per la sua camera. Quando mi levai, Maria andò a coricarsi ed io restai accanto a mio padre insieme all'infermiere. Ero abbattuto e stanco; mio padre più irrequieto che mai. Fu allora che avvenne la scena terribile che non dimenticherò mai e che gettò lontano lontano la sua ombra, che offuscò ogni mio coraggio, ogni mia gioia. Per dimenticarne il dolore, fu d'uopo che ogni mio sentimento fosse affievolito dagli anni. L'infermiere mi disse: - Come sarebbe bene se riuscissimo di tenerlo a letto. Il dottore vi dà tanta importanza! Fino a quel momento io ero rimasto adagiato sul sofà. Mi levai e andai al letto ove, in quel momento, ansante più che mai, l'ammalato s'era coricato. Ero deciso: avrei costretto mio padre di restare almeno per mezz'ora nel riposo voluto dal medico. Non era questo il mio dovere? Subito mio padre tentò di ribaltarsi verso la sponda del letto per sottrarsi alla mia pressione e levarsi. Con mano vigorosa poggiata sulla sua spalla, gliel'impedii mentre a voce alta e imperiosa gli comandavo di non moversi. Per un breve istante, terrorizzato, egli obbedì. Poi esclamò: - Muoio! E si rizzò. A mia volta, subito spaventato dal suo grido, rallentai la pressione della mia mano. Perciò egli poté sedere sulla sponda del letto proprio di faccia a me. Io penso che allora la sua ira fu aumentata al trovarsi - sebbene per un momento solo - impedito nei movimenti e gli parve certo ch'io gli togliessi anche l'aria di cui aveva tanto bisogno, come gli toglievo la luce stando in piedi contro di lui seduto. Con uno sforzo supremo arrivò a mettersi in piedi, alzò la mano alto alto, come se avesse saputo ch'egli non poteva comunicarle altra forza che quella del suo peso e la lasciò cadere sulla mia guancia. Poi scivolò sul letto e di là sul pavimento. Morto! Non lo sapevo morto, ma mi si contrasse il cuore dal dolore della punizione ch'egli, moribondo, aveva voluto darmi. Con l'aiuto di Carlo lo sollevai e lo riposi in letto. Piangendo, proprio come un bambino punito, gli gridai nell'orecchio: - Non è colpa mia! Fu quel maledetto dottore che voleva obbligarti di star sdraiato! Era una bugia. Poi, ancora come un bambino, aggiunsi la promessa di non farlo più: - Ti lascerò movere come vorrai. L'infermiere disse: - È morto. Dovettero allontanarmi a viva forza da quella stanza. Egli era morto ed io non potevo più provargli la mia innocenza! Nella solitudine tentai di riavermi. Ragionavo: era escluso che mio padre, ch'era sempre fuori di sensi, avesse potuto risolvere di punirmi e dirigere la sua mano con tanta esattezza da colpire la mia guancia. Come sarebbe stato possibile di avere la certezza che il mio ragionamento era giusto? Pensai persino di dirigermi a Coprosich. Egli, quale medico, avrebbe potuto dirmi qualche cosa sulle capacità di risolvere e agire di un moribondo. Potevo anche essere stato vittima di un atto provocato da un tentativo di facilitarsi la respirazione! Ma col dottor Coprosich non parlai. Era impossibile di andar a rivelare a lui come mio padre si fosse congedato da me. A lui, che m'aveva già accusato di aver mancato di affetto per mio padre! Fu un ulteriore grave colpo per me quando sentii che Carlo, l'infermiere, in cucina, di sera, raccontava a Maria: - Il padre alzò alto alto la mano e con l'ultimo suo atto picchiò il figliuolo. - Egli lo sapeva e perciò Coprosich l'avrebbe risaputo. Quando mi recai nella stanza mortuaria, trovai che avevano vestito il cadavere. L'infermiere doveva anche avergli ravviata la bella, bianca chioma. La morte aveva già irrigidito quel corpo che giaceva superbo e minaccioso. Le sue mani grandi, potenti, ben formate, erano livide, ma giacevano con tanta naturalezza che parevano pronte ad afferrare e punire. Non volli, non seppi più rivederlo. Poi, al funerale, riuscii a ricordare mio padre debole e buono come l'avevo sempre conosciuto dopo la mia infanzia e mi convinsi che quello schiaffo che m'era stato inflitto da lui moribondo, non era stato da lui voluto. Divenni buono, buono e il ricordo di mio padre s'accompagnò a me, divenendo sempre più dolce. Fu come un sogno delizioso: eravamo oramai perfettamente d'accordo, io divenuto il più debole e lui il più forte. Ritornai e per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia. Immaginavo che mio padre mi sentisse e potessi dirgli che la colpa non era stata mia, ma del dottore. La bugia non aveva importanza perché egli oramai intendeva tutto ed io pure. E per parecchio tempo i colloqui con mio padre continuarono dolci e celati come un amore illecito, perché io dinanzi a tutti continuai a ridere di ogni pratica religiosa, mentre è vero - e qui voglio confessarlo - che io a qualcuno giornalmente e ferventemente raccomandai l'anima di mio padre. È proprio la religione vera quella che non occorre professare ad alta voce per averne il conforto di cui qualche volta - raramente - non si può fare a meno. 29 - “La salute “malata” di Augusta” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupì: io amavo Augusta com'essa amava me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m'aspettavo che la seguente fosse tutt'altra cosa. Ma una seguiva e somigliava all'altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche - ciò ch'era la sorpresa - mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva: - Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto così? Lo sapevo pur io che sono tanto più ignorante di te! Non so più se dopo o prima dell'affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di poter finire col somigliare ad Augusta ch'era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non avevo neppur intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada e Guido. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta. Altro che il suo rossore! Quando questo sparve con la semplicità con cui i colori dell'aurora spariscono alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle su questa terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell'ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. Per quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo. Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita. Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. Non che la dicessi tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai ch'eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, breve, breve, che non s'intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo di non essersi conosciuti per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai più per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall'infettare chi a me s'era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo movermi come un uomo sano. Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare! Tutt'altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano un'importanza enorme: l'anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare di giorno, né quando io non m'adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto. Di domenica essa andava a Messa ed io ve l'accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l'immagine del dolore e della morte. Per lei non c'era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch'essa sapeva a mente. Niente di più, mentre se io fossi stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno. C'erano un mondo di autorità anche quaggiù che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel suo rispetto. Poi v'erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii regolari per salvarci quando - Dio non voglia - ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell'autorità: lei, invece, mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale m'avesse raggiunto, mentre lei credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassù e quaggiù, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m'accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o d'istruzione per guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 30 - “La profezia di un’apocalisse cosmica” da “La Coscienza di Zeno” (I. Svevo) La vita somiglia un poco alla malattia come procede per crisi e lisi ed ha i giornalieri miglioramenti e peggioramenti. A differenza delle altre malattie la vita è sempre mortale. Non sopporta cure. Sarebbe come voler turare i buchi che abbiamo nel corpo credendoli delle ferite. Morremmo strangolati non appena curati. La vita attuale è inquinata alle radici. L'uomo s'è messo al posto degli alberi e delle bestie ed ha inquinata l'aria, ha impedito il libero spazio. Può avvenire di peggio. Il triste e attivo animale potrebbe scoprire e mettere al proprio servizio delle altre forze. V'è una minaccia di questo genere in aria. Ne seguirà una grande ricchezza... nel numero degli uomini. Ogni metro quadrato sarà occupato da un uomo. Chi ci guarirà dalla mancanza di aria e di spazio? Solamente al pensarci soffoco! Ma non è questo, non è questo soltanto. Qualunque sforzo di darci la salute è vano. Questa non può appartenere che alla bestia che conosce un solo progresso, quello del proprio organismo. Allorché la rondinella comprese che per essa non c'era altra possibile vita fuori dell'emigrazione, essa ingrossò il muscolo che muove le sue ali e che divenne la parte più considerevole del suo organismo. La talpa s'interrò e tutto il suo corpo si conformò al suo bisogno. Il cavallo s'ingrandì e trasformò il suo piede. Di alcuni animali non sappiamo il progresso, ma ci sarà stato e non avrà mai leso la loro salute. Ma l'occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c'è stata salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si comperano, si vendono e si rubano e l'uomo diventa sempre più furbo e più debole. Anzi si capisce che la sua furbizia cresce in proporzione della sua debolezza. I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere efficaci che per la forza dello stesso, ma, oramai, l'ordigno non ha più alcuna relazione con l'arto. Ed è l'ordigno che crea la malattia con l'abbandono della legge che fu su tutta la terra la creatrice. La legge del più forte sparì e perdemmo la selezione salutare. Altro che psico-analisi ci vorrebbe: sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute. Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, ruberà tale esplosivo e s'arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto potrà essere il massimo. Ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie. 31 - “Ciàula scopre la luna” (L. Pirandello) I picconieri, quella sera, volevano smettere di lavorare senz’aver finito d’estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s’affierò contr’essi, con la rivoltella in pugno, davanti alla buca della Cace, per impedire che ne uscissero. – Corpo di… sangue di… indietro tutti, giù tutti di nuovo alle cave, a buttar sangue fino all’alba, o faccio fuoco! – Bum! – fece uno dal fondo della buca. – Bum! – echeggiarono parecchi altri; e con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto, e chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti, meno uno. Chi? Zi’ Scarda, si sa, quel povero cieco d’un occhio, sul quale Cacciagallina poteva far bene il gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso, che neanche un leone; lo agguantò per il petto e, quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in faccia, scrollandolo furiosamente: – Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giù tutti alle cave, o faccio un macello! Zi’ Scarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo, quel povero galantuomo, ed era naturale se lo prendesse su lui che, vecchio com’era, poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto, aveva anche lui, a sua volta, sotto di sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi più tardi: Ciàula, il suo caruso. Quegli altri… eccoli là, s’allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini; ridevano e gridavano: – Ecco, sì! tieniti forte codesto, Cacciagallì! Te lo riempirà lui il calcherone – Gioventù! – sospirò con uno squallido sorriso d’indulgenza zi’ Scarda a Cacciagallina. E, ancora agguantato per il petto, piegò la testa da un lato, stiracchiò verso il lato opposto il labbro inferiore, e rimase così per un pezzo, come in attesa. Era una smorfia a Cacciagallina? o si burlava della gioventù di quei compagni là? Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi, strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza giovanile. Nelle dure facce quasi spente dal bujo crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate, avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo d’erba, sforacchiate dalle zolfare, come da tanti enormi formicaj. Ma no: zi’ Scarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro, né faceva una smorfia a Cacciagallina. Quello era il versacelo solito, con cui, non senza stento, si deduceva pian piano in bocca la grossa lagrima, che di tratto in tratto gli colava dall’altro occhio, da quello buono. Aveva preso gusto a quel saporino di sale, e non se ne lasciava scappar via neppur una. Poco: una goccia, di tanto in tanto; ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, duecento e più metri sottoterra, col piccone in mano, che a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, zi’ Scarda aveva sempre la bocca arsa: e quella lagrima, per la sua bocca, era quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè. Un gusto e un riposo. Quando si sentiva l’occhio pieno, posava per un poco il piccone e, guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia, che alluciava nella tenebra dell’antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là, o l’acciajo del palo o della piccozza, piegava la testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettar che la lagrima gli colasse giù, lenta, per il solco scavato dalle precedenti. Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino; lui aveva il vizio della sua lagrima. Era del sacco lacrimale malato e non di pianto, quella lagrima; ma si era bevute anche quelle del pianto, zi’ Scarda, quando, quattr’anni addietro, gli era morto l’unico figliuolo, per lo scoppio d’una mina, lasciandogli sette orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre; ed egli la riconosceva subito: scoteva il capo, allora, e mormorava un nome: – Calicchio… In considerazione di Calicchio morto, e anche dell’occhio perduto per lo scoppio della stessa mina, lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane; ma ogni sabato sera, la paga gli era data, e per dir la verità lui stesso se la prendeva, come una carità che gli facessero: tanto che, intascandola, diceva sottovoce, quasi con vergogna: – Dio gliene renda merito. Perché, di regola, doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorar bene. Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con le buone maniere qualcuno a far nottata, zi’ Scarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano al paese, ad avvertire che egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in pensiero per lui; poi si volse attorno a chiamare il suo caruso,che aveva più di trent’anni (e poteva averne anche sette o settanta, scemo com’era); e lo chiamò col verso con cui si chiamano le cornacchie ammaestrate: – Te’, pa’! te ’, pa’! Ciàula stava a rivestirsi per ritornare al paese. Rivestirsi per Ciàula significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella che un tempo era stata forse una camicia: l’unico indumento che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a una a una tutte le costole, un panciotto bello largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino (ora il luridume vi aveva fatto una tal roccia, che a posarlo per terra stava ritto). Con somma cura Ciàula ne affibbiava i sei bottoni, tre dei quali ciondolavano, e poi se lo mirava addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore a’ suoi meriti: una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche, durante quell’ammirazione, gli si accapponavano, illividite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone e gli allungava un calcio, gridandogli: – Quanto sei bello! – egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca sdentata a un riso di soddisfazione, poi infilava i calzoni, che avevano più d’una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi; s’avvolgeva in un cappottello d’albagio tutto rappezzato, e, scalzo, imitando meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia – cràh! cràh! – (per cui lo avevano soprannominato Ciàula), s’avviava al paese. – Cràh! cràh! – rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone; e gli si presentò tutto nudo, con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato. – Va’, va’ a rispogliarti, – gli disse zi’ Scarda. – Rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per noi il Signore non fa notte. Ciàula non fiatò; restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta, con occhi da ebete; poi si poggiò le mani su le reni e, raggrinzando in su il naso, per lo spasimo, si stirò e disse: – Gna bonu! (Va bene.) E andò a levarsi il panciotto. Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non sarebbe stato niente, perché laggiù, tanto, era sempre notte lo stesso. Ma questo, per zi’ Scarda. Per Ciàula, no. Ciàula, con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco su la fronte, e schiacciata la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica scala sotterranea, erta, a scalini rotti, e su, su, affievolendo a mano a mano, col fiato mózzo, quel suo crocchiare a ogni scalino, quasi in un gemito di strozzato, rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva abbagliato; poi col respiro che traeva nel liberarsi dal carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli balzavano davanti; restava, ancora ansimante, a guardarli un poco e, senza che n’avesse chiara coscienza, se ne sentiva confortare. Cosa strana: della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in agguato la morte, Ciàula non aveva paura; né paura delle ombre mostruose, che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né del subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, in uno stagno d’acqua sulfurea: sapeva sempre dov’era; toccava con la mano in cerca di sostegno le viscere della montagna: e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno. Aveva paura, invece, del bujo vano della notte. Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là dall’imbuto della scala, per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata. Ma il bujo della notte non lo conosceva. Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con zi’ Scarda; e là, appena finito d’ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra, come un cane; e invano i ragazzi, quei sette nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza; cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale, ogni mattina, alla punta dell’alba, soleva riscuoterlo un noto piede. La paura che egli aveva del bujo della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di zi’ Scarda, già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciati dallo scoppio della mina, e zi’ Scarda stesso era stato preso in un occhio. Giù, nei varii posti a zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, quando s’era sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carusi erano accorsi sul luogo dello scoppio; egli solo, Ciàula, atterrito, era scappato a ripararsi in un antro noto soltanto a lui. Nella furia di cacciarsi là, gli s’era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta, e quando alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall’antro nel silenzio delle caverne tenebrose e deserte, aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala; ma pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito, invece, nell’uscir dalla buca nella notte nera, vana. S’era messo a tremare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito indistinto nel silenzio arcano che riempiva la sterminata vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, piccolissime, non riusciva a diffondere alcuna luce. Il bujo, ove doveva esser lume, la solitudine delle cose che restavan lì con un loro aspetto cangiato e quasi irriconoscibile, quando più nessuno le vedeva, gli avevano messo in tale subbuglio l’anima smarrita, che Ciàula s’era all’improvviso lanciato in una corsa pazza, come se qualcuno lo avesse inseguito. Ora, ritornato giù nella buca con zi’ Scarda, mentre stava ad aspettare che il carico fosse pronto, egli sentiva a mano a mano crescersi lo sgomento per quel bujo che avrebbe trovato, sbucando dalla zolfara. E più per quello, che per questo delle gallerie e della scala, rigovernava attentamente la lumierina di terracotta. Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa, che non posava mai, né giorno né notte. E nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi s’intercalava il ruglio sordo di zi’ Scarda, come se il vecchio si facesse ajutare a muovere le braccia dalla forza della macchina lontana. Alla fine il carico fu pronto, e zi’ Scarda ajutò Ciàula a disporlo e rammentarlo sul sacco attorto dietro la nuca. A mano a mano che zi’ Scarda caricava, Ciàula sentiva piegarsi, sotto, le gambe. Una, a un certo punto, prese a tremargli convulsamente così forte che, temendo di non più reggere al peso, con quel tremitio, Ciàula gridò: – Basta! basta! – Che basta, carogna! – gli rispose zi’ Scarda. E seguitò a caricare. Per un momento la paura del bujo della notte fu vinta dalla costernazione che, così caricato, e con la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin lassù. Aveva lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato Ciàula che si potesse aver pietà del suo corpo, e non ci pensava neppur ora; ma sentiva che, proprio, non né poteva più. Si mosse sotto il carico enorme, che richiedeva anche uno sforzo d’equilibrio. Sì, ecco, sì, poteva muoversi, almeno finché andava in piano. Ma come sollevar quel peso, quando sarebbe cominciata la salita? Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciàula fu ripreso dalla paura del bujo della notte, a cui tra poco si sarebbe affacciato. Attraversando le gallerie, quella sera, non gli era venuto il solito verso della cornacchia, ma un gemito raschiato, protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno, arrestato dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori. La scala era così erta, che Ciàula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, pervenuto all’ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva veder la buca che vaneggiava in alto. Curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra, e su la cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno, egli veniva su, su, su, dal ventre della montagna, senza piacere, anzi pauroso della prossima liberazione. E non vedeva ancora la buca, che lassù lassù si apriva come un occhio chiaro, d’una deliziosa chiarità d’argento. Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva, cresceva sempre più, come se il sole, che egli aveva pur visto tramontare, fosse rispuntato. Possibile? Restò – appena sbucato all’aperto – sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia; aprì le mani nere in quella chiarità d’argento. Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio, gli stava di faccia la Luna. Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai importanza. E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la Luna? Ora, ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, eccola là, la Luna… C’era la Luna! la Luna! E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva pel cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, nella notte ora piena del suo stupore. 32 - “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” dai capp. VIII e IX de “Il Fu Mattia Pascal” (L. Pirandello) Subito, non tanto per ingannare gli altri, che avevan o voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente non degna d'encomio, quanto per obbedire alla Fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi posi a far di me un altr'uomo. Poco o nulla avevo da lodarmi di quel disgraziato che per forza avevano voluto far finire miseramente nella gora d'un molino. Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava forse sorte migliore. Ora mi sarebbe piaciuto che, non solo esteriormente, ma anche nell'intimo, non rimanesse più in me alcuna traccia di lui. Ero solo ormai, e più solo di com'ero non avrei potuto essere su la terra, sciolto nel presente d'ogni legame e d'ogni obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato, e con I'avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer mio. Ah, un pajo d'ali! Come mi sentivo leggero! Il sentimento che le passate vicende mi avevano dato della vita non doveva aver più per me, ormai, ragion d'essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento della vita, senza avvalermi neppur minimamente della sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. Stava a me: potevo e dovevo esser l'artefice del mio nuovo destino, nella misura che la Fortuna aveva voluto concedermi. « E innanzi tutto, » dicevo a me stesso, « avrò cura di questa mia libertà: me la condurrò a spasso per vie piane e sempre nuove, né le farò mai portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e passerò oltre appena lo spettacolo della vita in qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò di farmela più tosto con le cose che si sogliono chiamare inanimate, e andrò in cerca di belle vedute, di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco a poco una nuova educazione; mi trasformerò con amoroso e paziente studio, sicché, alla fine, io possa dire non solo di aver vissuto due vite, ma d'essere stato due uomini. » Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato, poche ore prima di partire, da un barbiere, per farmi accorciar la barba: avrei voluto levarmela tutta, li stesso, insieme coi baffi; ma il timore di far nascere qualche sospetto in quel paesello mi aveva trattenuto. Il barbiere era anche sartore, vecchio, con le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star curvo, sempre in una stessa positura, e portava gli occhiali su la punta del naso. Più che barbiere doveva esser sartore. Calò come un flagello di Dio su quella barbaccia che non m'apparteneva più, armato di certi forbicioni da maestro di lana, che avevan bisogno d'esser sorretti in punta con l'altra mano. Non m'arrischiai neppure a fiatare: chiusi gli occhi, e non li riaprii, se non quando mi sentii scuotere pian piano. Il brav'uomo, tutto sudato, mi porgeva uno specchietto perché gli sapessi dire se era stato bravo. Mi parve troppo! - No, grazie, - mi schermii. - Lo riponga. Non vorrei fargli paura. Sbarrò tanto d'occhi, e: - A chi? - domandò. - Ma a codesto specchietto. Bellino! Dev'essere antico... Era tondo, col manico d'osso intarsiato: chi sa che storia aveva e donde e come era capitato lì, in quella sarto-barbieria. Ma infine, per non dar dispiacere al padrone, che seguitava a guardarmi stupito, me lo posi sotto gli occhi. Se era stato bravo! Intravidi da quel primo scempio qual mostro fra breve sarebbe scappato fuori dalla necessaria e radicale; alterazione dei connotati di Mattia Pascal! Ed ecco una nuova ragione d'odio per lui! Il mento piccolissimo, puntato e rientrato, ch'egli aveva nascosto per tanti e tanti anni sotto quel barbone, mi parve un tradimento. Ora avrei dovuto portarlo scoperto, quel cosino ridicolo! E che naso mi aveva lasciato in eredità! E quell'occhio! « Ah, quest'occhio, » pensai, « così in estasi da un lato, rimarrà sempre suo nella mia nuova faccia! Io non potrò far altro che nasconderlo alla meglio dietro un pajo d'occhiali colorati, che coopereranno, figuriamoci, a rendermi più amabile l'aspetto. Mi farò crescere i capelli e, con questa bella fronte spaziosa, con gli occhiali e tutto raso, sembrerò un filosofo tedesco. Finanziera e cappellaccio a larghe tese. » Non c'era via di mezzo: filosofo dovevo essere per forza con quella razza d'aspetto. Ebbene, pazienza: mi sarei armato d'una discreta filosofia sorridente per passare in mezzo a questa povera umanità, la quale, per quanto avessi in animo di sforzarmi, mi pareva difficile che non dovesse più parermi un po' ridicola e meschina. [….] Recisa di netto ogni memoria in me della vita precedente, fermato l'animo alla deliberazione di ricominciare da quel punto una nuova vita, io era invaso e sollevato come da una fresca letizia infantile; mi sentivo come rifatta vergine e trasparente la coscienza, e lo spirito vigile e pronto a trar profitto di tutto per la costruzione del mio nuovo io. Intanto l'anima mi tumultuava nella gioja di quella nuova libertà. Non avevo mai veduto così uomini e cose; l'aria tra essi e me s'era d'un tratto quasi snebbiata; e mi si presentavan facili e lievi le nuove relazioni che dovevano stabilirsi tra noi, poiché ben poco ormai io avrei avuto bisogno di chieder loro per il mio intimo compiacimento. Oh levità deliziosa dell'anima; serena, ineffabile ebbrezza! La Fortuna mi aveva sciolto di ogni intrico, all'improvviso, mi aveva sceverato dalla vita comune, reso spettatore estraneo della briga in cui gli altri si dibattevano ancora, e mi ammoniva dentro: « Vedrai, vedrai com'essa t'apparirà curiosa, ora, a guardarla cosi da fuori! [….] In fondo, ero già un po' stanco di quell'andar girovagando sempre solo e muto. Istintivamente cominciavo a sentir il bisogno di un po' di compagnia. Me ne accorsi in una triste giornata di novembre, a Milano, tornato da poco dal mio giretto in Germania. Faceva freddo, ed era imminente la pioggia, con la sera. Sotto un fanale scorsi un vecchio cerinajo, a cui la cassetta, che teneva dinanzi con una cinta a tracolla, impediva di ravvolgersi bene in un logoro mantelletto che aveva su le spalle. Gli pendeva dalle pugna strette sul mento un cordoncino, fino ai piedi. Mi chinai a guardare e gli scoprii tra le scarpacce rotte un cucciolotto minuscolo, di pochi giorni, che tremava tutto di freddo e gemeva continuamente, lì rincantucciato. Povera bestiolina! Domandai al vecchio se la vendesse. Mi rispose di sì e che me l'avrebbe venduta anche per poco, benché valesse molto: ah, si sarebbe fatto un bel cane, un gran cane, quella bestiola: - Venticinque lire... Seguitò a tremare il povero cucciolo, senza inorgoglirsi punto di quella stima: sapeva di certo che il padrone con quel prezzo non aveva affatto stimato i suoi futuri meriti, ma la imbecillità che aveva creduto di leggermi in faccia. Io intanto, avevo avuto il tempo di riflettere che, comprando quel cane, mi sarei fatto sì, un amico fedele e discreto, il quale per amarmi e tenermi in pregio non mi avrebbe mai domandato chi fossi veramente e donde venissi e se le mie carte fossero in regola; ma avrei dovuto anche mettermi a pagare una tassa: io che non ne pagavo più! Mi parve come una prima compromissione della mia libertà, un lieve intacco ch'io stessi per farle. - Venticinque lire? Ti saluto! - dissi al vecchio cerinajo. Mi calcai il cappellaccio su gli occhi e, sotto la pioggerella fina fina che già il cielo cominciava a mandare, m'allontanai, considerando però, per la prima volta, che era bella, sì, senza dubbio, quella mia libertà così sconfinata, ma anche un tantino tiranna, ecco, se non mi consentiva neppure di comperarmi un cagnolino. Del primo inverno, se rigido, piovoso, nebbioso, quasi non m'ero accorto tra gli svaghi de' viaggi e nell'ebbrezza della nuova libertà. Ora questo secondo mi sorprendeva già un po' stanco, come ho detto, del vagabondaggio e deliberato a impormi un freno. E mi accorgevo che... sì, c'era un po' di nebbia, c'era; e faceva freddo; m'accorgevo che per quanto il mio animo si opponesse a prender qualità dal colore del tempo, pur ne soffriva. « Ma sta' a vedere, » mi rampognavo, « che non debba più far nuvolo perché tu possa ora godere serenamente della tua libertà! » M'ero spassato abbastanza, correndo di qua e di là: Adriano Meis aveva avuto in quell'anno la sua giovinezza spensierata; ora bisognava che diventasse uomo, si raccogliesse in sé, si formasse un abito di vita quieto e modesto. Oh, gli sarebbe stato facile, libero com'era e senz'obblighi di sorta! Così mi pareva; e mi misi a pensare in quale città mi sarebbe convenuto di fissar dimora, giacché come un uccello senza nido non potevo più oltre rimanere, se proprio dovevo compormi una regolare esistenza. Ma dove? in una grande città o in una piccola? Non sapevo risolvermi. Chiudevo gli occhi e col pensiero volavo a quelle città che avevo già visitate; dall'una all'altra, indugiandomi in ciascuna fino a rivedere con precisione quella tal via, quella tal piazza, quel tal luogo, insomma, di cui serbavo più viva memoria; e dicevo: « Ecco, io vi sono stato! Ora, quanta vita mi sfugge, che séguita ad agitarsi qua e là variamente. Eppure, in quanti luoghi ho detto: - Qua vorrei aver casa! Come ci vivrei volentieri! -. E ho invidiato gli abitanti che, quietamente, con le loro abitudini e le loro consuete occupazioni, potevano dimorarvi, senza conoscere quel senso penoso di precarietà che tien sospeso l'animo di chi viaggia. » Questo senso penoso di precarietà mi teneva ancora e non mi faceva amare il letto su cui mi ponevo a dormire, i varii oggetti che mi stavano intorno. Ogni oggetto in noi suol trasformarsi secondo le immagini ch'esso evoca e aggruppa, per cosi dire, attorno a sé. Certo un oggetto può piacere anche per se stesso, per la diversità delle sensazioni gradevoli che ci suscita in una percezione armoniosa; ma ben più spesso il piacere che un oggetto ci procura non si trova nell'oggetto per se medesimo. La fantasia lo abbellisce cingendolo e quasi irraggiandolo d'immagini care. Né noi lo percepiamo più qual esso è, ma così, quasi animato dalle immagini che suscita in noi o che le nostre abitudini vi associano. Nell'oggetto, insomma, noi amiamo quel che vi mettiamo di noi, l'accordo, l'armonia che stabiliamo tra esso e noi, l'anima che esso acquista per noi soltanto e che è formata dai nostri ricordi. Or come poteva avvenire per me tutto questo in una camera d'albergo ? Ma una casa, una casa mia, tutta mia, avrei potuto più averla? I miei denari erano pochini... Ma una casettina modesta, di poche stanze? Piano: bisognava vedere, considerar bene prima, tante cose. Certo, libero, liberissimo, io potevo essere soltanto così, con la valigia in mano: oggi qua, domani là. Fermo in un luogo, proprietario d'una casa, eh, allora : registri e tasse subito! E non mi avrebbero iscritto all'anagrafe? Ma sicuramente! E come? con un nome falso? E allora, chi sa?, forse indagini segrete intorno a me da parte della polizia... Insomma, impicci, imbrogli!... No, via: prevedevo di non poter più avere una casa mia, oggetti miei. Ma mi sarei allogato a pensione in qualche famiglia, in una camera mobiliata. Dovevo affliggermi per così poco? L'inverno, L'inverno m'ispirava queste riflessioni malinconiche, La prossima festa di Natale che fa desiderare il tepore d'un cantuccio caro, il raccoglimento, l'intimità della casa. Non avevo certo da rimpiangere quella di casa mia. L'altra, più antica, della casa paterna, l'unica ch'io potessi ricordare con rimpianto, era già distrutta da un pezzo, e non da quel mio nuovo stato. Sicché dunque dovevo contentarmi, pensando che davvero non sarei stato più lieto, se avessi passato a Miragno, tra mia moglie e mia suocera - (rabbrividivo!) - quella festa di Natale. Per ridere, per distrarmi, m'immaginavo intanto, con un buon panettone sotto il braccio, innanzi alla porta di casa mia. « - Permesso? Stanno ancora qua le signore Romilda Pescatore, vedova Pascal, e Marianna Dondi, vedova Pescatore? » « - Sissignore. Ma chi è lei? » « - Io sarei il defunto marito della signora Pascal, quel povero galantuomo morto l'altr'anno, annegato. Ecco, vengo lesto lesto dall'altro mondo per passare le feste in famiglia, con licenza dei superiori. Me ne riparto subito! » Rivedendomi cosi all'improvviso, sarebbe morta dallo spavento la vedova Pescatore? Che! Lei? Figuriamoci! Avrebbe fatto rimorire me, dopo due giorni. La mia fortuna - dovevo convincermene - la mia fortuna consisteva appunto in questo: nell'essermi liberato della moglie, della suocera, dei debiti, delle afflizioni umilianti della mia prima vita. Ora, ero libero del tutto. Non mi bastava? Eh via, avevo ancora tutta una vita innanzi a me. Per il momento... chi sa quanti erano soli com'ero io! « Si, ma questi tali, » m'induceva a riflettere il cattivo tempo, quella nebbia maledetta, « o son forestieri e hanno altrove una casa, a cui un giorno o l'altro potranno far ritorno, o se non hanno casa come te, potranno averla domani, e intanto avran quella ospitale di qualche amico. Tu invece, a volerla dire, sarai sempre e dovunque un forestiere: ecco la differenza. Forestiere della vita, Adriano Meis. » […] Bastava guardarlo, bastava considerare un poco quella sua minuscola ridicola personcina, per accorgersi ch'egli mentiva, senza bisogno d'altre prove. Allo stupore seguì in me un profondo avvilimento di vergogna per lui, che non si rendeva conto del miserabile effetto che dovevano naturalmente produrre quelle sue panzane, e anche per me che vedevo mentire con tanta disinvoltura e tanto gusto lui, lui che non ne avrebbe avuto alcun bisogno; mentre io, che non potevo farne a meno, io ci stentavo e ci soffrivo fino a sentirmi, ogni volta, torcer l'anima dentro. Avvilimento e stizza. Mi veniva d'afferrargli un braccio e di gridargli: « Ma scusi, cavaliere, perché? perché? » Se però erano ragionevoli e naturali in me l'avvilimento e la stizza, mi accorsi, riflettendoci bene, che sarebbe stata per lo meno sciocca quella domanda. Infatti, se il caro ometto imbizzarriva cosi a farmi credere a quelle sue avventure, la ragione era appunto nel non aver egli alcun bisogno di mentire; mentre io... io vi ero obbligato dalla necessità. Ciò che per lui, insomma, poteva essere uno spasso e quasi l'esercizio d'un diritto, era per me, all'incontro, obbligo increscioso, condanna. E che seguiva da questa riflessione? Ahimè, che io, condannato inevitabilmente a mentire dalla mia condizione, non avrei potuto avere mai più un amico, un vero amico. E dunque, né casa, né amici... Amicizia vuol dire confidenza; e come avrei potuto io confidare a qualcuno il segreto di quella mia vita senza nome e senza passato, sorta come un fungo dal suicidio di Mattia Pascal? Io potevo aver solamente relazioni superficiali, permettermi solo co' miei simili un breve scambio di parole aliene. Ebbene, erano gl'inconvenienti della mia fortuna. Pazienza! Mi sarei scoraggiato per questo? « Vivrò con me e di me, come ho vissuto finora! » Sì; ma ecco: per dir la verità, temevo che della mia compagnia non mi sarei tenuto né contento né pago. E poi, toccandomi la faccia e scoprendomela sbarbata, passandomi una mano su quei capelli lunghi o rassettandomi gli occhiali sul naso, provavo una strana impressione: mi pareva quasi di non esser più io, di non toccare me stesso. Siamo giusti, io mi ero conciato a quel modo per gli altri, non per me. Dovevo ora star con me, così mascherato? E se tutto ciò che avevo finto e immaginato di Adriano Meis non doveva servire per gli altri, per chi doveva servire? per me? Ma io, se mai, potevo crederci solo a patto che ci credessero gli altri. Ora, se questo Adriano Meis non aveva il coraggio di dir bugie, di cacciarsi in mezzo alla vita, e si appartava e rientrava in albergo, stanco di vedersi solo, in quelle tristi giornate d'inverno, per le vie di Milano, e si chiudeva nella compagnia del morto Mattia Pascal, prevedevo che i fatti miei, eh, avrebbero cominciato a camminar male; che insomma non mi s'apparecchiava un divertimento, e che la mia bella fortuna, allora... Ma la verità forse era questa: che nella mia libertà sconfinata, mi riusciva difficile cominciare a vivere in qualche modo. Sul punto di prendere una risoluzione, mi sentivo come trattenuto, mi pareva di vedere tanti impedimenti e ombre e ostacoli. Ed ecco, mi cacciavo, di nuovo, fuori, per le strade, osservavo tutto, mi fermavo a ogni nonnulla, riflettevo a lungo su le minime cose; stanco, entravo in un caffè, leggevo qualche giornale, guardavo la gente che entrava e usciva; alla fine, uscivo anch'io. Ma la vita, a considerarla così, da spettatore estraneo, mi pareva ora senza costrutto e senza scopo; mi sentivo sperduto tra quel rimescolìo di gente. E intanto il frastuono, il fermento continuo della città m'intronavano. « Oh perché gli uomini, » domandavo a me stesso, smaniosamente, « si affannano così a rendere man mano più complicato il congegno della loro vita? Perché tutto questo stordimento di macchine? E che farà l'uomo quando le macchine faranno tutto? Si accorgerà allora che il così detto progresso non ha nulla a che fare con la felicità? Di tutte le invenzioni, con cui la scienza crede onestamente d'arricchire l'umanità (e la impoverisce, perché costano tanto care), che gioja in fondo proviamo noi, anche ammirandole? » In un tram elettrico, il giorno avanti, m'ero imbattuto in un pover'uomo, di quelli che non possono fare a meno di comunicare a gli altri tutto ciò che passa loro per la mente. - Che bella invenzione! - mi aveva detto. - Con due soldini, in pochi minuti, mi giro mezza Milano. Vedeva soltanto i due soldini della corsa, quel pover'uomo, e non pensava che il suo stipendiuccio se n'andava tutto quanto e non gli bastava per vivere intronato di quella vita fragorosa, col tram elettrico, con la luce elettrica, ecc., ecc. Eppure la scienza, pensavo, ha l'illusione di render più facile e più comoda l'esistenza! Ma, anche ammettendo che la renda veramente più facile, con tutte le sue macchine così difficili e complicate, domando io: « E qual peggior servizio a chi sia condannato a una briga vana, che rendergliela facile e quasi meccanica? ». Rientravo in albergo. Là, in un corridojo, sospesa nel vano d'una finestra, c'era una gabbia con un canarino. Non potendo con gli altri e non sapendo che fare, mi mettevo a conversar con lui, col canarino: gli rifacevo il verso con le labbra, ed esso veramente credeva che qualcuno gli parlasse e ascoltava e forse coglieva in quel mio pispissìo care notizie di nidi, di foglie, di libertà... Si agitava nella gabbia, si voltava, saltava, guardava di traverso, scotendo la testina, poi mi rispondeva, chiedeva, ascoltava ancora. Povero uccellino! lui sì m'inteneriva, mentre io non sapevo che cosa gli avessi detto... Ebbene, a pensarci non avviene anche a noi uomini qualcosa di simile? Non crediamo anche noi che la natura ci parli? e non ci sembra di cogliere un senso nelle sue voci misteriose, una risposta, secondo i nostri desiderii, alle affannose domande che le rivolgiamo? E intanto la natura, nella sua infinita grandezza, non ha forse il più lontano sentore di noi e della nostra vana illusione. Ma vedete un po' a quali conclusioni uno scherzo suggerito dall'ozio può condurre un uomo condannato a star solo con se stesso! Mi veniva quasi di prendermi a schiaffi. Ero io dunque sul punto di diventare sul serio un filosofo? No, no, via, non era logica la mia condotta. Così, non avrei potuto più oltre durarla. Bisognava ch'io vincessi ogni ritegno, prendessi a ogni costo una risoluzione. Io, insomma, dovevo vivere, vivere, vivere. 33 - “Non mi saprei proprio dire ch’io mi sia” dal cap. XVIII de “Il fu Mattia Pascal” (L. Pirandello) Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia Scolastica, che mi ha voluto offrir ricetto in casa sua. La mia bislacca avventura m'ha rialzato d'un tratto nella stima di lei. Dormo nello stesso letto in cui morì la povera mamma mia, e passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in compagnia di don Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai vecchi libri polverosi. Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, ajutato da lui. Di quanto è scritto qui egli serberà il segreto, come se l'avesse saputo sotto il sigillo della confessione. Abbiamo discusso a lungo insieme su i casi miei, e spesso io gli ho dichiarato di non saper vedere che frutto se ne possa cavare. - Intanto, questo, - egli mi dice: - che fuori della legge e fuori di quelle particolarità, liete o tristi che sieno, per cui noi siamo noi, caro signor Pascal, non è possibile vivere. Ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire ch'io mi sia. Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s'uccise alla Stìa, c'è ancora la lapide dettata da Lodoletta: COLPITO DA AVVERSI FATI MATTIA PASCAL BIBLIOTECARIO CUOR GENEROSO ANIMA APERTA QUI VOLONTARIO RIPOSA LA PIETA' DEI CONCITTADINI QUESTA LAPIDE POSE Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. Qualche curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s'accompagna con me, sorride, e considerando la mia condizione - mi domanda: - Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: - Eh, caro mio... Io sono il fu Mattia Pascal. 34 - “Veglia” (G. Ungaretti) Un’intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio ho scritto lettere piene d’amore Non sono mai stato tanto attaccato alla vita Cima Quattro, 23 dicembre 1915 35 - “San Martino del Carso” (G. Ungaretti) Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto Ma nel cuore nessuna croce manca E’ il mio cuore il paese più straziato (Valloncello dell’Albero Isolato il 27 agosto 1916) 36 - “Viatico” (C. Rebora) O ferito laggiù nel valloncello, Tanto invocasti Se tre compagni interi Cadder per te che quasi più non eri, Tra melma e sangue Tronco senza gambe E il tuo lamento ancora, Pietà di noi rimasti A rantolarci e non ha fine l’ora, Affretta l’agonia, Tu puoi finire, E conforto ti sia Nella demenza che non sa impazzire, Mentre sosta il momento Il sonno sul cervello, Làsciaci in silenzio – grazie, fratello 37 - “Voce di vedetta morta” (C. Rebora) C’è un corpo in poltiglia Con crespe di faccia, affiorante Sul lezzo dell’aria sbranata. Frode la terra. Forsennato non piango: Affar di chi può, e del fango. Però se ritorni Tu uomo, di guerra A chi ignora non dire; Non dire la cosa, ove l'uomo E la vita s'intendono ancora. Ma afferra la donna Una notte, dopo un gorgo di baci, Se tornare potrai; Sòffiale che nulla del mondo Redimerà ciò ch'è perso Di noi, i putrefatti di qui; Stringile il cuore a strozzarla: E se t'ama, lo capirai nella vita Più tardi, o giammai. 38 - “Mio padre è stato per me l’assassino” (U. Saba) Mio padre è stato per me “l’assassino”; fino ai vent’anni che l’ho conosciuto. Allora ho visto ch’egli era un bambino, e che il dono ch’io ho da lui l’ho avuto. Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, un sorriso, in miseria, dolce e astuto. Andò sempre pel mondo pellegrino; più d’una donna l’ha amato e pasciuto. Egli era gaio e leggero; mia madre tutti sentiva della vita i pesi. Di mano ei gli sfuggì come un pallone. “Non somigliare – ammoniva – a tuo padre”: ed io più tardi in me stesso lo intesi: Eran due razze in antica tenzone. 39 - “La confessione alla madre” da “Ernesto” (U. Saba) Capì qual era la sola cosa che gli restava da fare e decise, per quanto gli costasse, di farla. «Dal signor Wilder – disse a sua madre – non ci ritorno più». La signora Celestina rimase un po’ impressionata dall’accento risoluto del figlio. Però pensava ancora che si trattasse di un ripicco, di orgoglio offeso, o qualcosa di simile. «Non ti farà nessun rimprovero, – disse; – me l’ha promesso. Mi ha fatto anche comprendere che, se tutto ritornerà come prima, ti crescerà, per la fi ne dell’anno, la paga. Lo aveva già pensato prima che tu gli scrivessi la lettera. Ha parlato – aggiunse – come un padre, e non come un superiore, ed un superiore ingiustamente offeso. Nessun altro al suo posto...». «Ti ripeto – disse Ernesto – che dal signor Wilder non metto più piede; nemmeno se fosse lui a chiedermi scusa, e mi off risse cento corone al mese. La signora Celestina s’indignò. «Sei – gli disse – un cattivo figlio ed un cattivo soggetto; hai deciso, come tuo padre, di farmi morire a forza di dispiaceri». Non pianse; fece invece l’atto di alzarsi dalla sedia sulla quale era caduta ansante per la fatica delle scale, e di uscire dalla stanza. «Resta seduta – le disse, con voce improvvisamente dolce, quasi implorante, Ernesto. – Devo, mamma, confessarti una cosa che ti darà forse dolore, ma che devo dirti. Quando la saprai, non insisterai più perché ritorni dal signor Wilder. Mamma, – incominciava... ma subito si fermò. Come dire quella cosa? Come dirla a sua madre? Con l’uomo3, un ragazzo che, come Ernesto, non aveva peli sulla lingua, poteva parlar franco, ma con lei... Subito, appena udita la proposta del signor Wilder, aveva deciso di raccontarle tutto. Forse anche (situazione in cui si trovava a parte) era ancora troppo giovane, e non ce la faceva più a tenere per sé solo quel «terribile» segreto; provava (proprio come temeva l’uomo) il bisogno di confidarsi a qualcuno. E a chi poteva confidarsi se non a sua madre? Certo era una donna dura, e non sapeva, il più delle volte, comprenderlo; ma era pur sempre sua madre. E poi: come liberarsi altrimenti dall’obbligo di ritornare in ufficio? Se non diceva la «vera causa» del suo rifiuto, prevedeva scene peggiori di quelle che, a confessione fatta, l’aspettavano, e, per di più, interminabili. Il cuore gli batteva in gola: gli dispiaceva, un poco, anche per l’uomo: raccontare la loro storia era tradirlo due volte. Ma di sua madre poteva fidarsi; non avrebbe sicuramente parlato. Il difficile era trovare le parole... La signora Celestina si era di nuovo seduta, ed attendeva che suo figlio parlasse. Anche a lei doleva il cuore: si aspettava qualcosa di grave; ed aveva sofferte tante disgrazie nella sua vita che non si sentiva la forza di affrontarne delle nuove. «Parla» disse, quasi intimò, al figlio. Il suo pensiero era mille miglia lontano dalla verità. Ma Ernesto taceva; non trovava ancora – come si è detto – le parole. Rimaneva disteso sul letto; s’era presa la testa fra le mani. Sua madre era sempre più impressionata. «Non avrai mica – gli disse sottovoce e guardandosi intorno, come per la paura di essere udita, sebbene non ci fosse nessuno in quella stanza o nelle stanze attigue – non avrai mica rubato al signor Wilder?» Sapeva suo figlio onesto, ma anche spendaccione... E sui giornali si leggevano tante cose quasi incredibili commesse da ragazzi dell’età di Ernesto, magari più giovani, e che, fi no al giorno prima, erano sembrati tanti angeli. Fra tutti i «delitti» che possono commettere i poveri uomini, il furto era quello che l’impressionava di più. «No, mamma – disse Ernesto – non ho rubato». «E cosa hai fatto allora? In nome di Dio, parla; non farmi morire a fuoco lento». Però, adesso che il furto era escluso (sapeva che Ernesto non le diceva bugie), il cuore gli prediceva cose assai meno gravi. Pensò (e forse non andava lontano) a qualche ragazzata, a qualche monelleria, di cui suo figlio si fosse esagerate le conseguenze. Lo sapeva, oltre che spendaccione, esagerato. «Mio figlio – disse; rendendogli così, senza saperlo, la confessione più amara – non può aver commesso nulla di vergognoso; nulla che non possa, senza arrossire, raccontare a sua madre. Ed io sono qui, e ti ascolto». Ernesto aveva, intanto, trovate le parole. «Ti ricordi – incominciò – quell’uomo che venne un giorno a casa nostra, quando ero ammalato? Voleva i conti che avevo dimenticati nella tasca della giacca: lo aveva mandato il signor Wilder...». «Quel facchino – disse la signora Celestina – al quale hai voluto che off rissi un bicchiere di vino? Non mi è sembrata una cattiva persona. Ma non capisco...». «So che non puoi ancora capire; e forse... non capirai nemmeno dopo. Ma io devo parlare ugualmente. Ti ricordi – continuò, abbassando la voce – quello che mi disse una domenica lo zio Giovanni6, a tavola, prima di darmi il fi orino? Fu quando scoppiò in città quel maledetto scandalo intorno a quel deputato7 di cui parlarono tutti i giornali; poco tempo fa, insomma. “Ad un uomo”, mi disse, “che abbia fatte di quelle cose, non resta più che spararsi un colpo di revolver”. Ebbene, mamma, mammina, io e quell’uomo abbiamo fatto di quelle cose...». La signora Celestina ricordava esattamente, sebbene per altri motivi, quelle parole di suo fratello, alla fine di quel pranzo, nel quale era apparso, sulla mensa, un magnifico branzino allesso, un dono dell’invitato, per cui aveva perso la mattinata intera a sbattere, con cura particolare, un’abbondante salsa alla maionese. Ricordava anche che suo figlio era rimasto turbato «per eccesso, – pensò sua madre – di pudicizia»; tanto che ce l’aveva un po’ col fratello per aver intavolato quel discorso. «Lo avrà fatto – pensò – a scopo educativo»; ma col giovane Ernesto – che era, o a lei sembrava essere, il ritratto dell’innocenza – non ce n’era proprio bisogno. Del resto, aveva solo un’idea vaga di «quelle cose» che considerava, come il dialetto, appannaggio esclusivo degli infi mi strati della popolazione, del «basso ceto». Non aveva mai creduto che un deputato, un distinto personaggio, se ne fosse macchiato: tutto doveva essere una macchinazione dei suoi nemici. Quel personaggio era un signore. Ed anche Ernesto – malgrado la povertà e la dipendenza dalla zia – era un signore. «Non chiedermi nulla» implorò Ernesto quando, fra le dita delle mani di cui si faceva schermo alla faccia, lesse negli occhi di sua madre il turbamento causato dalla sua confessione. Temeva di averle inferto un colpo mortale, di vederla, da un momento all’altro strammazzare dalla sedia, morta per colpa sua... Se non fosse stato egli stesso così turbato, avrebbe visto che le sue parole avevano invece procurato a sua madre un senso quasi di sollievo. Dall’agitazione del figlio attendeva anche peggio... «Adesso capirai – continuò Ernesto – perché non posso più ritornare dal signor Wilder. Non devo più rivedere quell’uomo». La signora Celestina non vedeva che il lato materiale del fatto, che gli sembrava, più che altro, incomprensibile. Le sfuggiva del tutto il suo significato – la sua determinante – psicologica. Se no, avrebbe dovuto anche capire che il suo matrimonio sbagliato, la totale assenza di un padre, la sua severità eccessiva ci avevano la loro parte... Senza contare, bene inteso, l’età; e, più ancora, la «grazia» particolare di Ernesto, che forse traeva le sue origini proprio da quelle assenze. «Mascalzone – esclamò, prendendosela, ad ogni buon conto, con l’uomo – mascalzone, assassino, peggio di tuo... Abusare così di un ragazzo! Saprò bene io trovarlo, e dirgli quattro parole. Al solo vedermi, deve buttarsi in mare dalla vergogna, e subito; se non vuole che io...». «No – disse Ernesto – egli non ha tutta la colpa. Devi anzi, se non vuoi far andare in dispiaceri anche me, giurarmi che non cercherai mai né di vederlo, né di parlargli. Perché tu non sai, mamma... Adesso è finito; ma se ritornassi dal signor Wilder... Diceva di volermi bene, e non mi lasciava più pace... Mi portava perfino le paste». «E vorresti che io lo lasciassi impunito, dopo quello che ha fatto a mio figlio, a un ragazzo per bene...». «Non sono più per bene, e non sono più un ragazzo – disse, suo malgrado, Ernesto – o almeno non lo sono più per la Legge. E, se io non avessi voluto...». «Non mi dirai, adesso, che sei stato tu a pregarlo?». «No, mamma, a pregarlo no; ma,... ma gli sono andato incontro a più di mezza strada. Ecco perché non devi dir niente a nessuno, meno di tutti allo zio Giovanni». (Gli era venuta in mente l’idea – più terribile di ogni altra – che sua madre potesse denunciare la cosa a suo zio, che era anche il suo tutore, e per di più – Ernesto non lo dubitava – mezzo matto... Il padre di Ernesto era stato bandito – per attività sovversive: irredentistiche – dall’Impero d’Austria, di cui Trieste era, dopo la perdita di Venezia, «la più bella gemma»; e la Legge voleva che ogni minorenne, privo per causa di morte o altra, dell’assistenza paterna, avesse, almeno per la forma, un tutore). «Giurami – continuò – che non dirai nulla allo zio; giurami, mammina. Se no...». E si mise a piangere. La signora Celestina (e fu un miracolo) capì, questa volta, che suo figlio aveva più bisogno di essere consolato che rimproverato. Il fatto – va da sé – le ripugnava e, più ancora le riusciva – come si è detto – quasi incomprensibile. Ma non ne fece – come temeva Ernesto – un caso di vita o di morte. Si accontentava che, per il buon nome di suo figlio, rimanesse segreto; che nessuno, nemmeno l’aria, ne sapesse, o sospettasse, nulla «Ma lui... quell’uomo – disse – sei sicuro che non parlerà?». «Sicuro» si sforzò di mentire Ernesto. «Ed anche tu non devi farlo capire a nessuno; nemmeno – guai! – a tuo cugino. Sai che ragazzo è quello!» (Temeva che suo figlio fosse, oltre che un po’ esagerato, un po’ chiacchierino). «Ti ha fatto molto male?» aggiunse, sottovoce. «Oh, mamma!» implorò Ernesto; cacciandosi sempre più la testa fra le mani. (Il cugino corruttore gli sembrava, in quel momento, uno specchio di virtù). «Figlio, povero figlio mio!» s’intenerì, ad un tratto, la signora Celestina. E, seguendo questa volta l’impulso del cuore, mandò al diavolo (cioè al suo vero padre) la morale e le sue prediche inette. Si piegò sul ragazzo, e lo baciò in fronte. «Devi giurarmi – disse – che non lo farai più. Sono cose brutte, indecenti (Ernesto pensò involontariamente alla «forma esterna» dei suoi componimenti scolastici, che gli aveva procurato l’inimicizia di un professore al Ginnasio), indegne di un bel ragazzo come te. Solo i «muloni» le fanno, quelli che vendono limoni agli angoli delle strade, in Rena vecchia, non il mio Pimpo». (Nei suoi rari momenti d’espansione, la signora Celestina dava a suo figlio il nome che questi aveva dato al merlo). Dopo il bacio della madre, e sentendo avvicinarsi il perdono, Ernesto si sentiva rinascere. Era uno dei pochi baci che avesse ricevuti da lei. La povera donna ci teneva molto a essere – e più ad apparire – una «madre spartana». 40 - “Meriggiare pallido e assorto “(E. Montale) Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d’orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o su la veccia spiar le file di rosse formiche ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare m entre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com’è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 41 - “Spesso il male di vivere ho incontrato” (E. Montale) Spesso il male di vivere ho incontrato era il rivo strozzato che gorgoglia era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina Indifferenza: era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.