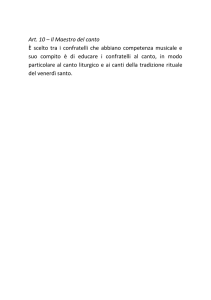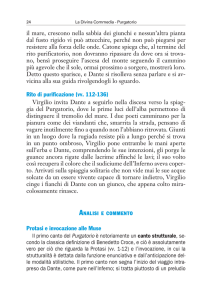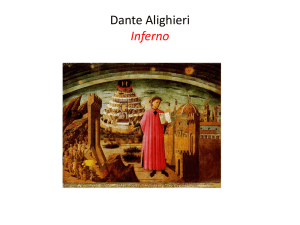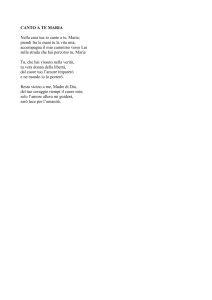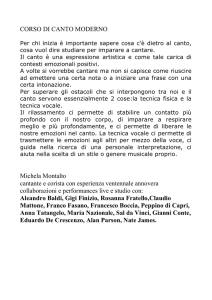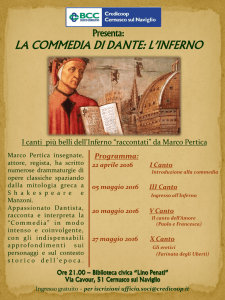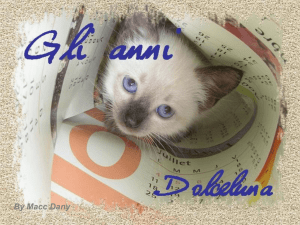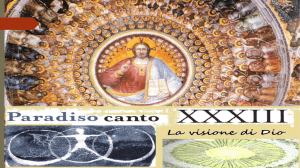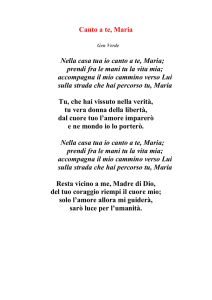caricato da
common.user1629
DANTE-INFERNO- canto XVIII-XX

DANTE Inferno CantI XVIII- XIX -XX Prof. Laura Ciampini A. S. 2018-2019 Canto I - Proemio Canto II Canto III - Vestibolo - Ignavi Canto IV - Cerchio I - Limbo - Virtuosi non battezzati Canto V - Cerchio II - Incontinenti - Lussuriosi Canto VI - Cerchio III - Incontinenti - Golosi Canto VII - Cerchio IV - Incontinenti - Avari e prodighi Canto VIII - Cerchio V - Incontinenti - Iracondi e accidiosi Canti IX, X e XI - Cerchio VI - Città di Dite - Eretici Canto XII - Cerchio VII - Girone I - Violenti contro il prossimo Canto XIII - Cerchio VII - Girone II - Suicidi e scialacquatori Canti XIV, XV, XVI, XVII - C VII - Girone III - Bestemmiatori; sodomiti, usurai Canto XVIII - Cerchio VIII - Bolgia I - Ruffiani e seduttori Canto XVIII - Cerchio VIII - Bolgia II - Adulatori e lusingatori Canto XIX - Cerchio VIII - Bolgia III - Simoniaci Canto XX - Cerchio VIII - Bolgia IV - Maghi e indovini Canti XXI e XXII - Cerchio VIII - Bolgia V - Barattieri Canto XXIII - Cerchio VIII - Bolgia VI - Ipocriti Canto XXIV e XXV - Cerchio VIII - Bolgia VII - Ladri Canti XXVI e XXVII - Cerchio VIII - Bolgia VIII - Consiglieri di frode Canti XXVIII e XXIX - C VIII - Bolgia IX - Scismatici e seminatori di discordie Canti XXIX e XXX - Cerchio VIII - Bolgia X - Falsari Canti XXXI e XXXII - Cerchio IX - Zona I Caina - Traditori di parenti Canti XXXII e XXXIII - Cerchio IX - Zona II Antenora - Traditori della patria Canto XXXIII - Cerchio IX - Zona III Tolomea - Traditori degli ospiti Canti XXXIV - Cerchio IX - Zona IV Prof. Laura Ciampini 2 RIASSUNTO DEL DICIOTTESIMO CANTO 3 Prof. Laura Ciampini CANTO XVIII Le Malebolge G. Stradano, 1587 Luogo è in inferno detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che dintorno il volge... Di qua, di là, su per lo sasso tetro vidi demon cornuti con gran ferze, che li battien crudelmente di retro... Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che da li uman privadi parea mosso... Gerione depone Dante e Virgilio nell'VIII Cerchio (Malebolge). Visione della I Bolgia, in cui sono puniti ruffiani e seduttori (tra loro vi sono Venedico Caccianemico e Giasone). Visione della II Bolgia, in cui sono puniti gli adulatori (tra loro vi sono Alessio Interminelli e Taide). È l'alba di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 4 Prof. Laura Ciampini 1300. CANTO XVIII, Descrizione delle Malebolge (1-18) Arrivato con Virgilio nelle Malebolge, G. Stradano, Il III Cerchio (1587) Dante descrive questo luogo come formato tutto di pietra di colore del ferro, come il baratro a strapiombo che lo circonda. Al centro di esso si apre un pozzo profondo e tra questo e la parete rocciosa c'è una striscia di pietra divisa in dieci fossati concentrici (le Bolge), del tutto simili ai fossati che cingono i castelli come protezione; le Bolge sono poi unite da ponticelli rocciosi, simili ai ponti levatoi che vanno dalle soglie dei castelli sino alla riva dei fossati. Prof. Laura Ciampini 5 La I Bolgia: ruffiani e seduttori (19-39) Dante e Virgilio si trovano dunque nell'VIII Cerchio dopo essere scesi dalla groppa di Gerione, e il discepolo segue il maestro che procede verso sinistra. Alla sua destra Dante vede nuovi dannati che subiscono nuove pene, di cui è piena la I Bolgia: i peccatori sono sul fondo, nudi, e procedono in due file parallele che vanno in direzioni opposte, una lungo il margine esterno della Bolgia (ruffiani) e l'altra lungo quello interno (seduttori), in modo simile dunque ai Romani l'anno del Giubileo che attraversavano il ponte di Castel Sant'Angelo. Ci sono dei demoni cornuti armati di frusta, che colpiscono i dannati da tergo e li fanno camminare velocemente alle prime percosse. G. Doré, I seduttori Prof. Laura Ciampini 6 Canto XVIII, Incontro con Venedico Caccianemico (40-66) Mentre procede lungo l'argine, Dante vede tra i ruffiani un dannato che crede di riconoscere e torna un poco indietro a guardarlo, cosa che Virgilio accetta di buon grado. Il peccatore cerca di nascondersi abbassando il viso, ma non può evitare che Dante lo riconosca e lo indichi come Venedico Caccianemico, al quale chiede come sia giunto in questa Bolgia. Il dannato risponde malvolentieri di essere colui che ha condotto la sorella Ghisolabella a soddisfare le voglie di Òbizzo d'Este, quale che sia la versione che si dà dell'accaduto. Dichiara inoltre di non essere il solo Bolognese nella Bolgia, che ne ospita tanti quanti sono quelli che vivono tra Savena e Reno (il che si spiega con la loro naturale avarizia). Mentre il dannato parla, un diavolo lo sferza crudelmente e lo manda via ricordandogli che qui non ci sono donne di cui fare mercato. Venedico "Caccianemico" dell'Orso (Bologna, 1228 – 1302) è stato un politico guelfo italiano bolognese. Nell’Inferno cerca di nascondere la sua faccia per non venire riconosciuto da Dante, perché aveva «venduto» sua sorella Ghisolabella alle voglie del marchese di Ferrara, dal quale Venedico cercava in tutti i modi di ottenere favori, Obizzo II d'Este o Azzo VIII. 7 Prof. Laura Ciampini Canto XVIII, I seduttori: Giasone (67-99) Dante si ricongiunge con Virgilio e poco dopo i due raggiungono un punto in cui dalla roccia parte un ponte di pietra, che sormonta la Bolgia da un argine all'altro. Vi salgono sopra agevolmente e giungono al punto più alto, da dove possono vedere l'interno della Bolgia: Virgilio raccomanda a Dante di osservare bene l'altra schiera di dannati (i seduttori) che non hanno potuto vedere perché prima procedevano nella loro stessa direzione. I due poeti osservano allora l'altra schiera di anime scudisciate anch'esse dai demoni, e Virgilio indica al discepolo un dannato che procede con aspetto regale, senza versare una lacrima nonostante il dolore: è Giasone, che con coraggio e astuzia si impadronì del vello d'oro. L'eroe aveva sedotto e ingannato Isifile nell'isola di Lemno, lasciandola incinta, e qui sconta questa colpa come l'inganno a Medea. Ipsipile, miniatura del Cinquecento È la protagonista dell'omonima tragedia di Euripide, regina di Lemno. Il Giasone è un dramma per musica, composto da Francesco Cavalli, del 1649, tratto dal mito di Giasone tramandato da Apollonio 8 Rodio. Prof. Laura Ciampini Gli adulatori della II bolgia: Alessio Interminelli (100-126) I due poeti sono ormai giunti al punto in cui il ponte roccioso si congiunge all'argine della II Bolgia, dove sentono dannati (adulatori) che si lamentano e soffiano rumorosamente con le narici, colpendosi con le loro stesse mani. Le pareti della Bolgia sono incrostate di muffa per i miasmi che provengono dal fondo e che irritano occhi e naso. La Bolgia è talmente profonda e oscura che per vedere bene i due sono costretti a salire sul punto più alto del ponte: da qui vedono gente immersa nello sterco, simile a quello che fuoriesce dalle latrine umane. 9 Prof. Laura Ciampini Gli adulatori della II bolgia: Alessio Interminelli (100-126) Dante osserva i dannati e ne scorge uno, talmente coperto di escrementi che non è chiaro se sia chierico o laico (non si vede se abbia o meno la tonsura). Il dannato rimprovera Dante di guardare solo lui, ma il poeta gli grida di averlo già visto coi capelli asciutti e lo indica come il lucchese Alessio Interminelli. Il dannato si colpisce il capo e afferma di scontare le adulazioni di cui la sua lingua non fu mai abbastanza sazia. Alessio Interminelli fu un nobile lucchese vissuto nel XIII secolo, Appartenente a una famiglia di parte guelfa e bianca. L'episodio di Alessio raggiunge uno dei culmini dello stile ‛ comico ' di D., con le rime aspre (brutti / asciutti / tutti, Lucca / zucca / stucca, sterco / cerco / cherco, lordo 10 / Bordo / ricordo) Prof. Laura Ciampini La prostituta Taide (127-136) Dopo l'incontro con Interminelli, Virgilio invita Dante a spingere lo sguardo un po' più avanti, in modo da vedere una donna sudicia e scarmigliata, che si graffia con le unghie piene di sterco e si china sulle cosce. È la prostituta Taide, che al suo amante che le chiedeva se lei lo ringraziava, aveva risposto: «Sì, moltissimo!». Dopodiché Virgilio invita Dante a lasciare la Bolgia e a passare in quella seguente. di quella sozza e scapigliata fante che là si graffia con l’unghie merdose, e or s’accoscia e ora è in piedi stante. Taide è, la puttana che rispuose al drudo suo quando disse "Ho io grazie grandi apo te?": "Anzi maravigliose!". E quinci sien le nostre viste sazie» VIDEO IM HD https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xviii.html Taide è un personaggio della commedia dell'Eunuchus di Terenzio, citata anche da Cicerone, da Dante Alighieri nonché da Jorge Luis Borges (nell'opera intitolata "L'Aleph", nel racconto "Lo Zahir"). Prof. Laura Ciampini 11 Canto I - Proemio Canto II Canto III - Vestibolo - Ignavi Canto IV - Cerchio I - Limbo - Virtuosi non battezzati Canto V - Cerchio II - Incontinenti - Lussuriosi Canto VI - Cerchio III - Incontinenti - Golosi Canto VII - Cerchio IV - Incontinenti - Avari e prodighi Canto VIII - Cerchio V - Incontinenti - Iracondi e accidiosi Canti IX, X e XI - Cerchio VI - Città di Dite - Eretici Canto XII - Cerchio VII - Girone I - Violenti contro il prossimo Canto XIII - Cerchio VII - Girone II - Suicidi e scialacquatori Canti XIV, XV, XVI, XVII - C VII - Girone III - Bestemmiatori; sodomiti, usurai Canto XVIII - Cerchio VIII - Bolgia I - Ruffiani e seduttori Canto XVIII - Cerchio VIII - Bolgia II - Adulatori e lusingatori Canto XIX - Cerchio VIII - Bolgia III - Simoniaci Canto XX - Cerchio VIII - Bolgia IV - Maghi e indovini Canti XXI e XXII - Cerchio VIII - Bolgia V - Barattieri Canto XXIII - Cerchio VIII - Bolgia VI - Ipocriti Canto XXIV e XXV - Cerchio VIII - Bolgia VII - Ladri Canti XXVI e XXVII - Cerchio VIII - Bolgia VIII - Consiglieri di frode Canti XXVIII e XXIX - C VIII - Bolgia IX - Scismatici e seminatori di discordie Canti XXIX e XXX - Cerchio VIII - Bolgia X - Falsari Canti XXXI e XXXII - Cerchio IX - Zona I Caina - Traditori di parenti Canti XXXII e XXXIII - Cerchio IX - Zona II Antenora - Traditori della patria Canto XXXIII - Cerchio IX - Zona III Tolomea - Traditori degli ospiti Canti XXXIV - Cerchio IX - Zona IV Prof. Laura Ciampini 12 CANTO XIX Dopo l'incontro con Interminelli, Virgilio invita Visione della III Bolgia dell'VIII Cerchio (Malebolge), in cui sono puniti i simoniaci. Incontro con papa Niccolò III, che predice la futura dannazione di Bonifacio VIII e Clemente V. Invettiva di Dante contro la corruzione ecclesiastica. È l'alba di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, alle prime ore del mattino. 13 Prof. Laura Ciampini CANTO XIX, I simoniaci della III Bolgia (1-30) Dante esordisce maledicendo Simon mago e tutti i suoi seguaci che fanno turpe mercato delle cose sacre, per i quali è necessario che suoni la tromba del Giudizio Universale visto che sono ospitati nella III Bolgia. Dante e Virgilio sono giunti sul punto più alto del ponte roccioso che sovrasta la Bolgia, da dove il poeta può vedere quanta è la giustizia divina che si manifesta nel mondo. Infatti egli vede le pareti e il fondo della Bolgia pieni di buche circolari, tutte della stessa dimensione, del tutto simili ai fonti battesimali del battistero di San Giovanni a Firenze, uno dei quali era stato spezzato da Dante per salvare uno che vi stava VIDEO: I PAPI ALL’INFERNO annegando. Ogni peccatore è confitto a testa in https://www.youtube.com/watch?v= giù nella buca, lasciando emergere solo le gambe DJwO4SZkeHY fino alle cosce, mentre le piante dei piedi sono accese da delle sottili fiammelle. I peccatori scalciano con forza, mentre le fiammelle lambiscono i piedi come fa il fuoco sulle cose unte. 14 Simoniaci, G. Dore Prof. Laura Ciampini CANTO XIX, Incontro con papa Niccolò III (31-63) Dante nota che uno dei dannati sembra lamentarsi più degli altri e ha le fiammelle sui piedi di un colore più acceso, quindi ne chiede conto a Virgilio. Il maestro risponde che, se Dante vuole, lo porterà sul fondo della Bolgia dove potrà parlare direttamente con lui. Dante risponde che ne sarà ben lieto, dopodiché i due giungono al termine del ponte e da lì scendono verso sinistra, sino al fondo della Bolgia. Dante si avvicina al peccatore e gli chiede di parlare, proprio come il frate che confessa l'assassino prima dell'esecuzione: il dannato risponde scambiandolo per papa Bonifacio VIII e chiedendo perché sia già giunto lì e se sia già stanco di fare scempio della Chiesa. Dante resta stupito e non sa che rispondere, quindi Virgilio lo invita a dire al dannato di non essere colui che crede, cosa che il poeta esegue immediatamente. Simoniaci, W. Blake 15 Prof. Laura Ciampini papa Niccolò III (31-63) Giovanni Gaetano Orsini (1210-1280), divenne papa nel 1277, si oppose a Carlo I d'Angiò divenuto re di Napoli e Sicilia, dandosi alla simonia e al nepotismo per rafforzare la sua posizione. Dante lo colloca fra i simoniaci della III Bolgia dell'VIII Cerchio. Dante nota che uno dei dannati ha le fiammelle ai piedi più rosse degli altri e si dimena maggiormente. Il dannato cade in errore, pensando che Dante sia in realtà l'anima di Bonifacio VIII destinato a seguirlo nella stessa buca: chiarito l'equivoco, il dannato si presenta come figliuol de l'Orsa, intento più ad avanzar gli orsatti che al suo ufficio ecclesiastico. In seguito Niccolò predice la dannazione per simonia di un altro papa, Clemente V. L'episodio si conclude con una violenta invettiva di Dante contro la simonia e la corruzione ecclesiastica Niccolo’ III 16 Prof. Laura Ciampini Bonifacio VIII Divenne papa nel 1294 in seguito alla rinuncia di Celestino V. Indisse il primo Giubileo della storia della Chiesa, nell'anno 1300, anche allo scopo di lucrare sulle indulgenze. Fu avversario di Filippo il Bello re di Francia, contro il quale emise la bolla Unam Sanctam (1302), manifesto della teocrazia medievale; subì la ribellione dei cardinali Colonna, che lo accusavano di frode e simonia. Ciò inasprì i rapporti già tesi col re di Francia, che in seguito all'oltraggio di Anagni lo fece imprigionare e ne provocò indirettamente la morte, nel 1303. Dante ne dà un giudizio negativo, soprattutto per le manovre che favorirono nel 1301 la presa di potere dei Guelfi Neri a Firenze, causando l'esilio del poeta. il viaggio dantesco avviene nel 1300, quando il papa era ancora vivo. In Par., XXVII, 16 san Pietro inveisce contro i papi corrotti e accusa Bonifacio di usurpare il suo seggio, nonché di aver trasformato il Vaticano in una cloaca. 17 Prof. Laura Ciampini Profezia di Niccolò III (64-87) A questo punto il dannato storce dolorosamente i piedi, quindi si presenta come il papa Niccolò III, appartenente alla nobile famiglia degli Orsini e che fu assai avido nell'arricchire i suoi famigliari, al punto che è finito all'Inferno. Sotto di lui nella stessa buca sono conficcati gli altri simoniaci, tutti appiattiti nella roccia, e anche lui verrà spinto più in basso quando arriverà realmente colui per il quale ha scambiato Dante (Bonifacio VIII). Ma questi rimarrà nella buca coi piedi di fuori meno tempo di quando c'è rimasto Niccolò: infatti lo seguirà un altro papa simoniaco (Clemente V), che spingerà di sotto entrambi dopo aver goduto in vita del favore del re di Francia, Filippo il Bello. 18 Prof. Laura Ciampini Invettiva contro i papi simoniaci (88-117) A questo punto lo sdegno di Dante esplode in una violenta invettiva contro Niccolò e tutti i papi dediti alla simonia, cui il poeta chiede ironicamente quanto volle Gesù da san Pietro prima di affidargli le chiavi del regno dei cieli, e rinfacciando che gli apostoli non pretesero alcun pagamento da parte di Mattia quando prese il posto di Giuda. Niccolò è dunque giustamente punito e deve custodire il denaro ricevuto per andare contro Carlo I d'Angiò. Solo il rispetto per il ruolo del papa impedisce a Dante di usare parole ancor più gravi, poiché l'avarizia dei papi simoniaci ha sovvertito ogni giustizia terrena. La Chiesa si è vergognosamente asservita agli interessi della monarchia francese, dopo essersi trasformata in un'orrida bestia. I papi sono simili agli idolatri, in quanto adorano cento dei d'oro e argento, mentre molto male ha prodotto la Miniatura del Codex Altonensis 19 donazione di Costantino. Prof. Laura Ciampini Dante e Virgilio tornano sul ponte della Bolgia (118-133) Mentre Dante accusa violentemente Niccolò, il dannato scalcia con forza come se fosse punto dall'ira o dalla coscienza sporca, mentre Virgilio manifesta col suo volto l'approvazione per il discorso del discepolo. Dopodiché il maestro sorregge Dante con entrambe le braccia e lo riporta sull'argine della Bolgia, da dove parte il ponte che conduce alla IV Bolgia, fino al quinto argine. Arrivato qui lo depone a terra, quindi i due si accingono a visitare la Bolgia seguente. Miniatura del Codex Altonensis VIDEO IM HD https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xix.html 20 Prof. Laura Ciampini Canto I - Proemio Canto II Canto III - Vestibolo - Ignavi Canto IV - Cerchio I - Limbo - Virtuosi non battezzati Canto V - Cerchio II - Incontinenti - Lussuriosi Canto VI - Cerchio III - Incontinenti - Golosi Canto VII - Cerchio IV - Incontinenti - Avari e prodighi Canto VIII - Cerchio V - Incontinenti - Iracondi e accidiosi Canti IX, X e XI - Cerchio VI - Città di Dite - Eretici Canto XII - Cerchio VII - Girone I - Violenti contro il prossimo Canto XIII - Cerchio VII - Girone II - Suicidi e scialacquatori Canti XIV, XV, XVI, XVII - C VII - Girone III - Bestemmiatori; sodomiti, usurai Canto XVIII - Cerchio VIII - Bolgia I - Ruffiani e seduttori Canto XVIII - Cerchio VIII - Bolgia II - Adulatori e lusingatori Canto XIX - Cerchio VIII - Bolgia III - Simoniaci Canto XX - Cerchio VIII - Bolgia IV - Maghi e indovini Canti XXI e XXII - Cerchio VIII - Bolgia V - Barattieri Canto XXIII - Cerchio VIII - Bolgia VI - Ipocriti Canto XXIV e XXV - Cerchio VIII - Bolgia VII - Ladri Canti XXVI e XXVII - Cerchio VIII - Bolgia VIII - Consiglieri di frode Canti XXVIII e XXIX - C VIII - Bolgia IX - Scismatici e seminatori di discordie Canti XXIX e XXX - Cerchio VIII - Bolgia X - Falsari Canti XXXI e XXXII - Cerchio IX - Zona I Caina - Traditori di parenti Canti XXXII e XXXIII - Cerchio IX - Zona II Antenora - Traditori della patria Canto XXXIII - Cerchio IX - Zona III Tolomea - Traditori degli ospiti Canti XXXIV - Cerchio IX - Zona IV 21 Prof. Laura Ciampini CANTO XX Visione della IV Bolgia dell'VIII Cerchio (Malebolge), in cui sono puniti gli indovini. Virgilio indica a Dante Anfiarao, Tiresia, Manto, Arunte, Euripilo, Michele Scotto, Guido Bonatti e Asdente. Spiegazione di Virgilio sull'origine di Mantova. È la mattina di sabato 9 aprile (o 26 marzo) del 1300, verso le sei. g. Stradano, Indovini Prof. Laura Ciampini 22 CANTO XX, Gli indovini della IV Bolgia (1-30) Dante è giunto al ventesimo Canto della prima Cantica e deve descrivere una nuova pena, quella degli indovini della IV Bolgia dell'VIII Cerchio che bagnano il fondo della fossa di pianto angoscioso. Il poeta vede avanzare una schiera di dannati che tacciono e piangono, avanzando lentamente come in una processione: guardando più in basso, si accorge che la loro figura è stravolta e che il viso è completamente rivoltato indietro, così che essi sono costretti a camminare a ritroso. Può darsi che una paralisi abbia ridotto qualcuno in tali condizioni, ma Dante non crede che ciò sia possibile. Il poeta è talmente sconvolto che non può evitare di piangere, specie quando vede i dannati versare a loro volta lacrime che bagnano loro la schiena e le natiche, così che si abbandona a un pianto dirotto che suscita l'aspro rimprovero di Virgilio (il maestro accusa Dante di provare compassione per queste anime scellerate). Gli indovini (miniatura del XIV sec.) Prof. Laura Ciampini 23 CANTO XX, Virgilio mostra alcuni antichi indovini (31-57) Virgilio invita perentoriamente Dante a guardare gli indovini, tra i quali c'è Anfiarao, uno dei sette re che assediarono Tebe e che fu inghiottito dalla terra apertasi sotto di lui, cadendo sino a Minosse; egli ha ora le spalle al posto del petto e per aver voluto vedere troppo in avanti adesso guarda indietro e cammina a ritroso. Anfiarao dalla Tebaide di Stazio, ma Dante elimina tutti i tratti eroici del personaggio. Prof. Laura Ciampini 24 CANTO XX, Virgilio mostra alcuni antichi indovini (31-57) Johann Heinrich Füssli, c. 1780-85. Virigilio mostra poi Tiresia, che divenne una donna in seguito a una metamorfosi e tornò uomo dopo aver colpito due serpenti che si accoppiavano. Tiresias appears to Odysseus during the nekyia of Odysse. Prof. Laura Ciampini 25 CANTO XX, Virgilio mostra alcuni antichi indovini (31-57) Lo segue Arunte, che visse in una spelonca presso la città di Luni, sulle alpi Apuane, da dove vedeva ampiamente le stelle e il mare. Virgilio indica ancora una dannata le cui lunghe trecce coprono il petto: è Manto, che vagò attraverso molte terre e infine si stabilì a Mantova, la città del poeta latino, che invita Dante ad ascoltarlo un poco. Mantó è una maga, personaggio letterario della mitologia greca. Figlia di Tiresia, sacerdotessa di Apollo a Delfi, madre di Ocno, leggendario fondatore di Mantova Manto nel De mulieribus claris di Giovanni Boccaccio Arunte è un aruspice etrusco, personaggio della Pharsalia di Lucano . Egli era un potente indovino specializzato nella divinazione tramite le viscere di animali, il volo degli uccelli ed altri fenomeni naturali. l'Alighieri sceglie di collocare l'indovino in una spelonca tra i bianchi marmi sopra Carrara, da dove poteva guardare sia il mare Prof. Laura Ciampini 26 che le stelle. CANTO XX, Le mitiche origini di Mantova (58-99) Virgilio spiega che Manto dopo che Tebe cadde sotto la tirannia di Creonte, girò in lungo e in largo per il mondo. Nell'Italia del nord sorge un lago (Garda), ai piedi delle Alpi che dividono l'Italia dalla Germania, detto Benaco. Al centro di esso c'è un luogo (l'isola dei Frati o Campione) soggetto ai tre vescovadi di Trento, Brescia e Verona, mentre dove la riva del lago è più bassa sorge la città di Peschiera, solida fortezza contro Bresciani e Bergamaschi. Qui a Peschiera l'acqua del lago fuoriesce a formare un fiume, il Mincio, che poi scorre tra verdi pascoli fino a Governolo, dove si getta nel Po. Il Mincio incontra un avvallamento dove si impaluda e d'estate è talvolta in secca. La vergine Manto passò di qui e vide una terra in mezzo alla palude, incolta e disabitata, dove si stabilì per sfuggire ogni contatto umano per coltivare le sue arti magiche coi suoi servi, e dove morì e fu seppellita. In seguito gli uomini che erano sparsi tutt'intorno si raccolsero in quel luogo, ben difeso dalla natura in quanto circondato dalla palude, e costruirono una città sulla tomba di Manto che chiamarono poi Mantova dal nome dell'indovina. Gli abitanti erano ben più numerosi prima che Pinamonte dei Bonacolsi ingannasse il folle conte Alberto di Casalodi. Virgilio conclude dicendo che questa è la vera origine di Mantova, Prof. Laura Ciampini 27 se mai Dante avesse sentito un'altra versione. CANTO XX, Le mitiche origini di Mantova (58-99) Prof. Laura Ciampini 28 CANTO XX, Virgilio indica altri indovini (100-130) Dante ringrazia Virgilio per la dotta spiegazione e chiede se fra gli indovini della Bolgia ve ne siano altri degni di attenzione. Il maestro risponde che il dannato la cui barba gli copre le spalle è Euripilo, che fu augure al tempo in cui la Grecia fu spopolata di maschi per la guerra di Troia e indicò con Calcante il momento propizio per far partire la flotta degli Achei. L'Eneide dello stesso Virgilio accenna a lui, come ben sa Dante che la conosce tutta. Un altro dannato dai fianchi esili è Michele Scotto, sempre dedito alle arti magiche e divinatorie; poi ci sono gli astrologi Guido Bonatti e Asdente (Maestro Benvenuto), che vorrebbe essersi dedicato solo al mestiere di calzolaio e ora si pente tardivamente. Priamo della Quercia Prof. Laura Ciampini 29 CANTO XX, Virgilio indica le maghe (100-130) Ci sono anche molte donne che lasciarono le opere femminili per dedicarsi alla divinazione, facendo magie con erbe e con immagini e diventando fattucchiere. Poi Virgilio invita il discepolo ad allontanarsi, in quanto la luna già tocca l'orizzonte e sta per tramontare sotto Siviglia. Essa era piena la notte precedente, cosa che Dante dovrebbe ricordare visto che la luce lunare gli giovò mentre era perduto nella selva oscura. Mentre i due parlano non cessano di camminare Vedi le triste che lasciaron l’ago, La la spuola e ’l fuso, e fecersi ’ndivine; strega e fecer malie con erbe e con imago. la mandra gora, Henry Fuseli, 1812 Prof. Laura Ciampini 30 BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA • • • • A. MARIOTTI, M.C. SCIAFANI, A. STANCANELLI, Talee, Messina- Firenze, G. D’Anna, 2008, vol. 2, pp 281-283 MARTA SAMBUGAR, GABRIELLA SALA’, Letteratura Modulare, Dalle origini al Seicento, 2009, pp. 95-97 L A DIVINA COMMEDIA, A CURA DI NATALINO SAPEGNO CLAUDIO GIUNTA, Cuori intelligenti, Garzanti scuola, 2017, vol 1 a, pp. 312-313, 330-335 • • • • • • • • • • • https://it.wikipedia.org/wiki/Venedico_Caccianemico https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xviii.html https://it.wikipedia.org/wiki/Ipsipile https://www.youtube.com/watch?v=tPShoX-mcBw (aria di Isifile, di Francesco Cavalli, 1649 ) https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Giasone https://it.wikipedia.org/wiki/Alessio_Interminelli https://ladante.it/dantealighieri/hochfeiler/inferno/person/anfiarao.htm https://it.wikipedia.org/wiki/Arunte_(aruspice) madre di Ocno, leggendario fondatore di Mantova https://divinacommedia.weebly.com/inferno-canto-xx.html https://www.youtube.com/watch?v=x2DZ613dWFM Prof. Laura Ciampini 31