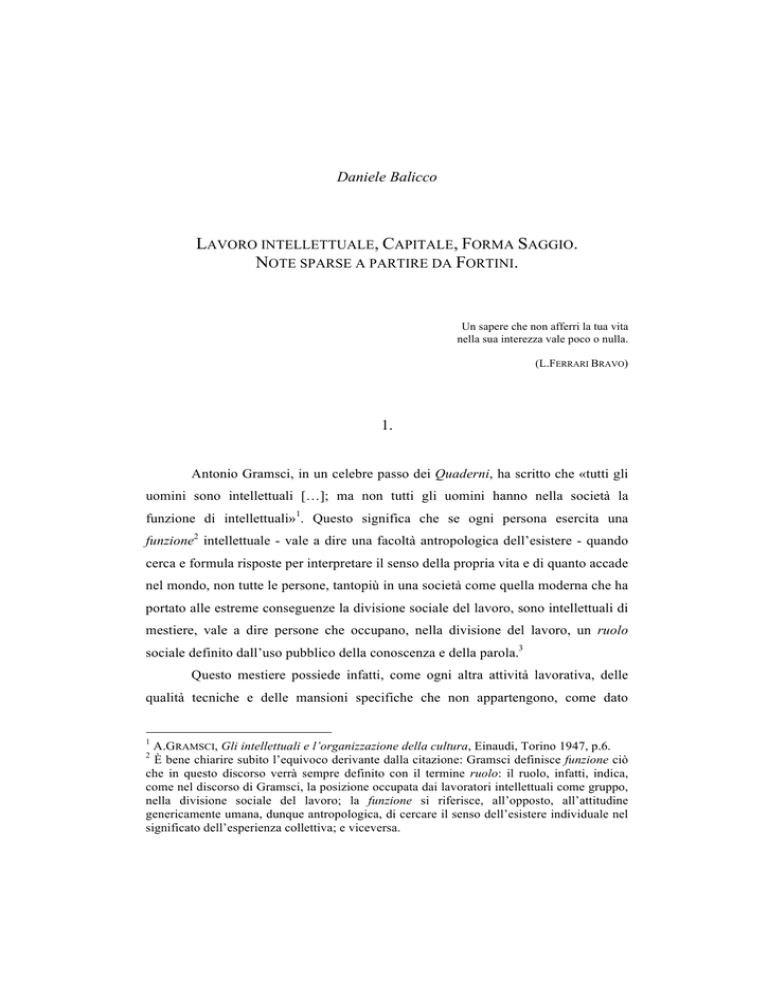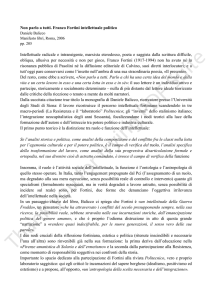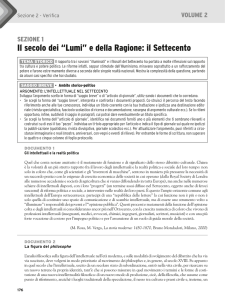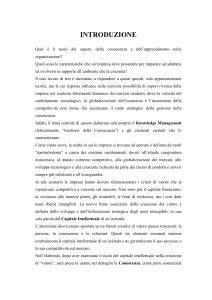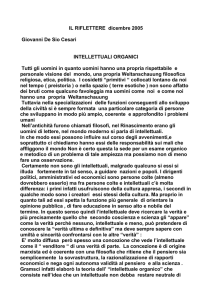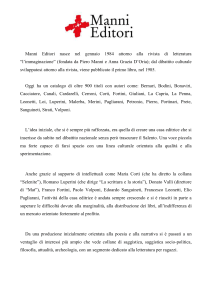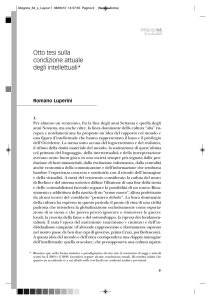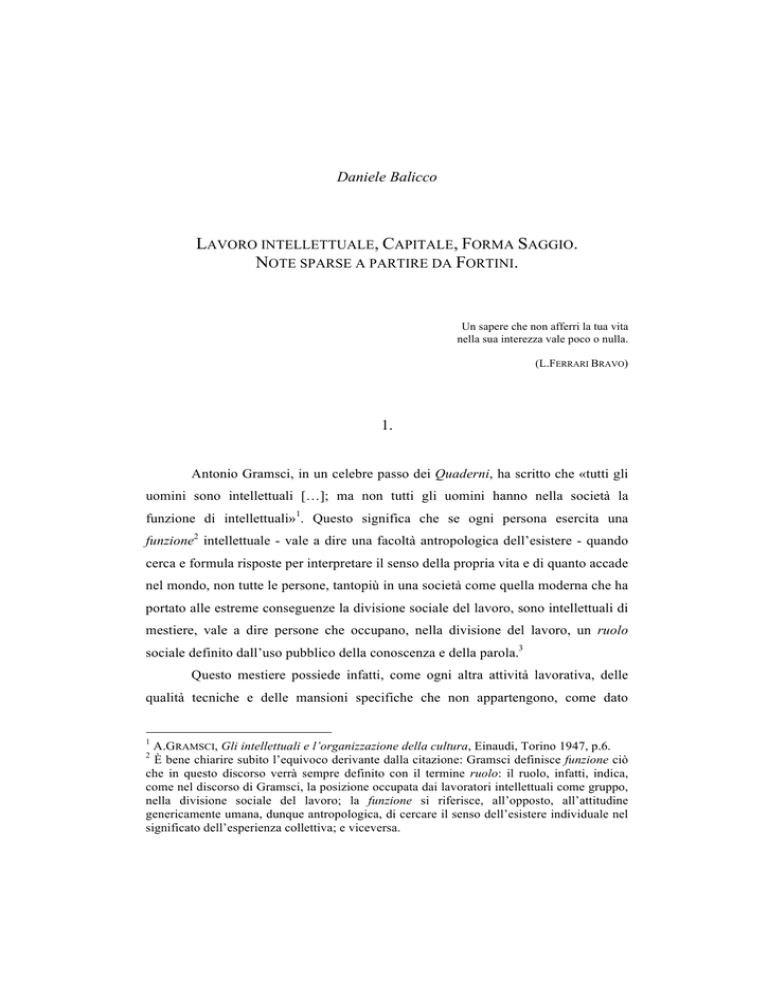
Daniele Balicco
LAVORO INTELLETTUALE, CAPITALE, FORMA SAGGIO.
NOTE SPARSE A PARTIRE DA FORTINI.
Un sapere che non afferri la tua vita
nella sua interezza vale poco o nulla.
(L.FERRARI BRAVO)
1.
Antonio Gramsci, in un celebre passo dei Quaderni, ha scritto che «tutti gli
uomini sono intellettuali […]; ma non tutti gli uomini hanno nella società la
funzione di intellettuali»1. Questo significa che se ogni persona esercita una
funzione2 intellettuale - vale a dire una facoltà antropologica dell’esistere - quando
cerca e formula risposte per interpretare il senso della propria vita e di quanto accade
nel mondo, non tutte le persone, tantopiù in una società come quella moderna che ha
portato alle estreme conseguenze la divisione sociale del lavoro, sono intellettuali di
mestiere, vale a dire persone che occupano, nella divisione del lavoro, un ruolo
sociale definito dall’uso pubblico della conoscenza e della parola.3
Questo mestiere possiede infatti, come ogni altra attività lavorativa, delle
qualità tecniche e delle mansioni specifiche che non appartengono, come dato
1
A.GRAMSCI, Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, Einaudi, Torino 1947, p.6.
È bene chiarire subito l’equivoco derivante dalla citazione: Gramsci definisce funzione ciò
che in questo discorso verrà sempre definito con il termine ruolo: il ruolo, infatti, indica,
come nel discorso di Gramsci, la posizione occupata dai lavoratori intellettuali come gruppo,
nella divisione sociale del lavoro; la funzione si riferisce, all’opposto, all’attitudine
genericamente umana, dunque antropologica, di cercare il senso dell’esistere individuale nel
significato dell’esperienza collettiva; e viceversa.
2
immediato, al senso comune, ma sono piuttosto esito di un complesso processo di
formazione e di selezione che ne determina lo skill. Gramsci è molto chiaro:
La capacità dell’intellettuale di professione di combinare abilmente l’induzione e la
deduzione, di generalizzare senza cadere nel vuoto formalismo, di trasportare da una sfera ad
un’altra di giudizio certi criteri di discriminazione, adattandoli alle nuove condizioni ecc., è
4
una «specialità», una «qualifica», non è un dato volgare del senso comune.
Per intendere per quale ragione questo tipo di attività lavorativa - la capacità
tecnica di astrarre, di giudicare, di progettare, di comprendere - abbia occupato una
posizione centrale, e per più di un secolo, nel dibattito filosofico, artistico e politico
occidentale; e per capire, nello stesso tempo, il significato attuale dell’eclissi di
questo stesso dibattito, è bene considerare, almeno a grandi linee, la posizione
specifica occupata dal lavoro intellettuale nella società moderna, e cioè il suo essere
attività lavorativa costretta «in un punto delicatissimo d’intersezione fra queste tre
sfere, che sono il lavoro, la società e il potere (o la politica)».5
In questa intersezione, infatti, vanno cercati i nessi che legano e
aggrovigliano, nello stesso tempo, la questione del ruolo intellettuale, e cioè della
storia, della trasformazione e, infine, della distruzione degli intellettuali come
gruppo sociale detentore del monopolio pubblico della scienza e della parola,
dunque del capitale sociale simbolico6; a quella della funzione intellettuale, vale a
dire della forma antropologica del conoscere come attitudine genericamente umana
ad interpretare il senso dell’esistenza individuale e sociale.
Se l’analisi storica e politica, come analisi della composizione e del conflitto
fra le classi nella lotta per l’egemonia culturale e per il potere politico, è il campo di
verifica del ruolo, l’analisi specifica della trasformazione del lavoro, come analisi
della sua progressiva disarticolazione formale e ortopedia7, del suo divenire cioè da
3
P.BOURDIEU, La responsabilità degli intellettuali, Laterza, Roma-Bari 1991.
A.GRAMSCI, Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura cit., p.141.
5
A.ASOR ROSA, Intellettuali in Enciclopedia, VII, Einaudi, Torino 1979, p.804.
6
P.BOURDIEU, La parola e il potere, Guida, Napoli 1988.
7
«Potendosi leggere tutta la storia della modernità dal punto di vista economico appunto
essenzialmente come la storia dell’ortopedia e della normalizzazione della forza-lavoro,
4
mestiere capace di determinare autonomamente forme a lavoro astratto comandato, è
invece il campo di verifica della funzione, della trasformazione cioè, in un’attività
particolare e generica come quella intellettuale, dell’immagine stessa dell’uomo,
della sua antropologia come essere generico determinato.
Ed è precisamente per questa sua qualità generica che, per quanto stravolto
e piegato, come qualsiasi altra attività nel moderno, dallo sfruttamento capitalista, il
lavoro intellettuale diventerà pressoché integralmente lavoro astratto solo dopo la
terza rivoluzione industriale, quella cioè che, nello sviluppo delle macchine
cibernetiche e informatiche, metterà a lavoro non solo il corpo del lavoratore, ma
soprattutto le funzioni conoscitive della mente, la sua coscienza8: naturalmente, in
questa lettura, almeno per chi scrive, vale ancora oggi l’insegnamento di Panzieri,
per il quale, come è noto, lo sviluppo tecnologico delle macchine deve essere letto
anche come sviluppo del dominio capitalista, come intensificazione, nella
razionalità di cui è attore, del comando e dello sfruttamento del lavoro vivo.
Così, se il problema della distruzione degli intellettuali come ruolo, cioè
come gruppo sociale del monopolio della scienza e della parola pubblica, è un
problema storico e politico che coinvolge e travolge la società italiana a partire dalla
seconda metà degli anni ’50; la trasformazione del lavoro intellettuale in lavoro
mentale, dunque in lavoro astratto, rinvia ad una trasformazione, visibile in Italia
solo nell’ultimo ventennio, molto più profonda perché coinvolge la funzione
obbligata ad erogare un lavoro il cui senso è sempre più definito dalla quantità meramente
temporale della prestazione» in R.FINELLI, Alcune tesi su capitalismo, marxismo e
«postmodernità» in L.CILLARO-R.FINELLI, Capitalismo e conoscenza. L’astrazione del
lavoro nell’età telematica, Manifestolibri, Roma 1998, p. 16.
8
«Il paradosso del nuovo lavoro - del lavoro cosiddetto postfordista e postmoderno –
consiste nel fatto che ciò che ora viene normalizzato e colonizzato, nel nuovo sistema forza
lavoro mentale-macchina informatica, è non più il corpo ma la mente stessa del lavoratore. È
cioè la sua «coscienza», sia come attitudine alla comprensione globale e intuitiva sia come
capacità logico-discorsiva (insomma ciò che finora veniva definito come la caratteristica più
personale e non normalizzabile del soggetto umano), ad entrare in un campo di fungibilità e
funzionalità interagente, ma subalterna, con la macchina dell’informazione» in Ivi, p.17
intellettuale
stessa:
una
trasformazione,
dunque,
che,
nella
sua
ragione
immediatamente economica, apre, invero, ad un ordine di problemi qualitativamente
diversi, riguardanti, insieme, l’antropologia e l’ontologia.
Il postmoderno, infatti, può anche essere letto come l’età nella quale la
sussunzione reale ha raggiunto, per così dire, le facoltà kantiane della ragion pura:
ed è precisamente nell’apriori comandato del conoscere che si rivela, come nel
rovescio di un arazzo, la possibilità attuale della distruzione della specie, la forma
cioè di un’ontologia che, non prevedendo diacronia, ma solo intensificazione di se
stessa
come
divenire
quantitativo
illimitato,
agisce
ormai
direttamente
sull’antropologia opponendo, senza mediazioni possibili, capitale a vita umana.
2.
L’itinerario saggistico di Fortini è l’itinerario di un intellettuale della Guerra
Fredda, di un pensatore cioè che ha attraversato i conflitti del secolo presupponendo
sempre, nella sua ricerca, la possibilità reale, sebbene stravolta nelle sue
incarnazioni storiche, dell’emancipazione politica del genere umano. Questa è la
grande narrazione che organizza e dirige il senso complessivo della sua attività
intellettuale, politica, poetica. Ed è la sua distruzione attuale, perfino come potenza e
negazione nell’immaginario sociale, a rendere quasi indecifrabili, per le nuove
generazioni, il senso vero delle sue parole. È, del resto, Fortini stesso a sostenerlo
introducendo, nel 1993, il suo ultimo libro pubblicato in vita, Attraverso Pasolini:
Quanto in lui e in me si agitò in quelle occasioni non può non apparire alcunché di
incomprensibile, quasi al confine della mania, per un giovane d’oggi. Ma non eravamo né
pazzi né fanatici. Eravamo, a poco più di dieci anni dalla fine della Seconda Guerra, nel
cuore del secolo, ancora ricchi di qualcosa che – scrisse Pasolini – ci faceva piangere
guardando Roma città aperta. Le lacrime non sono affatto un buon criterio di giudizio.
Eppure mi piacerebbe sapere che cosa possa oggi far piangere un uomo di trent’anni, che
tanti allora Pier Paolo ne aveva. E a uno o due di quei giovani anche vorrei dire: come si
impara una lingua straniera, cercate di capire la lingua nostra, solo in apparenza simile a
quella che ogni giorno impiegate conversando o pensando. Se ritenete che non valga la
fatica, chiudete in fretta i nostri libri e l’età che li produsse; e buona fortuna. 9
Oltre ad essere un pensatore della Guerra Fredda, Fortini può anche essere
letto come uno scrittore del «Triangolo Industriale». È stato, infatti, un intellettuale
umanista capace, in un universo ad alto sviluppo industriale, in quegli anni
attraversato da uno straordinario processo di politicizzazione di massa, di assumere
coscientemente la propria formazione letteraria come contraddizione, insieme figura
di subalternità e di potere. Del resto, gli scritti di Fortini, almeno fino agli anni
Settanta, sono gli scritti letterari, politici, estetici di un lavoratore dipendente, di un
consulente, naturalmente ad alta qualificazione, dell’Olivetti e dell’Einuadi; e solo in
un secondo tempo, dopo essere stato licenziato da entrambe, all’inizio degli anni
Sessanta, per ragioni politiche, di un insegnante delle secondarie superiori prima,
universitario poi.
Sta qui, probabilmente, la ragione della misura e del ritmo della sua scrittura
(vale a dire del «saggio come forma»), nonché della torsione ‘pratica’ che lui stesso
le imprime: osservata a distanza, nella sua qualità sintattica sembra infatti
depositarsi il conflitto fra due mondi e due tempi qualitativamente opposti, eppure
condensati in un equilibrio stabile, seppur scheggiato e assolutamente disarmonico.
La sua è la storia, in fondo, della lotta fra l’universalità che il sapere umanistico
pretende e un’universalità di segno opposto, quella della merce come arcano e
geroglifico sociale che impone strumenti per la sua interpretazione non differibili,
pena l’incomprensione del presente, l’incoscienza subita come determinazione del
dominio. Ed è una lotta tanto più estenuata, quanto più l’universo che la circonda
sembra chiudersi in una totalizzazione fatale: il senso di molta saggistica fortiniana è
per questo incomprensibile se non ricondotto a questa precisa posizione, ancor prima
che politica, geografica ed esistenziale.
9
F.FORTINI, Attraverso Pasolini, Einaudi, Torino 1993, p. X.
Del resto, sempre nello stesso ‘spazio’, il suo lavoro intellettuale ha
partecipato di una comunità politica diffusa, ma non ufficiale, le cui origini risalgano
quanto meno alla Resistenza e il cui sviluppo politico cresce accanto alle lotte
operaie e sociali del dopoguerra; ancora una volta, per comprendere il senso preciso
della sua scrittura, della sua posizione umanistica e «industriale», il confronto che
lui stesso pone, anche dal punto di vista lavorativo, fra sé e Pasolini può essere
davvero illuminante:
Nel 1961 uscì a Torino, in una situazione sociale che presto sarebbe esplosa, il primo numero
di «Quaderni Rossi» e l’anno successivo, a Piacenza, comparve una minuscola rivista che,
insieme ad alcune altre, avrebbe occupato in Italia uno spazio di opposizione intellettuale
simile a quello che in Francia si opponeva al gollismo, alla politica del PCF e alla guerra
d’Algeria. Ai primi del ’62 Torino visse gli scioperi della Lancia e della Michelin; e
quest’ultimo durato tre mesi. Col titolo Scioperi a Torino, avrei scritto il commento a un
documentario su quelle agitazioni. Il 23 giugno ci fu il grande e fino allora impensabile
sciopero di sessantamila operai alla FIAT. In quel periodo Pasolini veniva sviluppando la sua
opera di regista. È forse difficile oggi rendersi conto di quanto fosse stridulo il contrasto fra il
modo in cui veniva vissuto il presente fra Torino e Milano in quegli anni di trasformazione
profonda e l’immagine che di quello ci veniva da Roma. Per più di quasi tutti gli intellettuali
che erano stati vicini a pubblicazioni come «Quaderni Rossi» o «Quaderni Piacentini», fra il
1962 e 1964 scomparivano alla vista, rinunciavano alla ‘presenza’, sopravvivevano nelle
forme più modeste e anonime. È forse difficile capire, oggi, che per costoro, non solo
Pasolini ma anche Calvino erano dei ‘perduti’, dei passati nel campo avverso.10
Per Fortini, Milano resterà sempre dell’Italia, almeno fino alla fine degli
anni Settanta, il «privilegiato teatro dell’esistenza sociale»11, o forse meglio,
l’allegoria di una possibilità e di una sconfitta, lo spazio del comando e insieme
della negazione determinata del capitalismo italiano. Per Fortini Milano è stata,
infatti, la capitale della Resistenza, del marxismo critico, delle lotte operaie, dei
movimenti sociali di massa e nello stesso tempo la città guida del capitalismo
italiano, della finanza, dell’americanizzazione sociale; dunque un laboratorio
straordinario e contraddittorio, la città che ha espresso, al più alto grado possibile, un
10
Ivi, pp. 121-122
Id., Milano, città «scomparsa»? in Id., Saggi ed epigrammi, a cura di L.LENZINI,
Mondadori, Milano 2003, p. 1693.
11
movimento politico di massa incisivo e politicamente cosciente12 e, nello stesso
tempo, la sua negazione immediata, feroce e, in un certo modo, definitiva.
È inevitabile, dunque, che per questo suo essere «zona di frontiera», cuore
del capitalismo italiano e della sua negazione più cosciente, Milano rappresenti, per
Fortini, un punto d’osservazione privilegiato sulla verità delle trasformazioni
profonde, strutturali e ideologiche, che il nostro paese ha attraversato, quanto meno
lungo tutti gli anni della Guerra Fredda.
3.
A questo punto, se il suo itinerario saggistico è stato posizionato
storicamente nell’età della Guerra Fredda e geograficamente nella società politica
radicale dell’Italia industrializzata, il senso della sua scrittura può essere
ulteriormente approfondito considerandolo, nella sua qualità autoriflessiva, come
sintomo di una condizione generale, di una lacerazione oggettiva che ha attraversato
in profondità la cultura e la società italiana degli anni che qui si considerano.
Fredric Jameson ha sostenuto, in un noto saggio sui rapporti fra narrazione e
sistema mondo13, che un’analisi comparata delle varie letterature mondiali
contemporanee potrebbe portare ad una restituzione di una mappa simbolica nella
quale, tradotte e formalizzate nell’estetico, le reali gerarchie politiche ed
economiche dell’attuale sistema mondo si rivelerebbero come implicito contenuto di
verità. Proiettando, infatti, il conflitto hegeliano schiavo/padrone, come lotta
irriducibile fra due logiche culturali e simboliche (l’astrazione idealistica del
padrone contro il materialismo pratico dello schiavo), è possibile, secondo Jameson,
12
«In giorni come questi si è contenti di vivere a Milano. Il livello politico di massa è alto e
serio, non soltanto civile. C’è molta meno cattiva letteratura che a Roma e a Bologna» in Id.,
Disobbedienze, I, Gli anni dei movimenti, Manifestolibri, Roma 1997, p.140.
riconoscere, nella differente qualità strutturale e simbolica delle strategie narrative,
la forma estetica del conflitto strutturale fra Nord e Sud del mondo:
Ho l’impressione che noi americani, i padroni del mondo, ci troviamo per certi versi nella
stessa posizione. La vista dall’alto è epistemologicamente deformante, riduce i suoi oggetti
alle illusioni di una miriade di soggettività frammentate, alla povertà dell’esperienza
individuale di monadi isolate, a singoli corpi morenti privi di qualsiasi passato o futuro
collettivo, senza alcuna possibilità di afferrare la totalità sociale. Questa individualità
apolide, questo idealismo strutturale che ci permette il lusso del dibattito di ciglia sartriano,
rappresenta una benvenuta evasione dall’‘incubo della storia’, ma al tempo stesso condanna
la nostra cultura allo psicologismo e alle ‘proiezioni’ della soggettività privata. Tutto ciò è
negato alla cultura del terzo mondo, che dev’essere situazionale e materialistica suo
malgrado. Ed è questo, in definitiva, che deve spiegare la natura allegorica della cultura del
Terzo Mondo, in cui il racconto della singola storia e della singola esperienza deve per forza
di cose comportare, in un’ultima analisi, tutto il laborioso racconto dell’esperienza della
14
collettività stessa.
Proviamo a continuare, riferendolo agli anni che qui si considerano, il
ragionamento di Jameson e chiediamoci: qual è stata la posizione dell’Italia nel
sistema mondo durante tutto l’arco del secondo dopoguerra? In che modo questa
stessa posizione può avere influito sull’attività intellettuale non solo politica, ma
perfino simbolica ed estetica, del nostro Paese?
Senza dubbio, l’Italia è stata, per tutto il periodo dell’attività intellettuale di
Fortini, proprio come è titolata una sua raccolta di saggi, una «zona di frontiera».
Per un verso il suo spazio è stato infatti uno spazio ideologico15, vale a dire
uno spazio geografico connotato politicamente dall’essere uno dei teatri mondiali
della Guerra Fredda, e non solo perché Stato capitalistico in una zona di confine fra
Est e Ovest, ma soprattutto perché ulteriormente diviso, al suo interno, dalla
presenza tanto del più grande partito comunista occidentale, quanto dei più grandi
movimenti sociali che abbiano attraversato l’Occidente.
13
F.JAMESON, La letteratura del terzo mondo nell’era del capitalismo multinazionale in
«L’asino d’oro», I, 2, pp.127-150.
14
Ivi, p.149.
15
C.GALLI, Spazi politici, Il Mulino, Bologna 2002.
Per un altro il suo è stato, e continua ad essere, il confine di uno spazio
strutturale16, vale a dire uno spazio economico posizionato al confine geografico,
nel sistema mondo, fra Nord industrializzato e Sud agricolo, fra Europa e Africa.
Confine, e lacerazione fra due diversi universi sociali, ancora una volta, riprodotti in
scala al suo interno, nel contrasto fra un Nord industrializzato, ad alta conflittualità
operaia, e un Sud agricolo, riserva di manodopera a basso costo.
Quello che si vuole dire, insomma, è che l’Italia ha concentrato in uno
spazio geografico davvero limitato una qualità e una quantità tale di confini e di
contraddizioni da renderla, effettivamente, quanto meno negli anni che qui si
considerano, una riproduzione in scala del sistema mondo, una «zona di frontiera»
che ha riprodotto, al suo interno, squilibri e gerarchie, poteri politici e movimenti
sociali opposti, figure di conflitti distanti, eppure incredibilmente ravvicinati.
Ed è questa la ragione per la quale, in un certo modo, la dialettica
schiavo/padrone, il materialismo subìto e l’astrazione aerea senza appigli, è stata,
per così dire, temporaneamente sospesa, quasi avvicinando i due poli in un reciproco
riconoscimento: e se questo ha portato, sul piano dell’azione politica, ad un conflitto
operaio e sociale politicamente cosciente perché realmente capace di aggredire la
verità dell’accumulazione come comando sul lavoro17, sul piano dell’attività
simbolica, mai come nell’Italia del secondo dopoguerra, il piano politico ha invaso,
nel bene e nel male, l’estetico e l’estetico, a sua volta, il politico.
Non è dunque un caso se il «saggio come forma», per antonomasia genere
dell’intersezione fra queste due sfere, sia stato il genere guida della letteratura
16
I.WALLERSTEIN, Le invenzioni delle realtà spaziotemporali: verso una comprensione dei
sistemi storici in Id., La scienza sociale: come sbarazzarsene, Il Saggiatore, Milano 1995,
pp.147-162.
17
«Le lotte nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro non si limitavano alla richiesta di un
maggior salario, orari più corti, minore pressione sul lavoro. Ad essere messi in questione
erano l'insieme del comando padronale sulla produzione, le forme dell’organizzazione del
lavoro e della struttura tecnica della produzione, la stessa ‘disciplina di fabbrica’» in
R.BELLOFIORE, I lunghi anni settanta. Crisi sociale e integrazione economica internazionale
in Le radici della crisi. L’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, a cura di L.BALDISSARRA,
Carocci, Roma 2001, p. 74.
italiana contemporanea18. Forma dell’espressione soggettiva che pretende e rivela,
rifranta nella mediazione di un pretesto, la totalità come verità della propria
esistenza, il «saggio come forma» è stato l’allegoria della forma dell’Italia, della sua
posizione specifica nel sistema mondo, del suo essere, paradossalmente, cruciale
«zona di frontiera» della Guerra Fredda mondiale.
4.
L’itinerario intellettuale di Fortini è, per tutte queste ragioni, un itinerario
integralmente politico. Naturalmente a questo termine non va attribuito in alcun
modo un significato tecnico perché definisce, semmai, un’area connotativa, una
certa forma dell’agire e del pensare, una sintassi profonda che regola e attribuisce
senso all’esperienza di Sé e del mondo.
Del resto, l’eccezionale qualità critica del suo itinerario intellettuale, come
continua riflessione sulla liberazione possibile anzitutto dalla propria subordinazione
come lavoratore intellettuale, deriva dalla pretesa inseparabilità di ruolo e funzione,
di estetica e politica; e discende, da questa precisa impostazione, la comprensione
immediata del significato politico della radicale trasformazione antropologica (come
distruzione delle facoltà sintetiche dell’IO e della memoria volontaria) che segue, in
Italia, alla devastazione dei movimenti; e che abita il nostro presente.
Questa nuova soggettività, incapace di «incarnazione» e di «narrazione», di
memoria storica e di totalità politica, soggettività di cui il post-strutturalismo
francese (Lacan, Deleuze, Guattari, Foucault) può essere considerato côté
ideologico, non è altro, e nientemeno, che la forma realizzata della nuova
18
A.BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario,
Marsilio, Venezia 2002.
antropologia capitalista, vale a dire di quella nuova massa di forza-lavoro mentale
che lo sviluppo delle macchine informatiche metterà a lavoro nei decenni successivi.
Di fronte alla distruzione della storicità dell’esistere individuale, come limite
e potenza della sua libertà; di fronte alla sussunzione reale di ruolo e funzione; di
fronte all’avanzare di un’ontologia della quantità pura che non tollera alcuna
differenza qualitativa, se non l’aumento di se stessa, la lotta per la liberazione del
genere umano inevitabilmente si oscura in un presente che l’ha del tutto corrosa.
Questa è la ragione, credo, della radicale inattualità di una scrittura come quella di
Fortini, all’opposto integralmente attraversata dai limiti e dalla potenza di questa
grande narrazione che ha sempre preteso interlocutori attivi, perché direttamente
coinvolti nella conquista della sua realizzazione pratica.
Ed è precisamente questa, infatti, la ragione che ghiaccia nel presente il
senso stesso del lavoro critico: l’assenza di destinatari direttamente coinvolti nella
sovversione politica del presente. La critica ideologica, infatti, non è, almeno in
Fortini, discorso moralistico che un soggetto esterno propone ed impone ad un altro
soggetto, subalterno e ancora informe. All’opposto. Il lavoro critico è
esclusivamente lavoro autoriflessivo del soggetto sulla forma della propria esistenza:
il suo scopo è quello di corrodere la false immagini di Sé, insieme deformazione e
sottrazione di potenza, nelle quali è costretto qualsiasi soggetto umano in una
condizione di totalizzazione capitalistica. Fuori da questa prospettiva il lavoro
critico non ha mandato, dunque senso:
Perché andare a dire quel che non ci viene chiesto? […] Debbono essere i giovani a chiedere,
a cercare chi può rispondere, a domandare sempre di più, a federarsi, a controllare; altrimenti
meritano di essere lasciati affogare nella panna delle proprie spiegazioni organizzate.
Debbono arrivare a sentire intollerabile la loro miseria e la loro ignoranza. Debbono chiedere
aiuto. Al passato; alla storia; ai libri dei morti. Debbono morire al presente. Finché non
capiranno che chiunque altrimenti li lusinga è il loro nemico, non meritano che di distrarsi a
Bologna e di leggersi a vicenda le loro caritatevoli poesie di bambini cresciuti. Avranno,
tutt’al più il destino dei loro genitori. Che i giovani si separino, invece. Li invito ad una
dissidenza meno vistosa di quella del ’68 ma più spietata e intransigente. A una clandestinità;
che nulla abbia con quella terroristica. A una segretezza; che nulla abbia della P2. Una
congiura in piena luce che non perdoni nessuno e non renda facondo il disprezzo; e che, con
tenacia da formica, ripensi e rifondi le ragioni di una democrazia, proponendosi un «fino in
fondo» che implica la più radicale condanna, quella dell’oblio, per li avrà ingannati.19
In un presente che impedisce sapere e memoria, dunque perfino un profilo
minimo di autonomia e soggettività, il mandato del critico svanisce. Resta la
sapienza, la saggezza dell’anziano che tramanda al nipote, perché la protegga come
insegnamento, la verità della propria esperienza. Il rapporto fra le generazioni, che il
presente ha annientato, può essere forse ristabilito recuperando, ironicamente e
paradossalmente, forme antropologiche del sapere radicalmente inattuali, capaci di
sfidare un presente immobilizzato ricordando, silenziosamente, nel loro specifico
dettato, il senso del divenire del tempo, come divenire delle generazioni dell’uomo;
solo così, forse, la coscienza e la storia della lotta per il comunismo può essere oggi
tramandata, protetta e proiettata nel futuro; il suo racconto alle generazioni future si
mimetizzi dunque, se è necessario, perfino nella semplicità innocente della favola:
C’era una volta un’antica causa, il «sogno di una cosa» che tutto farebbe presumere perduta,
di tanto eccede le forze dei migliori di molte generazioni. Non sarebbe oggi e da noi perduta,
non fosse così necessario farla vincere domani o almeno difenderne l’onore. […] Tale antica
causa voleva rimuovere gli ostacoli che vietano al maggior numero di esseri umani la
comprensione, o coscienza, in forma di scienza e sapienza, della loro «condizione umana».
Non sa quale, quella «condizione», sia; ma sa (e per saperlo rischia la scelta e, con la scelta,
l’errore) che la possibilità di quella ricerca o del moto verso quella conoscenza sono impedite
o diminuite, nella grandissima maggioranza degli uomini ad opera di altri uomini, passati o
presenti, e se ne formano depositi e sedimenti immensi, o nuove miniere, di servitù e di male.
E aggiunge che quella conoscenza o almeno il moto verso quella, e dunque la sua esperienza,
deve essere rivolta soprattutto a sempre più profonde e più renitenti parti di se stessi, dove,
col nome di inconscio, si contorce la Storia. L’antica causa ritiene che tale comprensione (o
coscienza o esperienza) non sia dia fuori del conflitto o lotta fra interessi (fra ogni possibile
forma di interessi) contrapposti; non perché quella lotta possa mai concludersi – ad esempio
nella cosiddetta società senza classi; sebbene vi si avvicini come un asintoto – ma perché
certe lotte, certe loro forme e modi, quelle che continuano a far l’uomo lupo dell’uomo,
possano essere superate, conservandone tuttavia la memoria per impedirne il ritorno. Vittorie
parziali: che il tempo e la superbia dei vincitori possono, sebbene non necessariamente,
tramutare in sconfitte. Progressi parziali. Allegorie della «vittoria finale» che non ci sarà se
non come cuore e ragione delle singole vittorie parziali. E poi ogni vittoria di una parte è
sconfitta dell’altra; enigmatica condizione che fa godere allo sconfitto un suo oscuro
privilegio. Questi rovesciamenti paradossali (di cui vive, oltre tutto, il cristianesimo), questa
dialettica dei possibili, non sono però, come i mistici d’Oriente, fantasmagorie del desiderio
19
F.FORTINI, Per una congiura in piena luce.1981 in Id., Saggi ed epigrammi cit., p. 1054.
e della morte; ma schemi costitutivi di realtà, appunto, possibili, di modi di relazione
interumana ancora inediti, che attendono la propria incarnazione. Noi li percepiamo, oggi,
come pietrificanti paradossi; e invece la loro legge, come quella mosaica per Venanzio
Fortunato, ne fa umbra futurorum, figura dell’avvenire. Come la necessità di una struttura
metrica, quelle vittorie storiche che lottiamo per conseguire ci fanno (ci faranno) a un tempo
prigionieri e liberi. 20
Perché per quanto il presente precipiti, varrà sempre in Fortini
l’insegnamento di Brecht: «Chi è vivo non dica: mai».
20
F.FORTINI, Per una ecologia della letteratura in Id., Saggi ed epigrammi cit., pp. 16181619.