
MANFRFDO MASSIRONI
LA VIA PIÙ BREVE NEL PENSIERO VISIVO
Questo articolo è dedicato a
Gaetano Kaniz..~a nel ricordo
dcl suo insegnamento
I. È una metafora appropriata quella che rappresenta il lavoro dcl
pensiero teso alla soluzione di un problema come una via che parte dalla
condizione problemica e arriva alla soluzione. Ma possiamo parlare di
lunghezza di un percorso solo se possediamo uno strumento preciso o
almeno un criterio approssimativo per misurarla.
Ogni metrica della semplicità. o. come nel no~ilro caso, della «via
più breve» poggia su qualche presupposto di economia. Ma vi sono
almeno due modi di intendere rcconomia: uno signorile, elegante,
matematico sintetiuabile nella definizione «il massimo risultato con il
minimo sforzo• - la bolla di sapone è l'esempio emblematico di tale
tipo di economia, che si incontra spesso nel mondo della fisica e più
raramente in quello dell'attività cognitiva - l'altro è un modo meno
elegante, un po' più straccione, e potrebbe c<;scre riassunto cosl: se non
cl sono risorse sufficienti bisogna operare le scelte meno dispendiose.
non perché siano le migliori o portino al massimo dci risultati, ma
perché consentono di risparmiare risorse. Economia applicata per necessità non per scelta, allo stesso modo che in famiglia si fanno dci tagli
alle spese perché altrimenti non si arriva alla fine dcl mese. Molle
attività cognitive sono costrette a questo tipo di parsimonia: un caso
emblematico è quello dell'a1ten1ione, che avendo potenzialità limitate
deve decidere in continuazione su quale aspcllo dcl mClndo sintonizzarsi.
Ad esempio, non è possibile seguire contemporaneamente due conversazioni: anche se entrambe ci interessano dobbiamo scegliere a quale
prestare ancnzione, e di consegue01.a rassegnarci a perdere laltra quasi
completamente. Un altro caso è quello dcl pensiero. che spesso utiliua
semplificazioni sistematiche (euristiche) dci dati problcmici per giungere, con uno sforzo contenuto, ad un risultato accettabile anche se non
sempre correno. Quando parleremo di via più breve nel pensiero visivo.
la sua lunghezza sarà misurata sulla base di principi di economia dcl
secondo tipo.
2. Il termine «pensiero visivo• è abbastanza vago: è un contenitore
in cui possono rientrare cose molto eterogenee. lo lo userò per definire
SISTEMI INTELLIGENTI I a. VII, n. 2, agosto 1995
223
quella parte dcl pensiero che usa immagini mentali per svolgere un
compito o risolvere un problema. È chiaro quindi che si tratta di un
ampio settore di quell'attività cognitiva definita imagery (userò il termine inglese in mancanza cli un adeguato termine italiano, io accordo
con Giusberti 1991).
3. Prima di parlare del ruolo diverso che la parsimonia gioca ai vari
livelli di quei settori dell'attività cognitiva a cui appartengono percezione ed imagery. devo introdurre brevemente una distinzione, cara a
Kani1.sa e che sarà utile anche a noi: quella fra «vedere» e «pensare»
(racchiuderò sempre i due termini fra virgolclle per ricordare che non
sto parlando del vedere e del pensare in senso generico, ma nell'acce1ionc, sostenuta da Kanizsa, in cui «vedere» indica un'attività percettiva
prccategoriale e preattcntiva, che elabora in maniera autonoma l' input
visivo, e «pensare• indica un'attività dei processi superiori o secondari
sul frutto dell'elaborvJone primaria). Kanizsa in piò occasioni (1980,
1991). Kanizsa e Luccio (1985, 1986) hanno mostrato in maniera convincente come sia facile trovare configurazioni percettive in cui il
verificarsi di qualche tipo di regolarizzazione, dì economia io una
direzione. provochi nello stesso tempo l'annullamento di qualche regolarità già esistente (illusioni di Hcring. Poggendorf, ZOllner. ccc.); per
cui Kani1.sa e Luccio arrivano alla conclusione «che l'unico effetto
constatabile di una fona che spinge verso un miglioramento è un peggioramento,. (Kanizsa 1991, 140). Quando Kohler afferma che nella
visione il cerchio è una forma unica per le sue proprietà (cii. in Kanizsa
1991, 11 1) non si può che essere d'accordo, ma nello stesso tempo ci si
può chiedere fino a che punto questa affermazione sia vera. n suo grado
di verità dipende dal tipo di rapporto che devo intrattenere, o dal tipo cli
operazione che devo cffclluarc con quella figura. Se infatti dovessi
ricavare «l'unicità• dcl cerchio dalla accuratezza con cui riesco a svolgere certe operazioni motorie nei suoi confronti, come toccarlo, evitare
di andarci a sbattere contro, afferrarlo fra altri oggetti, spostarlo da un
luogo ad un altro ccc., mi renderei conto che, per queste operazioni. il
cerchio non è diverso da altri «oggetti visivi sconosciuti, senza signifacato. ma perfettamente visibili e stabili per forma, colore grandezza,
rapporti spaziali» come quelli di fig. I. Le cose mutano radicalmente, il
cerchio diventa effettivamente «unico» come figura, se cambio il tipo di
operazione da svolgere su di esso: se devo descriverlo, o memorizzarlo,
o usarlo per costruire immagini mentali, allora sl che il poter trattare
con un cerchio fa la differenza. Si potrebbe allora pensare che l'unicità
dcl cerchio sia una caratteristica che l'attività percettiva, il processo
primario, seleziona per soddisfare esigenze di economia dei processi
secondari. Il cerchio sarebbe allora una fom13 unica per il linguaggio. il
pensiero, la memoria, ma non per l'atlività motoria. L'attività percettiva
ha almeno due scopi distinti: t) fornire le informazioni utili per calibrare
224
o
ftG. I . ~g~e.lti visivi ~ac!lmente ca.leg_orinabili e quindi descrì"ihili (in alto). Oggclli
vmva scc>noscauh. senza s1gmf1ca10. ma pcrfcllamente visibili e stal>ili per
forma. colore, grandezza, rapporti spa1.1ali (in basso) (da Kaniz.sa 1991 ).
e direzionare l'attività motoria, specie quella \'Cloce; ii) predisporre e
organizzare l'informazione pro\'enicnte dall'esterno, in maniera 1ale da
renderla adatta alla conoscenza e alla manipolazione da parte dci processi di livello più allo.
4. Sulla base di tale dislirvionc e dcl presupposto secondo <:ui il
sistema cognitivo ~ fondato sul risparmio a tulli i livelli, si può notare
che la tendenza alla parsimonia è 1anto più stre11a e tanto più rigorosa
man mano che si sale dal processo primario, che opera le prime elaborazioni sui dati sensoriali, ai processi secondari. che utilizzano il
s~milavorato dci rendimenti pcrceuivi per ulteriori operazioni cognitive.
Sr potrebbe allora sostenere che le a1tività cognitive di livello più allo.
quali pensiero. memoria, linguaggio, sono avare mentre la percezione,
almeno a certi livelli, è prodiga. Per capire che cosa inlcndo con questa
affermazione basta una semplice \'eri fica. Se ad esempio guardiamo un
sellore dcl nostro mondo quotidiano e proviamo ad enumerare tutto
quello che vediamo, ci rendiamo presto conto che l'elenco che possiamo fare, qualora la nostra esplorazione non venga interrotta, è potenzialmente lunghissimo. Se invece dopo un'osservazione anche lunga e
ripetuta giriamo le spalle a ciò che stavamo guardando e proviamo a
fare un analogo elenco di oggetti e loro attributi, ci rendiamo conto che
gran parte della ricchen.a di informazione che prima era a nostra disposizione è sparita, e il nostro elenco risulterà di una brevità sconcertante.
Assumiamo, provvisoriamente, una priorità dcli· attività motoria su quella
conoscitiva. La percezione è l'interfaccia che media il modo con cui
entriamo in contallo con il mondo esterno. Questo mondo è complesso.
ricco, articolato, confuso, molteplice. inatteso. dinamico, mutevole ccc.
ecc. La probabilità di sopravvivere in questo mondo dipende da due
225
ordini di fatti: il dalla quanlilà di informazione che riusciamo a raccogliere e a_d elaborare nella minor quantilà di lemQ_O; Odalla veloc~I~ con
cui riusciamo ad emettere una ris~sta motoria, mirata con prec1s1ooe,
sul segmenlÒ di realtà con cui stiamo misurandoci i~ _9!!el mo?'en~o.
La percezione, al suo primo stadio, per essere uule deve nuscire a
raccogliere e ad elaborare una grandissima quantità di dati e lo base a
questi attivare una risposta motoria li piil possibile veloce e precisa.
Una volla che questa risposta è stata emessa, i dati raccolti possono
essere rimossi in tutto o in parte; anz.i, devono essere rimossi perché il
gioco possa ricomfociare un istante dopo. Se solo consideriamo la
quantità di informazioni, di giudizi e di risposte che permettono ad uno
schermidore, a un giocatore di tennis o agli allori di qualsiasi allra
competizione sportiva le loro veloci e precise prestazioni, ci rendiamo
conto della grande quantità di dati che viene raccolla e della precisi.on~
con cui vengono elaborali. Ma possiamo pensare anche a prestazJOnt
meno estreme e più quotidiane, come ad esempio rifare un letto, sparecchiare e apparecchiare la tavola, lava.re i piatti senza romperli, guidare
l'auto o andare in bicicletta nel traffico, discendere, più o meno di
corsa, da un pendio scosceso. In gran parte di queste attivilà, inoltre, la
risposta motoria viene emessa senza che il frutto completo dell'~labora­
zione percettiva raggiunga il livello della consapevolezza. D1 questa
fase dell'attività percettiva non sappiamo mollo, perché è stata poco
studiata e perché è difficile da studiare; ciò nondimeno sono propenso
a ritenere che essa utilizzi molte delle informazioni locali elementari,
fisiche dello stimolo, soprallullo a livello quantitativo; che sia cioè un
processo sostanzialmente o prevalentemente dissipativo.
Infatti una volta emessa la risposta motoria, la maggior parte delle
informazioni elaborate decade; forse solo una piccola parte, opportunamente riorganizzata, è messa a disposizione delle attività cognitive di
alto livello. Definirei questa come «percezione attivl!lt. Definirei invece
«percezione contemplativai. quella che noi conosciamo, abbiamo _studiato, continuiamo a studiare e a ~fo deJle nostre leone. I
risultati di questo up() di percezione non sono valutati verificando
l'adegua~risposta motoria, ma verificando la correuezza e/o
la velocità con cui sono compiute operazioni mentali di alto livello
come giudizi, confronti, scelte, riconoscimenti, valutazioni, categorizzazioni, descrizioni verbali. Ma questa è solo una metà, sicuramente
molto importante, della perce1Jooc: è quella al servizio delle attività
cognitive superiori, quella che produce risultati coscienti, qu~lla più
facile da studiare, quella che ha trovato nel metodo fenomenologico una
delle procedure più promeuenli per la sua comprensione. Volendo adottare la distinzione di Kanizsa, dovremmo dire che la percezione alti va fa
parte del «vederci. e quella contemplativa del «pcnsareit. Ab~iamo
dello che la percezione attiva è dissipativa in quanto conserva a livello
consapevole assa.i poco di quanto elaborato in funzione della risposta
f
226
motoria. La percezione contemplativa è invece necessariamente
conservativa: la maggior parte delle informazioni che utilizza sono
c_<>~~pevoli e ~s~no essere immagazzinate. richiamate, manipolate,
nuu.hz~~e, cosL1~u_iscooo ci~ il ~ateriale su cui poggerà gran parte
dcli amv11A cogmllva superiore. l:. a questo livello che il sistema ha
bisogno di fare più economia. perch~ quanto più le informazioni percettive
saran_no ben org~nizzate, semplificate. ordinate. categori1..za1c, tan10
megho saranno ricordate, potranno essere richiamate ed utilizzate dal
pensiero, diventare oggetto di un discorso. componenti della comunicazione, e.- perc~é no - oggetto degli studi sulla percezione. Il processo
che Karuzsa chiama del «pensar~ e che va dis1in10 dal «vedere» interviene in quasi tuui gli aspetti della percezione consapevole; la fatica di
Kani7.s~ nel separare i due processi può essere conseguenza dcl fallo
cl_1e egh cer~ava di operare questa distinzione su esempi di percezione
g1à elaborati per essere adatli ad operazioni di più alto li\'ello. Porrebbe
essere questa anche la ragione della fortuna che hanno avuro e conlinua:
no ad avere I sostenitori della pcrcc1ione come processo completamente
o parzialmente inferenziale (Mili 1842, 1843; Hclmholtz 1867; Arnhcim
1954, 1969; Gregory 1966, 1970; Rock 1983. 1984; Diedcrman 1987).
5. Lo schema grafico di fig. 2 sintetizza quanlo dello finora.' La
logica souoslante a questo schema è quella della modularilà della mente
(Fodor 1983), mentre la metafora su cui si basa il suo funzionamento è
quella degli specchi semitrasparenti inclinali di 45°. Le lince sulla
sinlso:a ~i fig. 2 n!os~r~no le info~ma1ioni in cn1ra1a registrate dagli
orgaru d1 senso penfenca; esse raggiungono un processore che funziona
come uno specchio semitrasparenlc (SI), che lascia passare le linee
verso destra e, allo stesso tempo, le devia verso il basso. Le lince che
proseguono verso destra sono il risultalo di processi di riorganizzazione
e ristrullurazionc che approderanno al rendimento percettivo. Le linee
deviate verso il basso connuiscono ndl' elaboratore delle risposte motorie
veloci; sicuramente anche in questo caso si allivano dci processi di
riorganizzazione (penso soprattutto alla segregazione figura-sfondo e ai
completamenti), ma probabilmente vengono conservate anche molte
infom1azioni elemenrari e locali. Siccome, però, non so come vadano
veramente le cose a questo livello, la trasform37ionc è rappresentata
solo mediante un diverso spessore delle lince'. Tullo quanto avviene a
livello di SI, per esigenze di velocità, non è trasparente alla consapevolezza. RM rapprescn1a la risposta motoria. F..ssa si diparte in due: una
linea continua che va verso gli organi cffellori cd una linea trat1eggia1a
che porta qualche tipo di ioforma1ione al magazzino della memoria
1
Ci sono dci contribuH che hanno dislinto. all"interno della cogn i7Jone spaziale.
un~ componente _sensoi:notoria ed una cogmliva: Dridgcman. Kirch e Spcrling (1981 ),
Bndgeman. Lcw1s. lle11 e Nagle (1979). Paillard (1987).
227
V-
-..
.
-li
....-.. . .
-·----.--------------------,
_'-\
I
I
I
...····
I
l
:
I
·.
MLT
..'........
AM
~ .........1. motot11
····-··t
LT
Fro. 2. Schema delle reln1ioni fro percezione e lmaguy. Spiegazione nel testo .
motoria a lungo termine. li frutto dcl lavoro di organiz.zazione rx:rcettiva
primaria, preattcntlva, Incapsulata è rappresentato dalle lince onzzonlali che vanno verso l 'arca punteggiata a destra dcl granco, arca che
rappresenta la memoria di lavoro secondo il modello di Daddcley ( 1986);
tali linee sono In numero minore rispetto a quelle proven.ienU dalla
sinistra di SI, perch~ molle di quelle inrormazlonl elementari sono state
riorganizzate e hanno dato ori gine a nuove strutture. ad un tc.mpo più
semplici e più ricche (lince di diverso spesso~e). Le 1nrormaz1onl cosl
ristrutturate incontrano un altro specchio semitrasparente (S2), che~:
trcbbe corrispondere al «visoni buffer» di cui parla Kosslyn, su cui s1
disegna il rendimento pcrcellivo di cui l'osservatore è consapev0Ie1 •
Le lince che danno rorma al rendimento percettivo In parte vengono
lasciate passare da S2 e connuiscono nel vis110-~patial sket~/1 p_ad, cd in
parte vengono deviate verso il basso e connu1scono nell ar11co/atory
i Kosslyn (1980) in hase nd un'ampia serie di esperimenti hn pr~posto un modello
computazionale dcl sistema immnginntivo. Secondo questo modello al sistemo opererebbe
in base n regole proprie e il medium in cui si costituiscono le i~1mn~i?i ment~li è
definito come visual b11ffercd è cnrnttcrizzato dall'avere delle proprietà d1 tipo spaziale.
228
loop, in accordo con la teoria ddla «111c11m1 ia <.li larnrn» di Oaddclcy
( 1986). Questi due ulteriori processori selc1iona11n e riorganiuano
ulleriormentc le lnrormazioni ed infine le inviano al magnzino della
memoria a lungo termine (MLT) 1• La dire1lone delle frecce indica la
direzione obbligata dcl nusso di informazione che va <.lalla rcgisLra7ione sensoriale alla MLT; le frecce che vanno invece dalla MLT all'arca
della memoria di lavrn o e precisamente al 1•i.wo-.çpatial sketch pad e
ali' articolatory loop e che da questi ritornano al buffer visivo (S2)
schcmaUzzano il processo di formazione delle IM. Lo schema mostra
che l e IM possono essere ronnate solo ulilizzamlo il materiale gill
organizzato, strutturato cd cconnmil:amente sintctit.zato dai processi
situati dopo S2: il processo di forma7..ionc delle IM non può proseguire
retroattivamente fino a modificare o assistere a quanto avvi ene in SI. in
accordo con la constatazione che l e IM possono utili7.7are solo gli
oggetti renomenlci e non gli stimoli fisici (Massironi 1995). Come
abbiamo già detto, il bisogno di economia e di parsimonia cresce man
mano che ci si sposta dal processi primari a quelli secondari: questi
ullimi infalli operano su daLì via via sempre più organizzati in base a
regole precise che stabiliscono quall lnformnzioni possono andare perse
,
e quali devono essere conservale. Tre esempi :
I) a livello percellivo il colore è definito da tre dimensionJ: tonalità, saturazione e chiarcna. Il processo di ca1egorin:1zionc dci colori
opera invece solo in base alla tonalità (è infalli in base a questa dimensione che vengono dati i nomi ai colori);
O:iddelcy ha proposto un modclloJi memoria 3 hr.:\'c l~rnunc definita. •memoria
di lavoro• c he ha come compito il mantcnimc1110 e l' clJhora1ione temporanea
dcli' informa1i1111c. I.a •memoria di lavoro .. ha un:i ~lrullur:i i:ciarchica costituiln da un
•esecutivo centrale• che coordina un insieme Ji sottosistemi i più importanti dci quali
sono I' articolatory loop e il 1•is110-spatial skt:t('/i pnd. il p111no svolge il compilo di
mantenere e modificnrc l'infnmrniionc verhale mentre ìl sccom.lu opcrn sull'informazione
visuo-spazialc. Questo modello di memoria a breve termine prevede che esistano due
modi distinti di codifica dcll'inforrn:iJ:ìOnc in cnlratu (visivo e vcrbnlc) a cui
corrispondcrchhero due modi scpnrati di rapprcscn1a1ionc ~ia nella memoria a hrcvc
termine (Dnddclcy 1986) che in quella a lungo tea mine (rniviu 1971, Kosslyn 1981 ).
I due subsistcmi, pur indipendenti. sarchbcro olt:1111cnlc interconnessi per cui l'infor.
mazionc può essere trasferita molto facilmente dall"uno all"nllro Questo passaggio è
Slalo definito vis11al ruo1ltng o 1•ubal rcroding. Ciù vuol dare che J'esi~tcn1.a di un
primo stadio di codinca non preclude fo ricodifica visiva dcl mMcriale verbale o.
viceversa, la ricodifica vcrllalc del materiale visivo . TcncnJn conto delle opcr:11joni di
rccoding ho ritenuto opp()rtuno di non far coincidere. nel 11110 ~chema. il visua/ b11ffer
di Kosslyn con il vis110-spatinl sknrlr pad di Dntldclcy contrnrìnmcnte a quanto
sostenuto dalla maggior parte della lettcr:uurn sull" arg11mc1110 I nfnlli se il 1•is11al b11ffrr
è il medium in cui si costituiscono le immngini mentali
dal momen to che esse
possono essere attivate sia sulla scnrta di infornrn7.i1111i vi~ivc che di informazioni
verbali il visunl buffer deve trovarsi necessariamente In unn po~i1.ionc intermedia tra
- e quindi esterna ad entrnrnbi - i suhsis1cmi che codifica no l'111fomin1ionc in entrata.
/'articolntory loop e il 1•is110 -spa1ial sketrli pad.
1
229
2) gli oggelti della nostra esperienza sono dcfinili, a livello percettivo,
In base a molte caratteristiche quali forma, dimensione, orientamento,
ma la ca1egorl7.za1.lone, I' aurlbuzione delle etlchetle linguistiche a gran
parie degli oggetti, nel momento In cui ne abbiamo un'esperienza
pcrccttlva diretta, viene fatta quasi esclusivamente In base alla forma
(Landau, Smllh e Joncs 1988; Landau e Steker 1990; Levora10 e Masslronl
1991). Praticamente non esistono, se non In casi mollo particolari come
«microrganismo» o «cucciolo», concetti che raccolgano gli oggetti In
base ad esempio alla loro dimensione;
3) a livello percettivo riusciamo a distinguere egualmente bene
forme regolari cd irregolari, segmenti orientati secondo gli assi orizzontale/verticale o secondo altre Inclinazioni. In genere riusciamo a fare
delle valutazioni piuttosto accurate su tali aspetti quando possiamo
osservare direttamente gli stimoli, e soprauutto non sbagliamo se dobbiamo agire su di essi; ma se le stesse valutazioni le dobbiamo rare in
condizioni di memoria differita, cl rendiamo subilo conto che tali operazioni potranno essere svolte solo se gli stimoli sono regolari, simmetrici, semplici, se gli angoli sono ortogonali, I segmenti paralleli ecc.
(Goldmeier 1982). Mi sono dilungato nella descrizione dello schema di
ng. 2 perché sarà utile in seguilo per capire alcuni passaggi delicati
Inerenti alla produzione e all 'utilizzazione delle Immagini mentali.
6. Se quanto detto fino ad ora è verosimile, ne consegue che quando
la via seguita dal pensiero visivo nell'affrontare alcuni problemi è
panicolarmente breve ciò non vuol djre che sia anche la piil elegante e
produttiva, ma che sono presenti dei vincoli Imposti dalla limitatezza
delle risorse cognitive disponibili. A mio parere c'è una differenza sia
quantitativa che qualitativa fra Il modo In cui opera il processo primario, sui datl di sua pertinenza, e Il modo In cui operano i processi di piil
alto livello su dati che sembrano essere gli stessi - ma che di fallo non
lo sono. Non lo sono perché le uniche aperture che i processi di alto
livello, come Il pensiero. hanno per raccogliere le Informazioni esterne,
passano sempre cd inevitabilmente per Il sistema percelllvo, li quale,
nella fase primaria del processo, non può esimersi dall'elaborazione,
organizzazione e ristrutturazione del dati in entrata. Tale elaborazione
obbedisce a regole inevitabili, incapsulate, veloci e comuni a tutti ed è
solo sul risultato di queste operazioni che potranno operare I processi di
plil alto livello. Siccome non siamo consapevoli delle operazioni automatiche che il sistema percettivo compie sul dati sensoriali, è facile
pensare che esse consistano nella registrazione fedele dci dati stimolatori,
che potranno essere trasformati solo successivamente da operatori di
plil allo livello. Invece è ben noto che le cose vanno in maniera diversa:
lattività percettiva svolge operazioni molto complesse di riorganizzazione
dcl dati, e tali operazioni, In accordo con l'ipotesi della mente modulare
(Fodor 1983), sono impermeabili ad Interventi, Influenze e correzioni
230
da parie dci processi di piil alto livello quali pensiero, memoria. linguaggio. Se le cose stanno cosl, deve essere possibile trovare delle
situazioni che consentano di rare dci confronti diretti fra i due processi.
Solo quando, lavorando sullo stesso materiaJc sperimentale, pur adattato alle due procedure, verificheremo che il «vedere» e il «pensare»
divergono, approdando a rlsullatl differenti, avremo una prova della
loro Indipendenza. Se Invece viene esplorato solo uno dcl due ambill
Indipendentemente dall'altro, è facile che lo spcrlmcntnlorc, sulla base
delle sue Ipotesi e dcl materiale scelto, l'accia, come è spesso accaduto,
delle gencrall1.zazionl sulla sovrapponibilità dci due processi. L•ambiio
di ricerca a cui farò riferimento è quello delle immagini mentali (d'ora
in avanti IM). che costituisce una regione di confine iç cui convergono
aspetti della percezione, dcl pensiero, della mcmorltt;'un ambito ancora
in ebollizione e che si arricchisce conlinuamcn1e di nuovi contributi.
Prenderò In considerazione due punti che ricnt:ano in modo diverso In
quel terreno di discussione che riguarda I' ana!ogia fra i111ngery e pcrcei.ionc, oppure. che per certi versi è lo stesso. fra «pensare» e «vedere».
Credo infatti che la distinzione sostenuta <!a Kanilsa si possa estendere
agli studi sulle IM, in cui è altrellanto necessario distinguere con precisione, e separare con chiarezza, la percezione dall 'i111(1gery1, SI traila
infatli dello stesso tipo di problema, che porla allo stesso tipo di confusioni e di errori. Nelle pagine che seguono i due aspclli dcl «vedere vs.
pensare» e della «percezione vs. i111ngt'I)'» verranno traltati come una
cosa sola. Parlerò quindi dci risultati ollcnuti da due programmi di
ricerca. Il primo riguarda la rcintcrprclllhìlilà delle irnmagìni mentali e
la creati vità in ambito di im<1gery: a lalc proposito farò ri ferimento in
particolare ad alcuni lavori di Finkc ( 1989. 1990). Il secondo riguarda la
possibilità di ricavare melllahnente la strultura tridimensionale di un
oggcuo sulla base dell'osservazione frammentaria di alcune sue facce.
e riguarda quindi la possibilità di ricavare lnfonna1.ioni su parti dcli' oggetto mai osservate dlrctl amentc; In questo caso farò rifcrimen10 al
lavoro della Coopcr ( 1989, 199 1).
7. Non avendo condo110 le opportune verifiche sperimentali, ricorrerò ad un metodo non proprio ortodosso: quello di chiedere la collahorazionc dcl lellore, il quale dovrebbe assumersi l'onere di fare da soggello, per verificare mediante I' autosscrvazione se quanto andrò dicendo si rlncuc nella sua esperienza. SI tratta di un metodo che ~ stato
utilizzato da Kanizsa In numerose occasioni, sopra11u110 quando il materiale illustrativo era cosl autocvldcnlc da conscn1irc al lcllorc di osservare direttamente il fenomeno trattalo e perciò di comprendere e condividere le argomentazioni dell'autore. I lcllori diventavano I soggclll di
un esperimento che non aveva avuto bisogno di soggclli ad hoc, pcrch~
i risultati si ripetevano per ogni lellore e ad ogni rilc11ura. Anche Doni
(1989) ha so11olinca10 l'uti lilà e a volle addirillura la funzionalità
231
dcli' introspezione e dcli' autosscrvazione nella verifica dirella dì cerle
allività dì pensiero. Un po' tranquillizzalo su questo punto delicato,
vado a cominciare.
8. Una polemica che ha aoJmato li recente dìbattJto sulle lM riguarda la loro reinlerpretabililà. Accenno sintctlcamenle al terminJ dcl djbattlto solo per quanto riguarda quegli aspetll che possono essere uUll al
presente discorso. Nel 1985 Chambers e Reìsberg avevano verificato
che in modalilà immaginativa non si verificava l'Inversione di figure
ambigue del Upo oca-coruglio di Jastrow, e ne avevano trauo l'affrettala
conclusione che le IM non possono essere reinterpretate. Successivamente gli stessi autori (Chambers e Reisberg 1992), anche sulla scoria
dei risultati ottenuti da Drandimonte e Gerblno (1993), Drandimontc,
Hltch e Dlshop (1992a, 1992b), Hyman e Nelsser (1991), Peterson et al.
( 1992) hanno ridcfinilo e precisato la loro posizione. Nel frattempo
Finke e i suol collaboratori (Finkee Slaylon 1988; Finke, Pinkere Farah
1989; Finke 1989. 1990) avevano condollo una serie di esperimenti Lesi
da un lato a confutare le affermazlonJ di non-relnterpretabilità delle IM,
e dall'altro a dimostrare che nell'ambito dell'imagery è possibile trasformare, fondere. modificare, adattare mentalmente oggcLU o figure
immaginate In modo da ottenere nuove IM di figure e di oggetti creativi
ed lnauesl.
Descrivo l'esperimento di Finke e Slayton (1988) che costituisce Il
prototipo a cui si sono rifatti lutli I successivi esperimenti del programma di ricerca sulla imasery creativa. I soggetll dovevano dapprima
memorizzare certe figure geometriche semplici, linee e caratteri
alfanumerici (vedi fig. 3). All'inlzjo di ogni prova, gli sperimentatori
chiedevano al soggetto, che teneva gli occlù cWusl, dj rievocare Ire
degli e lementi memorizzati, ad esempio «quadrato, quadrato. numero
0110,.. Il compito consisteva nel costruire, montando mentalmente i tre
uva
è8
lellcra ..,y,.
numero «8•
cerchio
giradischi
g
cerchio
quadralo
rellangolo
a
decorazione per
l'albero di Natale
e
gil)CO dcl
croquet
)...mn
linea
lellara ,.J,.
cerchio
lcllcro •T•
lcllera .,p,.
numero ..g,.
casa
vollo sorridcnle
[j
c1uadrato
quadrato
triangolo
®
cerchio
lcllcra ..o..
numero .,3,.
.:
b
OD~
0D
I
LT C
T 8 X VP
Fm. 3. Parti usate negli esperimenti sulla sintesi mentale c.realiva. Le parti erano
ddlnite con i seguenti nomi: cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo, lettera
•D•, linea verticale, linea orizzontale, leuera •L•, lellera «T•. lellera «C•,
lellera «h, numero «8•, lellera ..x,., lettera «V•, lellera ,.p,. (da Finite e
Slayton 1988).
232
cono gelalo
bandiera
cerchio
lellcra ... v,.
lellcra «C»
linea
cerchio
quadralo
p
9
Fio. 4. Esempi di oggetti che sono stati classificati come non creativi (in a) e come
c reativi (in b). Sollo ogni disegno sono riportale le pani usate per la sintesi
mentale (da Finlce e Slayton 1988).
233
elementi, uno o più oggetti rlconoscibill. Le parti nominale dallo
sperimentatore potevano essere modi ncatc nel le dimensioni. nell' orientamento e nella posizione. ma non nella forma. Si richiedeva che l'oggeuo. risultalo della sintesi, fosse un oggello che un' alLra persona avrebbe
potuto riconoscere. Non c'erano oggelll-target previsli a priori dallo
sperimentatore, e In questo risiedeva uno degli aspetU c1l originalità dcl
compilo. li soggello aveva due mlnuU di tempo per svolgere la prova,
dopo di che doveva scrivere Il nome degli oggctll immaginati e poi
doveva disegnarli. Successivamente, un gruppo di giudici valutava sia
Il grado di corrispondenza fra disegni e definizioni , sia Il grado di
originalità dell'elaborato. Dai rlsultaU è emerso che I soggetti avevano
costruito mentalmente oggetti riconoscibili nel 40% delle prove, e che
fra queste Il 15% erano particolarmente creative (vedi fig. 4). Sulla base
di questi risultati gli autori sono glunll alla conclusione che I' imagery è
capace di sintetizzare cd esplorare combinazioni creative di parti , nno
ad ouencrc forme e pattern slgnilìcaUvi ed Imprevisti, in analogia con
quanto si riesce a fare con gli oggetti reali. Successivamente Finkc ha
utilizzato un diverso set di figure (Og. 5) per condurre un' a lira serie di
esperimenti sull a creatività nell' imagery (che egli ha definllo: «Invenzioni creative libere» e «vincolate»; «separazione fra sintesi creative cd
Interpretazioni»; «produzione di forme pre-lnventive mediante il gioco
combi natorio»; «posslbililà di scoprire, operando sulle forme pre-lnvenlivc, nuovi concelll e principi»). Ma ciò che interessa Il presente
discorso non riguarda i risultati ollcnuti da Flnke e dai suoi collaboratori, quanto piultos10 un'analisi del processi che si può pensare siano
alla base dell'esecuzione dei compiti proposti.
L'a11endibililà di un esperimento dipende dal grado di necessità che
lega le premesse al risultali. Nel gioco dell'esperimento, le premesse
sono Impersonale dalle variabili Indipendenti, le quali di solito sono
accettate senza essere sottoposte a critica, In quanto frullo della libera
scelta e della creati vità dello sperimentatore. Fra le companenti di una
variabile indipendente un ruolo fondamentale è giocato dal materiale
utilizzato. Il quale, se consente da un lato di rendere esplicito e verificabile
un problema, dati' altro nasconde altri problemi, che un diverso materiale avrebbe consentilo di mettere in luce.
La domanda che pongo è: in che misura I rlsultatl ottenuti da Flnkc
dipendono dal materiale utilizzato (vedi ngg. 3 e 5)? Gli esperimenti di
Finke fu nzionano perché il materiale che usa, le figure fatte memorizzare ai soggclli, rispetta del vi ncoli prcc i ~i, che sono:
I) le figure devono essere facilmente memorizzabili: devono infalll
possedere quelle carallcristiche di regolarità, di semplicità, di consuetudine (esempli fi cate dal caratteri alfanumerici) che consentono loro di
essere ricord ate In tulle le loro parti. Devono cioè sottoS1arc ai limiti di
economia Imposti al materiale visivo dal processi mnestici (Goldmclcr
1982);
234
o
?
~·
f io. 5. Parli usale da finkc negli espcrimenli sull'invernionc nelle lrnmagini menlali.
Le varie parli crono dcfinilc con i scgucnli nomi: sfera. semisfera, cubo, cpno,
cilindro. rilo mc1allico. lubo. quadralo piallo, mensola. blocco rcLLangolare.
uncino. ruote, croce, anello, maniglia (da finke 1990).
2) le figure devono essere univocamente dcfinilc da un 'cti ~hclla
verbale conosciuta o Imposta d allo sperimentatore in fase di apprendimento del materiale. Devono essere membri protolipicl di una specifica
categoria figurale. La categoria prescelta a questo scopo è quella delle
figure geometriche piane e regolari. Anche in questo caso le. figure
scelle obbediscono ad un principio di economia e di scmpllncazlonc.
che è quello che regola i processi di ca1egori1.zazione;
3) le figure devono essere accuratamente riproducibili in maniera
non ambigua. PolcM la variabile dipendente è il disegno dcll'oggcllosintesl Immaginato, in esso devono essere riconoscibili con certezza le
tre parti costituenti. Anche in questo caso il vincolo economico è quello
della semplicità, dal momento che le figure complesse non possono
essere né ricordate, né riprodotte in lulU i dettagli.
Dati questi vincoli , risulla evidente l'Impossibilità di replicare gli
esperimenti di Finke utilizzando il materiale ngurativo di flg. 6. Eppure, se pensiamo al tipo di prova previsto, qucst' ull i1110 malcrlaJe dovrcb·
be rendere il compilo più facile e quasi automatico. in accordo con le
osscrvvjoni di Teofraslo da lulli noi verificate dirctlamcnte. Teofraslo,
ripreso in molle occasioni cd in particolare da Leonardo'. proponeva
• •Non resterò di mellcre fra questi precetti una nuova i1wcn1iunc di spcculn1innc,
la quale, benché pala piccola e qua51 clcgna di riso, nnndimcno è di grande ulilitll a
dcslJlrc l'ingegno a vorie invenzioni. f: questa è 5c lu riguarderai in alcuni muri
im brall3li di varia m11cchic o in pietre di vari 111is1i ... potrai Il vedere simililudini di
diversi pncsi. ornali di monlogne. fiumi. sa5si, alberi, pianure grandi. valli e colli in
235
<
Fio. 6. Parti eh~ no~ potre.bbero essere usale in un espcrimenlo di sintesi rncnlale
perché dLffic1ll da ricordare e da descrivere.
come utile esercizio dcl vedere e dcll'lnven1are, quello di fermarsi ad
osservare nuvole, macchie di umJdltà sui muri, crepe sull' lnlonaco o sul
fango, per vedere il fonnarsi autonomo e quasi automatico di scene
diver~e. comrlicatc ed ina11ese, originali e produttrici di meraviglia.
. F1~ke cluedev.a ai suoi soggetti proprio di scoprire, mediante l a
s 1~t es1 mentale dt figure, oggelll sconosciuti, meglio se Jnallcsi ed
~ngin~ll. Se I' alll vilà di ima9ery riflettesse, Collie è stato soslenuto,
I a1Uv11à del percepire, l 'operazione di sintesi mentale dovrebbe essere
più facile con il materiale irregol are di ng. 6 che con quello delle figg.
3_ e 5, sopr~tlutto se si tiene presente che le figure possono essere
dilatale o ndollc, molale e spostate a piacimento. Ma le cose non
s~mbrano ~tar~ in q_uesto modo. Riandando allo schema di fig. 2, Je
n strul~ur:iz1on1 c~ns 1derate da Teofrasto e Leonardo si producono solo
s.u da~1 s~1111ola1 on provenlenU dall'esterno sintcllzzali e riorganizzall a
hvelh d1 SI: è un processo del «vedere» alimentato dalla continua
riorganizzazion~ pc~eeul va eh~ oper~ sul dato stimolatorlo e che poi si
conclud~ con I attnbuzl~ne d1 un s1gnlficato. Ma a quel punto, per
quanto riguarda l a percezione, li processo si è concluso nel rendimen10
fenomenico che potrà essere consegnato alle attività cognitive superiori
di~er~i m~i: anc?~a vi. poU:ai vedere dive~se baltaglic ed aui pronti d.i figure strane,
a_rie d1 volli ed a~11~ ed in fin.ile cose... Non 1sprcu.are questo mio parere nel quale ti si
ricorda che non Il sin grave il femia rti alcuna volta a vedere nelle macchie dc' muri, e
nella cenere del fu?co, ~ nuvoli o fanghi, od al tri simili luoghi, ne' quali, se ben
s~a~no ~a t~ con~1~crau, tu. lro~cral invenzioni, sl di componimenti di ballaglie,
d. a~tmal~ e d. u~r~m1, come d1 van componimenti di paesi e di cose mostruose, come
d1 diavoli e s1m1h cose• (Leonardo, Trai/aro della pirwra, par. 63).
236
e su cui l'attività percettiva non ritornerà. pcrd16 deve essere pronta a
passare ad una nuova organizzazione di dati. I .'opurn1iom.: tli sintesi
Immaginali va prevista da Finke è diversa ri spello alla sintesi dcriva111e
dall'organizzazione percelli va. Le operazioni di sintesi I mmagln:Hiva si
producono nella parte destra dello schema di lìg. 2: il materiale utili7.zabile è sol o quello molto semplificato e rigidamente strutturato dalle
regole di codinca, che ne permettono l'immaga7.7.inarnento nella MLT
e l a manipQl azlonc da parte dcl pensiero. La tlifferenza rra i due tipi di
oper azioni emerge anche dall'esame introspctlivo dcl diverso grado di
difficoltà che si incontra nell'esecuzione dci tluc compili. Quello di
osservazi one delle nuvole è facile, automatico, adtlirittura tlivcrtcnte cd
i risultali sl impongono In huon numero con facilità e «naturalezza».
Quello proposto da Finkc è faticoso, lento, volontario. prevede un
notevole impegno attenlivo e i risultati sono poco numerosi. Le regole
che presiedono allo svol gersi dcl lavoro di sintesi immaginativa non
sono l e stesse che operano nella sintesi pcrccllìva. Nel primo 'aso il
lavoro di sintesi può avvenire solo nelle condizioni di stre11a economia
dettale dalle esigenze di alto livello e che Il materiale di finke rispcua.
Nel secondo caso la sintesi si compie in presenza di una sovrabbondanza
di infonnazioni, che an7.i il lavoro di sin1csi ~ preposto a ridurre e a
coagulare. Non avendo (come già dello) dci dati sperimentali ad hoc,
propongo tre esercizi, eseguendo i quali ogni lettore dovrebbe verincare,
mediante un po' di autosservazionc, l a differenza fra sinlesi pcrcelliva
e sintesi immaginali va, o fra «vedere» e «pensare». I compili, simili fra
loro, saranno paralleli, cio~ condotti separatamente nelle due modalilà.
Esercizio 1. Tenendo coperta la parte destra di lìg. 7, si osservi e si
memorizzi l a parte sinistra (a), costituita da un ghirigoro generato da
una traccia casuale curvilinea che si chiuuc su se stessa. Successivamente, tenendo coperta l a parte sinistra di fig. 7. si memorizzi la parte
destra (b) costìtui ta da un piccolo triangolo equilatero e da un cerchietto
posto sulla prosecuzione dcl lato superiore dcl triangolo stesso. Con gli
occhi chiusi sl sommino, in modalità immaginativa, le due fi gure in
modo che il Lriangolo equila1cro si a tangente con il suo la10 di sinistra
ad un punto qualunque del contorno esterno dcl ghiri goro, cd in modo
che il cerchietto cada invece al suo interno.
o
C>
b
Fto. 7. Materiale dell'esercizio t. Splega7.ionc nel testo.
237
a
1'10. 8. Risultali della sintesi percelllva. SI vedono due uccelli differenti: ciò~ dovuto
al diverso modo con cui le parli di fig . 7a e 7b sono accostale.
1'10. IO. Lo stes~o effetto della figura precedente si produce 311chc usando ghirigori
rettilinei.
1'10. 9. Esempi di ghirigori (in alto) che diventano il corpo di uccelli quando vengono
associati al triangolo e al cerchio di fig. 7b (al centro): gli uccelli appaiono
avere un corpo diverso quando c.mbia la posizione di triangolo e cerchio (io
basso).
Qual è la ngura che ne risulta? Tutte le persone che In maniera
Informale ho so11opos10 a quesla prova hanno dichiarato trattarsi di una
fi gura senza significato, risultato della somma delle due conngurazionj
date. Ora, se facciamo la stessa opcra1Jone In modalità percettiva vedremo
apparire la fi gura di un uccello (vedi ng. 8a). Se si prova a far aderire il
triangolino in punti diversi del contorno dcl ghirigoro, non solo cambia
238
Il tipo di uccello che si vede, ma appare addirlllura modi ncala e diversa
la forma dcl ghirigoro (vedi fi g. 8b). In ng. 9 sono mostrali altri casi
divertenti dello stesso tipo (nella riga In allo sono disegnale le figure
semplici, nella seconda e terza riga le fi gure di sintesi).
Si può notare inollrc che l'evento si compie non solo con forme
casuali avcnli contorni arrotondali, ma anche con forme casuali avcnli
contorni rcllilinci (fig. 1O). Questo esempio mostra che la pcrcc1.ione, In
maniera Involontaria cd automatica, ricava (come ncll'eserciiio di
Teofrasto-Leonardo) nuovi cd inallesi significali anche da fonne complesse, irregolari e sconosciute; cosa che I' imagery non riesce a fare.
L'imagery può operare solo con forme conosciute in quanto presenti
nella memoria a lungo tem1inc o caricale di recente in quella a breve
termine, cd I nuovi significati debbon() essere ricercati in maniera
attenti va mente mirata, volontaria cd impegnali va.
239
a
b
[
flm. 11. Materiale dell'esercizio 2. Spiegazione nel testo.
Esercizio 2. Si osservi e si memorizzi, tenendo coperta la parte
destra di fig. 11, la configurazione costituita da un poligono biconcavo
avente un segmento vcrUcale ali' Interno della concavità di sinistra (n g.
11 a).
Successivamente, tenendo coperta la parte sinistra della stessa figura, si memorizzi la configurazione sulla destra costituita da Ire segmenl I
fra loro ortogonali in forma di «C• (Og. 11b). Il compito consiste nel
meuere Insieme mentalmente, secondo le Istruzioni che seguono, le
parti «a• e «b• di flg . 11 , prestando attenzione, sempre mentalmente, al
reltangolo compreso fra il segmento verticale e la parte Interna della
concavità di sinistra di figura 11 a, che chiameremo «rettangolo critico».
SI chìcdc di verificare se, e In che maniera, al mutare della sintesi
mentale conseguente al mutare delle Istruzioni, mutano anche le caratteristiche fenomeniche del reltangolo critico. Mutamento fenomenico
vuol dire In questo caso che la superficie dcl rettangolo critico può
apparire come parte dello sfondo su cui giace Il poligono biconcavo,
oppure come parte di una figura fenomenlcamente Interposta fra Il
poligono biconcavo e lo sfondo. Potremmo dire che nel primo caso Il
rettangolo critico è «vuoto•, mentre nel secondo caso è «pieno•. Il
senso fenomenico di tali termini è ben esemplificato In fig. 12, che
potrebbe costituire una tavola per l'addestramento degli Ipotetici soggetll di questo esperimento.
Le situai.ioni da valutare sono le seguenti :
a) accostare la «C» di fig. 11 balla sinistra dcl poligono di fig. 11 a
In modo che gli estremi dei due segmenti liberi orizzontali tocchino i
due denti, superiore cd Inferiore, dcl poligono biconcavo. Stabilire se il
rettangolo critico è e<pieno» o «vuoto•;
b) accostare la «C» alla destra del poligono In modo che gli estremi
dci due segmenti li beri orizzontali tocchino I due denti superiore ed
Inferiore dcl poligono biconcavo. Stabilire se li rettangolo critico è
«pieno» o «VUOIO»;
240
pica
fio. 12. :r avola di addestramento per l'esercizio 2. Serve per chiarire cosa si deve
mtcndcre per .. vuoto• e •pieno•.
e) accostare una «C» alla sinistra del poligono come specificato al
pu~to a), cd un'altr~ «C», speculare alla prima, alla destra dello slesso
poh ~ono come spcc1ncato al punio b). Stabi lire se il rcllangolo crit ico
~
«pieno» o «VUOLO»;
d).due «C» devon~ essere accos1ate - sempre con i segmenti liberi
- la pnma al lato supcnor.e e ~a ~cco~da al lato inferiore del poligono, in
modo c he~ segmenti vcr11ca1J d1 sinistra di entrambe siano allineali con
li I.alo verllcalc dcl rcuangolo critico. Sta bilire se il rcllangolo critico~
«pieno» o «Vuoto»;
241
e) tre «C» accos1:11e una a sinistra, una sopra e una sollo al poligono
in accordo con te istruzioni n) e tf). Stabilire se il rellangolo criti co è
«pieno» o «VUOtO».
Ritengo che la maggior parte dci soggelli souoposti a queste prove
riferirebbero di non aver ril evalo nessun cambiamcn10 nell'apparenza
fenomenica dell'arca considerala; oppure fornirebbero risposte casuali,
non corri spondenli a quanto si verifica, in maniera coercitiva, nei disegni
che presentano il risultato delle operazioni di sintesi proposte (vedi fig.
13). È facile per tulU constatare che In questo caso il rcltangolo critico
muta il suo aspclto fenomenico passando alternativamente dal «vuoto»
al «pieno» dopo ogni operazione; ciò accade nonostante che, dal punlo
di vista fisico, niente lnlervenga a modificarlo. Questo esercizio costituisce una prova del fatto che, nelle slnlesl immaginative, non possono
aver luogo i co111pl e1amenli e l e uninca1ioni amodali allo stesso modo
dl quanto avviene in percezione.
Esercizio 3. Questo esercl1io conslsle in una 1rascrizionc per imagery
di un classico esperimento di Uuncker ( 1929) sul movimento iodouo;
quindi dovrehbcro eseguire qucsla prova solo soggclll che non conoscano
Il fenomeno. Confido che i lellori che Invece lo conoscono vogliano
collaborare ugualmente, assumendo un a11cggiamcn10 il più possibile
ingenuo'.
Si osservi e si mc111orlz1l prima la cornice sulla sinistra di lig. 14. e
successivamente Il cerchlelto sulla des1ra della stessa ligura. Con gli
occhi chiusi si immagini di inserire il ccrchicllo al centro della cornice,
poi di far scorrere la sola cornice verso destra di qualche cen1imetro; il
soggeuo deve dire se, mentre si compie questa tral:formazione mentale,
egli nola qualche modificazione a carico dcl cerchietlo .
•
Fio. 14. Materiale dell'cscrciiio ). Spicga7.ione nel lesto.
Fro. 13. Configurazioni risultanti dalle sintesi descritte nelle istruiionl dell'esercizio
2 . li «rellangolo critico• appare alternativamenlc «Vuo to» e cpieno».
Spiega1Jone nel testo.
242
' Si parla di ~movimento indulto• in quei ca~i in cui appare fenomenicamente in
movimento la parte dello si imo lo che fisicamcnle sia fcnna e viceversa appare immohile
ciò che si muove nella realtà fisica. Duncker ( 1929) presenti> un caso esemplare di
movimento indollo che fun1.iona in quc~tu modo, in un nrnhicnlc huio è mostralo un
rettangolo luminoso ul cui interno si trova un ccrchicuo onch 'c.~so luminoso. quando si
sposta lentamente il rettangolo e si mantiene fenno il cerchicllo si vede il ccrchiello
muoversi in direzione opposta a quella dcl rellongolo che appare invece immobile.
243
Se il soggc110 non conosce i risultati di Ouncker e non inferisce la
solu1ionc fenomenica, non dovrebbe notare nessuno spostamento. In
contrasto con quanto accade In percezione. L ' andamento delle frecce
nell a parte destra dello schema di fig. 2 mostra Il perché di questo
ri sultato. Le Immagini mentali sono prodotte da Informazioni già presenti in MLT o nella memoria di lavoro, che si costituiscono In S2, ma
non possono ollrcpassarlo per attivare dall'interno SI. Se le Informazioni su cui si basa la costruzione della IM sono che Il movimento appartiene alla cornice, esso rimane un attributo della cornlce, che non può
essere trasferil o al cerchiello. Le cose vanno invece diversamente a
livello percclt i vo: r informazione arriva solo dall'esterno e viene eiabo·
rata in base a processi speci fici, nascosti, come dice Culling (1991),
nella nostra dotazione biologica. Il risultalo è Incapsulato perché deve
essere veloce, e segue un cammino obbligato che l'allività Immaginati·
va non può arrivare a percorrere o ripercorrere.
I tre cserci1i appena svolii hanno mostrato, anche se non dimostrato,
l'csis1en1a di alcune diffcren7.e soslani.iali fra reintcrpretabilità pcrcctliva
e reinterpre1abilil à immagi nativa: r) In percezione il materiale oggetto
di reinterpreta1.lone può essere notevolmente pili complesso che In
imagery; ii) la percezione ra ggiunge i suoi rlsul11111 In maniera automatka e veloce. mentre I' imflRery procede in maniera necessariamente
volontaria e l enta; iii) i risultali delle reinterpretazioni percettive sono
sostan1ialmcnte gli stessi per tutti i soggetti e dipendono da quel segmento di dotazione genetica condivisa che codinca le regol e con cui
vengono elaborati i dall :;ensoriall grezzi; le reinterpretazioni immaginat ive sono Invece sempre differenti fra i diversi soggetti, In quanto
dipendono dalle diverse esperienze individuali, dal diverso patrimonio
mnestico e dalle diverse dotazioni mentali; iv) nelle rcintcpretazlonl
percelli ve si verilicano del fcnomcnJ peculiari. quali il completamento
amodalc e il movimento Indotto ma sicuramente anche altri, che non si
vcrilicano nelle rei ntcrprcta7.ionl immaginative; v) in imagery i vincoli
di economia che determinano la quantità e la qualità dcl materiale
1ra11ato sono molto pii) ri gidi che in perce7.ionc. Possiamo per ora
concludere che I termini ~rei nterpretabililà» e «rcinterprclaz.ione» assumono significati diversi nelle due modalità, dal momento che presuppongono processi e ri sultali diversi; diventa allora compito dell' indagine empirica precisare gli aspetti di tale differenza. Non è difficile,
scorrendo l a letteratura sulla percezione e quella sulle IM, trovare altri
risultati che opportunamente ripensati possano di ventare dci compiti
utili a dimostrare che l'i11wgery approda a ri sultali diversi dalla percezione. Ouoni candidali per questo scopo sono i fenomeni di contrasto
cromatico: la perdila di regolarità di un esagono a seguito della presenza
di triangoli neri sui vertici, come mostrato da Gerbino ( 1978); il modi·
licarsi dell'orientamento di triangoli equilateri per cffcllo dell'Inclinazi one di un rettangol o includente, Individuato da Palmer (1989), Palmer
244
e Oucher ( 1981). Il problema ddla reinterp1e1ahili1l\ delle IM, rhistn
alla luce della di l fercn1a fra <(vedere» e «pensare•>, conlrihuisce a chiarire la differen7.a fra i due tipi di processo. Anche quando i risultali dcl
«vedere» sembrano sovrapporsi u coincidere con quelli dcl «pensare» si
tratta di coincidenze fittizi e, contrariamente a quanto ~ stato spesso
sostenuto da un buon numero di studiosi di immagini mentali. Per poter
discriminare con accuratezza le sottili ma precise differen7c fra percezione e imngery. o fra «vedere,. e «pensare». i! necessario trovare dci
compili che consentano dci confronti dirclli fra i risultali ollcnuli nelle
due modalità.
9. Un altro modo di utilizzare la distinzione fra «vedere)) e «pensare» è quello di controllare se cl l'ellivamente I ' imaguy l avori come l a
percezione e possa quindi avere una fun7.ione vicariante o surrogatoria
dcll 'a1U vi1à percettiva, o se invece le IM siano uno strumento dcl pensiero, un tool opera1.ionale, che rispetta l e regole di parsimonia dcl
pensiero seguendo i pen.:orsi piì1 hrcvi e 111c110 i111pcµ11a1ivi. seni.a rare
sror7i inutili .e non richiesti, come sarebbero quelli necessari a mimare
l 'attività percettiva. Vi sono ricerche l ese a sostenere quest'ultimo
punto: è il caso di alcuni lavor i di L ynn Coopcr ( 1989. 199 1,) che
prenderò in considerazione nelle prossime pagine per solloporli ad una
critica si stematica. Il mio punto di parten.1.a è che t 'imllgery, e cioè il
pensiero impegnalo a risolvere un problema di n~11ura visi va, non produrrà certe IM se queste comportano un aumento dcl costo cogniti vo e
dcl rischio cli insuccesso. anche se il produrre quel li po di IM consentirebbe di supportare l 'ipotesi di una con1inui1à e bi1.lire1.ionalilà delle vie
che collegano I' imagery alla pcrce7.ionc.
Ln Coopcr ( 1988. 1989) ha uliliz.7.alo un metodo di studio delle IM
particol armente Ingegnoso e che. al di là dci ri sultali ollcnuti nei suoi
esperimenti, costituisce un malcriale utile per co111prenderc l e procedure seguite dal pensiero vi sivo ne li' affrontare i prohlcmi. Lo scopo della
ricerca a cui facciamo riferimento era quello di indagare la nostra
capacità di riconoscere oggetti nel loro insieme anche se. come spesso
avviene nella vita di tutU i giorni. abbiamo avuto occasione di osservarli
solo in maniera frammcnt:iria cd incompleta. Ai soggc111 erano fornite
solo informazi oni par.1.iali circa la strullura di un oggcllo sconosciuto;
in seguito veniva l oro richiesto di dare giudi.1.i cd operare confronti
relativi ad aspelli dell'oggetto che non erano esplicitamente contenuti
nelle informa1ioni fornilc. Non entrerò nel mcrilo dci risullati ollcnuti
dalla Cooper per quanto ri guarda il ruolo giocato dalle IM nei suoi
esperimenti, ma utilizzerò in maniera parassitaria sia il suo materiale
che i suoi ri sul tali per portare avanti il discorso che mi interessa sul
pensiero visivo e le sue economie. Non avendo fallo gl i esperimenti
necessari a provare ciò che Intendo sostenere. devo ulili7.zarc. ancora
una volta, il discutibile metodo di i !lustrare la mia cspc1lenza introspettiva
245
Di:ipositiva I: Due proiezioni ortogonali
[O]
a
[]0
Pinnla
Lulo
a
CDJO
Pronte
Oiaposiliva 2: Tena proiezione orlogonale
D
[2J
Risposta
errala
o
b
Risposi.a
corre Ila
b
Asson ometria dcl
solido corretto
Assonomclria dcl
dislrnllorc
Fio. I S. l!sempio di materiale per il compilo di «Compatibili là ortografica.. Spiegazione
nel teslo (da Coopcr 1989).
Fio. 16. l!sempio di nwlcriulc per il compilo tli .. riconosci111e1110 assonometrico,..
Spiegazione nel testo (da Cooper 1989).
di ipotetico soggetto sperimentale. Chiedo al lettore di fare altrettanto e
di verificare se i suoi risultati corrispondono a quelll che andrò esponendo.
Il primo compilo previsto dalla Coopcr era un compito di problem
solving definito di compatibilittl ortografica: ai soggetti (studenti di
ingegneria a conoscenza delle regole e delle procedure della geometria
descrittiva) venivano mostrate due figure (vedi fig. 15a) che raffiguravano le proiezioni ortogonali, bidimensionali della faccia superiore e di
quella frontale di un oggetto tridimensionale; sulla destra c'era un
quadrato vuoto che fungeva da contenitore della proiezione della terza
faccia. Il compilo consisteva nel decidere quale di due figure, mostrate
subilo dopo le prime, era la proiezione ortogonale corretta del fianco
dello stesso oggetto (vedi ng. 15b).
A questo primo compito ne seguiva un altro di rico11oscime1110
i11cide11tale, in cui veniva chiesto ai soggetti di decidere quale fra le
rappresentazioni assonometriche di due oggetti (l'oggetto target e un
distrattore, vedi lig. 16b) corrispondesse all'oggetto presentato nella
prova di pro/Jlem solving. L' ipotesi della Cooper era che n secondo
compito poteva essere svolto solo se, durante lo svolgimento del primo,
il soggetto avesse costruito una sorta di modello mentale tridimensiona-
246
le (d'ora in avanti, 30) dell'oggetto considerato. Pér risolvere il problema di compatibilità ortografica è necessario manipolare mentalmente
le immagini stimolo al fine di decidere, dopo una serie di confronti
incrociali , quale delle due soluzioni proposte dallo sperimentatore sia
quella corretta. Se ci mclllamo negli scomodi panni di uno dei soggetti
della Cooper e proviamo ad affrontare qualcuno di questi problemi, la
prima conclusione a cui arriviamo è che il compito è piuttosto difficile.
Tale difficoltà emerge, oltre che dalla nostra autosservazione, anche da
altre eviden7.e: a) gli sperimenlalori hanno dovuto ricorrere a soggclli
esperti (si udenti di ingegneria); /J) nonostante ciò, il grndo di accuratezza nelle risposte non è stato altissimo (76,5%): e) il tempo di latenza
medio per la decisione è staio di 45 scc. Sorge allora spontanea la
domanda: perché questo compito è difficile? Si traila in fondo di aggregare alcune parti piuttosto semplici in un'unica struttura.. È un lavoro
che sembra andare nella stessa direzione di molti processi cognitivi.
dalla perce1.ione alla categorizzazione. che tendono a meuere insieme
parti. dapprima separate, in unii:\ org::mizza1c: ma. come vedremo, non
si traila di processi di aggregai' inne dello stesso tipo. Prima di proporre
247
·.
una risposta al quesito consideriamo il problema opposto, quello cioè di
ricavare le proiezioni ortogonali partendo dall'oggelto 30: constatiamo
subito che questo problema, a parità di complessità dell'oggetto, è
molto pili facile. Dato un oggeuo unitario 3D (prendiamo ad esempio
uno di quelli della figura I Gb), è abbastanza agevole, in modalità Immaginativa, spostare il nostro punto di osservazione in modo che si venga
a trovare di volta in volta ortogonale alle facce che cl Interessano e
ricavarne l e viste ortogranche bidimensionali (d'ora in avanti, 20). Ma
una volta operato, in maniera abbastanza naturale, questo smontaggio,
li percorso inverso, quello di rimontare le varie viste 20, per esempio
quelle di ng. I 6a, in un unico oggetto 30 diventa Innaturale e fallcoso.
Esaminerò dapprima due ordini di ragioni che contribuiscono a
spiegare questa difficoltà, e poi in base a tali analisi sosterrò che Il
procedere dcl pensiero visivo nell'affrontare il compito non può essere
quello previsto dalla Cooper.
La prima ragione di difficoltà dipende dal fatto che un oggello
osservato dire11amcnte fornisce, ad ogni spostamento dell'osservatore,
un flusso continuo di informazioni concatenate le une alle altre, a volte
ritlondanti, per cui è facile sceglierne alcune (le proiezioni delle varie
facce) e trascurarne altre. Un numero finito di viste ortografiche invece,
anche se teoricamente esauriente per ricavarne l'oggcllo 30, fornisce al
sistema pcrce1tivo delle informazioni discontinue, che devono essere
rimontate integrando le parti visive che mancano. Ma non è questa la
difficoltà maggiore; ve ne è un'altra, che consiste nell'accorpare I
differcnU punli di vista da cuj sono slatc proiettale le diverse facce in un
nuovo, u1ùco punto tli vista che osservi l'oggetto nel suo Insieme 30. n
sistema dovrebbe caricare le viste 20 delle varie facce e poi ruotare
opportunamente, ma in maniera diversa. ognuna di esse fino al momento in cui i diversi punti di proiezione in base ai quali sono state ricavate
le viste 20 collassano nell'unico punto da cui sarà visto l 'oggetto 3D
nel suo insieme. Se l e facce sono tre, il nuovo punto di vista si troverà
lungo la traiclloria dcli' asse uscente dal vertice costituito dal punto di
incontro delle tre facce rivolte verso l'osservatore.
La seconda ragione di diflìcoltà dipende dal fatto che non vi è
corrispondenza biunivoca fra oggello 30 e rappresentazione ortografica
(2D) delle sue facce. Ciò vuol dire che se partiamo dall'oggetto 3D c'è
sempre una corrispondenza uno a uno fra ciascuna delle sue facce e le
corrispondenti proiezioni ortogonali , ma che se partiamo dalla rappresentazione ortogonale 20 di una faccia la sua corrispontlenza con una
struttura 30 è dcl tipo uno a molli, nel senso che vi può essere pili di una
struttura 30 che è corret1amente rappresentata da quella vi sta ortogonal e. Per chiarire questo punto consideriamo i tre solidi di fig. 17. È facile
verificare che la faccia anteriore dcl solido A è rappresentata in proiezioni ortografiche solo tramite il rettangolo r; ma anche la faccia anteriore dei solidi 13 e C può essere rappresentata sol o dal rettangolo r;
248
____,.
--
'
,,
n
J}
J
D
~'
('
D
r
h.
q
t..
'il
fio. 17. Alcu ni solidi diversi (in alto) le cui proiezioni ortogonali di pianta (q) e
prospeuo (r) sono invece uguali.
'
~
Y/,.,.11/
quindi se parliamo dai solidi c·~ un solo motlo per rappresentare la loro
faccia anteriore. ma se partiamo dal rettangolo esso può corrispondere,
secondo le regole delle proiezi oni ortogonali, a molte facce diverse di
oggclli 30. Allo stesso modo, il rettangolo piccolo q può rappresentare
la pianta di tutli e tre i solidi A, 13 e C: quindi se ad un soggetto sono
fornite solo le due visle ortograliche r e q egli 11011 può ricavarne
univocamente la terza faccia. Il granco di ng. 18 schematizza quanto
dello Cinora: l'ovale 30 mostra l 'insieme di tutte le facce degli oggetti
tridimensionali, mentre l'ovale 20 mostra l'insieme délle rappresentazi oni bidimensionali delle singole racce degli oggetti secondo le regole
delle proiezioni ortogonali.
l'io. 18. Schema delle corri~ponde111,c possihili fra solidi lridi111c11sio11ali (a sinistra) e
le proiezioni ortogonali delle loro facce (n destra). Spicgnione nel lesto.
249
\
D
[2J
\
Fro. 19. Esempi di solu1ioni altema tivc, lutlc corrette, del problema di •COmpatibilitl
orlogranca. di ng. 151.
Fio. 20. Esempi di solu1,ionl alternative. tulle corrcuc, dcl prohlcrna di • compalihllitll
ortografica• di fig. I 6a.
Come si può vedere, a ci ascuna faccia A, D, C, ... degli oggelll 30
corrisponde una ed una sola rappresentazione a, b. r, mentre alla proiezi one 20 a possono corrispondere mollepllcl facce diverse A, E. L ... di
oggetti tridimensionali, perché uno spigolo Inclinato o curvilineo non
può essere definilo da una sola vista se questa è ortogonale al plano su
cui giace la linea curva o inclinata. Sono queste le ragioni per cui, per
definire completamente un oggetto tridimensionale, occorrono almeno
tre vi ste ortografiche, applicando però l'accorgimento che consente di
mostrare gli spigoli occlusi mediante linee tratteggiate. Ma questa è
anche la ragione che rende cosl sbilanciato il carico cognitivo a seconda
che si proceda dall'oggetto alle sue r appresentazioni o viceversa.
Sulla base di queste considerazioni passiamo ad esami nare due dci
problemi proposti dalla Cooper.
Primo problema. ln llg. I 5a sono mostrate l e due viste ortograllche
(pianta e prospetto) dell'oggello problema; in fi g. 15b sono mostrate le
due soluzioni fra cui scegliere quella corrella, corri spondente alla terza
faccia dello stesso oggclto. È facile constatare che oltre a quella propo·
sta vi possono essere numerose altre ligure correue. In fig. 19 sono
mostrate allre cinque solu1i oni dcl problema, tulle compatibili con le
viste ortografiche di lig. 15a.
Secondo problema. I n fig. l 6a sono mostrate sulla sinistra la pianta
e il fronte dell'oggcllo, sulla destra l a soluzione corrclla. I n lig. 20 sono
mostrate alcune delle soluzioni alternative compatibili con le viste
ortografiche di lìg. I 6a. Tenendo conto di quanto fin qui esposto,
ritengo che l'esecu1.ionc dcl compil o non avvenga prima costruendo
l ' l M dell 'oggetto 3D, come ipotizzato dalla Coopcr, poi osservando con
l 'occhio della mente l a tcr1a faccia inferita, ed infine confrontando il
ri sultato con le soluzioni proposte.
250
La Cooper ( 1989. 96) afferma: (<For thc 111ajorily of 1hc problems,
U1e thrce-dimcnsional object corresponding 10 the ori hographics prescn1cd
was uniqucly de1er111incd frorn U1e lwo in ili al orlhographic views. given
lhc constraints of the task cnvironmenb>. Fra l e ngurc che illustrano
l 'articolo non cc n'è nessuna che sia univocamen1c determinala dalle
due viste ortografiche iniziali, a meno che la prccisa1ionc «givcn U1c
constrai111s or the task cnvironment» non solli ntcnda che si richiedeva la
soluzi one più semplice possibile fra quelle compalibili, o che si pensava
che in ogni modo l a solu1ione preferita sarebbe s1a1a certamente la più
semplice. I n questi casi, però, sarebbe staia necessaria una definizione
di semplicltil; che d' allrondc non avrebbe cl i 111i nato le di rncollà i ncrenli
alla costrutionc dcli' I M dell'oggetto 30. Tali di I ncollll possono essere
ri assunte in quallro punii :
I ) dover far convergere I punii di visla rcla1ivi alle tre facce in un
unico punto di vislo rclalivo all'intero oggetto 3D;
2) dover procedere, per passare dalla proiezione 20 all 'oggcuo 30.
nella direzione uno-1110111, come spiegato in precedenza, e quindi dover
affron1are un percorso in salila;
. . 3) rischiar~ di elaborare una terza faccia corrella in quanto compaL1b1le con le prnnc due. ma non compalibile con la soluzione proposta
(come mostr:uo nelle figure 19 e 20);
4) dover manipolare un tipo di i nformazione v1s1vamentc e
cognitivamcnle ambigua quale è quella fornita dalle lince tratteggiale,
quelle che rapprcscntnno gli spigoli occlusi in quella vista. La possibilìtà di utilizzare questo I ipo cli informazioni presupporrebbe che dapprima I ' imagery costi uisca un solido trasparente.
25 1
Per 1ali ragioni, penso che non solo la solu7ione non venga trovata
mcdianle la produzione dcll' IM dcll'oggc110 30, ma che, anche dopo
l ' individuazione della terza faccia, l'oggetto mentale 30 non sia ancora
costituito.
A mio avviso le cose dovrebbero andare in un altro modo. Illustro la
sequenza dcl passaggi facendo riferimento al problema di Og. 15.
I) Vengono memorizzate le due viste ortografiche iniziali (fig.
15a). tenendo conio che quella superiore è la vista dall 'alto e quella
inferiore è l a vista frontale dell'oggetto.
2) Comi ncia l 'osservazione delle due possibili soluzioni proposte
dallo sperimentatore (lìg. 15b). Si rendono disponibili in tal modo due
fonti di informazione complementari : l a figura corretta e quella errata.
3) Più che tentare di costruire una sintesi tridimensionale delle tre
viste, viene smontato ìl problema complessivo in souoproblcmi parziali: ciò avviene partendo dalle figure disp(rnibili in quel momento (vedi
ng. 15b) e verilieando, linea per linea, sia le corrispondenze corrette
che quelle errate, in quanto informative entrambe, fra le linee presen!I
nelle soluzioni proposte e quelle presenti nelle viste 20 Iniziali.
4) Se la verifica ha inizio dal disegno a sinistra di fig. 15b, si noterà
presto che la linea trallcgglala presenla un angolo concavo. 11 vertice di
tale angolo indica che nel solido, a due terzi dcll'allezza, vi è uno
spigolo che dovrebbe essere i ndlcato mediante una linea orizzontale nel
prospello dcl solido. vale a dire nel rettangolo centrale del disegno a
sinistra In basso di fi g. 15a; ma dal momento che tale lìnea non c'è, si
giunge alla conclusione che quella è la soluzione sbagliata e quindi che
l'altra è quella giusta. La via ora descritta appare la più breve, pcrch~
richiede l'utilizzazione e la manipolazione mentale di un numero minore di Informazioni, richiede un numero minore di operazioni, comporta
un minor rischio inteso come possibilità di produrre soluzioni corrette,
ma Inutili in quanti diverse da quella proposta. Anche la seconda parte,
quella cruciale. dell'esperimento della Coopcr ci può aiutare a sostenere
che le cose vanno nel modo appena descrillo. Come si ricorderà, la
procedura sperimentale prevedeva che i soggelli, dopo aver .svolto ~I
compilo di compatibilità ortografica. affrontassero quello di rico11osc1me1110 i11ciclc11tale. All'inizio di tale prova veniva presentata ai soggetli
una diapositiva che mos1rava le rappresentazioni assonometriche (30)
di due oggclti, uno dci quali era l'oggcllo trattato anche nel compito di
compatibilità ortografica. mentre li secondo era un distrattore che condivi deva solo alcuni aspetti dcl primo (vedi fig. 16b). li numero di
ri sposte correlle è stato dcl 90%. Anche in questo caso non credo che il
soggello confronti l'IM <lcll'oggcuo 3D, ipoteticamente prodotta durante l a solu7.ionc dcl problema di compatibilità ortografica, con gli
oggetti 3D prcscnta1igli nel compito di rico noscimcn t~ ìi1cid~ntale;
penso piullosto che egli ricavi dalle assonometrie a sua d1sposiz1one le
vi ste ortografiche delle facce e le confronti una alla volta con le facce
252
memorizzale durante il compi to di pro/Jf,•111 Jo/l·i11i:. Si traila tli una
procedura più graduale e pu<.:o impegnativa. p!.!r le s~guenU ragioni:
I ) le rappresentazioni assonometriche rimanevano a disposi zione
dcl soggetto durante tulla l'esecuzione della prova: ciò facilitava la
possibilità di ricavare le proiezioni ortogonali delle tre facce·
. 2) ri~avare le viste ort ografiche dall'oggelto 3D è molto.più sempllc~ dcli op~ra7.io~1c opposta. perché, come abbiamo clcllo lo precedenza, s1 traila d1 cornspondcni'c univm:hc e quindi più facili;
3) partendo dall' assonorneLria dcli ' ogge110 3D l a risposta può essere raggiunta allravcrso una procedura au101cnninantc, nel senso che non
è sempre n~cessario ricavare tutte e Lrc le viste ortografiche per approdare alla risposta corrclla; nel caso in cui si parta dalla verinca del
distraltorc, ad esempio, la risposta può essere raggiunta mediante un
minor numero tli confronti;
4) an<.:he in questo caso il confronto complessi vo può essere smon~ato in confronti parzi ali meno impegnativi, ma che forniscono sempre
1nformazlo11i ulili.
Questa procedura, che ritengo la più probabile, è confermata da un
altro esperimento condotlo sullo stesso malcriale (Cooper. Mowafy e
Stcvcns 1986) per esplorare il grado di accessibilità anche a quçllc facce
dell ',oggcllo non ~plic i tamcnlc mostrale durante il compito di problem
solv111g. l soggetta, dopo aver risolto il problema di compatibilità ortograllca, dovevano svolgere sempre il compito di riconosdmento incidentale, ma in questo caso le rappresentazioni assonometriche dell'oggetto erano costruite in moùo da prescntnrc le stesse tre facce mostrate
nel compilo di problem solvi11g, oppure sol o due. una, o nessuna di esse.
La fig. 2 I mostra le qua11ro possibili raffigurar.ioni assonometriche
dell'oggello di cui nel riqu adro cenlralc sono mostrate le proiezioni
ortogonali. Anche in questo caso il compito prevedeva la scelta forzata
fra due rappresentazioni assonometriche, una relativa all'oggcllo considerato e l 'altra relativa ad un distra11orc.
L'ipotesi di lavoro degli au tori era che la corre11a soluzione del
problema di compatibilità ortografica presupponesse la costruzione
mentale dcli' oggcllo 30; «llowevcr, rctcntion of information about
corresponding isometrie rcprcscntations or objects shoul d be strongl y
affectcd by problem solving accuracy bccause, by hypothesis, lt is the
~ental. conslru~tio n of a rcprcsentalion corrcsponding 10 a lhrce _
d11nens1onal o.bJcct thai undcrlics the problem solution proccss» (Coopcr
1991, 28). R1tc.ngo. ancora una volta che tale procedura sia troppo
compi.essa e «~1 sch1?sa» , e che quindi la via segu ita sia quella gi à
descn11a: e cioè ri cavar e le viste ortografiche dall'immagine
~ssonomc~ri~a sollo osservazione e conrronlarle con quelle conservale
lll memoria 111 quanto apprese durante la prova di problem solving. Gli
autori danno per scontato che l'IM dell'oggcuo 30 venga costruita. e si
attendono che i risullati li aiutino a chiarire la natura delle IM. Le loro
253
due racce
tre facce
~§
~
proluioni ort~onali
(S
una faccia
~D,QJ
0
nessuna faccia
rio. 21 . [!.s empio dci quattro tipi di ossonomctrie che mostrano 3. 2. I e nes~una delle
facce raffigurale nelle proiezioni ortogonali dello stesso oggello, riquadro al
centro (da Cooper 1989).
Ipotesi si basano sulla dlstln7.lone operata da Marr ( 1982) fra rappresentazioni di oggetti che preservano la specificità del punto di vls~a da ~ui
sono osservati e r:ipprcscnta?.ioni libere da tale vincolo (orie11tat1on
free). In cui perciò tutte le Informazioni s1rutturall su ll'oggetto rlsu~te­
rcbbcro egualmente disponibili. indipendentemente dal punto di vasta
da cui sono osservate. Se le IM fossero state dcl primo tipo, i risultati
dell'esperimento avrebbero dovuto, secondo gli autori, rivel are una
differenza significativa fra le rappresentazioni assonometriche in posi1.ione standard con tre viste condivise e tutte le altre. Se l e IM fossero
state invece dcl secondo tipo, non sarebbero dovute emergere forti
differenze fra I diversi ori entamenti delle assonometrie. I risultati, come
dicono gli autori, cadono in una posizione lntcm1edia; infatti i li veli.i di
accuratezza dcl riconoscimento fra l'assonometria standard (tre vaste
condivise) e quella con due viste condivise sono risultati lnd~st.in~uibill;
mentre è risultata signilìcativa la differen7.a fra queste cond1Z1om (Lre e
due viste condivise) e le altre due (una e nessuna vista condivisa). In
quest'ultima circostan1.a il grado di accuratezza non si discostava significativamente dal caso (60%). Questi risultati concordano meglio con la
mia ipotesi che con quella degli autori. La mia Ipotesi - che ~ovreb~~
essere quella seguita dal lettore che avesse provato a svolgere 1 compau
proposti tlalla Coopcr - prevede che i soggclli partano dalla rappresentazione dcl solido 30 che è davanli ai loro occhi e da essa ricavino
mentalmente. una alla volta, le proietioni ortogonali delle varie facce
254
1
da confrontare con le proic1.ioni ortografiche conservare in memoria,
piullosto che coslruire l 'oggcuo mentale 31) partendo dalle configurazioni 20 osservate in preccdcnn e confrontare tale «Oggetto» con
quello proposto clal nuovo compito. Se riandiamo alla lig. 21 , vediamo
che è facile ricavare dulie assonometrie con tre e due viste condivise
anche la proiezione ort ogonale della tcr7.a faccia, mentre tale possibilità
praticamente si annulla nel caso di una e nessuna vista condivisa. Se
riteniamo che le procedure dcl pensiero visivo seguano sempre la via
piì) breve, quella che consente qualche lipo di risparmio delle risorse
cognitive, la ragione principale - che depone a favore di un procedimento di csecu1ionc dcl compilo che prescinda dall' IM dcli 'oggcuo 30
e che vada perciò in dire1.ionc con1rarla a quella prevista dalla Coopcr
e dai suol collaboratori - risiede nella constata1ionc che dal punto di
vista cognilivo il primo percorso è pili facile dcl secondo. Le regole
della geometria dcscrìltiva prevedono che il processo mediante il quale
possiamo ottenere le proiezioni ortogonali delle varie facce di un ogget~
lo 30 sia perfcllumentc reversibile. nel senso di poter ritornare scn1.a
difficoll?l dalle proiezioni 20 all'oggetto 30. Tale simmetria di percorso non si riscon1ra nei processi cognilivi che presiedono alla generazione delle IM: abbiamo visto infalU che In una dlre7.ione (dall'oggello alle
prolei.lonl ortogonali delle sue facce) Il cammino è In discesa. perciò
ritengo che sia quello seguito, mcnlrc nella dlrc1io11e contrarla è in
salita e quindi ritengo che sia evitato. A tale proposilo la Coopcr stessa
deve conveni re che «thc mental represcntation or an ohject formcd from
separate nat orthographic projectlons may coniai n accessible informatìon
al>oul the slructure of immediatcly adjaccnt surf:lccs; howcvcr, csscnliaJly
no structural informatlon is availablc about completcly hiddcn vicws»
(Coopcr 1991. 11). Emerge una conlradtlizionc in quesla frase quando
si parla tli una rapprcsenlazione mentale dcll'oggello che però non
contiene informazioni strullurali complessive sull'oggetto stesso; io
ritengo che se 1ale oggetto 3D fosse s1a10 111en1almcn1e sintcti 7.zato. il
recupero delle informazioni riguardanli le fa..:ce nascoste sarebbe stato
possibile mediante una sempliccopcra1jonc di ru1a1fonc mentale (Shcpard
e Cooper 1982); ciò avrebbe comportato un aumento dcl tempo di
risposta, ma non un aumento tlcgli errori , cosa che non si è veriricata.
Alla base delle ipotesi di Cooper e collabor atori c'è la convin1ione che
esi sta una forte analogia. se non adtlirillura di una sovrappòsi7.ione, fra
imngery e perce1ione; si ccome la percc1.ionc riesce a ricavare informazioni sugli oggetti che ci circondano anche da osscrva1ioni discontinue
e parziali , era l oro in1cn7.ione dimostrare che anche I' imager_v sa fare
altrcllanto. L' ip.otcsi che ho presentato è i nvc<.:e tli segno opposto. e cioè
che il ((pensare» (imngery) e il «vedere» (pcrcc1ionc) siano due proccssi indipcndcnli. che seguono pcrco1si diversi e raggiungono rlsul1a1l
autonomi e spesso di fferenU. Dato il presupposto che. se vi sono pi il vie
che portano egualmente alla solu1.ionc, il pensiero segua sempre la
255
ì
X.
meno impegnativa e rischiosa, abbiamo dovuto dimostrare. seppure
solo come soggetti Impropri, infiltrati in esperlmcnli al~I. che c·~
almeno un modo per risolvere i problemi o per operare 1 c~nfront1
richiesli che è mene> costoso. in termini di impegno cognitivo, dt quello
lpotl1.zato dagli sperimentatori. I ri sultali ottenuti infalll sembrano accordarsi di più con la nostra Ipotesi che con quella degli autori.
I O. Conclusioni. Il discorso sul pensiero visivo che ha riempito le
pagine precedenti si è appoggiato. per cercare di stare In piedi, a due
assunzioni:
l) il fallo che I vincoli di parsimonia che presiedono a tutti~ processi cognitivi non Il penalizzano tutti allo stesso modo. ma dlv~ntano
progressivamente più rigidi man mano che si passa dal processi d1 basso
a quelli di alto li vello;
2) ta fun1ionc chiarincatrlcc che può avere anche ne.Ilo studio dcl
pensiero vi sivo la dlstln1ionc fra «vedere» e «pensare». D1slinzlone che
è risultata u1ile per chiarire qualche aspetto della discussione sull'analogia fra perce1ionc e imagery.
Gli studiosi di percezione che sostengono la necessità di una componente lnferen1.lale nella attività perceulva, cosl come coloro che
sostengono un'analogia mollo strclla fra percezione e imagery, lpo~27ano
una continuità scn1a soluzione fra «Vedere>) e «1>ensare». I pnm1 sostengono che I processi dcl vedere si possano compiere sol o se c'è
l'intervento dcl pensiero che metle ordine fra gli input in entrata, sulla
scorta di quanto già conosciuto. I secondi sostengono che l 'at.Uvi_tà di
pensiero riuscirebbe a retroagire In maniera ta.nto compici~ da nat~vare
tutli i passaggi dell'allività percettiva anche an assenza d1 uno stimol o
es temo.
In accordo con il pensiero di Kanizsa. abbiamo cercato di dimostrare che il passaggio d,'.11 «vedere» (percezione) al «pensare» (imnge~)
non è bidirc1.lonalc. E stato messo a punto uno schema che mostra sia
l ' indipendenza dci due processi che la dirczionatilà obbligata dcl flusso
di informazione~. li diverso tipo di economia che regola 11 «vedere»
rispello al «pensare» ci ha aiutalo a mellcre in luce, Infiltrandoci n~~li
esperimenti di Flnkc, delle importanti differcn1e fra rclnt.erpretab~htà
percettiva e immaginativa. La prima riesce a tratlarc materiate relauvamcnte più compl esso. l avora In maniera automatica e veloce, produce
gli stessi risultali in tutti i soggetù, può far conto sul completamento
6 Non è possibile in qucsla sede 11auare un passaggio i!nporlanl~ dello sc~em.a •.di
solilo poco, o punto considerato nei manuitli di pcrcenone, e c10~ che I all~v!tà
percettiva elabora doti destinati • due funzioni diverse: rauivltll motoria e l'allJV1là
cognilivo. La prima richiede molta informazione per un 1empo n~olto breve. La seconda
relativamenle poche informat.ioni adnllc però nd essere manipolate e conservate a
lungo.
256
amodate e sul movimento indollo; la seconda invece riesce a trauarc
s?lo m~te.riale. scmpl ice. lavora in maniera tenia e vol ontaria. produce
n_su lta~ ~1vers1 nei diversi soggclll , non riuscircbhc ad attivare fenomeni quali 11 complclamcnto amodalc e il movimento indotto.
Mentre il riesame critico degli cspelimcnti di finkc era focalizzato
sulla natura dcl materiale, il riesame dci risultati della Cooper era
c.~ntrat o su ll a natura dci processi. Partendo dalla convinzione che
I 1mngery l avora come la percezJonc, l a Coopcr e I suol collaboratori
hanno ritcnu lo che I compiti proposti nel loro espcrlmcn1i potessero
essere svoli~ solo se I' image1}' avesse proccdu10 come un surrogato
detta percezione, pro~ucendo l'immagine 111c111:1te dcll'oggcllo :m. te
operazioni ~er ~segu ire questa procedura cr:mo però cognitivamentc
c~stose, e nscluosc per quanto riguarda l a effclliva ulili1.zabilità dcl
r~sultato. Partendo dal presupP<>Slo con1rario, e cio~ che I' imngcry non
sia. un.surrogato della percezi one ma uno s1ru111cnto dcl pensiero, e che,
quand1, essa eviti operazioni costose e rischiose, ahhiamo visto. auravcrs~ una sorta di sl111ulazlone in1rospc1tiva. che~ rosslhilc ottenere gli
stessi r.lsultali per vie più brevi e faci1111e111e percorribili.
~n .ultima considerazi one di carattere generale. t .e I M sono prodolli
dell all~vitò cognillva che hanno uno srnlulO pa11icolarc, in quanto sono
prodo111 dcl pensiero che u1itizzano cd a11ivano qualche passaggio e
qualche ~~hrouli n~ d~ll_' a_u_ivit~ pcrcclli va. Quesl a loro ani ma duplice
rende tah 1111111agl111 d1fflc1h da 111terprc1:irc 1coricamcn1c; ciò ha portato
~ qua~chc confusione eccessiva e a qualche polemica inu1ile. Esse sono
rnfatu il frullo di processi di allo livello che u1ili1.1.ano i risultati dci
proccss~ di hasso livello, quelli che approdano alla consapevolezza. 1
processi_ ~upcrlori per ~llivare un'immagine 111cn1alc utilinano, eposso.no u.111111arc, solo 1 rendimenti fenomenici prodolli dal processo
pnmano; n~ consegue una cena innegabile somiglianza fra JM e oggetto fenomc111co:. In base a ciò molti studiosi hanno rilcnuto di poter
~ostcne rc che I 1111agery ~un processo simi l -pcrcclli vo, che può essere
innescato dall'allo cd in assenza di stimoli cs1e1 ni, 111a che condivide
tutte, o gran palle delle propriclò dcll'a11ivi1ò pcrce11iva (Finkc 1980
I 989)_. A m.io avviso (M.assironi 1992, l 995), 1ale i111crpretazione ~
fu orvi ante, 111 quanto nmsce col non rendere giusti1ia né all'utilità
funz!on7. spccilìcitÌl delle immagini mentali. né all'utililà, ricchezza~
spec11ìc1~à della pc~cczionc. Pc.r chjarire te cose ~ risullato particolarmente utile il paradigma di Kan1zsa. che soslienc la radicale distinzione
fra «vedere» e «pensare». Il (<vedere» dovrebbe essere limitato a ci ò che
avv~ene nella parie sinistra dello schema di ng. 2 e il pensare a quanto
avviene nella parte dcslra. Il fallo che le frecce. che indicano la direzi one dcl Ouss? di lnfonna1.ionc, abbiano, nella palle centrale dcl grafico,
una sola direzione tla sinistra a desini, indica, secondo una logi ca
strellamcnte.m?dulare. ;1te non vi può essere rc1roa1.ionc dci processi di
allo su quelli d1 basso hvcllo. Inoltre, da un pu1110 di vista più generate
257
- quello di una l ogica a<.1atta1 i va - non si capirebbe l ' utilità di un
processo che proce<.lemlo a rilroso andasse a rimettere in discussione
l'el aborazione primaria, con l'unico risultato di rallentarl a, di renderla
incerta cd i narndabllc.
Lo scopo di queslo lavoro era q uello di sostenere la necessità teori ca
di una netta distinzione fra imagery e percezione. li secondo dei ci nque
pr incipi su cui secondo Fi nke (1989) si fonderebbe l'imagery, Il «principio di equi valenza percetti va», recita: «I' imagery è funzi onalmente
equivalente alla percezione, nel senso che meccanismi simili a quel li
atti vali nel si stema visivo sono atti vali sia quando oggclll o evenll sono
Immaginati che quando gli stessi oggetti o eventi sono realmente percepi ti» (p. 4 1, traduzione mia).
Questo presupposto - stretta analogia fra percezione e imagery che è ritenuto da molti sperimcn1almente dimostrato, anche se di fatto \
non lo è, poggia, seppure non esplicitamente, sulla convinzio ne che
percezi one e pensiero siano, non solo s1rettamcn1e collegali. ma per
certi aspetti addirillura intercambiabili. Questa continuità e mu1ua1ionc
reciproca delle fun1.ionl si ronda sulla convinli one, sostenuta dai f autor i della «percezione indiretta», che l'attlvllà percettiva possa essere
spiegala solo dall'intervento di qualche processo i ntegratore del pensiero su dati sensoriali Incompl eti ed impreci si. In modo analogo. ma
specul are, I' attivil1'1 di imagery dimostrerebbe che l a percezione interviene a dar forma visi va ad alcuni prodotti del pensiero. In queste
pagine si è i nvece cercato di sostenere l'utilit à epi stemol ogi ca e
chiarificatri ce di una netta d istinzione fra i due processi.
Gli oggetli della percezione hanno l a caratteristica di essere, come
direbbe Dozzi, «Oggetti sotto osser vn2ionei. e quindi di essere l à, fuori
d i noi. ~grazie a questa cara11erlstlca che noi non solo li vedi amo come
parti dcl mondo che ci circonda, ma possi amo I ntraprendere qual che
azione nei toro confronti. Quando Don Chisciotte va alla carica dcl
mulini a vento. è vero che l o fa perché ha visto dci giganti, perché nel
suo mondo fenomenico ci sono i giganti anche se nel mondo fisi co cl
sono sol o i mulini, ma quei giganti l ui li ha visti là fuor i, è assolutamente certo di non averli i mmaginati, perché se fosse stato cosciente di
averli i mm agi nali non sarebbe par lito ali' attacco. È questa di sponibi lità
ali' azione, anche a vuoto, che fa la di ffcrcn7a fra un' allucinazione cd
un ' i mmagine mentale. Un'allucinazione, contrariamente ad un'Immagine mentale, è dal punto di vista di chi l a esperi sce una percezi one vera
e propria. e come tale può Indurre risposte motorie nei confronti del
mondo fenomenico da essa prodotto. T ale differenza, che può apparire
scontata, è i nvecc Importante perché ci dice che nell' allo del vedere, ma
non in quello dcli' inunaginare, elabori amo anche Informazioni sulla
compatibilità fra l'oggetto osservato e qualche tipo di alli vit à motori a
tesa a modificarlo; l e modificazi oni degli oggetti generati dalle Immagini mentali possono Invece essere prodouc solo dal pensiero.
258
RIFURIMl!NTI DIDUOORAllCI
ARNrrnM R. C1954), Art a11d 1·is11a/ peruptio11. Dcrkctcy, Univcrsi1y ofCalifomia
Press, trad. il. Arte e perazio11e 1ùi1'a, Milano, P"eltrinclli, 1962.
ARNlllHM R. ( 1969). Visua/ tliinking, Los Angeles, Univcrsi ly or California
Press, !rad. il. li pensiero visivo, Torino. Einaudi, 1974.
DADDELEY A.O. ( 1986), Working memory. Oxford, Cl:ircnuon Press. uad. il. La
memoria di lavoro, Milano, Cortina, 1990.
DIEOERMAN I. (1987), Recognition by component.f: A tlieory of l11111111n image
11nder.rttmding, in «Psychological Rcvicw», 99. Jlll. 115-147.
Bozzi P. (1989), Fenome11ologin sperimentale, Dologna, Il Mulino.
DRANDIMONTE M.A. e GERDINO W. (1993). Menta/ image re1·ersal and verbal
recoding: When ducks become rnbbits, in «Mcmory & Cognilion ... 21 pp.
23-33.
'
DRAN~IMONrn. M.~ ... I l1T~11 GJ. e D1s.11or D.V.M. ( 1992h). Verbal recoding of
vwwl st1111ul1 1111pair.r menta/ 1111age tra11.rfor111art"o11.f. in "Mcmory &
Cognition», 20, pp. 449-455.
DRllXliiMAN D.• KIR(.11 M. e SrERLIN(j A. (198 1), Segregation of cognitÌl'e and
motor a.fpects of 1·i.wal f1111ction 11sing induced 111otio11, in ..Pcrception e
Psychophysics>o, 29. pp. 336-342.
DRllXlF.MAN D., Li:w1s S., lli;rr G. e NAm.i; M. ( 1979). Relatio11.rl1ip be,t11·c•en
cog11itfre aru/ 111~tor-orie11ted systems of vi.mal position perception, In
«Joumat or Expcr1111cn1nl Psychology: I luman Pcrccp1ion anu Pcrfonnrutl"C•,
5. pp. 692-700.
CllAMDllRS D. e RF.lsoi:Ro D. ( 1985). Can menta/ i111ages be a111big11011s ?, in
«Joumol oCExpcri111enlnl Psychology: llunrnn Pcrccplion antl Pcrfonna11CC»,
I I. pp. 3 I7-328.
CrrAMDERS D. e Ri,1soEROD. (I 992), \Vliat an i111age depicts deptnds on ll'liat an
image means, in «Cognitive Psychology... 24, pp. 145-157.
CoorER L .A. (I 988). 7'fle rote of .fpatia/ repre.m11ations in compiex problem
soflting, in S. Schiffcr e S. Stcclc (a cura di), Cognitia11 and representation,
Doultlcr (CO), Wcslvicw.
Co<>Pt;R L.A. ( 1989), Menta I models of tlie strucwre of risual objects, in D.E.
Shcpp e S. Dallcstrcros (a cura di), Object perceptio11: structure e process,
llillsuulc, (NJ), falhaum. pp. 91-1 19.
CooPER L.A. ( 199 I ), l)i.rsociable aspects oftlle me11wt represe11tation of 1•is11al
objects, in R.11. Logie e M. Dcnis (a cura ui), Menta{ image.r in /111111nn
cognitio11, Amstcrtlam, NortJ1-llolland, pp. 3-34.
CooPER L.A.. MoWAl'Y L. e STEVENS J.J. (1986), Perceil'ing llidden structure:
View-imlipende11t recogn1tion of co11.rtructed tliree-dimcn.fianal reprtsemotions, Relazione presc111:t1a al 27mo incolllro :lllnualc della l'sychonomic
Socicty, New Orlcnns (LA). novembre.
ClTlTlNO 1.E. ( 199 I), Wliy 011r sti11111li look as tlicy do, in G.R. Lockhcad e J .R.
Pomcrantz (a cura di), 171e perception of stmct11re,Washing1on (DC),
Amcrican Psychological Association, pp. 4 1-52.
DuNcKr.it K. (1929), Ober ifld11zier1e Bell'egrmg (Ein Bei/rag wr Theorie
optisch wahrge110111111ener Beweg1mg), i n «Psychologische r:orschung»,
12, pp. 180-259.
FINKE R.A. ( 1980), Le1•els of eq11Ìl'nlence in ima:~ery Oflll perception. i n
«Psychological Rcvicw», 87. pp. I 13- 132.
259
f-1NKE R.A. ( 1989), Principles of menta/ imagery, Cambridge (MA), Mrr Press.
f-INKE R.A. ( 1990), Creative imagery, llillsdale (NJ). Erlbaum.
FlNKE R.A., P1NKER S. e fARAll M. (1989), Reinterpreting vis11al patterns in
menta/ imagery, in «Cognitive Science», 13, pp. 51·78.
FINKE R.A. e SLAYTON K. ( 1988), Explorations o/ creative vis11a/ synthesis in
menta/ imagery, in «Memory & Cognition», 16, pp. 252-257.
FoooR J.A. (1983), Tlle mod11larity o/ mind. An essay on faculty psycllology,
Cambridge (MA), MIT Press, trad. it. La mente modulare, Bologna, Il
Mulino, 1988.
GEROINO W. (1983), la percezione, Bologna. Il Mulino.
G1useERT1 F. ( 1991), Le parole della psicologia: imagery, in «Giornale Italiano
di Psicologia», 5, pp. 847-850.
GOLDMElER E. (1982), Tlle memory trace: lts formation and its fate, Hillsdale
(NJ), Erlbaum.
GREGORY R.L. (1966). Eye and brain. The psycllology o/ seeing, London,
Weidenfeld e Nicolson.
GREOORY R.L. (1970), The inte/lige11t eye, London, Weidenfeld e Nicolson.
llELMrrOLTZ voN Il. (1867), Handbuch der physiologischen Oprik, Leipzig,
Voss.
Il YMAN I.E. e NmssER U. ( 1991), Reconstruing mental imoges: Problem o/
metllod, Ernory CogniLion Project Rcport # 19, Emory University, Atlanta
(GA), aprile.
KANIZSA G. (1980), La grom111a1ica del vedere, Bologna, li Mulino.
KANtZSA G. (1991), Vedere e pensare. Bologna, Il Mulino.
KANrzsA G. e Luccio R. ( 1985), la pregnanza e le s11e amabiguità, in «Psicologia
Italiana», l , pp. 11-39.
KANl7..'>A G. e Luccio R. (1986), Die Doppeldeutigkeiten der Prilgnanz, in
«GcstaJt Theory», 8, pp. 99- 135.
KossLYN S.M. (1981), /mage and mind, Cambridge (MA), Harvard Univcrsity
Press.
LANDAU B., SMm1 L.D. e JoNES S.S. (1988). Tfle importance o/ shape in ear/y
/exical learning, in «Cognitive Development», 3, pp. 299-321.
LANDAU B. e STECKER D. ( 1990). Objects and places: Syntacric and geometrie
representations in early lexical learning, in «Cognitive Developmenl», 5,
pp. 287-312.
LEONARDO DA V1Nc1 (1792), Tra11ato della pittura di Leonardo ridalo alla sua
vera lezione sopra 1111a copia a penna di mano di Srefano della Bella,
Firenze, ristampa anastatica sull'edizione del 1815, Milano, Savelli, 1982.
LEvORATO M.C. e MAss1RoN1 M. ( 1992), Dall'immagine al linguaggio: uno
studio dei processi percettivi implicati nella descrizione di figure, in
«Versus», 59-60, pp. 141-171.
MARR D. (1982), Vision, S. Francisco (CA), Freeman.
MAss1RoN1 M. (1992), Quante gocce di percezione nel cocktail di un 'immagine
mentale?, in L. Vecchio (a cura di), Le immagini mentali, Firenze, La
Nuova Italia, pp. 69-95.
MAss1RoN1 M. ( 1995), /I "fisico" e il "fenomenico" nelle immagini mentali, in
S. Marucci (a cura di), le immagini mentali, Firenze, La Nuova Italia
Scientifica.
M1LL J.S. (1842), Bailey 011 Berkeley's theory o/ vision, in «Westminstcr
Rcview» (vedi J.S. Mili, Dissertations and discussions, voi. 2, Boston,
Spenccr, 1865-68).
M1u J.S. (1843), Regioincler to Mr. !Joiley's reply, in «Wcstminstcr Revicw»
(vedi J.S. Mili, Dissertations and disc11ssio11s, voi. 2, Boston Spcnccr
J 865-68).
•
'
PA•L.LARO J .. ( 19~7); Cognitive v~rsus sensorimotor encoding of spatial
1nformat1on, 111 I . Ellcn e C. Thmus-Dlanc (a cura di), Cognitfre processes
and spotial orientation in animai and man, Martinus Nijhorr.
PAIVIO A. ( 197 1), /magery and verbal proce.ues, New York, I lolt-Rinchart and
Winston.
P AL~f>R S.E. (1989), Referenceframes in the perception ofshape and orientation,
in B.E. Shcpp e S. DallcsLreros (a cura di), Object perception: structure
and process, llillsdalc (NJ), Erlbaum, pp. 121- 163.
PALMER~ .E. e Du~11ER N.M: (1981), Co11fig11ral effects in percei1•ed pointing of
a111/ng11011s lf/angles, 111 <dournal of Experimental Psychology: Jlurnnn
Perccpt ion and Performance», 7. pp. 88- 114.
PETERSON M.A., KmLSTROM J.F., Rosi! P.M. e GusKv M.L. (1992), Mento/
images con be a111big11011s: Reconstrual and reference-frame reversal;, in
«Mcmory & Cognition», 20, pp. 107-123.
RocK I. ( 1983), Tlte logie of perception, Cambridge (MA), Mrr Prcss.
RocK I.(1984), Perception, New York, Scicn1ific Amcrican Library.
S11EPARO R.N. e CoorER L.A. (1982), Menta/ images and tlteir transformations,
Cambriuge (MA), M1T Prcss.
Ma11fredo Manironi, Istituto di Psicologia, Universilà degli studi di Verona, V.lo
Cieco dietro S. Francesco, 37129 Verona.

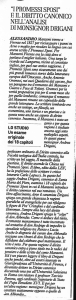

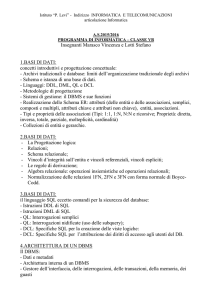

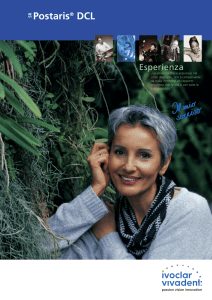
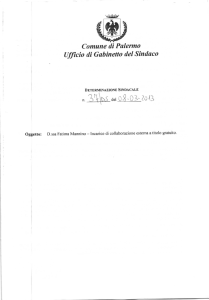

![Contratto con Sanisystem [pdf - 530,26 KB]](http://s1.studylibit.com/store/data/006230647_1-fc81501d02636e5972321f7b03c486fe-300x300.png)

