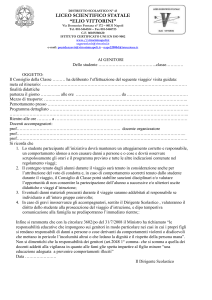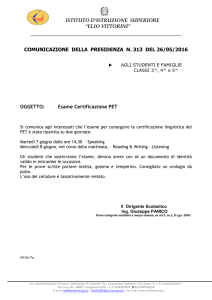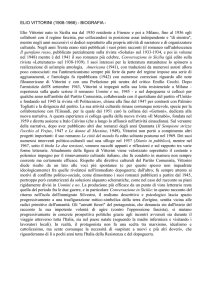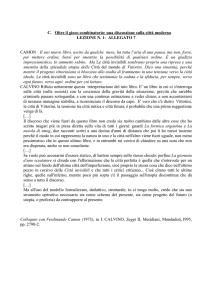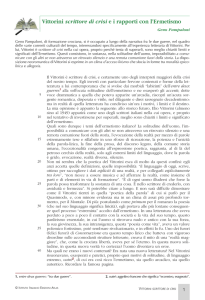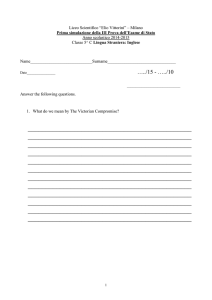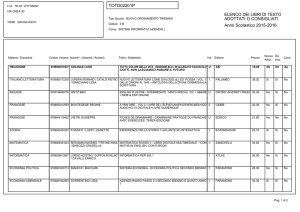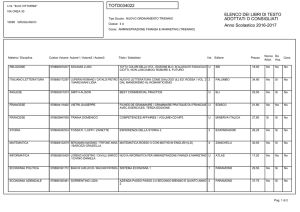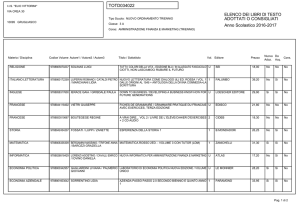CULTURA
GIORNALE DI BRESCIA DOMENICA 24 APRILE 2011
51
ELZEVIRO
Regole di decoro
nel gergo politico
degli antichi
di Gian Enrico Manzoni
i è detto e scritto anche recentemente che la politica avrebbe
cancellato le parole. Ne hanno discusso in pubblici dibattiti autorevoli studiosi della lingua e ne hanno
scritto anche i quotidiani nazionali. Ma
diverse e contraddittorie sono le cose
che possono essere intese, quando si parla dell’uccisione della lingua da parte della politica.
Innanzitutto se ne può considerare l’imbarbarimento, nel senso di un’accondiscendenza diffusa alla volgarità. Il «Föra
dai ball» rivolto da un ministro della Repubblica agli immigrati ne è il penultimo
esempio; l’ultimo invece è il «vaffa» con
cui un altro ministro ha apostrofato il
presidente della Camera.
Dovremo imparare a «relativizzare» anche queste espressioni? Può darsi.
Ma la cancellazione delle parole però è
altra cosa: è il loro svuotamento di significato, la loro banalizzazione, l’uso improprio. Oppure è la riduzione della comunicazione a slogan, all’uso di frasi fatte, utili più o meno in tutte le situazioni: se la
decisione assunta può essere definita importante, ecco che viene enfatizzata come storica; se la svolta è di rilievo, almeno per chi la fa e non per chi la subisce,
ecco che, come le riforme, viene promossa a epocale. Promossa ma inevitabilmente sbiadita: svalutata perché viene
ignorata (o banalizzata) la relazione con
altre decisioni
o riforme del
genere, che
meriterebbero pari considerazione.
Certochelaretorica, l’antichissima tecnica del parlare bene, nata
nella Sicilia
greca quasi
2.500 anni fa,
si dovrebbe
occupare ancor oggi, come in effetti si Socrate (affresco I sec. d.C.)
occupava in
origine, dell’efficacia politica della comunicazione. La retorica è tecnica di persuasione, dichiara Gorgia a Socrate nel dialogo omonimo: persuasione in tribunale,
dove si tratta di convincere la giuria a pronunciare la sentenza nel senso auspicato, nelle celebrazioni ufficiali e nei discorsi di propaganda, e soprattutto nelle assemblee politiche, dove si deve convincere la gente a votare in un certo modo. Le
scuole antiche di retorica insegnavano
in maniera dettagliata che cosa dire e
che cosa non dire, come e quando farlo,
come organizzare il discorso, e magari
con quale postura recitarlo per essere
più efficaci.
E tra le materie insegnate c’era pure quella che gli Ateniesi chiamavano léxis e i
Romani elocutio: cioè la scelta dei termini appropriati e di un certo stile nell’impiegarli. Una materia imprescindibile
per chiunque volesse avere successo
non solo a scuola ma anche e soprattutto
in pubblico, nella cosiddetta società civile (altra frase fatta oggi di moda).
Ciò non significa che anche nelle discussioni antiche non si scadesse nel turpiloquio, nell’insulto, nell’attacco alla persona: ne abbiamo molte testimonianze,
greche e romane.
La foga di Demostene contro Eschine, e
viceversa, trascende infatti ogni regola
codificata in tal senso. Significa solo, o
invece, che si insegnava il contrario, cioè
che un certo modello o stile era indicato
come positivo, al di là della sua efficacia
immediata. In questo senso si insisteva a
scuola e, in genere, così valutava la società che recepiva tali messaggi. La misura
del successo dipendeva anche dall’impiego o meno di determinate regole di
decoro: teoria e pratica dello stile tendevano, salvo eccezioni, a coincidere, anche nella vita pubblica.
S
Il «rotolo» del manoscritto di «Sulla strada» («On the road», 1951) di Jack Kerouac, uno degli scrittori americani che rinnovarono anche la letteratura italiana
Vittorini, la frontiera della scrittura
Edoardo Esposito delinea la forte e innovativa personalità dell’intellettuale
che dalla letteratura americana attinse la forza per rinnovare lo stile
partire dagli anni Venti del secolo scorso la letteratura «egemonica» in Italia era quella di
tipo rondista che faceva capo a
Cardarelli, Cecchi, Baldini. Lo scrittore
che primo reagì a quel clima fu Elio Vittorini. Grazie anche alle sue esperienze di
traduttore della letteratura anglo-americana, uscì dal genere «romanzesco» per
dare vita a una narrativa volta a creare
effetti di poesia attraverso un’attenta osservazione del mondo affettivo e un linguaggio sciolto dai consueti schemi sintattici, con narrazioni di tono spesso autobiografico, ma non intimistico.
Nel rinnovato interesse che contrassegna questo caposcuola esce il succoso
volume di Edoardo Esposito, «Elio Vittorini, Scrittura e utopia» (Donzelli, pp.
214, 25 euro). L’autore, docente di Letterature comparate e Teoria della letteratura all’Università di Milano, sulla base delle ultime acquisizioni archivistiche e dell’epistolario che sta per essere da lui stesso completato per Einaudi, illumina gli
aspetti più significativi della narrativa e
dell’attività di Vittorini.
Prof. Esposito, il realismo fantastico di
«Conversazione in Sicilia» per quel suo
dar vita a dialoghi più sottintesi che
espressi appartiene alla tradizione che
da Cielo D’Alcamo giunge a Verga?
Non credo sia necessario ricondurre i
suoi modi a forme della «sicilianità», anche se autori come Verga erano certamente familiari a Vittorini (e tuttavia
non del tutto amati). La stessa Sicilia di
A
Lo scrittore Elio
Vittorini era nato a
Siracusa il 23 luglio
1908 e morì a
Milano il 12
febbraio 1966
Il romanziere e
giornalista
statunitense Ernest
Hemingway (1899
- 1961) fotografato
durante un safari
cui Vittorini parlava era, come precisava
la nota di accompagnamento, «solo per
avventura Sicilia».
Lei scrive che Vittorini fu affascinato dagli scrittori americani per «la loro aderenza anche antiletteraria alla vita». Come la recepì? Perché non volle tradurre
Henry James?
«Aderenza antiletteraria alla vita» voleva
dire che per questi scrittori era più importante raccontare certe cose che preoccuparsi del come raccontarle. Vittorini fu affascinato da questa freschezza,
magari cruda e un po’ grezza. James non
gli piaceva proprio perché era un americano troppo legato al vecchio mondo e
alle sue raffinatezze o complicazioni a
volte sterili.
Che posto occupa l’antologia degli scrittori statunitensi, «Americana» (33 autori, 1.036 pagine) curata da Vittorini, censurata nel 1942 e apparsa integralmente solo nel ’68?
È il posto di un mito, di un’intenzione
che riuscì solo in parte a diventare realtà.
Ebbe da insegnare qualcosa, in quanto
realtà, e lo fece attraverso i testi e gli autori che fece conoscere. Ma, paradossalmente, attraverso la censura che la colpì,
«Americana» ha contato di più nella nostra cultura per ciò che, nel 1942, non le
fu dato di esprimere. Le sue pagine più
famose sono infatti quelle di inquadramento storico e letterario scritte da Vittorini e che allora furono soppresse.
In Vittorini - lei scrive - il simbolo non è
una chiave che deve aprire qualcosa.
Quale ne è la funzione?
La necessità di ricorrere ai simboli discendeva da quella di eludere la censura,
che non avrebbe permesso di parlare di
certe cose o di definire il fascismo una
«offesa al mondo»; ma Vittorini voleva
parlare in generale di una situazione, e
non di fatti o persone specifiche. Del resto, la scelta di un linguaggio simbolico
era implicita nella volontà di dare vita alla scrittura poetica che gli stava a cuore.
Il 29 settembre 1945 esce il primo numero del «Politecnico». Vittorini scrive:
«occuparsi del pane e del lavoro è ancora occuparsi dell’anima». Cosa intendeva?
Era un’affermazione rivolta contro coloro che pretendevano di svolgere la loro
funzione intellettuale nell’ignoranza dei
problemi della «produzione del lavoro»,
contro le «anime belle» che ritengono
che la politica sia una cosa con cui non
bisogna sporcarsi.
Vittorini si oppose alla pubblicazione
de «Il gattopardo» di Tomasi di Lampedusa. Per quali ragioni?
Contrariamente a quanto è sempre avvenuto, non è alla questione ideologica
che bisogna riferirsi: nessuno ricorda
mai che il giudizio fu dato su un’opera
che non era compiuta ed era un’opera di
impianto e di linguaggio tradizionali,
mentre Vittorini dirigeva una collana di
narrativa giovane e sperimentale. Fu solo dopo un’elaborazione adeguata che
l’opera diventò pubblicabile.
Sergio Caroli
Ecco la Pivano «madrina» yankee Due ciak da Kerouac:
Mostra a Milano su colei che diffuse tanta America letteraria
roseguirà fino al 18 luglio
(sua data di nascita nel
1917) a Milano, al Credito
Valtellinese- Refettoriodelle Stelline (c.so Magenta 59), la mostra documentaria «Fernanda Pivano. Viaggi, cose, persone» ideata da
Michele Concina, curata da Ida Castiglionicon FrancescaCarabellie la
consulenzadiEnricoRotelli,giàassistente della Pivano e curatore dei
«Diari». Morta a 92 anni, nel 2009,
«Nanda»harappresentatoper60anni, un ponte culturale tra Stati Uniti
eItalia,contribuendoallaconoscen-
P
Un ritratto della
Pivano: una
mostra la ricorda
za di scrittori come Ernest Hemingway, Sherwood Anderson, Francis
ScottFitzgerald,William Faulkner,e
di tutta la Beat Generation.
La Pivano iniziò da traduttrice nel
1943,quandoEinaudipubblicò«Antologia di Spoon River» di Edgar Lee
Master. In mostra scritti, lettere (tra
cui le inedite a Cesare Pavese suo
maestro), documenti, foto e altre testimonianze,anchesul sodalizioconiugale-intellettualeconEttoreSottsass. In proiezione i filmati «Pivano
Blues» di Teresa Marchesi e «A farewell to beat» di Luca Facchini.
On The Road e Big Sur
attore franco-americano Jean Marc Barr
è il protagonista di un adattamento di Big
Sur, il romanzo autobiografico che Jack
Kerouac pubblicò nel 1962. A dirigerlo è
lo scrittore-regista Michael Polish. Nel libro, il re dei
beatnik raccontava i giorni trascorsi a Big Sur, sulla
costa della California per sfuggire ai clamori del successo della pubblicazione di «On the road», ma anche per disintossicarsi dall’alcol. Con Barr recitano
Kate Bosworth e Josh Lucas. Dopo un altro recente
film sulla Beat Generation («Howl», con James Franco nei panni del poeta Allen Ginsberg e Todd Rotondi in quello di Kerouac), nel corso di quest’anno dovrebbe uscire anche «On the road» di Walter Salles,
con Sam Riley, Kristen Stewart e Viggo Mortensen.
L’