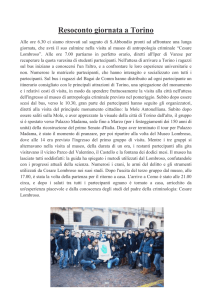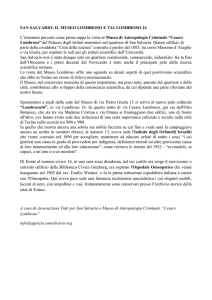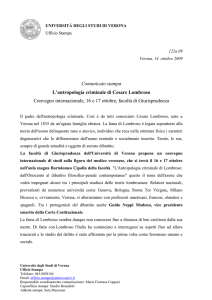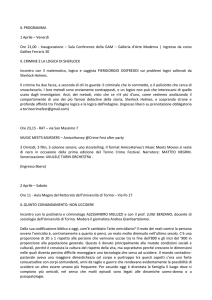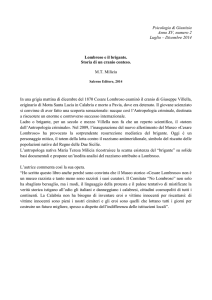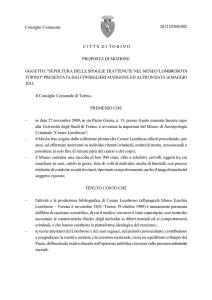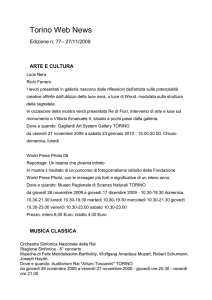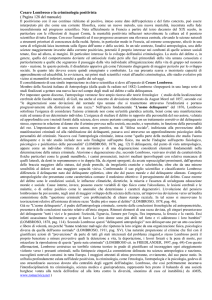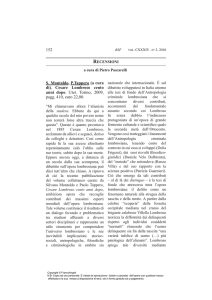![[brescia - 46] gdb/cultura/cultura](//s1.studylibit.com/store/data/006309725_1-a56abe5b34ac03307e2972fce00fdc22-768x994.png)
Data e Ora: 25/11/09
20.08 - Pag: 46 - Pubb: 26/11/2009 - Composite
46
Giornale di Brescia
Giovedì 26 Novembre 2009
Cultura&Spettacoli
Il San Giovanni Battista di Leonardo a Milano
Dal Louvre a Palazzo Marino, dove sarà esposto gratuitamente da domani fino al 27 dicembre
■ Custodito in un forziere di massima sicurezza è arrivato
l’altra notte a Milano, dal Museo del Louvre a Parigi, il San
Giovanni Battista di Leonardo da Vinci. Per un mese da domani al 27 dicembre, il dipinto sarà esposto nella Sala Alessi
di Palazzo Marino, sede del Comune, che per l’occasione resterà aperta gratuitamente al pubblico, come già fu fatto un
anno fa con grande successo per la «Conversione di Saulo» di
Caravaggio, dei principi Odescalchi di Roma. Il San Giovannino su tela (catalogo Skira), realizzato tra il 1505 e il 1510, da
quando fu donato al re di Francia Luigi XIV è stato spostato
da Parigi solo una volta per essere mostrato nel 1939 proprio
a Milano in occasione della grande monografia che il Palazzo
dell’Arte (sede della Triennale), dedicò a Leonardo da Vinci.
Il dipinto - mistico, col dito al cielo che annuncia la Venuta di
Cristo e la Salvezza, ma anche i moti celesti - e sensuale, nella
figura androgina e nel sorriso allusivo che ha fatto appellare il
San Giovannino anche come «il Giocondo» - è collocato dentro una teca infrangibile in una camera oscura alla fine di un
percorso multimediale. Un sofisticato sistema di illuminazione dà al visitatore l’impressione che l’opera galleggi nel buio.
Il ritorno a Milano del dipinto rinascimentale voluto dal sindaco Moratti, è sostenuto dall’Eni. Palazzo Marino ha già accolto nei mesi scorsi Leonardo, quando a luglio ha esposto in
anteprima due fogli del Codice Atlantico.
LOMBROSIANA MENTE
L’uomo che lesse
il delitto in faccia
Cent’anni dopo i neuroscienziati «riabilitano»
in parte il padre dell’antropologia criminale
O
ggi riapre il Museo di Antropologia criminale
dell’Università di Torino inaugurato nel
1898, che espone le preziose collezioni di Cesare Lombroso: centinaia di crani, fotografie,
disegni, schede, strumenti di punizione e reperti di carceri e manicomi raccolti per i suoi studi dal padre dell’antropologia criminale, oggetto da alcuni decenni, malgrado il ripudio delle sue teorie, di un profondo riesame critico. Laureatosi in psichiatria a Pavia nel 1838, Lombroso
fece parlare di sé pubblicando nel 1858 le «Ricerche sul
cretinismo in Lombardia». Medico militare nelle guerre
contro l’Austria nel 1859 e nel 1866, divenne primario del
reparto malattie mentali dell’Ospedale di Pavia, poi professore straordinario di Clinica di malattie mentali. Passato a insegnare a Torino, nel 1905 fu nominato ordinario di Antropologia criminale. Medico delle carceri torinesi, e poi sovrintendente ai manicomi, nel 1906 fu eletto
presidente onorario della Ethical Society di Londra.
Partendo dai principi del positivismo, Lombroso tentò di motivare con le anomalie fisiche la degenerazione
morale del delinquente, da lui considerato un particolare soggetto antropologico. Su questi principi fondò la
nuova scienza dell’Antropologia criminale, che ebbe le
basi teoriche nella sua opera principale, «L’uomo delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza
ed alle discipline economiche», apparsa nel 1876. Lombroso fu anche uno dei primi al mondo a esplorare l’universo femminile attraverso la lente della scienza, con il
suo saggio «La donna delinquente» che per quasi mezzo
secolo è stato il libro più influente sulla criminalità femminile.
Delle nuove interpretazioni espresse da studiosi di tutto il mondo sulla figura e l’opera dello scienziato veronese, morto 74enne il 18 ottobre 1909, dà conto il volume
«Cesare Lombroso cento anni dopo» a cura di Silvano
Montaldo e Paolo Tappero (Utet).
Professor Montaldo, docente di Storia contemporanea all’Università di Torino, quali ragioni inducono la
comunità scientifica a rivisitarne il pensiero?
I neuroscienziati di oggi chiamano spesso in causa la
sua figura in quanto precursore degli studi sul rapporto
tra biologia e comportamento, ma si tratta - ha ricordato Peter Becker nel recente convegno torinese "Cesare
Lombroso. Gli scienziati e la nuova Italia" - di un ricorso
a Lombroso come "luogo della memoria", funzionale a
legittimare le proprie ricerche. Per gli storici l’interesse
verso Lombroso ha oggi ben altri significati: egli fu uno
dei più noti, se non il più noto, tra gli intellettuali italiani
del tardo Ottocento e del primo Novecento, e questo fatto lo rende di per sé un soggetto degno di studio. Fu la
punta più avanzata e battagliera del Positivismo italiano, impegnato in uno sforzo di rinnovamento culturale
che lo portava ad affrontare temi nuovi, circolanti altrove o toccati da lui per la prima volta. In tal senso, Lombroso non può essere ricondotto solo all’immagine del
delinquente nato».
Lombroso ha considerato il delinquente come una varietà della specie umana da studiare attraverso i metodi delle "scienze della natura". Ma si resta sconcertati
quando si legge nel suo "L’uomo delinquente" il ritratto,
per esempio, dello stupratore: "L’occhio è scintillante,
la fisionomia delicata, labbra e palpebre tumide, per lo
più gracile e qualche volta gibboso". Fino a che punto il
suo metodo era "galileiano" e fino a che punto
strampalato?
Non era un metodo galileiano, certo, ma aveva una
sua razionalità, in quanto era attraverso descrizioni di
questo genere, volte a impressionare i lettori, che Lombroso entrava in risonanza col pubblico, ne confermava i
pregiudizi e quindi riusciva a diffondere le sue teorie, che
svolgevano d’altra parte una funzione rassicurante: il criminale era un anormale, identificabile attraverso una
prassi scientifica, il delitto aveva un volto ed era possibile contrastarlo attraverso il dettato dell’antropologia criminale.
Oggetto delle ricerche di Lombroso furono i detenuti
nelle carceri italiane negli ultimi decenni dell’800. Ma
Guido Neppi Modona documenta nel libro che si trattava per lo più di poveri e analfabeti. Non di congenite
anomalie fisiche e psichiche dell’uomo delinquente si
dovrebbe quindi parlare, ma delle anomalie di un siste-
ma penale strumento di abbrutimento degli appartenenti ai ceti ritenuti socialmente o politicamente pericolosi. Non lede tutto ciò la scientificità di Lombroso?
Oggi l’interesse degli studiosi nei confronti di Lombroso non attiene all’atavismo o all’idea dell’inferiorità della
donna nei confronti dell’uomo, ipotesi del tutto prive di
fondamento. Semmai è interessante esaminare i materiali da lui raccolti sulla realtà carceraria, conservati nel
Museo di Antropologia criminale di Torino, e studiare i
suoi libri sull’argomento, come i "Palinsesti del carcere",
testimonianza della cultura degli strati marginali della
popolazione italiana di fine ’800.
George L. Mosse, insigne storico, descrive Lombroso
come il precursore del progetto nazista di rigenerazione razziale e di eugenetica. Ma è pur vero che Lombroso, ebreo, pubblicò nel 1894 "L’antisemitismo e le scienze moderne", nel quale "il soffio gelido dell’odio selvaggio" che attraversava l’Europa gli appariva null’altro
che lo storico retaggio dell’odio antiebraico proveniente dal buio dei secoli. È un’altra prova che in lui coesistevano razionalismo e irrazionalità?
Non dobbiamo enfatizzare più di tanto gli aspetti contraddittori di questo intellettuale. Certo nella sua sterminata produzione saggistica si può trovare di tutto, ma
riguardo al razzismo la sua posizione era coerente col
suo credo evoluzionista, come lo era anche la sua denuncia nei confronti dell’imperialismo, del nazionalismo aggressivo, del militarismo e della xenofobia, cioè di quegli
elementi presenti nella politica e nella cultura occidentali da cui sarebbe scaturita la catastrofe della Grande
Guerra. Egli riteneva che l’antisemitismo sarebbe scomparso con l’integrazione degli ebrei nella società contemporanea, una volta che essi avessero abbandonato quelle che a lui sembravano leggi e tradizioni arcaiche.
È corretto affermare che l’antropologia criminale è
un’esplorazione ardita dei labirinti oscuri della personalità umana?
Direi di sì, e probabilmente anche in questo si trova
una spiegazione del successo internazionale dei libri di
Lombroso: toccavano corde sensibili dell’opinione pubblica dell’epoca, preoccupata e insieme affascinata dal
crimine, dall’irrazionalità, dalla follia.
Sergio Caroli
IL MUSEO CESARE LOMBROSO
OGGI L’INAUGURAZIONE A TORINO
A cento anni dalla morte di Cesare Lombroso, fondatore dell’antropologia criminale, si riallestisce il «suo» museo, unico al mondo. Si inaugura oggi a Torino il Museo
di Antropologia Criminale «Cesare Lombroso» dell’Università (via Pietro Giuria 15, chiuso la domenica, tel.
0116708195 www.museounito.it/lombroso). Si arricchisce così di un ulteriore spazio espositivo il nuovo polo museale del Palazzo degli Istituti anatomici, dove dal
2007 sono già fruibili il Museo di Anatomia Umana e il
Museo della Frutta. Il polo museale propone uno sguardo su alcuni aspetti di quel positivismo scientifico che,
tra fine ’800 e inizio ’900, ebbe in Torino un centro di
rilievo internazionale. Le collezioni comprendono preparati anatomici, disegni, fotografie, corpi di reato e
produzioni artigianali e artistiche, realizzate da internati nei manicomi e da carcerati. Lombroso iniziò a raccogliere i materiali intorno al 1859 e continuò a farlo per
tutta la vita, con l’aiuto di allievi e ammiratori che in
Italia e in altri Paesi europei, in America, Asia e Australia, si ispirarono alle sue teorie. Fu poi il genero e successore Mario Carrara a proseguirne l’opera, fino al 1932,
quando fu espulso dall’Università per aver rifiutato di
giurare fedeltà al fascismo. Non è un museo dell’orrore;
presenta il pensiero di uno scienziato fortemente interessato ai problemi della sua epoca e che fu guidato da
una profonda curiosità verso il crimine e verso qualsiasi
forma di devianza dalle norme della società borghese
ottocentesca, un’anormalità intesa anche in senso positivo, nelle persone di genio artistico, scientifico o politico. Foto: maschera in cera di «falsario»
fl
Montini
alla Pace
50 anni fa
Per iniziativa dei Padri della Pace, della Cooperativa Cattolico-democratica di Cultura e dell’Università popolare Astolfo Lunardi, stasera, giovedì, alle
20.45, nella Sala Bevilacqua in via Pace 10, si terrà
l’incontro «Giovanni Battista Montini e l’Oratorio
della Pace», relatore Luciano Pazzaglia, con testimonianze di padre Giulio Cittadini C.O. e del prof. Carissimo Ruggeri.
T
ra le diverse memorie montiniane riaffiorate
con la recente visita di Papa Benedetto, trova posto anche il ricordo di una visita compiuta da Giovanni Battista Montini, allora
cardinale di Milano, all’oratorio e alla chiesa della Pace in città.
Sono trascorsi precisamente, o quasi, cinquant’anni da allora: il 18 novembre 1959 l’arcivescovo Montini, giunto appositamente da Milano, concludeva i lavori del Piccolo sinodo diocesano e celebrava, nella
bellissima chiesa dei padri filippini dell’Oratorio, una
Messa, nel centenario della morte di Giovanni Maria
Vianney, il santo curato d’Ars.
«Il santo protettore dei sacerdoti» era il titolo autografo scritto sulle cartelle del dattiloscritto dell’omelia pronunciata sulla figura ascetica del sacerdote,
morto nella cittadina francese di Ars nel 1859, beatificato da Pio X nel 1905, poi canonizzato da Pio XI nel
1925 e quindi divenuto patrono dei sacerdoti impegnati nella cura delle anime. L’anno in corso 20092010 è stato dunque proclamato dal Papa attuale come «Anno sacerdotale» nel centocinquantesimo anniversario della scomparsa dell’umile prete della campagna francese.
Anche Montini cinquant’anni fa si rivolse esplicitamente ai sacerdoti. Lo sappiamo perché l’edizione critica dei «Discorsi e scritti milanesi» di Montini, pubblicati nel 1997 dall’Istituto Paolo VI di Brescia, riporta il testo integrale del discorso.
Esso è desunto da alcune cartelle dattiloscritte, da
edizioni occasionalmente uscite per la circostanza, e
soprattutto dal nastro di registrazione tuttora esistente e ascoltabile. Il cardinale di Milano parlò a lungo, quasi a volersi sdebitare col clero bresciano «al
quale devo tanto e al quale tanto poco io ho dato»,
come disse: il testo a stampa occupa sedici pagine.
Al di là di quell’occasione, è noto il ruolo fondamentale svolto dai Padri della Pace nell’educazione del
giovane Montini, in particolare quello ricoperto dai
padri Bevilacqua, Caresana, Manziana, ma anche dalle figure dei padri Olcese, Marcolini e Carli, per limitarci solo ai più noti.
Se ne è scritto in più occasioni, anche recenti, e
avremo modo di risentirne parlare giovedì sera alla
Pace. L’oratorio della Pace, insieme all’Istituto Arici
dei padri Gesuiti, costituisce un pilastro fondamentale nella formazione culturale e spirituale del giovane
Montini; si tratta di due ambienti bresciani diversi,
ma complementari: nel primo ricevette la prima preparazione scolastica, fino alla soglia della Maturità;
nel secondo fece gli incontri decisivi per la sua formazione come sacerdote.
Rileggendo il testo dell’omelia troviamo spunti interessanti e di perenne attualità. Il richiamo all’umiltà, innanzitutto, che nel caso del curato d’Ars era arrivata a suscitare la scelta di una povertà radicale e di
una nullità personale totale. E poi il concetto di servizio, scaturito dal superamento della logora ma sempre allettante tentazione dell’unione del potere spirituale a quello temporale («una psicologia feudale del
sacerdote», disse precisamente Montini): anzi un «pericolo», ribadì con voce ferma durante l’omelia. Il pericolo «che anche lo sforzo di dare a se stessi una coscienza sacerdotale derivata da questo mistero operato in noi dal sacramento dell’Ordine, possa anche
in noi alterare la vera coscienza sacerdotale».
Fu un discorso deciso, a tratti anche un po’ duro,
che oggi forse potremmo considerare nel segno della
normalità, ma che certamente non lo era allora. A tutti, sacerdoti o semplici fedeli, Montini indicò la vita di
Giovanni Maria Vianney come esemplare sulla strada della santità personale, nonostante le difficoltà, le
incomprensioni e i dissidi interiori.
Gian Enrico Manzoni
Ionesco, l’assurdo di un solitario per la libertà
A cent’anni dalla nascita un incontro alla «Feltrinelli» sul grande drammaturgo, celebrato in questi giorni a Parigi
Oggi, giorno del centenario della nascita di
Eugène Ionesco, Laura Trevini Bellini e Alberto Gaffi Editore presentano alle 18 alla Libreria Feltrinelli di Brescia, in corso Zanardelli 3,
il romanzo «Il solitario», scritto da Ionesco nel
1973, e il saggio di Nicola Fano - pure presente
in libreria - «Ionesco, Eugène» editi da Alberto
Gaffi (Roma). Laura Trevini Bellini leggerà
brani da testi teatrali e dal libro «Note e Contro-Note» (Einaudi 1965).
N
ell’anno che celebra il centenario della nascita di Eugène Ionesco, l’inventore del teatro dell’assurdo è rievocato in Francia con due importanti iniziative: la Bibliothèque Nationale de France ha
allestito a Parigi, nella galleria Francesco I,
l’«Exposition Ionesco» - aperta fino al 3 gennaio - che presenta centinaia di documenti inediti
del drammaturgo, tratti dai suoi archivi privati
donati dalla figlia, mentre l’editore Gallimard
edita, in coedizione con la stessa Bibliothèque
Nationale, l’opera «Ionesco», che offre un approccio alla sua attività di drammaturgo, saggista e romanziere attraverso manoscritti, note e
corrispondenze; numerose foto vi testimoniano inoltre delle principali messe in scena delle
sue pièces in Francia e all’estero.
Nato a Bucarest il 26 novembre 1909 da padre romeno e madre francese, Ionesco visse colà fino al 1940 specializzandosi in francese in
quella Università. A Parigi, dove trascorse parte dell’infanzia, ebbe negli occhi - scriverà nel
’39 - «le figure dei corpi deformi, dei sorrisi atroci, dei piedi biforcuti» dei mutilati della Grande
Guerra, rimanendone indelebilmente impressionato. Dopo un fallimentare inizio nel teatro,
crebbe a fama di «classico» prima in Inghilterra
poi in Francia, al punto da entrare da vivente
(fatto raro) nella Bibliothèque de la Pléiade.
«Teatro dell’insolito» (e non «teatro dell’assurdo») è la definizione che Ionesco ha preferito per la propria drammaturgia, che irride senza pietà ai miti e ai riti dei «collettivi della banalità». La sua prima «anti-pièce», l’atto unico
«La cantatrice calva», inaugura nel 1950 un ciclo teatrale la cui sola norma sarà l’assenza di
norme. Deformando i protagonisti a fantocci
inamidati privi di anima, Jonesco non disinte-
gra solo la logica causa-effetto, ma le funzioni
stesse del linguaggio, dandoci ragione della tesi da lui più tardi espressa: «Beckett distrugge
il linguaggio con il silenzio. Io lo faccio con l’eccessivo linguaggio, con personaggi che parlano
a caso e inventano parole».
Sarà questo il tratto distintivo delle sue opere successive. Accanto a «La lezione», «Le sedie», «Jacques ovvero la sottomissione», «Il re
muore», «Macbett» - originalissima trasposizione del «Macbeth» shakespeariano, - la sua
pièce più acclamata resta «I rinoceronti»
(1959), i cui protagonisti paiono usciti da un
connubio fra l’uomo e la bestia. Nella paciosa
cittadina dove, alla vista di un rinoceronte in
piazza, tutti cominciano a «vedere» rinoceronti
proliferare, finché qualcuno comincia a «trasformarsi» in pachiderma, al punto che la metamorfosi investe la maggior parte della popolazione, Ionesco schernisce in filigrana il regime
nazista nel quale ad aver ragione è la maggioranza. C’è bisogno di ricordare che Hitler salì al
potere nel 1933 con un plebiscito di popolo?
Più in generale il rinoceronte è però allegoria
del totalitarismo che, sotto qualsiasi cielo, tra-
sforma il consorzio umano in gregge condannato all’entusiasmo. Il linguaggio ripetitivo, le deformazioni verbali, i neologismi burleschi, la parodia dei proverbi sono mezzi attraverso i quali
Ionesco crea effetti di straniamento, che nello
spettatore generano senza soluzione di continuità angoscia commista a riso.
Insofferente per tutta la vita a qualsiasi forma di autoritarismo - ideologie, istituzioni, apparati burocratici, militari e giudiziari dello Stato - Ionesco ebbe il culto della libertà. Agli intellettuali comunisti che, come Sartre, dopo averlo dapprima preso a ben volere, gli rimproverarono il suo anticomunismo, rispose: «Ogni volta che si è cercato di cambiare utopicamente la
società, si sono installate le utopie. Sono terribili. I primi rivoluzionari avevano un ideale di
giustizia, di libertà, di fraternità. Ma occorre
chiedersi se volevano davvero tutto ciò, giacché hanno fatto il contrario di ciò che dichiaravano di voler fare». Non è un caso che negli ultimi anni questo «anarchico di destra» collaborasse al «Giornale» di Montanelli, iscrivendosi
anche al Partito Radicale di Marco Pannella.
Ionesco morì nel 1994, ed è sepolto nel cimitero
di Montparnasse.
s. c.
![[brescia - 46] gdb/cultura/cultura](http://s1.studylibit.com/store/data/006309725_1-a56abe5b34ac03307e2972fce00fdc22-768x994.png)