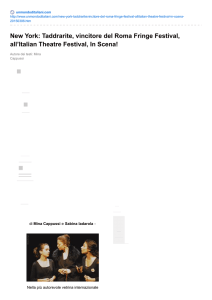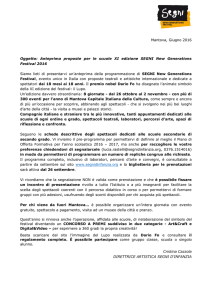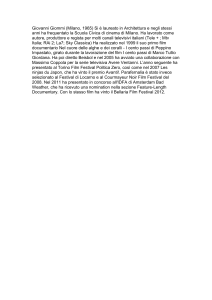Festival di Edimburgo
STORIE DI ‘FRINGE’: SE L’INTERA CITTÀ DIVENTA UNA SCENA
Note e appunti di memoria (e di smarrimento) attraversando a intervalli, dal 1993 al
2010, la ‘frangia’ della grande manifestazione teatrale, che è ormai il cuore vero e
proprio dell’International Festival. Centinaia di spettacoli, a tutte le ore del giorno e
fino a notte inoltrata, che si svolgono dovunque, occupando scuole, ristoranti,
giardini, pub, scantinati, alberghi, una miriade di chiese sconsacrate e, infine, ‘anche’
teatri. Con folle di spettatori che sciamano in ogni dove, subissati dal richiamo di
volantini, giornali, gente che urla per strada, lavagne fuori dalle ‘venue’, manifesti
che coprono completamente tutte le pareti di tutti i locali. Ricerca artistica e
personale qui si confondono, bisogna lasciarsi sorprendere e continuare a cercare un
filo di senso, piuttosto che trovarlo. È questo il segreto e il fascino di un evento
multiscenico, unico al mondo.
________________________________________________________________________________
di Simone Caffari
Il Fringe. La Fringe. Ho ancora qualche dubbio. È “la” fringe, cornice, marginalità, “frangia”,
dell’International Festival, il festival “ufficiale” (e quindi, Festival Fringe, la cornice del festival).
Ma da anni è “il” Fringe, è il festival vero e proprio (e quindi, Fringe Festival, cioè “il festival che
si chiama Fringe”), quello delle centinaia di spettacoli quotidiani, delle file chilometriche ai
botteghini, dei ragazzi travestiti su tutto il Royal Mile a Edimburgo. In mezzo alle cornamuse, sì, ci
sono davvero le cornamuse, e quando qui ci abiti, cominciano a non piacerti più, non come prima.
“Prima” è una mezza vita prima. Non posso parlare di Edimburgo o di Fringe da critico o da
scholar, da accademico. Da frequentatore, sì. Da attraversatore. La città e il suo festival, o al
contrario, il festival e la sua città (the Festival city, la chiamano qui), che ad agosto sono tutt’uno, li
ho cercati, annusati, attraversati in modo disordinato e appassionato, entusiasta e annoiato su un
arco di 17 anni. Per me, mezza vita, appunto. Ora vivo a Edimburgo, dopo averla visitata, lasciata,
pensata, ritrovata. Quel che posso offrire sono pennellate, spezzoni, immagini, frammenti, per
parlare di cosa renda questo festival delle arti diverso. Diverso nei luoghi in cui si svolge, nei tempi,
nelle atmosfere. Diverso nelle convenzioni, o nella loro assenza. Diverso nel disorientamento che
produce la prima volta, e poi ancora la seconda, la terza. Frammenti. Storie. Miei, mie, non solo.
L’incontro, la quantità.
Agosto 1993. 17 anni fa. Ho 17 anni. “C Venue” in Princes St.
L’ingresso sembra quello di un ufficio. Io e Ludovica ci chiediamo se è qui. Cosa è una venue non
lo so ancora. Teatro in inglese è theatre. No?
Lo spazio è piccolo, fa molto caldo. In scena due ragazzi, giovani, bellocci, magliette bianche con
sopra dei nomi. Quella del più basso dice “Dorian Gray”. Si cambiano più volte, indossano altre
magliette con altri nomi. Indossano altre persone, con facilità. Si baciano anche in scena. Il primo
incontro con il Fringe è anche il mio primo incontro con i temi omosessuali a teatro.
Siamo alle prime armi. Lo spettacolo l’abbiamo scelto perché il titolo è familiare. Oscar Wilde, The
Picture of Dorian Gray. Ci piace, ci capiamo qualcosa. Ce lo possiamo permettere: 4-5 sterline,
poco meno di 10.000 lire. Siamo nel budget. Si può scegliere uno spettacolo in base al titolo? Da
principianti del festival, a volte puntiamo a spettacoli segnalati con una stella sull’immenso posterprogramma giornaliero distribuito gratuitamente al Fringe office. Su questa specie di lenzuolo sono
stampate decine di titoli, divisi per fascia oraria. Si parte al mattino alle 8.30 e si finisce intorno
all’una di notte. Ne ho tenuti da parte una quindicina, non li fanno più.
Intuiamo che scegliere i titoli non basta, ma nomi di “grandi” della scena, a 17 anni, non ne
conosciamo. Le recensioni non saremmo in grado di leggerle. Siamo qui per impararla, la lingua.
Ma siamo qui soprattutto per il teatro, e per l’atmosfera. Ecco, l’atmosfera. Torniamo più volte alla
“C Venue” perché ci è piaciuto il posto. La “venue”, appunto, il locale, lo spazio, l’ambiente. Come
si dice in Italia? La situazione. I luoghi. “Off” in un modo che a 17 anni, in Italia, a Roma, ci è
ancora sconosciuto. Questo di solito non è un teatro, e allora cosa? La piccola stanza in cui abbiamo
visto lo spettacolo, il portone da cui siamo entrati, la saletta in cui abbiamo atteso di entrare, cosa
sono tutto il resto dell’anno? Non lo sappiamo.
È muovendoci seguendo luoghi e atmosfere che ci imbattiamo nel Bedlam Theatre, una chiesa
neogotica sconsacrata alla fine di George IV Bridge. La porta è rossa, le mura annerite dal fumo, il
soffitto dentro è altissimo e oscuro. Ci andiamo una sera tardi, apposta per vedere che effetto fa
uscire di notte da una chiesa che non è una chiesa. The Tree Monsters, uno spettacolo inquietante,
un pianoforte sul palco e i personaggi a suonare una melodia ossessiva che ricordo tuttora. In scena
lo scemo del villaggio fa volteggiare tre uova, le riprende al volo e fa per andarsene, ma il cattivo lo
ferma e gli stringe le mani, le uova dentro. Una frittata, lo scemo piange, muto. Un’immagine
potente.
Gli spettacoli li scegliamo in un calderone enorme e ribollente di roba incomprensibile. Il
programma completo è di cento e più pagine, quattro righe di presentazione per ogni spettacolo. Ci
mettiamo una settimana a capire che sono le compagnie stesse a presentarsi, definendosi
“eccezionali”, “imperdibili”. È ancora così, ma il programma cresce ogni anno e le compagnie sono
sempre più eccezionali e imperdibili. Poi ci sono i volantini. Al primo attraversamento del Fringe si
viene sommersi di volantini e li si tiene religiosamente tutti. È un rito di passaggio. Tantissimo
teatro, tanta danza, una quantità abnorme di comedy, spettacoli comici. Professionisti, dilettanti,
studenti, grandi, piccoli, imperdibili, spazzatura.
Del mio primo Fringe mi sconvolgono le quantità. La quantità di spettacoli: centinaia, a tutte le ore
del giorno e fino a notte inoltrata. Puoi entrare in una venue al mattino e rimanerci fino a sera. La
quantità di persone: c’è pubblico ovunque, non ho mai visto una tale concentrazione, non di
semplici turisti, ma di turisti perché spettatori, in fila ovunque, ovunque a leggere il programma. La
quantità di informazione: volantini, giornali, gente che urla per strada, lavagne fuori dalle venue,
manifesti che coprono completamente tutte le pareti di tutti i locali. E poi la quantità di luoghi. Il
Fringe è praticamente ovunque nel centro di Edimburgo, occupa scuole, ristoranti, giardini, pub,
scantinati, alberghi. Anche teatri. E poi, una miriade di chiese sconsacrate: venendo da Roma, è
quantomeno sorprendente. È un’occupazione dello spazio mai vista altrove, come se l’intera città,
per tre settimane, fosse una scena. Con la consapevolezza, la fiducia, che si può, si può far vivere
l’intero centro di una piccola capitale europea come un immenso stage per tre settimane.
C’è spazio anche per la fringe del Fringe: sulla piazza del Mound, gli attori di strada
orgogliosamente rivendicano di non ricevere denaro “né dal governo, né dal Fringe, né da altre
organizzazioni criminali”. Più off del festival off.
Il ritorno, l’orientamento.
Agosto 2002. 26 anni, appena laureato.
A Edimburgo quest’estate lavoro dopo una faticosa laurea in Lettere. Edinburgh Castle, in cima alla
collina, guida turistica. Pregusto il Festival da Edimburghese, da local. E così anche i miei colleghi
scozzesi. “Ci pensi?” mi dice Jamie, guida turistica a tempo pieno, cantautore nel tempo libero, “da
domani si beve fino alle 5 di mattina”. Per gli abitanti di Edimburgo, che per strada devono schivare
turisti distratti e distributori di volantini, il Fringe è un’invasione, una iattura, un problema, pur se
ricco. Un Colosseo o un Vaticano pieno di pellegrini concentrati nei vicoli stretti di una città di
provincia. Un’occasione per bere fino all’alba. Orari da Festival. Da settembre si torna alla
normalità.
Ora parlo meglio la lingua, conosco meglio la città, a Roma ho iniziato una scuola di teatro. Nel
calderone del Fringe ho qualche riferimento in più. Credo. Per scegliere gli spettacoli ora leggo
recensioni sul Guardian e sullo Scotsman, ma anche, ancora, vado a naso. A caso. Bello il volantino
de La Divina Commedia dei Derevo. Chi sono? Non lo so ancora. Non lo sa neanche la signora che
in prima fila, all’inizio dello spettacolo, ride: quel misto di generosità e superficialità dello
spettatore anglosassone che ci mette un po’ per arrivare al tuning, a una corretta accordatura, a
sentire cosa sta succedendo. In compenso, a differenza dello spettatore italiano, l’anglosassone non
passa lo spettacolo a cercare di scoprire il trucco, l’errore, a interpretare, a recensire, a voler capire
tutto.
È uno spettacolo di physical theatre russo, teatro danza. Tre danzatori, le maschere dietro la testa li
rendono demoniaci, o angelici. Danzano il viaggio dell’anima attraverso il rosso denso dell’inferno
e la luce rarefatta del paradiso, su una piattaforma girevole che non si ferma mai. Alla fine dello
spettacolo io sono in lacrime, la signora ha smesso di ridere da un pezzo. Scoprirò poi che al Fringe
i Derevo vincono premi da anni. Ci ho azzeccato.
A volte ci si azzecca sbagliando. Su un giornale italiano portato da un amico leggo che c’è in scena
un testo di Mark Ravenhill. Io ho letto il famoso Shopping and Fucking, sono curioso. Lo
spettacolo, guarda un po’, è di nuovo alla “C Venue”. Ma i luoghi si muovono: scopro che la “C” è
una sorta di catena che promuove produzioni studentesche in diversi spazi. Li ho anche contattati
quando ancora cercavo lavoro: mi hanno offerto un posto full-time, sei settimane, tre di festival, tre
di preparazione, rimborso spese e posto letto. Ho rifiutato: voglio lavorare per mettere da parte
qualcosa. Col tempo scopro quanti studenti si fanno le ossa lavorando gratis nelle produzioni del
Fringe, negli uffici stampa, nei box office, come maschere. Anche di questo vive il festival.
Lo spettacolo di Ravenhill, A desire to kill on the tip of the tongue, è appunto una produzione
studentesca. Com’è possibile? Perché non l’hanno scritto nella recensione italiana? Ma l’hanno
visto? Ero andato a botta sicura, e invece… E invece è una produzione sì semi-professionale, ma
energetica, pulita. Non so se il giornalista l’ha visto, non importa. Ho cercato di orientarmi, mi sono
perso, mi sono ritrovato. Succede a tutti. La stessa estate una compagnia porta in scena un testo
intitolato A Beginner’s Guide to the Fringe, “Guida al Fringe per principianti”. Meta-Fringe. Per
orientarsi ci vuole tempo, soldi, fortuna. Io ho deciso di investire nel festival e vado a vedere anche
4-5 spettacoli al giorno nei giorni liberi.
Ci vuole coraggio per i performer, e fortuna, tempo e qualcosa da parte. Trovi produzioni amatoriali
completamente sold-out e professionisti con sale deserte. Nell’estate 2010 a una session folk aperta
in un pub del centro, il Sandy Bell’s, incontro un gruppo di musicisti galiziani, bravissimi. Vengono
dal loro concerto in un teatro di una certa importanza. Cartellone ricco, forse troppo: alla loro prima
data, mi raccontano, c’erano tre spettatori.
Ti perdi, ti ritrovi, ti riperdi.
I Grandi e le loro (non-)convenzioni
Agosto 2005. Primo pomeriggio.
L’estate in cui incontro il mio primo mostro sacro. Perché un attore e drammaturgo di fama
internazionale partecipa a un festival così pieno di tutto? Avrà un posto d’onore, una sala speciale,
un biglietto carissimo? Un orario “da teatro”? No. Alle 3 di pomeriggio, 10 sterline, all’Assembly
Hall, cioè l’aula magna della facoltà di teologia (!) della University of Edinburgh, Steven Berkoff
porta in scena Shakespeare’s villains, un monologo sui cattivi shakespeariani.
Gigioneggia, Berkoff, si diverte, tratteggia Lady Macbeth mimandone le curve e ipotetiche labbrone
siliconate. A metà spettacolo una coppia si alza in piedi da una delle file più avanzate e se ne va il
più silenziosamente possibile. Ma la sala è illuminata. Berkoff se ne accorge, e senza interrompere
la declamazione di un verso, li osserva allontanarsi e li saluta con la mano e un sorriso.
Meraviglioso. È tutto esaurito, anche se i biglietti sono riuscito a trovarli ancora il giorno prima. E
alla fine, un giro di applausi, e via, si esce subito. È perché si smonta tutto, si monta un altro
spettacolo, senza sosta. Ma il singolo giro d’applausi è prima di tutto una prassi britannica: mica
devi per forza uscire tre, quattro, cinque, sei volte a farti dire quanto sei bravo. Altri luoghi altra
ritualità.
Che il rapporto con il pubblico qui segua convenzioni diverse lo osservo di nuovo due anni più
tardi. E’ l’Agosto del 2007. 9 di mattina. Sono qui da turista. Ho costretto me stesso e Viviana, che
mi ospita, a svegliarci presto. Non sappiamo neanche se troveremo ancora i biglietti, l’idea c’è
venuta all’ultimo momento. Ma davvero rischiamo di non trovare posto? Ma chi ci va a teatro alle 9
di mattina?
Ce la facciamo per un pelo, due biglietti restituiti al botteghino. Quando entriamo, è tutto pieno. Di
nuovo Ravenhill, ma questa è una chicca. Ravenhill for breakfast, colazione inclusa, caffè e panino
con salsiccia e uova strapazzate che ti puoi portare in sala. Che c’è di strano? C’è il ricordo della
prima volta a teatro con la scuola: qui non è come al cinema, non si mangia in sala, non si beve.
Eppure qualche anno fa avevo visto Shakespeare for breakfast, un classico in scena al Fringe da 20
anni, 45 minuti di spezzoni shakespeariani per bambini e ragazzi, caffè e ciambella compresi nel
prezzo. O latte e cereali, a scelta. E le pinte di birra in sala sono un classico.
Insomma, Ravenhill for breakfast. L’autore presenta un testo nuovo ogni giorno per una settimana.
Gli attori lo portano in scena a mo’ di reading. Ma non rischia di bruciarsi, autore giovane, testi
nuovi, non rodati, al mattino, al festival più grande d’Europa? Anche la disponibilità al rischio è un
marchio di fabbrica anglosassone. Andando a sedermi quasi inciampo nel mio vicino. Mi scuso.
Quando lo spettacolo sta per iniziare, il mio vicino si alza per andare a presentare lo spettacolo. Il
suo spettacolo. Ero seduto vicino alla star, e non lo sapevo. Con un caffè, e un panino con salsiccia
in mano. So much for formality.
Agosto 2010. 17 anni dopo.
Vivo a Ediburgh da due anni: prima da studente di Master in antropologia, poi da tutor-libraio-
traduttore. Carriera degli anni 2000. Devo aggiungere anche musicista-storyteller: così mi sono
presentato al mio pubblico l’estate scorsa in una breve serie di concerti da Henderson’s, un locale
nel West End di Princes St. Non ero nel programma del festival, si paga troppo caro per comparire.
Ma insomma, sette serate spalmate su tre settimane ad agosto sono una partecipazione al Fringe.
Rileggo i miei appunti e cerco un filo nelle storie (e ce ne sono molte altre) che da 17 anni mi
diverto a raccontare a chi il Fringe non l’ha mai vissuto. Cosa si cerca al Fringe? Cosa sono queste
quantità, disorientamento, disponibilità, diverse ritualità, casualità, professionalità, e questa ubiquità
del festival?
Una possibilità. La possibilità di vivere dentro arte e cultura.
Non è solo e non tanto la possibilità di incontrare il Grande o di scoprire il Nuovo (spettacolo,
attore, testo. Sembra quasi di sentire la domanda del critico: “chi c’è quest’anno al Fringe? Quali
sono le ‘nuove tendenze’ del teatro inglese?”). Non è detto che succeda.
È più la sensazione, che mi è rimasta anche al mio settimo Fringe, di essere immersi in una scena,
in uno spazio teatrale totale, in un extra-quotidiano che diventa quotidiano. Una ri-ritualizzazione di
tempi e luoghi che non può non cambiare chi ne entra a far parte, da spettatore o da performer.
Fosse anche solo questo – entrare in uno scantinato e scoprire che è un teatro, o veder danzare
studenti in una chiesa nello spazio in cui solo un secolo fa c’era un altare – vale la pena di venire a
vedere cosa succede.
La mia giornata ideale al Fringe, assolutamente naif, rimane la stessa da quando avevo 17 anni.
Vagare per il Royal Mile, raccogliere volantini, sfogliare il programma, leggere le recensioni del
giorno, fare la fila al box office per uno spettacolo noto e uno ignoto, mangiare in strada di fronte ai
giocolieri, appuntare tutto e perdere gli appunti, spendere troppo, entrare in tre venue diverse.
Lasciarsi sorprendere. Cercare un filo, piuttosto che trovarlo.
Non è questo il senso della ricerca artistica?