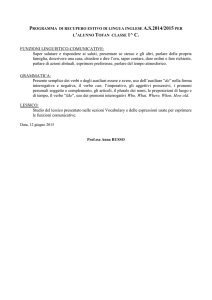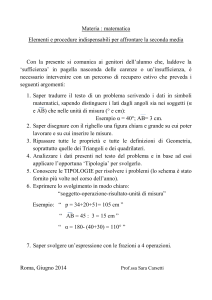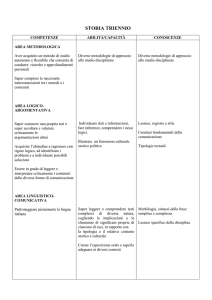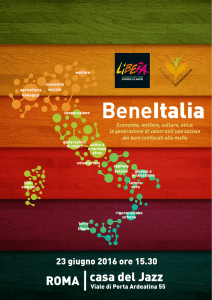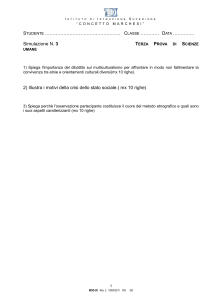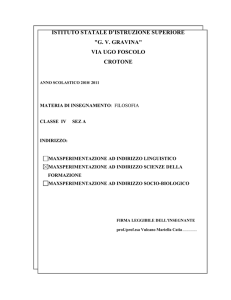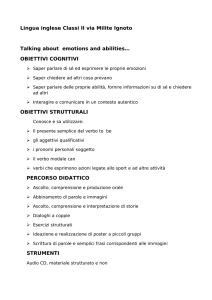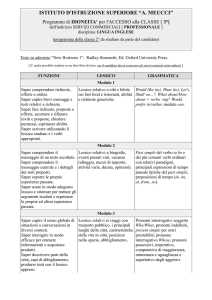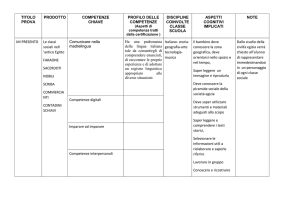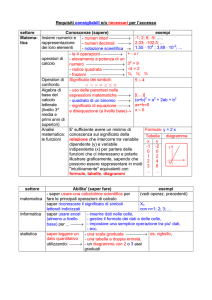Liceo Scientifico Statale “ Manfredo Fanti ”
viale Peruzzi, 7 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059.691177/691414 - Fax. 059 641109
e-mail: [email protected]
pec: [email protected]
C. F. 81001160365
Sito web: www.liceofanti.it
Prot. n.4960/G
Carpi.11 Maggio 2016
ESAMI DI STATO A.S. 2015/2016
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(art. 5 comma 2 D.P.R 23/07/1998 N° 323)
PERCORSO FORMATIVO COMPLESSIVO
DELLA CLASSE 5^ SEZIONE Q
INDIRIZZO SCIENZE UMANE
Opzione Economico sociale
1
SOMMARIO
1)
Finalità formative della scuola
2) Finalità specifiche dell’indirizzo
3) Profilo formativo in uscita
4) Obiettivi educativi e cognitivi comuni
5) Piano di studi della classe
6) Continuità didattica nel triennio
7) Storia della classe
8) Profilo della classe
9) Percorso formativo
9.1 Contenuti
9.2 Attività intercurricolari
9.3 Metodi
9.4 Mezzi
9.5 Spazi
9.6 Tipologie di verifica
9.7 Criteri di valutazione
10) I docenti del Consiglio di classe
11) I membri interni della Commissione per l'Esame di Stato
12) Allegati: Simulazioni prove d’esame
2
1. LE FINALITÀ FORMATIVE DELLA SCUOLA
Le finalità formative esplicitano i valori a cui si ispirano le scelte della scuola e che la scuola
intende promuovere negli studenti.
Esse definiscono il quadro di riferimento entro cui si collocano i singoli interventi formativi e
didattici; si traducono negli obiettivi che vengono fissati in sede di programmazione dai
Dipartimenti, dai Consigli di Classe e dagli insegnanti delle diverse discipline.
Finalità e obiettivi si distinguono per i tempi di realizzazione, per il grado di specificità, di precisione
e di verificabilità.
Mentre le finalità sono traguardi a lungo termine verso cui tendere, che non necessariamente si
conseguono nell'arco del quinquennio e che comunque non è possibile definire, osservare e
misurare in modo preciso, gli obiettivi sono comportamenti precisi, osservabili e misurabili e
coincidono con ciò che lo studente deve saper fare al termine di ogni tappa (unità didattica,
quadrimestre, anno di corso, biennio, triennio) del percorso formativo e didattico.
Finalità Formative
1.
Valorizzare la cultura della
democrazia e della pace
2.
Educare al rispetto e alla
valorizzazione della diversità
3.
Educare alla salute e al rispetto
dell’ambiente
4.
Stimolare la motivazione
all’apprendimento e allo studio
5.
Prevenire l’insuccesso
scolastico e favorire la
prosecuzione degli studi
6.
Promuovere la progettualità e
l’autonomia degli studenti
7.
Promuovere l’autovalutazione e
l’autostima
3
Strategie di Intervento
a. Favorire la conoscenza storica e civile dei valori
democratici
b. Offrire occasioni di dibattito democratico
c. Sostenere la partecipazione attiva agli organi della
scuola come punto di partenza di una cultura civica
a. Favorire la comprensione delle altre culture attraverso
l’apprendimento linguistico
b. Attivare esperienze educative che promuovano il senso
di solidarietà e scoraggino atteggiamenti pregiudiziali
c. Realizzare esperienze concrete che stimolino la
conoscenza e il rispetto delle diversità
a. Attuare programmi di prevenzione (contro alcolismo,
fumo, droga, AIDS, ecc.) in collaborazione con le
strutture socio-sanitarie competenti
b. Individuare la valenza formativa di ciascuna disciplina in
relazione ai vari programmi di prevenzione attuati
c. Realizzare programmi di raccolta differenziata e di
risparmio energetico
d. Valorizzare gli spazi verdi
a. Valorizzare la valenza formativa di ogni disciplina
b. Favorire attraverso i contenuti disciplinari lo sviluppo e il
riconoscimento di attitudini e potenzialità individuali
a. Acquisire tutte le informazioni utili per la valutazione del
curricolo degli studenti (fascicolo personale, P.O.F. delle
scuole di provenienza, programmi ministeriali, etc.)
b. Attivare progetti di accoglienza
c. Individuare strategie di sostegno e attività di
potenziamento
d. Armonizzare la programmazione fra biennio e triennio
e. Facilitare occasioni di colloqui, anche individuali, fra
studenti e insegnanti
a. Fornire occasioni per imparare a progettare
b. Fornire metodologie per il reperimento e l’utilizzo delle
informazioni
c. Sostenere la realizzazione di progetti verificabili
d. Stimolare l’acquisizione del senso di responsabilità
personale
a. Illustrare agli studenti gli obiettivi educativi/didattici e i
criteri di valutazione adottati
b. Favorire la consapevolezza degli studenti in merito alla
dinamica del loro processo di apprendimento e al livello
di competenza raggiunto
a. Stimolare le modalità di lavoro di gruppo, nel gruppo
classe o in un contesto di classi aperte
b. Favorire il dibattito democratico fra pari
c. Educare all’ascolto e alla riflessione
8.
Sviluppare competenze
relazionali e disponibilità
all’apprendimento permanente
9.
Valorizzare ed indirizzare
attitudini ed interessi personali
a. Stimolare attività creative ed espressive (teatro, musica,
etc.)
b. Sostenere attività di laboratorio (fisica, chimica,
informatica)
c. Favorire la realizzazione di prodotti multimediali
10.
Assicurare un raccordo fra
scuola e realtà socio-culturale
circostante
a. Predisporre spazi e tempi di scambio con la realtà socioculturale circostante, con particolare riferimento agli
interessi giovanili (corsi, incontri, partecipazione a
spettacoli, ecc.)
b. Sviluppare il concetto di cittadinanza europea e globale e
di comunità di pari opportunità
11.
Favorire la prosecuzione degli
studi
a. Organizzare attività di orientamento implicito ed esplicito
b. Predisporre contatti con Università ed Enti preposti alla
formazione
c. Sviluppare capacità di ricerca e gestione delle
informazioni
d. Educare alla scelta
2. LE FINALITA' SPECIFICHE DELL'INDIRIZZO
L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli
studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni ai vari indirizzi, dovranno:
4
conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;
comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse
di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;
individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione
dei fenomeni culturali;
sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi
teorici;
utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;
saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le
istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella
globale;
avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
3. PROFILO FORMATIVO IN USCITA
Area metodologica
Area logico-argomentativa
Area linguistica e
comunicativa
Area storico umanistica
5
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di
continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo
l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari
ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i
contenuti delle singole discipline.
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare
criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i
problemi e a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di comunicazione.
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli
elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico,
anche letterario e specialistico), modulando tali
competenze a seconda dei diversi contesti e scopi
comunicativi;
o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la
tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi
contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità
e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri
che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici
e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel
contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni
nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione,
scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e
strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici,
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l’analisi della società
contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione
letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea
attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
Area scientifica, matematica
e tecnologica
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua
importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della
conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo
sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della
storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della
civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica,
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico,
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base
della descrizione matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.
4. OBIETTIVI EDUCATIVI E COGNITIVI COMUNI
a - obiettivi comportamentali
1. Regolarità della frequenza
2. Interesse e partecipazione al lavoro
2.1 segue con attenzione
2.2 interviene in modo pertinente
2.3 collabora a recupero e potenziamento
3. Responsabilità nell’atteggiamento scolastico
3.1 esegue i compiti e studia regolarmente
3.2 programma il proprio lavoro
3.3 porta il materiale
4. Relazionalità con i compagni e col personale scolastico, rispetto delle
attrezzature e dell’edificio scolastico
6
b - obiettivi cognitivi
CONOSCENZE Padronanza dei contenuti disciplinari e/o pluridisciplinari
Linguistiche generali (morfosintassi e lessico)
Logico–argomentative (coerenza e organicità)
COMPETENZE Tecniche e procedurali
Analisi
Sintesi
Elaborazione critica
CAPACITÀ
Organizzazione del lavoro individuale e/o di gruppo
7
1. PIANO DI STUDI DELLA CLASSE 5^Q
1°biennio
1°
anno
2°
anno
2°biennio
3°
anno
4°
anno
5°
anno
TIPO DI
PROVE
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale
Lingua e letteratura italiana
4
4
4
4
4
SO
Storia e geografia
3
3
-
-
-
O
Storia
-
-
2
2
2
O
Filosofia
-
-
2
2
2
O
Scienze umane *
3
3
3
3
3
SO
Diritto ed economia politica
3
3
3
3
3
SO
Lingua e cultura straniera 1 (inglese)
3
3
3
3
3
SO
Lingua e cultura straniera 2 (spagnolo)
3
3
3
3
3
SO
Matematica *
3
3
3
3
3
SO
Fisica
-
-
2
2
2
O
Scienze naturali ***
2
2
-
-
-
O
Storia dell’arte
-
-
2
2
2
O
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
2
P
Religione/A.A.
1
1
1
1
1
O
27
27
30
30
30
Totale ore
*Psicologia, Antropologia, Sociologia e Metodologia della ricerca
**con informatica nel primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienza della Terra
8
2. CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO
DENOMINAZIONE MATERIE
Classe 3^
Classe 4^
Classe 5^
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
C
A
A
A
A
A
A
Lingua e letteratura italiana
Storia
Filosofia
Scienze umane
Diritto ed economia politica
Lingua e cultura straniera 1 (inglese)
Lingua e cultura straniera 2 (spagnolo)
Matematica
Fisica
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
Religione/A.A.
N.B. L’uso di lettere uguali indica continuità didattica dello stesso docente.
9
3. STORIA DELLA CLASSE 5^ SEZIONE Q
COMPOSIZIONE
Totale
Alunni
ESITI
Di cui
Ripetenti
Provenienti da altra
scuola/altro corso
interno
M
F
M
F
M
F
Respinti
M
Promossi con debito
formativo
Ritirati o trasferiti
F
M
F
M
F
2
5
2
/
5
1° ANNO
2010/11
26
8
18
4
3
/
/
2° ANNO
2011/12
25
8
17
/
/
/
/
1
1
6
2
/
2
3° ANNO
2012/13
26
7
17
1
4
/
/
2
2
2
4
1
1
4° ANNO
2013/14
20
5
15
/
/
/
/
/
/
4
4
/
/
5° ANNO
2014/15
10
5
15
/
/
/
/
10
4. PROFILO DELLA CLASSE
La classe è composta attualmente da 20 alunni: 5 ragazzi e 15 ragazze.
Nel corso del curricolo il gruppo classe ha subito alcune modifiche. L’attuale composizione
è rimasta invariata negli ultimi due anni.
Gli alunni hanno raggiunto nel complesso gli obiettivi educativi e didattici fissati dal
Consiglio di Classe in sede di programmazione e corrispondenti al Piano dell’Offerta
Formativa di Istituto. La maggior parte ha dimostrato di saper partecipare al dialogo
educativo e scolastico in modo corretto e propositivo in tutte le discipline. Frequenza
scolastica e impegno individuale differenziati, capacità ed interessi diversificati nelle varie
discipline hanno portato gli allievi a livelli di competenza e di profitto eterogenei. Vi sono
studenti che hanno raggiunto un grado di conoscenza dei contenuti disciplinari e
trasversali decisamente buono, con punte di eccellenza, dimostrando anche una certa
curiosità intellettuale e un’autonoma capacità di orientamento nelle varie discipline. Grazie
ad uno studio diligente e costante, dalla maggior parte della classe, è stato raggiunto un
profitto più che sufficiente, benché si rilevi una scarsa rielaborazione personale dei
contenuti. Qualche alunno ha mantenuto alcune fragilità nella preparazione, attestandosi
su risultati appena sufficienti ed evidenziando alcune lacune nel lessico specifico delle
discipline .
11
9. PERCORSO FORMATIVO
9.1 Contenuti
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
U.D. 1 Preromanticismo e Neoclassicismo. Caratteri generali ed elementi di poetica.
U.D. 1, 1 Ugo Foscolo. Biografia e opere scelte.
U.D. 2 Il Romanticismo. Caratteri generali ed elementi di poetica. Testi scelti.
U.D. 2, 1 Giacomo Leopardi. Biografia e opere scelte.
U.D. 2, 2 Alessandro Manzoni. Biografia e opere scelte.
U.D. 3 La crisi del Romanticismo.
U.D. 4 Naturalismo e Verismo. Caratteri generali ed elementi di poetica.
U.D. 4, 1 Giovanni Verga. Biografia e opere scelte.
U.D.5 Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo. Caratteri generali ed elementi di
poetica.
U.D. 5, 1 Giovanni Pascoli. Biografia e opere scelte.
U.D. 5, 2 Gabriele D’Annunzio. Biografia e opere scelte.
U.D. 6 Le avanguardie storiche: Futurismo e Crepuscolarismo.
U.D. 7 Italo Svevo. Biografia e opere scelte.
U.D. 8 Luigi Pirandello. Biografia e opere scelte.
U.D. 9 Poeti e poetiche del Novecento: Saba, Ungaretti e Montale.
Testi scelti dalle principali raccolte poetiche di ciascun autore.
U.D. 10 Dante Alighieri, Divina Commedia, analisi e commento dei seguenti canti del
Paradiso:
I, III e VI (per intero); la trilogia di Cacciaguida:
XV, vv. 25-72; vv.85-120; vv.130-135;
XVI, vv. 1-34; 49- 51;
XVII, vv. 1-36; 46- 93; 112- 142
12
Produzione scritta: esercitazioni e verifiche sulle diverse tipologie degli Esami di Stato:
analisi di un testo letterario, tema di attualità, testo argomentativo, tema storico.
Testi utilizzati per le lezioni:
G. Baldi- S. Giusso- M.Razetti- G. Zaccari, Il Piacere dei Testi (Volumi 4, 5, 6 e Giacomo
Leopardi), Paravia, con integrazioni tratte da: Luperini- Cataldi- Marchiani- Marchese,
La scrittura e l'interpretazione, vol 3- tomo I: Naturalismo e Simbolismo.
Dante Alighieri, edizione a scelta per gli alunni. L'insegnante si è avvalsa dell'edizione
antologica: Divina Commedia, La mente innamorata, a cura di Gianluigi Tornotti, Bruno
Mondadori.
STORIA
U.D.1
-
Liberalismo e socialismo
Il socialismo “utopistico”: Owen, Saint-Simon, Fourier, Blanqui, Blanc, Proudhon.
Marx ed Engels: Il Manifesto del Partito comunista.
Origini e sviluppo del pensiero liberale (XVII-XIX sec.).
J. S. Mill e A. de Tocqueville.
U.D.2 Il compimento del processo di unificazione in Italia e Germania
- L’unificazione tedesca e la nascita del Reich.
- Cavour e l’unificazione italiana.
- La politica della Destra storica.
- I problemi dell’Italia post-unitaria.
- La questione romana e la sua soluzione.
- I presupposti economico-sociali del cambio di maggioranza.
- La politica della Sinistra storica.
- L’ingresso dei cattolici nella vita politica italiana e la Rerum Novarum.
U.D.3 L’Europa tra due secoli
- Gli aspetti contradditori della Belle Epoque: il suffragio universale e l’avvento della
società di massa, la diffusione dell’istruzione e della stampa, lo sviluppo industriale
e la razionalizzazione produttiva, la questione femminile, i partiti socialisti e la
Seconda Internazionale, il nuovo nazionalismo e le teorie razziste.
- Il nuovo sistema di alleanze: la Triplice alleanza e la Triplice intesa, la Germania
guglielmina, i conflitti nazionali nell’Impero austro-ungarico, la rivoluzione russa del
1905, le crisi marocchine e le guerre balcaniche.
- L’Italia giolittiana, il movimento nazionalista e la guerra di Libia
13
U.D.4
-
-
La prima guerra mondiale
Le cause del conflitto e i rapporti di alleanza.
1914-1915: dalla guerra di movimento alla la guerra di usura e logoramento.
Il dibattito italiano tra interventisti e neutralisti e l’entrata in guerra dell’Italia.
1915-1916: le battaglie dell’Isonzo, la guerra di trincea, le nuove tecnologie militari,
il fronte interno e la propaganda, lo sterminio degli Armeni, la guerra sottomarina, l’
“inutile strage”.
1917: l’intervento degli Stati Uniti, la crisi dell’esercito russo dopo la rivoluzione
d’Ottobre, la disfatta italiana di Caporetto.
1918: la pace di Brest-Litovsk, il programma di pace di Wilson, la resa degli imperi
centrali.
I trattati di pace: pace democratica e pace punitiva, la dissoluzione dei grandi
imperi, le nuove nazioni, la Società delle nazioni.
U.D.5
-
La rivoluzione russa e lo stalinismo
La rivolta degli operai e dei soldati di Pietrogrado.
Lenin e le tesi di Aprile.
La rivoluzione d’Ottobre.
La stretta autoritaria del regime rivoluzionario bolscevico.
La guerra civile.
La Terza Internazionale e la nascita dei partiti comunisti.
Il comunismo di guerra e la NEP.
La nascita dell’URSS.
L’ascesa di Stalin, l’industrializzazione forzata e la collettivizzazione dell’agricoltura.
Lo stalinismo e le “grandi purghe”.
U.D.6
-
Il fascismo
I problemi del dopoguerra in Italia, la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume.
Il “biennio rosso” in Italia.
I Fasci di combattimento e lo squadrismo agrario.
La conquista del potere: la nascita del Pnf, la crisi dello Stato liberale e la marcia su
Roma.
La politica autoritaria di Mussolini, le elezioni del ’24 e il delitto Matteotti, le leggi
“fascistissime” e l’avvento della dittatura.
Il totalitarismo imperfetto.
Il consolidamento del regime: la fascistizzazione della società, il controllo
dell’istruzione e della stampa, il corporativismo e la politica economica, la politica
estera e l’Impero, l’Asse Roma-Berlino.
L’antifascismo.
-
U.D.7
14
Il nazismo
Il “biennio rosso” in Europa e l’insurrezione spartachista in Germania.
La nascita della Repubblica di Weimar.
La difficile situazione economica e l’onere delle riparazioni di guerra.
-
L’offensiva della destra e del Partito nazionalsocialista, Hitler e il “putsch” di
Monaco.
Il Mein Kampf e l’ideologia nazista.
1929-1933: la crisi economica, il collasso delle istituzioni liberali e l’avvento al
potere di Hitler.
Il Terzo Reich: Hitler capo dello stato, le organizzazioni di massa, le persecuzioni
antisemite e le pratiche eugenetiche, l’apparato repressivo e la propaganda.
U.D.8 L’Europa e gli Stati Uniti fra le due guerre
- Stati Uniti: la ripresa economica degli anni ’20, il crollo della borsa e la crisi
economica, Roosevelt e il New Deal.
- I regimi autoritari nell’Europa centro orientale e balcanica.
- La guerra civile spagnola.
U.D.9 La seconda guerra mondiale
- L’espansionismo hitleriano e la politica delle annessioni, la politica dell’appeasement di Francia e
Inghilterra.
- Il “patto d’acciaio” e il patto tedesco-sovietico di non aggressione.
- L’invasione della Polonia, la conquista della Francia e la Repubblica di Vichy.
- 1940-1941: l’Italia in guerra, la battaglia d’Inghilterra, l’invasione dell’Urss,
l’espansionismo giapponese e l’intervento degli Stati Uniti.
- La persecuzione degli ebrei e la “soluzione finale”.
- 1942-43: la svolta della guerra, la caduta del fascismo e l’armistizio, la Repubblica
sociale italiana, l’occupazione tedesca dell’Italia, la Resistenza e il Cln.
- 1944: lo sbarco in Normandia, l’avanzata dell’Armata Rossa, la sconfitta della
Germania e la liberazione, l’offensiva americana nel Pacifico e la bomba atomica.
- Il processo di Norimberga.
U.D.10 L’Italia della prima repubblica
- Il dopoguerra in Italia: il referendum e l’Assemblea costituente, le elezioni del 1948.
- Gli anni del centrismo.
- Il miracolo economico.
- Il centro-sinistra.
- Il compromesso storico.
- Gli anni di piombo.
_______________________________________________________________________
Nell’ambito del modulo CLIL (insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua
straniera) sono state affrontate le seguenti unità didattiche, secondo le modalità indicate
nell’apposita sezione del documento:
U.D.11 La guerra fredda
- Le conseguenze della seconda guerra mondiale.
15
-
La fine della “grande alleanza” e la divisione dell’Europa in sfere d’influenza.
Il patto atlantico e il patto di Varsavia.
Il muro di Berlino.
U.D.12 Il conflitto arabo-palestinese
- La nascita dello Stato d’Israele. Origine e sviluppo del confitto.
- Le guerre arabo-israeliane.
- Il processo di normalizzazione e gli accordi di pace.
- L’impegno di Y. Rabin a favore del processo di pace.
U.D.13 La discriminazione razziale e la lotta per i diritti civili in Sudafrica e negli
Stati Uniti d’America
- Gli Stati Uniti negli anni Sessanta.
- Origini e caratteristiche della discriminazione razziale negli Stati Uniti d’America.
- Martin Luther King e la lotta per i diritti civili degli afroamericani.
- Origini e caratteristiche della segregazione razziale in Sudafrica (apartheid).
- Nelson Mandela e la lotta per i diritti civili dei neri.
FILOSOFIA
U.D.1 L’idealismo tedesco
- J. G. Fichte: i tre principi della «dottrina della scienza», la struttura dialettica dell’io,
dogmatismo e idealismo, l’idealismo etico, la «missione» del dotto, il pensiero
politico e la missione del popolo tedesco.
- F. W. J. Schelling: la critica a Fichte, la filosofia della natura (il rifiuto del
meccanicismo e del finalismo, la spiritualità della natura), il sistema dell’idealismo
trascendentale, la teoria dell’arte.
- G. W. F. Hegel: gli scritti giovanili, i capisaldi del sistema hegeliano, la dialettica, la
critica a Fichte e Schelling, la Fenomenologia dello spirito (coscienza,
autocoscienza, ragione), l’Enciclopedia delle scienze filosofiche (delle tre sezioni –
logica, filosofia della natura e filosofia dello spirito – è stata trattata in modo
approfondito solo quest’ultima e in particolare le parti dedicate allo spirito oggettivo
e allo spirito assoluto).
U.D.2 La reazione critica all’idealismo
- A. Schopenhauer: fenomeno e noumeno, il «velo di Maya» e la volontà di vivere, le
caratteristiche della volontà di vivere, il pessimismo e l’opposizione irrazionalistica
all’ottimismo panlogistico di Hegel, le vie di liberazione dal dolore.
U.D.3 Dalla filosofia posthegeliana al marxismo
- Caratteri generali della Destra e della Sinistra hegeliana.
- D. F. Strauss e la riduzione del cristianesimo a mito.
16
-
-
L. Feuerbach: la critica all’hegelismo come teologia razionalizzata, l’origine dell’idea
di Dio nell’uomo, la religione come antropologia capovolta, l’alienazione religiosa e
l’ateismo, il materialismo antropologico.
K. Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica allo Stato moderno e al
liberalismo, la critica all’economia borghese, la critica alla Sinistra hegeliana, il
confronto con Feuerbach e l’interpretazione della religione come “oppio dei popoli”,
il materialismo storico, l’alienazione socio-economica, il rapporto tra struttura e
sovrastruttura, la concezione dialettica della storia, l’analisi scientifica del sistema
capitalistico, l’origine del plusvalore, le contraddizioni del capitalismo e la caduta
tendenziale del saggio del profitto, la lotta di classe, la rivoluzione comunista, la
dittatura del proletariato e l’avvento del comunismo.
U.D.4 Il Positivismo
- Caratteri generali del positivismo.
- A. Comte: la legge dei tre stadi, la classificazione delle scienze, la fondazione della
sociologia e la divinizzazione della scienza.
- L’evoluzionismo di C. Darwin.
- Il positivismo evoluzionistico di H. Spencer.
U.D.5 F. Nietzsche
- Il periodo giovanile: apollineo e dionisiaco, la nascita e la decadenza della tragedia
greca, la critica all’intellettualismo filosofico di Socrate, la funzione dell’arte e della
musica, la critica allo storicismo e allo storiografismo.
- Il periodo “illuministico”: la filosofia del mattino, il metodo genealogico e la critica
della morale, l’«uomo folle» e l’annuncio della «morte di Dio».
- Il superamento del nichilismo: lo smarrimento dell’uomo di fronte alla morte di Dio,
l’annuncio di Zarathustra e l’avvento dell’oltreuomo, la filosofia del meriggio,l’eterno
ritorno e la volontà di potenza.
U.D.6 S. Freud e la rivoluzione psicoanalitica
- Gli studi sull’isteria e il “metodo catartico”, la scoperta dell’inconscio e il concetto di
“rimozione”.
- Le due topiche della psiche umana, le cause delle nevrosi e le vie di accesso
all’inconscio (sogni, lapsus, errori, atti mancati), la terapia psicoanalitica.
- La teoria della sessualità: la libido, la sessualità infantile e le sue tre fasi, il
complesso edipico.
- La teoria psicoanalitica dell’arte.
- Una nuova concezione della società e della morale.
U.D.7 L’epistemologia di Karl Popper
- K. Popper: l’opposizione al neopositivismo, il principio di falsificabilità delle teorie
scientifiche, la critica al marxismo e alla psicoanalisi, il procedimento per
«congetture e confutazioni», la critica al metodo dell’induzione.
17
UD.8 La riflessione sui totalitarismi del Novecento
- K. Popper: società chiusa e società aperta, la critica dello storicismo, i caratteri della
democrazia.
- H. Arendt: l’origine e lo sviluppo dei totalitarismi, il concetto di «banalità» del male.
- H. Jonas: il problema della teodicea dopo Auschwitz, il principio di responsabilità.
SCIENZE UMANE
Storia dell’Antropologia del Novecento (settembre/ ottobre)
-
Lo strutturalismo di Levi Strauss: studi sulla linguistica, unità elementare della
parentela, inconscio strutturale, analisi e studio del mito
-
Crisi dell’antropologia classica, nuovo approccio e nuovi metodi di ricerca a partire
dagli anni ’70, nascita della scuola interpretativa
-
Scuola interpretativa di Geertz: definizione di cultura, interpretazione dei fenomeni
culturali, importanza della scrittura etnografica, paradosso dell’osservazione
partecipante e nascita del metodo dell’osservazione della partecipazione.
-
Antropologia dialogica (tratti generali)
-
Marc Augè: società surmoderna, accelerazione della storia e restringimento del
pianeta, luoghi e non luoghi
Globalizzazione (novembre)
-
Che cos’è la globalizzazione
-
Le forme della globalizzazione
-
L’antiglobalismo e movimento no-global
-
Globalizzazione: nuove regole, nuovi attori, nuovi mercati
-
Globalismo, scetticismo e trasformazionalismo
-
Questioni globali (esempi), i principali punti sulla globalizzazione secondo Amartya
Sen
-
Globalizzazione
La disuguaglianza nella società globalizzata (dicembre)
18
-
Sviluppo umano e disuguaglianza
-
Indice di sviluppo umano (ISU)
-
Altri indicatori specifici: indicatore di sviluppo di genere (ISG), indicatore di povertà
umana (IPU)
-
Da dove viene la povertà (Jeffrey Sachs e Vandana Shiva a confronto)
-
Amartya Sen (Sviluppo e libertà, funzionamenti e capacitazioni)
-
Il problema del debito
-
Disuguaglianza e stratificazione sociale
-
Nuove povertà ( bassa intensità del lavoro, deprivazione materiale,..)
-
Come cambia la famiglia, le nuove strutture strutture famigliari
Lettura di alcuni passaggi contenuti nell’opera di Amartya Sen “La libertà individuale
come impegno sociale” Laterza
Le trasformazioni economiche nel passaggio dalla società moderna a quella
contemporanea (gennaio)
-
Il fordismo
-
La crisi del fordismo e l’avvento del postfordismo
-
Un nuovo modo di produrre, il nuovo consumo e il nuovo mercato del lavoro
-
Esternalizzazione e delocalizzazione
-
Flessibilità nel lavoro
-
Precarietà del lavoro
-
Lavoro atipico
I contenuti di quest’ultimo modulo sono stati tratti anche dall’opera “Capire la
società contemporanea” di D.Ungaro, Carocci Editore
Welfare State e Terzo Settore (gennaio/febbraio)
19
-
Definizione
-
Origine ed evoluzione dello Stato sociale: i primi interventi in materia di Welfare
State in Germania, Rapporto Beveridge, l’età d’oro del Welfare
-
La crisi del Welfare State (finanziaria, organizzativa e di legittimità)
-
Dal Welfare fordista al Welfare attivo\promozionale, Amartya Sen e le capabilities
-
Le politiche sociali (principali aree d’intervento)
-
Le politiche sociali in Italia
-
Modelli di Welfare: la tipologia di Titmuss (modello residuale, rimunerativo,
ridistributivo), la tipologia di Esping-Andersen ( regime liberale, socialdemocratico e
conservatore)
-
Fattori di crisi del Welfare State (i cambiamenti economici, demografici, di
legittimità)
-
L’alternativa al Welfare (la nascita del privato sociale, che cos’è il Terzo Settore,
attori e limiti)
-
Nuove prospettive per il Welfare ( Welfare mix, strategia europa 2020)
Lettura di alcuni passaggi contenuti nell’opera di Amartya Sen “La libertà individuale
come impegno sociale” Laterza
Storia della Sociologia del Novecento (aprile)
-
La migrazione della Sociologia in America all’inizio del Novecento
-
La Scuola di Chicago: William Thomas, F. Znaniecki e lo studio sul contadino
polacco, la definizione di situazione e il teorema di Thomas
-
Talcott Parsons e lo struttural-funzionalismo (il sistema, la funzione, i tre postulati).
L’analisi funzionale di R.Merton.
-
Le teorie del conflitto: C.W.Mills e lo studio sullo sviluppo del ceto medio, la Scuola
di Francoforte e gli studi sulla società di massa, Dahrendorf e il conflitto di classe
-
L’approccio fenomenologico ( A.Schutz)
-
E. Goffman: l’approccio drammaturgico e lo studio sulle istituzioni totali
-
Il ritorno della Sociologia in Europa
-
Le caratteristiche della società postindustriale e postmoderna attraverso il
contributo di alcuni sociologi contemporanei (A.Touraine, Z.Bauman, A.Giddens e
U.Beck)
Flussi migratori (una parte a dicembre ed una a maggio)
20
Migrazione legale o clandestina, volontaria o forzata, temporanea o di lunga durata
-
Fattori di spinta e di attrazione
-
La società multiculturale: i fenomeni migratori, la differenza come valore, i
movimenti per i diritti civili degli anni ‘60/’70, dal sogno del meltingpot alla fine degli
ideali di assimilazione, la nascita del multiculturalismo e la politica delle differenze.
Diritti individuali e collettivi.
-
Omologazione e occidentalizzazione
La tesi dello scontro culturale, globalizzazione, ibridazione e multiculturalismo
Testi in adozione:
- Vincenzo Matera Angela Biscardi “Il manuale di Scienze umane. Antropologia. Secondo
biennio e quinto anno” Marietti Scuola
-Volontè,Magatti, Mora, Lunghi “Sociologia. Liceo delle Scienze Umane. Opzione
economico-sociale” Einaudi Scuola
-Simonetta Corradini, Stefano Sissa “Capire la realtà sociale” Zanichelli
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
Lo Stato e la Costituzione.
Gli organi costituzionali dello Stato.
La Pubblica Amministrazione.
La funzione giurisdizionale.
La comunità Internazionale.
L’unione europea e le sue istituzioni.
Le fonti del diritto dell’Unione europea.
La politica economica.
Le politiche di Welfare e il contributo del terzo settore.
Il commercio internazionale e la globalizzazione dei mercati.
L’impresa e l’ambiente.
LINGUA E CULTURA INGLESE
. THE ROMANTIC AGE
21
. William Wordsworth, The Preface to the second edition of the “Lyrical Ballads”, “ I
wandered lonely as a Cloud”, “She Dwelt among the Untrodden Ways”, “A slumber did
my Spirit Seal” from The Lucy Poems,
. Samuel Taylor Coleridge, “The Genesis of Lyrical Ballads” (from “BiographiaLiteraria”),
“The Rime of the Ancient Mariner”
. John Keats, two letters to Fanny Brawne, “Bright Star”, “Ode on a Grecian Urn”,
. THE VICTORIAN AGE
. Historical background
. Lord Alfred Tennyson , “The Lady of Shalott”, “Ulysses”
. The Victorian novel
. Charles Dickens, “Oliver Twist”, “Hard Times”, “Great Expectations”
. The Aesthetic Movement
.Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray”,
. Drama at the end of the Victorian Age
. George Bernard Shaw, “Pygmalion”
. MODERNIST FICTION
. James Joyce, “Araby”, “Eveline”, “The Dead” (from Dubliners),
.DYSTOPIAN NOVEL
.George Orwell, “Animal Farm”
. MODERNIST POETRY
.Wystan Hugh Auden, “Epitaph on a tyrant”, “Musée des Beaux Arts”
. POST-WAR DRAMA
. Samuel Beckett, “Waiting for Godot”
. John Osborne, “Look back in Anger”
. CONTEMPORARY NOVEL
. Ian McEwan, “Saturday”
.CONTEMPORARY POETRY
. Carol Ann Duffy, “Anne Hathaway”.
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
Testo in adozione:Contextosliterarios (Del Romanticismo a nuestrosdías), AA.VV., ed.
Zanichelli
22
EL SIGLO XIX
ROMANTICISMO.
Contextohistórico y marco social. La guerra de Independencia, las guerra carlistas, la
Revolución Gloriosa. De la sociedadestamental a la sociedad de clases.
Marco artístico y literario. Característicasgenerales: rasgos y temas.
La poesíaromántica.
JOSÉ DE ESPRONCEDA
La canción del pirata.
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
Biografía. Documental “Bécquerdesconocido”. History Channel.
Rima XXIII (Por una mirada un mundo..)
Rima I (Yo sé un himno gigante y extraño..)
Rima XI (Yosoyardiente, yosoy morena..)
Rima XLII (Cuando me lo contaronsentíelfrío..)
Leyenda: El monte de lasánimas
El Teatro romántico
JOSE ZORRILLA Y MORAL
Don Juan Tenorio: primera parte, actoprimero, escena XII; primera parte, acto IV, escena
III. Primera parte, acto IV, escena III, Escena IX, escena X. Segunda parte, actotercero,
escena II. Escenaúltima. Don Juan Tenorio de Zorrilla.
Escenas y secuenciaspelícula Don Juan Tenorio, decorados de S. Dalí.
REALISMO Y NATURALISMO
Marco literario del Realismo y del Naturalismo (prosa).
BENITO PÉREZ GALDÓS
Fortunata y Jacinta. Fragmentossacados del cap.III (pag.275), del cap.VI (pag.276), del
capítulo IX (pag.277). Pasajesfotocopias. Parte I, cap. IV; parte I, cap.V.
23
Película "Fortunata y Jacinta" sacada de la novela de Galdós.
LEOPOLDO ALAS CLARÍN.
La Regenta.Fragmentoscap.XIII(pag.280,281) y cap.XXX (pag.283), fotocopias.
LA GENERACIÓN DEL ’98.
MIGUEL DE UNAMUNO
Niebla: cap.VIII y XXXI (fotocopias)
ANTONIO MACHADO
Es una tarde cenicenta y mustia… (pag.326)
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
MANUEL RIVAS. La lengua de lasmariposas (obra completa)
Visión película "La lengua de lasmariposas" de José Luis Cuerda con Fernando
FernánGómez.
DICTADURA ARGENTINA
Visionado película "La noche de loslápices" (desaparecidos argentinos).
Madres de Plaza de Mayo. El Terrorismo de Estado en la dictadura militar argentina de
1976-1983. La apropriación de niños y bebés. Las abuelas de Plaza de Mayo. La justicia
en democracia, lasLeyes del perdón: Punto final y Obedienciadebida.
MATEMATICA
ANALISI
Funzioni e loro proprietà:
Definizione di funzione. Classificazione
Dominio. Gli zeri di una funzione ed il suo segno
Funzioni iniettive, suriettive, biettive, pari, dispari, funzioni crescenti e decrescenti;
periodiche. Funzioni composte.
Lettura di grafici.
Il limite e le continuità:
Gli intervalli e gli intorni:
Definizioni di limite e loro significato
Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno. Teorema del
confronto.
24
Enunciati dei teoremi sulle operazioni dei limiti.
Forme indeterminate
Condizioni per la determinazione degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui
Definizione di continuità e classificazione dei punti di discontinuità con esempi grafici .
Derivate e studio di funzioni:
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.
Definizione di derivata prima e suo significato geometrico.
Punti stazionari, punti angolosi, cuspidi (definizioni, esempi grafici, significato geometrico).
Derivate delle funzioni elementari.
Derivata di: una costante per una funzione; di una somma di funzioni; di un prodotto; di un
rapporto; di funzioni composte.
Massimi e minimi relativi ed assoluti.
Ricerca dei massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima.
Relazione fra derivabilità e continuità.
Flessi. Ricerca dei flessi a tangente orizzontale e a tangente obliqua con lo studio del
segno della derivata seconda.
Studio completo di funzioni intere, razionali fratte.
PROBABILITA’
Le diverse concezioni di probabilità: classica, statistica, assiomatica.
Si prevede di concludere con :la somma logica e la probabilità condizionata
Sono stati utilizzati i testi in adozione:
Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.azzurro vol. 4 Zanichelli.
Bergamini-Trifone-Barozzi Matematica.azzurro vol. 5 Zanichelli.
FISICA
La carica e il campo elettrico
Corpi elettrizzati e loro interazioni. Conduttori ed isolanti. Elettrizzazione per strofinio, per
contatto, per induzione. Polarizzazione dei dielettrici. La conservazione della carica. Legge
di Coulomb nel vuoto e nella materia.
Concetto di campo e vettore campo elettrico. Linee di forza.
Il campo elettrico di una carica puntiforme.
Il potenziale e la capacità
Energia potenziale elettrica: lavoro del campo elettrico.
Il campo di un conduttore in equilibrio elettrostatico
Le superfici equipotenziali e il potenziale elettrico nei conduttori in equilibrio elettrostatico,
il potere dispersivo delle punte.
La capacità di un conduttore. Condensatori.
La corrente elettrica continua
La corrente elettrica e la forza elettromotrice.
La resistenza elettrica e le leggi di Ohm.
25
Forza elettromotrice e differenza di potenziale, resistenze in serie ed in parallelo.
Energia e potenza elettrica.
Il magnetismo
Campi magnetici generati da magneti e da correnti: campi magnetici dei magneti, il campo
magnetico terrestre, campi magnetici delle correnti.
Interazioni magnete-corrente e corrente-corrente.
Il campo di induzione magnetica.
Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente.
Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche
Azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico
Le proprietà magnetiche della materia.
L’induzione elettromagnetica
Le esperienze di Faraday e le correnti indotte
La legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz.
Sono state effettuate alcune semplici esperienze: visualizzazione, tramite limatura di ferro,
delle linee di campo di alcuni magneti permanenti; interazioni corrente-corrente e
magnete-corrente.
E' stato utilizzato il testo in adozione:
Caforio-Ferilli Fisica! Le leggi della natura vol. 3 Le Monnier
STORIA DELL’ARTE
.
Fra Settecento e Ottocento
NEOCLASSICISMO
-La riscoperta dell'antico e le teorie di Winkelmann, il Grand Tour e l’amore per l’arte
classica. L'Encyclopédie di Diderot e D'Alambert.
J. L. David, A. Canova
Ottocento
PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO
L'artista genio, tormentato e istintivo. L'espressione individuale, l'esaltazione
dell'irrazionalità, della fantasia e del sentimento come argomenti artistici principali. La
natura creatrice ed espressione divina. Fuga nello spazio e nel tempo. La riscoperta del
Medioevo. Il fascino per le altre culture. I colori chimici. La Rivoluzione Industriale e i suoi
effetti sulla società.
- Le inquietudini preromantiche di F. Goya
- La pittura romantica in Germania: la filosofia della natura: C. D. Friedrich.
- Sublime visionario e vedutismo romantico nella pittura inglese: J. Constable, W. Turner
26
- La pittura in Francia tra realtà storica e ricerche formali: T.Gericault, E. Delacroix
- Cenni sull’architettura romantica (caratteri generali )
IL REALISMO
Le grandi città e i nuovi ritmi di vita. La dignità del vero e la denuncia sociale nell'arte
dell'Ottocento
O. Daumier, G. .Courbet
IMPRESSIONISMO
L’Impressionismo fra tradizione e innovazione. Il rifiuto dei modi della pittura ufficiale. L'
arte dei Salon e il Salon des Refusés.. Alcune invenzioni e scoperte ( telegrafo, telefono,
treno) e loro effetti sulla società e gli artisti. La ricerca sulla luce. Il nuovo mercato dei
colori chimici in tubetto e la teoria dei colori (principali-secondari e complementari) e
percezione delle forme. I temi disimpegnati e il rapporto con la modernità. Il rapporto con
la fotografia e la prima mostra nel 1974 presso il fotografo Nadar. Il lavoro ‘en plein air’. La
passione per le stampe giapponesi. La figura del mercante d'arte e i nuovi acquirenti e
fruitori.
E. Manet, C.Monet, A. Renoir, E. Degas
La nuova architettura del ferro e del vetro in Europa:Le esposizioni universali (caratteri
generali)
POST-IMPRESSIONISMO
Le linee di sviluppo dell’arte derivate dall’Impressionismo: scientifica ed espressionisticosimbolica. La costruzione dell’immagine indipendentemente dalle apparenze naturali.
Viaggi reali e viaggi della mente. Confronto con la pittura giapponese nelle tecniche
pittoriche.
- Puntinismo o Neoimpressionismo, il rapporto arte e scienza: G. Seurat
- La costruzione di un’”armonia parallela”, la progressiva astrazione dal dato naturale e la
scomposizione delle forme. L'anticipatore del cubismo : P. Cezanne.
- L'angoscia di vivere, la pittura vorticosa e materica. Le radici dell'espressionismo: V. Van
Gogh
- La ricerca di luoghi incontaminati, il richiamo alle vetrate istoriate gotiche e ai simboli
religiosi medievali nelle immagini, nei colori e nelle forme: P. Gauguin
Fra Ottocento e Novecento
27
SECESSIONI E MODERNITA'
- La secessione viennese: G. Klimt
- Le tenebre della solitudine e la visione tragica della vita. Le radici dell'espressionismo
tedesco:E. Munch
- Architettura e arti applicate, l'Art Nouveau e relative declinazioni europee. Confronto con
l'architettura del ferro e del vetro.
Novecento
LE AVANGUARDIE STORICHE
- Espressionismo.
Fauves, la violenza del colore: H. Matisse
Die Brücke, un ponte verso la modernità: E. L. Kirchner
- Cubismo: la rottura della forma, semplicità e stilizzazione, destrutturazione dello spazio
e degli oggetti. La “quarta dimensione”. La relatività . Il colore come fatto puramente
mentale. La cultura primitiva. L'impegno civile: P. Picasso
- Futurismo, la ricostruzione dell'universo : U. Boccioni:
LIBRO DI TESTO
-Il Cricco Di Teodoro “Itinerario nell’arte,, Versione verde, terza edizione, vol. 3, Ed.
Zanichelli
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
U.D. 1 - GINNASTICA A CORPO LIBERO E CON PICCOLI ATTREZZI
U.D. 2 - ATLETICA LEGGERA: CORSA DI RESISTENZA (Endurance)
U.D. 3 - TEORIA DELL’ALLENAMENTO
U.D. 4 - TENNISTAVOLO
U.D. 5 - CRICKET
U.D. 6 - CONOSCENZA DELL'IO ED IL LINGUAGGIO NON VERBALE
U.D. 7 - FORZA - SISTEMA MUSCOLARE - LAVORO CON PICCOLI SOVRACCARICHI
U.D. 8 - BASEBALL
U.D. 9 - HIT-BALL
28
RELIGIONE
ARGOMENTO
DURATA
IN ORE
TIPO
DI
VERIFICA
ELEMENTI DI ESCATOLOGIA: LA VITA OLTRE LA MORTE NELLA VISIONE
CRISTIANA E NELLE ALTRE RELIGIONI. ETIMOLOGIA DEI TERMINI:
PARADISO, INFERNO E PURGATORIO.
2
ORALE
ANALISI DI ALCUNI BRANI TRATTI DALL’ANTOLOGIA DI SPOON RIVER DI
E. LEE MASTER E ASCOLTO DEI BRANI DI DE ANDRÈ.
2
ORALE
LE ALTRE RELIGIONI: INDUISMO, BUDDISMO, CONFUCIANESIMO, E
CONVERSAZIONE SU TAOISMO, SHINTOISMO E ISLAMISMO.
8
ORALE
VISIONE DEL FILM “IL PIANISTA. ”, RICERCA STORICA DEL PERIODO E
DEI PERSONAGGI E COMMENTO.
4
ORALE
IL LAVORO E LE SUE DIMENSIONI, CRISTIANESIMO E LAVORO, SINTESI
DELLA “LABOREM EXERCENS”, COORDINATE DI ETICA SOCIALE PER
UNA CONVIVENZA UMANA SECONDO IL PROGETTO DI DIO.
1
ORALE
TEMPI FORTI DELL'ANNO LITURGICO: AVVENTO, NATALE, QUARESIMA,
PASQUA.
1
ORALE
ARGOMENTI A SCELTA DEGLI ALUNNI: ATTENTATI TERRORISTICI,
TOLLERANZA E LIBERTÀ DI PAROLA.
5
ORALE
ATTIVITÀ SUI GENERI.
Ad integrazione del lavoro sono stati usati:
BIBBIA, DOCUMENTI DEL MAGISTERO, ARTICOLI, SCHEDE INTEGRATIVE, AUDIOVISIVI.
LINNE GUIDA DEL PROGRAMMA di RELIGIONE
9.2 ATTIVITÀ INTERCURRICOLARI (gite, conferenze..)
Oltre alle attività curricolari sopra indicate, la classe ha partecipato ad altre esperienze:
STAGES
FINALITÀ
- Porre l'allievo in grado di prendere coscienza di sé e favorire lo sviluppo abilità di auto
– orientamento e auto – apprendimento.
29
-
-
Sviluppare la motivazione ad uno studio qualitativamente elevato e basato su esigenze
concretamente riscontrate.
Attuare delle esperienze inerenti l'applicazione delle teorie psico – sociali e
antropologico - culturali acquisite.
Mostrare la dipendenza dell'oggettività delle conoscenze dal livello teorico di
riferimento e dall'interazione fra apparato conoscitivo del soggetto e situazioni
empiriche.
Favorire la comprensione del processo di funzionamento di alcune delle realtà
formative, culturali e lavorative presenti nel territorio.
Favorire un interesse specifico per le scienze umane e per il diritto e l’economia
Favorire la conoscenza della realtà economica territoriale
OBIETTIVI ESPRESSI IN TERMINI DI
CONOSCENZE
Conoscenza di concetti e teorie riferiti alla psicologia sociale, evolutiva, cognitiva e del
lavoro, alla sociologia della comunicazione e del lavoro, all’antropologia con particolare
riguardo allo studio delle realtà locali sia nel loro evolversi storico che sia nella loro
attualità.
Conoscenza di alcune problematiche del mercato del lavoro e del mercato globale.
Conoscenza del funzionamento, dell'organizzazione, delle metodologie utilizzate, degli
aspetti strutturali, della valenza formativa e assistenziale di alcune agenzie di
formazione, di socializzazione, e culturali presenti nel territorio (Scuola Primaria,
Scuola dell’infanzia, Asilo Nido, Centro di accoglienza per disabili, Centro Anziani,
Consultorio, ludoteca, spazio giovani, biblioteche, ecc.).
Conoscenza del funzionamento, dell'organizzazione, delle metodologie utilizzate e
degli aspetti strutturali di alcune agenzie dei servizi e lavorativi presenti nel territorio
(studi notarili, di avvocati, agenzie di pubblicità, centri di riabilitazione ed educazione
motoria, aziende di produzione, ecc.)
Conoscenza diretta della componente educativo - pedagogica insita nella professione
docente.
Conoscenza diretta delle professioni operanti sul territorio, nel settore produttivo e dei
servizi attraverso l'analisi dei profili.
Conoscenza della tipicità economico – produttiva del territorio
Conoscenza delle regole riferite alla sicurezza sul lavoro
COMPETENZE
Acquisizione di una maggiore consapevolezza sulle reali problematiche e dinamiche
insite nel rapporto educativo e socio – assistenziale.
Acquisizione di una maggiore consapevolezza sulle reali problematiche e dinamiche
insite nei rapporti economico – lavorativi.
Saper effettuare una ricerca sul campo col metodo dell’osservazione partecipante.
Saper stendere una relazione – dossier sull’esperienza attuata.
Riconoscere le aree di intervento i profili professionali, il target, ecc. delle realtà
studiate.
Saper intervenire operativamente in situazioni concrete di lavoro.
Sapersi orientare nella complessità delle offerte di mercato.
Sapersi relazionare nella realtà lavorativa.
Saper riconoscere le regole aziendali.
Saper riconosere le regole sulla sicurezza.
30
CAPACITÀ
Favorire l'integrazione delle conoscenze curricolari attraverso la loro applicazione nella
realtà socio-economica del territorio.
Sviluppare autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro.
Sviluppare il senso del rispetto delle regole sulla sicurezza e aziendali.
Saper rilevare problematiche e ipotizzare interventi.
Saper progettare un intervento educativo e\o socio-assistenziale definendone tutti gli
aspetti caratterizzanti ed inserirlo in un contesto annuale di programmazione.
PRECISAZIONI SULL'ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti, il percorso prevede una
scansione triennale:
per le classi terze è prevista la preparazione dei tirocini operativi che verranno
realizzati in quarta;
per le classi quarte è prevista l’attivazione di tirocini operativi oltre all’approfondimento
di tematiche curricolari;
per le classi quinte verrà attivato un lavoro di riflessione interdisciplinare
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE CLASSI TERZE
Il percorso rivolto alle classi terze si configura come un momento di preparazione culturale
e di organizzazione dei contatti e delle modalità d’ingresso nelle strutture d’accoglienza.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE CLASSI QUARTE
In questa classe è prevista l’attivazione di stages a valenza orientativa.
Contenuti professionalizzanti
1. L’individuo, i suoi bisogni e l’orientamento scolastico
2. I servizi educativi, per la famiglia, le figure professionali nei servizi, la rete dei servizi
sociali e socio - educativi nel territorio di appartenenza
3. Le istituzioni culturali
4. Le aziende e la loro organizzazione
5. Le aziende commerciali
6. Le aziende di servizio
Il tirocinio operativo (72 ore)
Verrà effettuato in considerazione delle preferenze espresse dagli allievi, presso i servizi
educativi, socio – assistenziali, culturali e lavorativi in genere.
La rielaborazione
Verrà effettuata a scuola, in aula e in laboratorio d’informatica e servirà per:
socializzare le esperienze attraverso rilettura di gruppo e un reciproco confronto delle
esperienze attuate;
attivare una riflessione di confronto tra aspettative e realtà incontrata;
elaborare un report sintetico sull’esperienza vissuta;
attivare riflessioni per un progetto personale di crescita e di scelta orientativa futura.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE CLASSI QUINTE
Verranno completati i lavori di mappatura e di messa a punto del prodotto.
Verrà completato il lavoro di elaborazione teorica.
31
VERIFICHE (una o più a scelta)
Alla fine delle esperienze, a testimonianza di quanto appreso, gli allievi hanno prodotto
una relazione individuale o di gruppo con l'ausilio di modelli e schemi interpretativi.
Sono state realizzate delle ricerche di approfondimento
MONITORAGGIO
La presenza e la partecipazione allo stage è stata documentata da un tutor aziendale il
quale ha valutato anche la qualità delle prestazioni offerte dagli allievi attraverso la
compilazione di una griglia di valutazione.
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
15/10/2015, Incontri di “Sensibilizzazione alla donazione del sangue e del midollo
osseo” con le associazioni AVI e ADMO. Alcuni allievi hanno aderito al progetto
AVIS
19/03/2016, Corso di Primo Soccorso a cura di CRI
30/03/2016 Progetto “VOLO”: presentazione del servizio civile europeo
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO NELLA CLASSE 5
Novembre 2015 Partecipazione su base volontaria a “Job Orienta” 25 a mostra
convegno nazionale orientamento scuola formazione, presso fiera di Verona
19/12/2015 Progetto Bussola orientamento universitario a cura del gruppo Metexis
16/01/16 Progetto di Educazione finanziaria
21-22/01/2016 Incontro con esperto (CNA) sulla ricerca attiva del lavoro (lettera di
presentazione, curriculum vitae e colloquio di lavoro, lavoro e social network) e
sulle caratteristiche dell’economia del territorio.
18/02/2016 Open day UNIMORE, visita alle facoltà dell’Università di Modena e
Reggio Emilia
Marzo-Aprile 2016 Compilazione questionario di Alma Diploma per l’orientamento in
uscita ai fini della definizione di un profilo personalizzato
01/03/2016 Partecipazione su base volontaria all’attività di orientamento presso
Università degli Studi di Bologna
Visite individuali alle facoltà secondo l’interesse personale
FILM, CONFERENZE, SPETTACOLI
19/09/2015 partecipazione al “Festival della filosofia” e visita al Museo del
Deportato
16/02/2016 conferenza sul nucleare di E: Nurrito studente di Fisica
17/02/2016 incontro con il sindaco di Carpi sul tema: “Il bilancio del comune di
Carpi”
09/03/2016 Spettacolo teatrale a conclusione dell’attività di Educazione finanziaria
”Tu di che PIL sei? Anche gli economisti piangono”
12 /04/2016 dalle 9,00 alle 12,30 Visione di “THE RACE. IL COLORE DELLA
VITTORIA” film di Stephen Hopkins
32
13/04/2016 laboratorio pomeridiano di scrittura con prof. Celato
VISITE D’ISTRUZIONE
18/01/2016 visita all’ex manicomio di Reggio Emilia
16-21/3/2016 Due alunne hanno partecipato alla visita d’istruzione ad Auschwizt
nell’ambito del progetto “Un treno per Auschwitz”
19-23/4/2016 Visita d’istruzione alla città di Praga
9.3 METODI
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI, STRATEGIE DI COLLEGAMENTO
Il Consiglio di Classe ha utilizzato nella pratica didattica i seguenti metodi:
Lezione frontale, informativa, per presentare gli argomenti
Dialogo interattivo sui temi proposti, per sollecitare la riflessione critica
Analisi e discussione guidata di testi e fonti, per promuovere attitudini interpretative
Ricerche e relazioni individuali o a gruppo
Simulazione di casi
INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA
(STORIA)
-
Prerequisiti (disciplinari e linguistici)
1) Competenze di analisi del testo.
2) Conoscenza del lessico storico.
3) Capacità di attivare collegamenti interdisciplinari.
-
Obiettivi didattici disciplinari
1) Conoscere gli eventi storici.
2) Comprendere le relazioni intrinseche tra cause, conseguenze sul piano
sociale, economico e politico.
3) Cogliere l'evoluzione dei modelli istituzionali ed ideologici in rapporto alla
politica internazionale.
4) Collocare sul piano cronologico gli eventi e i fatti evidenziando un filo
conduttore nell'ambito geo-politico.
33
-
Obiettivi linguistici
1) Conoscere ed usare il linguaggio specifico storico in lingua inglese.
2) Sapere esporre in modo chiaro e coerente quanto appreso e quanto elaborato
autonomamente.
3) Comprendere il testo di un documento scritto in lingua inglese.
4) Rielaborare i contenuti appresi.
-
Contenuti
U.D.1: THE COLD WAR (4 h)
U.D.2: THE ARAB-ISRAELI CONFLICT AND THE ISRAELI-PALESTINIAN
PEACE PROCESS (2 h)
U.D.3: THE RACIAL DISCRIMINATION AND THE STRUGGLE FOR CIVIL
RIGHTS (3 h)
a- THE UNITED STATE AND THE SIXTIES
b- THE APARTHEID IN SOUTH AFRICA
Tempi : 14 ore
-
Metodologia
In classe sono stati letti e commentati i seguenti discorsi:
Winston Churchill: The Iron Curtain
John Fitzgerald Kennedy: Ich bin ein Berliner
Yitzhak Rabin: Nobel lecture
Martin Luther King: I have a dream
Nelson Mandela
Il gruppo classe è stato suddiviso in quattro gruppi composti da cinque studenti
ciascuno. Ogni gruppo si è occupato di sviluppare una delle quattro unità didattiche
sopraelencate. Ad ogni studente è stata assegnata una delle seguenti attività:
34
Create a timeline with dates, illustrations and photos.
Create a glossary of keywords and an acronyms list.
Write a 2000 words essay about the topic.
Describe an image (photo, work of art, poster, etc.).
Illustrate a particular case.
Al termine del lavoro di ricerca, condotto principalmente mediante l’ausilio di
supporti multimediali, gli studenti hanno presentato i loro elaborati alla classe.
-
Modalità di verifica: orale.
9.4 MEZZI
Manuali scolastici
Strumenti audiovisivi e multimediali, internet per le ricerche
Attrezzature dei laboratori (linguistico, informatico, di fisica ed audiovisivo) e delle
palestra
9.5 SPAZI
35
Aule teoriche e Aula video
Palestra
Laboratorio linguistico
Laboratorio di fisica
9.6 TIPOLOGIE DI VERIFICA
Prima prova
L’insegnante di Italiano ha proposto tutte le tipologie di prova previste dal
nuovo esame di stato
Simulazione di Prima Prova 27/04/2015
Seconda
Prova
L’insegnante di Diritto ed Economia Politica ha proposto
Simulazione di Seconda Prova 09/05/2015
Terza prova
Tra le tipologie previste dal MPL, il Consiglio di classe ha optato per la
trattazione sintetica di argomenti (tipologia B)
Sono state effettuate due simulazioni di terza prova:
24/02/2016 Materie coinvolte: filosofia – scienze umane –fisica –
spagnolo.
03/05/2016 Materie coinvolte: storia – inglese – matematica - storia
dell’arte.
Si allega copia dei testi predisposti e dei criteri di valutazione seguiti
Colloqui orali
Il CDC ha utilizzato le seguenti tipologie:
36
-
verifiche orali formative e sommative, volte a verificare
essenzialmente la conoscenza dei contenuti e le competenze di
analisi, di sintesi, logico-espressive e applicative
-
colloqui monodisciplinari e interdisciplinari volti a verificare le
capacità di collegamento e di rielaborazione critica all’interno della
medesima area.
9.7 CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione del colloquio
Conoscenza
Comprensione
applicazione
Non ha nessuna
Non comprende i concetti Non riesce ad applicare le
1-2 conoscenza degli
procedure essenziali
argomenti trattati
Ha una conoscenza molto Fatica a comprendere i
Applica in modo errato
lacunosa, frammentaria e concetti
anche le procedure
3-4
superficiale degli argomenti
essenziali
trattati
Ha una conoscenza
Comprende i concetti quasi Applica le procedure in
5 frammentaria e superficiale sempre in modo incerto e modo incerto e impreciso
degli argomenti trattati
frammentario
Ha una conoscenza priva di Comprende in modo
Applica correttamente le
6 rilevanti lacune ma non
accettabile i concetti
procedure essenziali
approfondita
essenziali
Ha una conoscenza
Comprende
Applica le procedure
7 corretta degli argomenti
adeguatamente i concetti correttamente
trattati
Ha una conoscenza
Comprende molti concetti e Applica le procedure
articolata e approfondita
mostra qualche attitudine correttamente e in casi
8
degli argomenti trattati
alla rielaborazione
semplici le applica anche a
contesti non noti
Ha una conoscenza
Comprende anche i
Applica le procedure con
9 completa, sicura e ampia concetti complessi e li
sicurezza anche in contesti
degli argomenti trattati
rielabora con sicurezza
non noti
Ha una conoscenza
Comprende anche i
Applica le procedure con
10 completa, sicura e ampia concetti complessi e li
sicurezza anche in contesti
degli argomenti trattati
rielabora con sicurezza
non noti
37
analisi
sintesi
espressione
Non sa analizzare i testi, i
casi o i problemi proposti
Non sa sintetizzare le
conoscenze acquisite
Si esprime in modo del tutto
scorretto e inadeguato
Analizza in modo errato
anche i testi, casi o
problemi semplici
Sintetizza in modo errato
anche contenuti semplici
Si esprime in modo
frequentemente scorretto,
inadeguato, incoerente
Effettua analisi parziali e
Effettua sintesi parziali e
Si esprime in modo non sempre
non corrette dei testi, dei imprecise delle conoscenze corretto ed adeguato
casi o dei problemi proposti acquisite
Analizza con sufficiente
Sintetizza con sufficiente Si esprime in modo comprensibile
precisione i testi, i casi o i precisione le conoscenze e sufficientemente corretto
problemi proposti
acquisite
Analizza correttamente i
Sintetizza correttamente le Si esprime correttamente
testi, i casi o i problemi
conoscenze acquisite
proposti
Analizza con una certa
Sintetizza con una certa
Si esprime correttamente e con
precisione e autonomia i
precisione e autonomia le una certa competenza linguistica e
testi, i casi o i problemi
conoscenze acquisite
lessicale
proposti
Analizza i testi, i casi o
Sintetizza le conoscenze Si esprime con apprezzabile
problemi con rigore e
acquisite con precisione e competenza e spigliatezza
precisione
rigore
Analizza i testi, casi o
Sintetizza contenuti anche Si esprime con sicura padronanza,
problemi anche complessi complessi con autonomia e spigliatezza e proprietà
con autonomia e originalità precisione
LICEO “M. FANTI” CARPI (MODENA)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
Voto
10
9
8
7
6
5
Indicatori
-
Frequenza assidua e puntualità costante
Attenzione ed interesse continui, partecipazione attiva
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
Pieno rispetto degli altri
Ruolo propositivo nel gruppo classe
Adempimento regolare e responsabile delle consegne scolastiche
-
Frequenza regolare e puntualità costante
Attenzione ed interesse continui
Puntuale rispetto del regolamento scolastico
Pieno rispetto degli altri
Ruolo positivo nel gruppo classe
Adempimento regolare delle consegne scolastiche.
-
Frequenza regolare, saltuari ritardi
Attenzione ed interesse buoni
Sostanziale rispetto del regolamento scolastico, ma qualche richiamo verbale da parte di uno o più insegnanti
Rispetto degli altri
Ruolo positivo nel gruppo classe
Adempimento abbastanza regolare delle consegne scolastiche.
-
Frequenza alterna e saltuari ritardi*
Attenzione ed interesse talvolta selettivi
Parziale rispetto del regolamento scolastico, con richiami scritti sul registro di classe
Non sempre rispettoso degli altri
Partecipa alla vita della classe con discontinuità
Adempimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche.
-
Assenze e ritardi frequenti **
Attenzione ed interesse saltuari
Scarso rispetto del regolamento scolastico, con richiami scritti sul registro di classe
Disturbo del lavoro scolastico
Limitata partecipazione alla vita di classe
Adempimento saltuario delle consegne scolastiche.
-
Frequenza scarsa, assenze ingiustificate, ripetuti ritardi
Attenzione ed interesse pressoché assenti
Mancato rispetto del regolamento e/o degli altri con gravi infrazioni che hanno comportato la sospensione
dalle lezioni per più di 15 giorni
Ruolo negativo nel gruppo classe
Inadempienza delle consegne scolastiche.
-
* la somma delle assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate deve essere un numero tra 10 e 15 nel trimestre; 15 e 20 nel pentamestre.
** la somma delle assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate deve essere un numero maggiore di 15 nel trimestre; 20 nel pentamestre.
Sono esclusi dal conteggio delle assenze prolungati periodi di assenza per motivi documentati. I voti vengono assegnati dal C di C in presenza della
maggior parte delle condizioni previste per ciascun livello.
38
10. I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI
DISCIPLINA
CARDO RAFFAELA
RELIGIONE
CELATO GENNARO
LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
MAGNANI LORELLA
LINGUA E CULTURA
STRANIERA (INGLESE)
NIZZOLI ROBERTA
LINGUA E CULTURA
STRANIERA (SPAGNOLO)
TORELLI RAFFAELLA
FILOSOFIA
TORELLI RAFFAELLA
STORIA
RINALDI CLAUDIO
DIRITTO ED ECONOMIA
POLITICA
LUSUARDI SARA
SCIENZE UMANE
ARIOLI ALESSANDRA
MATEMATICA
ARIOLI ALESSANDRA
FISICA
MAZZELLI SIMONA
STORIA DELL’ARTE
SERAFINI CLAUDIO
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
FIRMA
11. I MEMBRI INTERNI DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO
La commissione d’esame è costituita nella componente interna dai seguenti docenti:
Prof. Arioli Alessandra (Matematica, Fisica)
Prof. Rinaldi Claudio (Diritto ed Economia Politica)
Prof. Magnani Lorella (Lingua e Cultura Inglese)
39
12. ALLEGATI
Griglia di valutazione della prima prova scritta
Indicatori
CONOSCENZE
Relative all'argomento e/o al quadro di
riferimento
Punteggio
massimo
Punt.
in decimi
Descrittori
• conosce i contenuti in modo approfondito, la contestualizzazione è articolata;
4
3
COMPETENZE LINGUISTICHE
a)
Correttezza morfosintattica
b)
punteggiatura adeguata
c)
proprietà lessicale
d)
uso del registro adeguato
e)
chiarezza
4
2
2.5
• conosce i contenuti essenziali, la contestualizzazione è semplice;
2.75
1.75
2
1.5
• conosce i contenuti in modo lacunoso e privo di contestualizzazione.
1.5
1
• applica con sicurezza e precisione le competenze richieste dalla prova;
4
2
• applica in modo preciso e corretto le competenze richieste dalla prova;
3.5
1,5
• applica le competenze in modo semplice, ma corretto;
2.75
1,25
2
1
1.5
0.5
• applica le procedure richieste dalla prova con gravi e ripetuti errori .
• si esprime in modo efficace con ricchezza di lessico e registro appropriato;
3
• si esprime in modo puntuale, con lessico e registro adeguati;
• si esprime in modo semplice, ma chiaro e corretto, usa un lessico essenziale;
40
4
3.5
2
1.5
1,5
1
3
2
2,5
1,5
• dimostra sufficienti capacità critiche
1.75
1.25
• fatica a dimostrare capacità critiche
1.5
1
• evidenzia capacità critiche e rielaborative in modo autonomo e disinvolto
2
2,5
1.75
• impiega costrutti sintattici talora scorretti , usa un lessico ripetitivo o generico
3
3
2.75
•si esprime utilizzando costrutti sintattici errati, un lessico improprio e un
registro inadeguato.
CAPACITA'
a) analisi e sintesi
b)capacità di collegamenti autonomi
c) contributo personale e originale
3
3.5
• applica le competenze in modo incerto e con alcuni errori;
4
4
Punt.
in decimi
• conosce i contenuti in modo adeguato, la contestualizzazione è corretta;
• conosce i contenuti in modo superficiale, la contestualizzazione è parziale;
COMPETENZE PROCEDURALI
a) comprensione e rispetto delle consegne
dell’analisi testuale
b) comprensione e utilizzo dei materiali del dossier
(tipologia B),
c) organizzazione di un testo scritto espositivo e/o
argomentativo (coerenza argomentativa)
d) coerenza del testo e del titolo rispetto alla
destinazione scelta (tipologia B)
Punteggio corrispondente
• evidenzia discrete capacità critiche
Seconda prova: Griglia di valutazione
Insuff.
Mediocre
Suff.
Più che suff.
Discreto
Buono
Ottimo
PERTINENZA
(comprensione della traccia;
adeguatezza delle consegne;
rigore metodologico)
CONTENUTO
(livello delle informazioni e
delle conoscenze disciplinari;
rigore della documentazione)
SVILUPPO CONCETTUALE
(strutturazione complessiva;
proprietà e coerenza
dell’argomentazione;
rielaborazione in chiave
pluridisciplinare)
STILE
(correttezza e chiarezza
espositiva; efficacia della
comunicazione)
< 5-7
41
8-9
10
11-12
12-13
13-14
15
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
(TIPOLOGIA B)
Candidato ____________________________ Classe ___________ Data _________________
INDICATORI
PUNTEGGIO MASSIMO
ATTRIBUIBILE
ALL'INDICATORE
LIVELLI DI
VALORE/
VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE
AI DIVERSI LIVELLI
CONOSCENZE
Relative all'argomento
e/o al quadro di
riferimento
9 punti
Buono/Ottimo
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Scarso
9
8
7
5,5
4
COMPETENZE
Applicazione alle
procedure
Utilizzo del lessico
specifico
4 punti
Buono/Ottimo
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Scarso
4
3
2
1,5
1
CAPACITA'
Analisi e/o sintesi
Rielaborazione
personale
2 punti
Buono/Ottimo
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Scarso
2
1,5
1
0
0
VOTO
ATTRIBUITO
ALL'INDICATORE
N.B. Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali,
viene approssimato in eccesso all'unità superiore. La sufficienza è corrispondente al voto di 10/15
Carpi, ___________________
42
Voto complessivo attribuito alla prova ___________________/15
SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DEGLI ESAMI DI STATO
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ( A019)
TIPOLOGIA A
MERCATO E POLITICHE ECONOMICHE
Negli ultimi due secoli, le istituzioni economiche e sociali dell'Occidente si sono
immedesimate nel regime dell'economia di mercato, e in tempi recenti in molti paesi ci si è
affidati sempre più ai privati nel meccanismo di distribuzione delle risorse, con una
relativa e significativa limitazione dell’intervento pubblico .
Nonostante la crescente fiducia nel ruolo del mercato, non sempre questo è in grado di
conseguire un risultato efficiente. Pertanto, lo Stato svolge tuttora un ruolo fondamentale
nell’economia.
Il candidato, in base ai testi proposti e alle conoscenze pregresse, esponga le sue
considerazioni sull’intervento dello Stato nell’economia, riflettendo in particolare sulle
seguenti questioni:
•
origini e caratteri del sistema misto
•
ruolo dello Stato nell’assicurare le precondizioni necessarie per il
funzionamento del mercato e perseguire fini redistributivi e di stabilizzazione del
reddito
•
intervento pubblico per aumentare l’efficienza del mercato, quando
questo non riesca a garantire un’allocazione ottimale delle risorse.
DOCUMENTI
“L’azione più importante dello stato si riferisce non a quelle attività che gli individui privati
esplicano già, ma a quelle funzioni che cadono al di fuori del raggio d’azione degli
individui, a quelle decisioni che nessuno compie se non vengono compiute dallo stato. La
cosa importante per il governo non è fare ciò che gli individui fanno già, e farlo un po’
meglio o un po’ peggio, ma fare ciò che presentemente non si fa del tutto. [...] Da parte
mia, credo che il capitalismo, saviamente governato, può probabilmente essere reso più
efficiente di qualsiasi altro sistema ora in vista nel raggiungere obiettivi economici, ma che
in se stesso è in molte guise estremamente criticabile”.
“I difetti più evidenti della Società economica nella quale viviamo sono l’incapacità a
provvedere la piena occupazione e la distribuzione arbitraria e iniqua delle ricchezze e dei
redditi […] ritengo che vi siano giustificazioni sociali e psicologiche di disuguaglianza dei
redditi e delle ricchezze, ma non di disparità tanto forti quanto quelle oggi esistenti”.
Tratti da: J. M. Keynes, Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta.
54
“Come sintetizza Kenneth J. Arrow (Uncertaintyand the welfare economics of medical
care, «The American economicreview», 1963, 53, 5, pp. 941-73), quando il mercato non è
in grado di condurre a uno stato ottimale (come accade in un contesto di asimmetria
informativa o d’incompletezza dei mercati), la società prenderà, almeno parzialmente,
coscienza del problema e istituzioni sociali sorgeranno con il fine di migliorare gli esiti di
mercato.
Le precedenti considerazioni spiegano per quale motivo in tutti i Paesi, e in particolare in
quelli sviluppati, sia presente un sistema di protezione sociale strutturato. Ma la diversa
lettura dei fallimenti di mercato, o dell’allontanamento dalle condizioni ottimali, spiega
perché le concrete articolazioni siano anche molto differenziate”.
Tratto da: Roberto Artoni, Alessandra Casarico, Il ruolo economico dello Stato.
“I Costituenti hanno fortemente voluto e ottenuto che la Costituzione della Repubblica non
fosse - a maggior ragione nei suoi risvolti economici - il frutto di una teoria asetticamente
ed impropriamente applicata alla realtà. In proposito, nel corso dell’Assemblea
Costituente, i Costituenti hanno così stabilito: ”Noi possiamo fissare i principî, possiamo
stabilire le direttive entro le quali dovrà orientarsi il legislatore di domani, possiamo aprire
la strada a questo legislatore, togliere alcuni limiti alla sua azione. In questo senso
possiamo introdurre alcuni elementi di una economia nuova, possiamo predisporre
l'intervento dello Stato nella vita economica, possiamo prevedere la necessità e la facoltà
per lo Stato di attuare determinati piani generali che possano coordinare le diverse attività
economiche secondo un'unica direttiva e rivolgere l'attività produttiva del Paese verso gli
interessi delle grandi masse lavoratrici. Ma non solo possiamo fare questo; possiamo e già
ve ne è cenno nel progetto di Costituzione, prevedere gli organi attraverso i quali lo Stato
potrà concretare queste riforme e potrà attuare questi piani. [..]Il che è avvenuto”.
Tratto da: Boscolo Anzelotti Matteo, “Costituzione italiana ed economia globale” , in “Diritto
Costituzionale” , 30 ottobre 2014.
Art.41 Cost.
“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.”
La norma sembra distinguere due diversi momenti: il momento della scelta del tipo di
attività economica da svolgere, e quello del suo concreto svolgimento. L'iniziativa sarebbe,
quindi, libera, mentre l'attività economica subirebbe penetranti limitazioni, sia in negativo
che in positivo, per il raggiungimento dei fini sociali. […] La Costituzione riconosce che
55
il libero mercato è un efficiente sistema di utilizzo delle risorse, ma non che comporti
automaticamente anche un'equa e socialmente utile distribuzione delle risorse stesse. Per
questo motivo richiede che l'attività economica (sia pubblica che privata) sia indirizzata e
coordinata mediante opportuni programmi e controlli. In ogni caso l'indirizzo ed il
coordinamento non possono mai sopprimere l'iniziativa individuale. [..] In Italia, si è
preferito operare mediante programmazioni di settore o per obiettivi precisi e con una
politica d'incentivi (sgravi fiscali, finanziamenti agevolati etc.) piuttosto che di controlli,
anche al fine di tenere alto il livello di occupazione.
Tratto da: www.brocardi.it / Costituzione
QUESITI DI APPROFONDIMENTO
Il candidato risponda a due quesiti tra quelli proposti:
•
Spesso l’intervento pubblico, anziché costituire una soluzione alle
inefficienze del mercato può costituire esso stesso una fonte di nuovi fallimenti.
Quali sono a tuo avviso le cause del fallimento dello Stato nel sistema
economico?
•
Lo Stato, nell’esercizio della sua sovranità, si colloca rispetto ai privati
in una posizione definita potestà d’imperio. Quali sono i significati che possiamo
attribuire a questi termini ?
•
Cosa si intende per uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale
nello Stato democratico?
•
In che senso il riconoscimento internazionale costituisce un elemento
essenziale dello Stato?
E’ consentito soltanto l’uso del dizionario di italiano e del codice civile non
commentato
Durata massima delle prova: 5 ore
56
Iª Simulazione di terza prova
24.02.2016
Lingua Spagnola (Tipologia B)
1)Elige uno de los tres protagonistas de la novela de Galdós “Fortunata y Jacinta” y
señala sus rasgos característicos. (15 righe)
2) ¿Cuáles son los rasgos realistas y naturalistas que destacan en “Fortunata y Jacinta de
Galdós y en “La Regenta” de Clarín? Justifica tu respuesta. (15 righe)
Fisica (Tipologia B)
Dopo aver scritto da cosa è caratterizzato il collegamento in serie di due o più
resistori, ricava, spiegando i vari passaggi, la formula per ottenere la resistenza
equivalente di due resistori di resistenza rispettivamente R1 e R 2 , collegati in
serie.(10 righe)
Spiega in cosa consiste l’effetto Joule ed illustra le trasformazioni energetiche, a
livello microscopico, che ne sono la causa. (10 righe)
Enuncia la legge di Coulomb (che indicherai con FC) e quella di Newton (che indicherai
FN) ed illustrane le differenze e le analogie. (10 righe)
Filosofia (Tipologia B)
Il candidato mostri come le riflessioni di Schopenhauer si caratterizzino per una totale
opposizione all’ottimismo panlogistico di Hegel. (11 righe max)
Il candidato illustri il significato del titolo dell’opera di Schopenhauer Il mondo come
volontà e rappresentazione, facendo riferimento ai seguenti concetti: fenomeno,
noumeno e velo di Maya. (11 righe max)
Il candidato chiarisca come, secondo Feuerbach, l’idealismo e la religione offrano una
versione rovesciata della realtà. (11 righe max)
Scienze umane (Tipologia B)
Perché a partire dalla metà degli anni Settanta il Welfare, in particolare in Italia, è
entrato in una fase di crisi piuttosto acuta? Spiegane le cause. (Max 15 righe)
57
Attraverso quali processi nella nostra epoca le imprese riducono il costo del lavoro?
Spiegali (Max 15 righe)
Quali sono i punti critici del Welfare italiano? Quali del Terzo Settore? Spiegali (Max 15
righe)
IIª Simulazione di terza prova
03.05.2016
Lingua Inglese (Tipologia B)
Answer the following questions in about 12 lines each:
Write about James Joyce’s aim in writing the collection of short stories “Dubliners”, how
the stories are arranged, the narrative technique he employed and the main themes he
developed.
Illustrate the features of the Theatre of the Absurd, referring to what you have studied
about the characters, structure and language of “Waiting for Godot” by Samuel Beckett.
Storia dell’arte (Tipologia B) (max 8 righe)
ESEGUIRE LE ANALISI DESCRITTIVA, COMPOSITIVO-FORMALE E COLORISTICA DELL'OPERA PROPOSTA.
AUTORE......................................TITOLO.......................................................DATA CIRCA.............................
ART NOUVEAU: INDICARE LA DATA CIRCA, LA COLLOCAZIONE GEOGRAFICA E LE RELATIVE DENOMINAZIONI, LE
CARATTERISTICHE ARTISTICHE PRINCIPALI E I MATERIALI PIÙ UTILIZZATI.
INDIVIDUA GLI AUTORI STUDIATI DELLE SECESSIONI E INDICA I LUOGHI, LE MOTIVAZIONI CULTURALI E ARTISTICHE DI
QUESTE CORRENTI.
Matematica (Tipologia B)
Data la funzione
y
4x 2 1
x 2 2
determina:
Dominio, eventuali simmetrie, intersezioni con gli assi e segno
58
Asintoti (tralascia l’intersezione con tali asintoti), massimi, minimi
Flessi e grafico.
Storia (Tipologia B)
Il candidato illustri sinteticamente quali problemi si trovò ad affrontare lo Stato unitario
italiano e quali furono le soluzioni adottate dalla classe politica che guidava il paese in
quegli anni. (Max 10 righe)
Il candidato sviluppi un confronto tra liberalismo e socialismo evidenziandone eventuali
affinità e differenze. (Max 10 righe)
Il candidato illustri quali furono le ripercussioni della Prima guerra mondiale in campo
politico, sociale ed economico. (Max 10 righe)
59