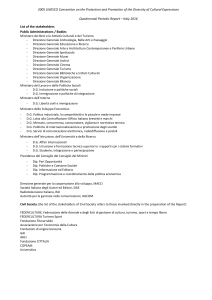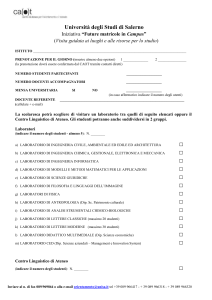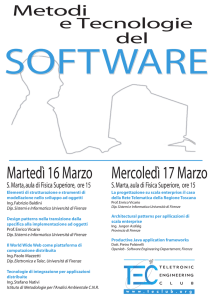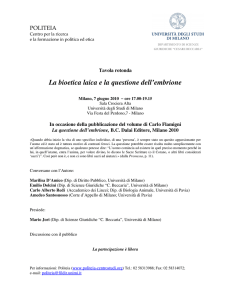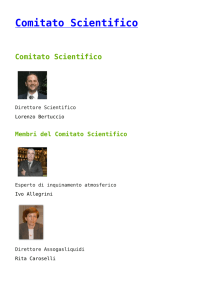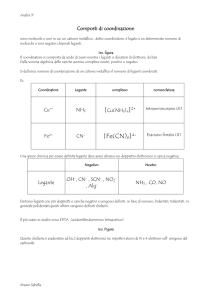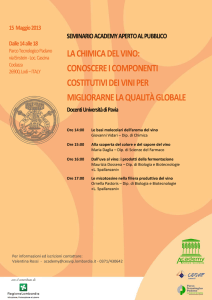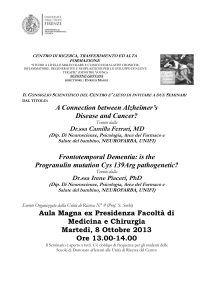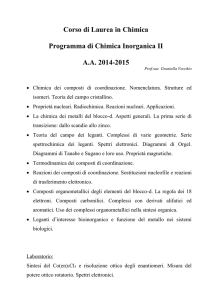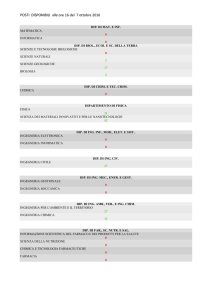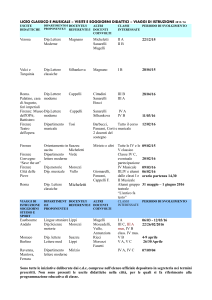CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN
CHIMICA DEI METALLI NEI SISTEMI BIOLOGICI
Attività scientifica svolta
dalle Unità Locali nel corso
dell‟anno 2006
PRESENTAZIONE
3
PRESENTAZIONE
La scienza, la tecnologia, la disponibilità di risorse umane qualificate costituiscono il
differenziale che distingue il grado di sviluppo dei diversi sistemi paese. Essere in posizione
avanzata su questi temi, poter partecipare alla cooperazione internazionale in forma non subalterna,
accrescere ed innovare la propria capacità produttiva e la disponibilità e diffusività di servizi
determinano la possibilità dei sistemi nazionali di essere protagonisti e competitivi nei processi di
crescita economica, culturale e sociale.
Si parla comunemente di “economia della conoscenza e dell'apprendimento” e di “sistemi
nazionali di innovazione” per indicare una nuova fase di sviluppo in cui non è più possibile tenere
separata la funzione di produzione di idee, progetti e prodotti scientifici e tecnologici da quella di
un loro impiego per il soddisfacimento di una domanda diffusa generata dalle complesse esigenze
della società.
In questo contesto il Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei
Sistemi Biologici (C.I.R.C.M.S.B.), con sede legale a Bari e 21 Università consorziate, promuove e
coordina le proprie ricerche con l‟obiettivo di formare e valorizzare i ricercatori ed i risultati da essi
ottenuti con la consapevolezza del valore strategico della ricerca come vantaggio competitivo nella
Società della Conoscenza e nella convinzione che le infrastrutture di ricerca e alta formazione siano
leve strategiche per il rilancio dell‟economia nazionale.
A tale scopo le attività del C.I.R.C.M.S.B. si articolano in macro aree di ricerca scientifica e
tecnologica a carattere interdisciplinare, che riguardano i settori delle biotecnologie, dei farmaci, dei
materiali e dell‟ambiente. Tali aree di intervento attualmente oggetto di ricerca del Consorzio fanno
capo alle seguenti tematiche:
a) Diagnostici innovativi in oncologia e malattie cardiovascolari: la Risonanza Magnetica per
Imaging;
b) Metallo-proteine come catalizzatori biologici;
c) Biomineralizzazione e biocristallografia;
d) Biosensori e biostrumentazione;
e) Nuovi farmaci inorganici in oncologia;
f) Radiofarmaci nella diagnostica e radioterapia tumorale;
g) Ioni metallici nelle patologie degenerative croniche.
Il C.I.R.C.M.S.B. è presente in tutta Italia attraverso una rete di Unità Locali di Ricerca, al
fine di favorire una diffusione capillare delle proprie competenze su tutto il territorio nazionale ed
agevolare i contatti e le collaborazioni con enti ed industrie locali.
Quello di seguito riportato è un riassunto dei risultati acquisiti nell‟anno 2006 da ciascuna
delle Unità di Ricerca del C.I.R.C.M.S.B.
A tutti coloro che vi hanno partecipato va rivolto il nostro più profondo e sentito
ringraziamento per gli sforzi profusi.
Prof. Giovanni Natile
5
INDICE
7
INDICE
UNITA’ DI RICERCA
9
BARI
Pag. 13
BOLOGNA
Pag. 17
CAMERINO
Pag. 27
CATANIA
Pag. 31
FERRARA
Pag. 37
FIRENZE
Pag. 47
INSUBRIA
Pag. 55
LECCE
Pag. 57
MESSINA
Pag. 65
NAPOLI
Pag. 67
PADOVA
Pag. 73
PALERMO
Pag. 89
PARMA
Pag. 97
PAVIA
Pag. 107
PIEMONTE ORIENTALE
Pag. 111
POLITECNICA DELLE MARCHE
Pag. 119
ROMA
“La Sapienza”
Pag. 123
ROMA
“Tor Vergata”
Pag. 131
SIENA
Pag. 133
TORINO
Pag. 135
TRIESTE
Pag. 139
PUBBLICAZIONI E BREVETTI
Pag. 145
PERSONALE AFFERENTE
Pag. 177
10
ATTIVITA’ DI RICERCA
UNITA’ LOCALI
11
12
UNITA’ DI RICERCA DI BARI
Direttore Scientifico: Prof. Giovanni Natile
L'attività scientifica dell‟unità di ricerca di Bari ha riguardato le seguenti tematiche:
1) Sintesi, caratterizzazione ed attività citotossica di complessi di platino con basi aromatiche;
2) Analisi dei fattori influenzanti formazione e stabilità di conformeri in addotti cisplatino-DNA;
3) Aspetti molecolari dell‟attività antitumorale di farmaci a base di platino(IV).
1. Sintesi, caratterizzazione ed attività citotossica di complessi di platino con basi aromatiche
Già nel 1989 Hollis ed i suoi collaboratori hanno pubblicato una serie molto interessante di
complessi di platino che violano alcune delle classiche relazioni struttura-attività, pur conservando
l‟attività antitumorale. Questi composti, con formula [PtClA2L]+ (A2 = due ammine monodentate o
un‟ammina bidentate, L = ammina secondaria o terziaria oppure un eterociclo N-donatore), sono
caratterizzati da una carica positiva e da tre leganti N-donatori non labili.
Già in passato l‟Unità di Ricerca di Bari ha portato avanti lo studio su un complesso simile a quelli
di Hollis, il cis-[PtCl(NH3)2(ACV)]+, che contiene nella sua sfera di coordinazione l‟agente
antivirale acyclovir [ACV = 9-(2-idrossi-etossimetil)guanina]. Questo complesso ha mostrato la
stessa efficacia citotossica del cisplatino quando sono stati somministrati in vivo in dosi
equitossiche in topi con leucemia P388. Ancora più interessante è risultato il fatto che lo stesso
complesso ha mostrato attività citotossica in vivo anche nei confronti di una linea leucemia P388
resistente al cisplatino.
Ultimamente si è esteso lo studio a complessi analoghi ai precedenti nei quali la 2,9-dimetil-1,10fenantrolina sostituisce il legante A2 e L è la 2-picolina (1), la 6-ammino-2-picolina (2), o la 1metil-citosina (3) (Fig. 1).
L‟analisi ai raggi X del complesso 2 ha mostrato una incurvatura del piano della fenantrolina,
un‟inclinazione del piano della fenantrolina rispetto al piano di coordinazione del platino, ed una
totale schermatura del centro metallico dovuta ai sostituenti in orto della fenantrolina ed ai leganti
piridinici.
Sono stati effettuati saggi di inibizione della crescita in vitro sul complesso 3 (il più solubile in
acqua). I risultati indicano che questo complesso è caratterizzato da una potente attività inibitoria
della crescita, con un valore di IC50 (in un pannello di 11 linee cellulari di tumori umani) di 1,1 μM
rispetto al valore di 3,8 μM del cisplatino. Lo stesso complesso ha inoltre mostrato di superare
completamente la resistenza acquisita al cisplatino che deriva da un ridotto assorbimento o da altri
meccanismi multifocali, indicando che ha un meccanismo di azione differente da quello del
cisplatino.
13
5
6
+
7
4
8
9
H3C
3
N
N
2
CH3
Pt
I
I
L
N
6'
5'
CH3
2'
3'
4'
PIC
N
H2N
6'
5'
CH3
2'
3'
4'
L=
AmPIC
N
O
N
H3C
NH2
5'
6'
MeCY
Figura 1. L = 2-picolina (PIC, complesso 1), 6-ammino-2-picolina (AmPIC, complesso 2),
1-metil-citosina (MeCY, complesso 3)
2. Fattori influenzanti formazione e stabilità di conformeri in addotti cisplatino-DNA
A causa della sua natura chirale, il DNA potrebbe interagire in modo differente con i complessi di
platino contenenti leganti amminici enantiomerici. Sono stati fatti diversi tentativi per trovare le
relazioni esistenti fra la configurazione di questi leganti e le modificazioni strutturali indotte da
questi composti per coordinazione al DNA e/o ai processi cellulari che ne derivano.
Per meglio comprendere i fattori che influenzano la stereochimica degli addotti Pt-DNA, l‟U.R. di
Bari ha intrapreso lo studio di composti di tipo cis-[PtA2G2], nei quali A2 è un legante amminico
bidentato con ingombro sterico vicino al sito di coordinazione in cis e G è un derivato guaninico
legato al platino via N7. In questi modelli la rotazione intorno ai legami Pt-N7 è lenta sulla scala dei
tempi NMR e pertanto può essere messa in evidenza la presenza di differenti rotameri.
Lo studio di detti complessi ha permesso di analizzare le diverse interazioni che sono coinvolte
nella stabilizzazione di addotti di cisplatino con mono e polinucleotidi e che possono influenzare il
comportamento dinamico di tali addotti.
Tutti i complessi cis-[metallo(nucleotide/nucleoside)2] con la guanina e con le relative purine finora
caratterizzati allo stato solido hanno mostrato una conformazione HT (con orientazione testa-coda
delle due basi e chiralità destrogira) (Fig. 2). La conformazione HT (chiralità levogira), al
contrario, si riscontra in soluzione acquosa, sia acida sia neutra, dei complessi cis-[PtA2(5‟-GMP)2].
Modelli molecolari ed esperimenti effettuati in soluzione indicano che il conformero HT è
stabilizzato da interazioni di tipo legame idrogeno fra il 5‟-fosfato ed il protone in N1 del nucleotide
in cis. Questa evidenza, comunque, quantunque ampiamente suffragata, è indiretta. Alla fine sono
14
state messe a punto le condizioni utili per permettere la cristallizzazione di questo conformero. La
struttura ottenuta rivela tre caratteristiche uniche e non presenti in tutte le altre strutture allo stato
solido di complessi cis-[PtA2(nucleotide)2]: una conformazione HT, interazioni molto forti di tipo
legame idrogeno fra il fosfato ed il protone in N1 dei nucleotidi in cis, ed un angolo diedro molto
piccolo fra i piani delle due guanine che giacciono quasi perpendicolari al piano di coordinazione.
Questi nuovi risultati indicano che , poiché non ci sono repulsioni locali fra le basi che impediscono
la conformazione HT, forze globali piuttosto che interazioni locali determinano la predominanza
del conformero HT sul conformero HT sia allo stato solido che in soluzione, in addotti crociati
con oligonucleotide e DNA di tipo sia intra che inter-catena.
Pt
Pt
Pt
HT
HH
HT
Figura 2
Inoltre l’U.R. di Bari si è occupata di complessi di platino con legante amminico tridentato (A3) e
una base nucleica (L), i quali rappresentano dei modelli molto utili per lo studio di interazioni fra la
base nucleica e l’ammina in cis senza le complicazioni derivanti dalle interferenze fra le basi
nucleiche presenti in tutti i bisaddotti del tipo cis-[PtA2L2]. In questo contesto il complesso
Pt(Me3dien)L (Me3dien = N1,N4,N7-trimetildietilentriamina), studiato già in passato, è stato
particolarmente utile. La presenza di un gruppo metilico su ciacuno degli atomi di azoto terminali
rende la rotazione di L intorno al legame Pt-L lenta sulla scala dei tempi NMR ed inoltre rende non
equivalenti i due semispazi definiti dal piano di coordinazione. È stato trovato che, contrariamente a
quanto apettato, i derivati guaninici e deossiguaninici hanno velocità di rotazione comparabili. La
uguale velocità di rotazione per un derivato stericamente molto più ingombrato quale la guanina
(contenente un ossigeno in posizione 6) è stata spiegata per mezzo di un’interazione di tipo legame
ad idrogeno fra l’atomo di ossigeno O6 della guanina ed il gruppo NH dell’ammina in cis che fa
abbassare notevolmente la barriera energetica.
Ultimamente lo studio è stato esteso ai complessi con Me5dien (Me5dien = N1,N1’,N4,N4’,N7pentametildietilentriamina). I risultati ottenuti indicano che l’assenza di un protone sull’atomo di
azoto terminale non solo riduce la velocità di rotazione di L di un fattore di 1010, ma aumenta
notevolmente la differenza di velocità fra i leganti L che mimano la guanina e la deossiguanina.
3. Aspetti molecolari dell’attività antitumorale di farmaci a base di platino(IV)
Proseguendo nella ricerca di nuovi composti di platino in grado di migliorare le proprietà del
cisplatino, l’Unità di Ricerca di Bari si è occupata anche di composti di platino(IV). Tali composti
risultano più inerti delle specie di platino(II) e questo potrebbe permettere una loro utilizzazione per
via orale. Il JM-216 cis,trans,cis-[PtCl2(CH3COO)2(NH3){NH2(C6H11)}] rappresenta il prototipo di
farmaci di platino(IV) somministrabili oralmente ed è attualmente in fase clinica II.
Ultimamente è stata riportata la sintesi e la citotossicità di una serie di altri complessi di platino(IV)
con leganti idrofobici ingombranti. Il complesso cis,trans,cis-[PtCl2(CH3COO)2(NH3)(1adamantilamina)] (adamplatino(IV), Fig. 3) ha mostrato in saggi effettuati in vitro un’elevata
citotossicità senza resistenza crociata al cisplatino. La valutazione della citotossicità dell’
adamplatino(IV) su un pannello di linee cellulari tumorali resistenti al cisplatino ha rivelato un alto
effetto citotossico di questo farmaco nei confronti di linee cellulari di leucemia, melanoma e tumori
15
colorettali ed un’alta propensione a scatenare l’apoptosi. L’effetto citotossico dell’adamplatino(IV)
su linee cellulari tumorali resistenti al cisplatino è rapido e più forte di quello del cisplatino e del
JM-216. In questo modo l’adamplatino(IV) sembra essere molto promettente nella prospettiva della
sua applicazione nella terapia dei tumori; perciò è di grande interesse comprendere i dettagli dei
meccanismi molecolari e biochimici che sono alla base della sua efficacia biologica.
a
b
Figura 3. cisplatino (a), adamplatino(IV) (b)
Fra i maggiori fattori influenzanti gli effetti antitumorali dei complessi di platino sono da
sottolineare l’assorbimento cellulare del farmaco, le alterazioni del DNA indotte dal farmaco stesso
e la sua inattivazione dovuta alla formazione di addotti con composti che contengono lo zolfo. In
quest’ottica l’U.R. di Bari ha esaminato la rilevanza di questi fattori farmacologici sul meccanismo
d’azione di adamplatino(IV) ed ha comparato i risultati ottenuti con quelli di analoghi studi condotti
sul cisplatino.
I risultati ottenuti mostrano che la disattivazione dell’adamplatino(IV) dovuta a composti che
contengono lo zolfo (come il glutatione o le metallotioneine) sembra avere un minore impatto sul
meccanismo di resistenza cellulare all’adamplatino(IV), se confrontato con il corrispondente effetto
nel caso del cisplatino. È stato riscontrato che il trattamento di cellule tumorali con adamplatino(IV)
non porta a modificazioni del DNA significativamente diverse da quelle prodottea dal cisplatino.
Pertanto sono altri fattori, quali il pronunciato accumulo cellulare del farmaco, la forte inibizione
della polimerizzazione del DNA dovuta a formazione di tali addotti, il ridotto riparo del DNA e la
formazione di addotti crociati DNA-proteina, a rendere conto del diverso effetto biologico
dell’adamplatino(IV) e del cisplatino. Le differenze fra gli effetti dell’adamplatino(IV) e quelli del
cisplatino, osservati a livello molecolare, potrebbero essere d’aiuto nel comprendere l’unicità
dell’efficacia terapeutica dell’adamplatino(IV).
16
UNITA’ DI RICERCA DI BOLOGNA
Direttore Scientifico: Prof. Norberto Roveri
L‟ attività dell‟ Unità Operativa di Bologna si è sviluppata principalmente su quattro linee di ricerca
nell‟ ambito della tematica “ biomineralizzazione e biocristallografia” oltre ad una attività di
divulgazione scientifica :
1) Biomineralizzazione e struttura di proteine
2) Sviluppo di nuovi biomateriali nanostrutturati
3) Nanotecnologie applicate a problematiche odontoiatriche e alla medicina rigenerativa
4) Interazione di sistemi biologici modello con superfici inorganiche
5) Ricerca di Storia della Chimica e attività di divulgazione scientifica
1) Biomineralizzazione e struttura di proteine
Studio dei processi di cristallizzazione di carbonato di calcio per l’industria cementizia
Lo scopo di questo lavoro vuole essere quello di stabilire la variazione qualitativa/quantitativa dei
prodotti d‟idratazione/carbonatazione delle fasi presenti nel clinker in relazione alla presenza di
superfluidificanti polimerici e le variazioni
morfologiche indotte nelle fasi. Si intende inoltre
verificare effetti quali temperatura e saturazione
di CO2 sull‟evoluzione temporale del processo.
Lo studio avviene seguendo il processo di
carbonatazione/idratazione del clinker in presenza
di superfluidificanti polimerici sia dal punto di
vista temporale che chimico-fisico. Gli additivi
impiegati, di interesse commerciale, sono
prioritariamente HSP 147, MPSP6 e SNF. La
ricerca mostra che i vari additivi hanno una forte
influenza sulla morfologia del carbonato di calcio.
Alcuni di essi inoltre, già in quantità dell‟ordine
dei ppm, sono in grado di inibire completamente
Cristallo di carbonato di calcio cresciuto in
la precipitazione del carbonato di calcio.
presenza di SNF
RIP: Proteine Inattivanti il Ribosoma
Numerose proteine isolate da una varietà di tessuti vegetali sono simili alla catena A della ricina e, in
modo analogo a queste, inattivano il ribosoma eucariotico mediante un meccanismo enzimatico. Il
loro meccanismo di azione è stato identificato come un‟attività N-glicosidica che rompe in modo
idrolitico il legame N-glicosidico del A4324 del 28 S rRNA. La denominazione proteine inattivanti
il ribosoma (RIP) tipo 1 (a differenza del tipo 2, tra le quali la ricina e tossine simili a doppia catena)
è utilizzata per indicare le proteine a catena singola con le proprietà descritte sopra. Le RIP mostrano
un‟alta omologia di sequenza amminoacidica e sembrano avere una simile attività enzimatica.
Tuttavia, esse agiscono in modo diverso su ribosoma di piante, protozoa e animali. L‟attività di
ricerca del gruppo è ricolta allo studio di RIP tipo I. Queste sono: la lichnina, la diantina 30, la
buganina e la momorchina S. La diantina 30, la buganina e la lychnina sono state cristallizzate e la
loro struttura è stata risolta tramite “molecular replacement”. Sono ancora in corso esperimenti di
cristallizzazione della momorcochina-S per ottenere dei cristalli adatti ad uno studio strutturale a
raggi X. Le strutture della buganina e della lichinina sono state risolte e vanno ad aggiungersi a
17
quella della dianthina 30 già determinata dal gruppo di ricerca. Lo Studio ha evidenziato ancora con
maggior impeto il ruolo del potenziale di superficie nel determinare l‟attività catalitica e la
selettività verso diversi substrati.
Amelogenina
Le amelogenine rappresentano una famiglia di proteine che sono secrete dagli ameloblasti. Esse
costituiscono la principale entità strutturale dello smalto nello stadio della sua formazione. Nello
smalto la formazione, e la degradazione, della matrice
formata dalle amelogenine, è concomitante con la crescita
e la formazione di cristalli di idrossiapatite. Nelle
sequenza di amminoacidi di amelogenine di varie specie
si riscontra una alta omologia nelle regioni terminali,
suggerendo che queste regioni hanno degli specifici ruoli
funzionali nella biomineralizzazione dello smalto.
La struttura dell‟amelogenina non è stata ancora
determinata è questo è il campo si lavoro del nostro
gruppo di ricerca. In collaborazione con la University of
Southern California sono stati effettuali degli studi in cui
si è mostrato come l‟amelogenina, in una sua forma
ricombinante, si assembli prima formando delle nanoImmagine di micro-ribbon di amelogenina
sfere del diametro di circa 20 nm e successivamente in
catene ordinate di nano-sfere che formano dei nastri birifrangenti in grado di controllare la
deposizione dell‟idrossiapatite.
Gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi fotosintetica
Le gliceraldeidi-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH)
sono enzimi implicati nella glicolisi, nella
glucosogenesi e nel ciclo della riduzione del
carbonio di organismi fotosintetici. Il gruppo di
ricerca ha recentemente pubblicato, per la prima
volta, la struttura cristallografica di una GAPDH
fotosintetica (la forma non regolatrice A4 estratta
dalle foglie degli spinaci) complessata con il
NADP. Le caratteristiche basilari di questa
struttura sono molto simili alla GAPDH
glicolitica, già conosciuta. Tuttavia delle
differenze sostanziali sono state osservate nel
dominio di legame col cofattore. Anche la
struttura cristallina della forma ricombinante A4GAPDH da Spinacia oleracea, espressa in E.coli,
complessata con NAD è stata risolta dal gruppo di
ricerca. Dal confronto tra le strutture dei due
complessi si osservano, nell‟organizzazione
Struttura dell'isoforma A4 della gliceraldeide-3fosfato fotosintetica.4
tridimensionale, delle differenze minime quando
la GAPDH ospita nel dominio di legame il NAD o
il NADP. La struttura cristallina del A4-GAPDH complessata con il NADP ha mostrato che i residui
conservati, Thr33 e Ser188, interagiscono tramite legami ad idrogeno con il 2-fosfato del NADP,
suggerendo che questi residui conservati possano essere implicati nella definizione della specificità
del coenzima nella GAPDH fotosintetica. Sulla base di queste informazioni, ed avendo disponibile la
18
forma ricombinante, sono state prodotte e cristallizzate due forme mutanti del A4-GAPDH, T33A e
S188A. La struttura di questi due mutanti è stata risolta.
2) Sviluppo di nuovi biomateriali nanostrutturati
Una delle più promettenti linee di ricerca nell‟ambito della scienza dei biomateriali è quella che ha
come obiettivo lo studio dei “bio-inspired materials”, in grado di riprodurre seppure in parte, delle
specifiche funzionalità dei tessuti biologici.
Una delle linee di ricerca dell‟unità operativa di Bologna è focalizzata sulla sintesi di nuove apatiti
nano-dimensionate e geli di silice nanostrutturati che rappresentano due importanti classi di
materiali biogenici. Le apatiti sono i costituenti fisiologici delle ossa e dei denti, mentre la silice
nanoporosa è prodotta da organismi unicellulari.
Il passo successivo alla riproduzione in laboratorio di biomateriali è il conferimento ad essi di
bioattivà specifiche. I nano-materiali possono esser resi “smart”, ovvero in grado di veicolare
informazioni specifiche e di agire selettivamente nell‟environment biologico del sito dell‟impianto.
Un approccio per estendere e finalizzare la bioattività può essere ottenuto con la sintesi di strutture
composite materiale-molecola funzionale, dove la molecola funzionale sia in grado di veicolare le
informazioni che stimolino specifiche risposte cellulari.
Nanocristalli apatitici aventi bioattività specifiche
E‟ stato provato come i trattamenti chemioterapici applicati localmente a patologie quali
l‟osteosarcoma, possono avere come risultato l‟inibizione del tumore e la diminuzione dei valori di
tossicità dei farmaci rilasciati in situ. Di qui l‟importanza applicativa di una ricerca volta alla
determinazione dei parametri che influenzano il binding e il rilascio da nanocristalli apatitici di
molecole quali bisfosfonati geminali (alendronato) e complessi a base di platino (in particolare
cisplatino e complessi di Keppler) ed oro. La sintesi e lo studio della chimica di tali composti
vengono condotti in collaborazione con le Unità Operative di Bari e Padova che ne curano la sintesi
e ne testa l‟attività farmacologica.
I dati suggeriscono che l‟adsorbimento ed il desorbimento delle biomolecole è fortemente
dipendente dalle loro specifiche proprietà e dalle caratteristiche superficiali e dalla morfologia delle
nanoparticelle di idrossiapatite. In particolare nel caso dei complessi di platino l‟interazione è
sostanzialmente di tipo elettrostatico, mentre nel caso dell‟alendronato l‟adsorbimento avviene con
uno scambio di leganti nel quale i due gruppi fosfonati della biomolecola sostituiscono due gruppi
fosfati del substrato. Ovviamente l‟adsorbimento delle specie idrolizzate di cisplatino cariche
positivamente sarà favorito sull‟idrossiapatite ricca di ioni fosfati in superficie mentre
l‟adsorbimento dell‟alendronato carico negativamente sarà favorito sull‟idrossiapatite che porta in
superficie più ioni calcio. Le forze di interazione elettrostatiche governano anche la cinetica di
desorbimento delle biomolecole infatti il rilascio sarà più veloce per le specie neutre mentre avverrà
con una cinetica più lenta per le specie cariche. Questi risultati ci suggeriscono che variando le
proprietà chimico-fisiche dell‟idrossiapatite si possono assemblare coniugati in grado di rispondere
in maniera specifica a diverse applicazioni terapeutiche.
La bioattività di un biomateriale può essere valutata attraverso la sua reattività chimica con l‟intorno
biologico. In questo senso lo studio dell‟interazione tra proteine e idrossiapatite rappresenta un
metodo per capire il modo attraverso cui il materiale comunica. Nel nostro caso la modificazione
della superficie dell‟idrossiapatite in seguito a funzionalizzazione con l‟alendronato è stata testata in
base mediante interazione con mioglobina. Questa proteina presenta un diverso grado di affinità nei
confronti dell‟apatite funzionalizzata con l‟alendronato rispetto all‟apatite non funzionalizzata.
Inoltre la struttura secondaria della mioglobina che interagisce con l‟apatite funzionalizzata non
subisce modificazioni, al contrario di quanto sembra avvenire per quella che interagisce con
l‟apatite non funzionalizzata.
19
Il trasferimento di alcuni dei processi di laboratorio su scala industriale è stato reso possibile dalla
collaborazione con “Guaber” grazie alla quale si è riusciti a produrre apatite biomimetica
nanocristallina da poter utilizzare come principio attivo per la riparazione di smalto e dentina in
alcuni prodotti del “dental care” di largo consumo.
Xerogeli nanostrutturati per il rilascio di molecole bioattive
Accanto alle apatiti nanocristalline, un materiale interessante ai fini della realizzazione di device per
il rilascio programmato di molecole bioattive è rappresentato dai geli di silice nanoporosi.
I geli di silice possono essere ottenuti da tetraalcossisilani mediante un processo sol-gel che,
avvenendo a temperatura ambiente ed in condizioni non lontane dalla neutralità, ha il vantaggio di
consentire di incapsulare nella matrice silicea molecole bioattive senza alterarne la stabilità.
Figura 1. Immagine TEM relativa alla microporosità degli
xerogeli sintetizzati. Le microporosità possono esser
sfruttate per l‟incapsulamento e delivery programmato di
biomolecole
La modulazione di alcuni parametri di sintesi
consente di controllare la nanoporosità dei
materiali ottenuti e di conseguenza la cinetica
con cui essi rilasciano le molecole bioattive
incapsulate. Le conoscenze acquisite in tal senso
sono state utilizzate per realizzare sistemi per il delivery prolungato di eparina, potenzialmente utili
per lo sviluppo di materiali da usare per la costruzione di organi artificiali ed il rivestimento di
stents cardiovascolari.
Figura 2. Visualizzazione del meccanismo di
funzionamento di uno stent cardiovascolare
Coating proteici, inorganici e compositi
Ricerche sull‟ottenimento di coating proteici (ad es. di collageno), apatitici
o compositi mediante tecniche di deposizione elettrochimica e
nebulizzazione ultrasonica vengono effettuate in collaborazione con la
School of Chemistry dell‟Università di Bristol.
Nel primo caso i parametri del processo di deposizione e gli
elettrodi possono essere opportunamente scelti in modo da
sincronizzare il processo di autoassemblaggio delle fibre di
collageno durante la formazione dei cristalli di idrossiapatite. Nel
secondo caso film ceramici ad alta area superficiale e film
polimerici possono esser ottenuti mediante precipitazione di un
reagente aerosol in una soluzione reattiva.
Figura 3 Coating proteico ottenuto mediante deposizione elettrochimica su
lamina di titanio
20
I dati ottenuti consentono di creare nuovi film o coating bioattivi che potranno anche essere
utilizzati come substrati biomimetici per il rilascio di farmaci con cinetica controllata. I risultati
inoltre stabiliscono nuove metodiche di sperimentazione per studiare i meccanismi di
biomineralizzazione del collageno nei tessuti biologici.
Son stati ottenuti diversi compositi biomimetici costituiti da -fibrille di collageno self assembled e
nanocristalli di idrossiapatite mediante deposizione elettrochimica su piattine di titanio-catene di
alginato self assembled e nanocristalli di idrossiapatite -chitosano e nanocristalli di idrossiapatite.
I compositi potranno in seguito essere utilizzati per l‟incapsulamento e rilascio di molecole
bioattive.
Un approccio innovativo per modulare e finalizzare la risposta cellulare alle nanoapatiti da impianto
che non preveda l‟uso di molecole bioattive, può essere ottenuto inducendo una specifica proprietà
fisica sui nanocristalli. A questo scopo sono state sintetizzate delle apatiti che risultano esibire delle
proprietà magnetiche che rappresentano un potenziali candidati per il trattamento locale dei tumori
ossei mediante ipertermia.
3) Nanotecnologie applicate a problematiche odontoiatriche e alla medicina rigenerativa
L‟attività di ricerca si è incentrata sulla caratterizzazione chimico-fisica e sulla valutazione in vitro
ed in vivo dell‟efficacia di un materiale inorganico nanostruttturato sviluppato con l‟obiettivo di
rimineralizzare le superfici dentarie e di prevenire l‟insorgenza della carie e dell‟ipersensibilità
dentinale.
Le proprietà innovative del materiale, da utilizzarsi anche come principio attivo in paste dentifricie
sono basate non solo sulla sua composizione chimica, ma anche sulla sua nanostrutturazione.
La sintesi del biomateriale con stechiometrica [Ca10(PO4)6-x(CO3)x(OH)2] dove x rappresenta il 24% in peso è stata ottenuta in condizioni sol-gel. Il materiale è stato caratterizzato tramite
microscopio elettronico a trasmissione (TEM) e diffrattometria a raggi X (XRD).
In seguito si è ottenuta una sospensione acquosa dei materiali (HA: H2O 1.5:1 in peso) che è stata
immediatamente applicata sulle sezioni dentinali prima mordenzate con acido ortofosforico per 1
minuto in modo da esporre i tubuli dentinali. Le sezioni sono state lasciate umide in una camera
d‟incubazione a 37° a contatto con la soluzione sperimentale per i seguenti tempi d‟applicazione
sperimentali: 10 minuti, 1 ora, 6 ore, 12 ore e 24 ore ed in seguito risciacquate con spray aria-acqua
per 1 minuto e analizzate al microscopio elettronico a scansione (SEM)
La Figura successiva mostra l‟immagine dei nanocristalli apatitici al TEM. I nanocristalli
presentano lunghezza che varia da 20 a 100 nm e spessore che varia da 5 a 10 nm.
Immagine TEM dei nanocristalli apatitici
Di seguito si riportano i patterns di diffrazione XRD dei nanocristalli sintetici di idrossiapatite (a)
comparati con la fase inorganica della dentina (b)
21
a
b
Patterns di diffrazione dei nanocristalli di HA (a) e fase inorganica della dentina (b).
Le dimensioni nanometriche dei cristalli e la bassa cristallinità sono responsabili della loro alta
bioreattività.
Le caratteristiche della dentina sono state analizzate al SEM ad un originale ingrandimento di
1000x, evidenziando una progressiva obliterazione dei tubuli dentinali. Le figure successive
mostrano la progressiva obliterazione dei tubuli
Tempo 0 (superficie demineralizzata) e non trattata
con il materiale. Si osservano gli imbocchi dei
tubuli dentinali pervi
Applicazione del materiale per 10 min. e lavato. Si osserva la
comparsa di aree di mineralizzazione.
Applicazione del materiale per 1 ora.
Il deposito di materiale si presenta distribuito
uniformemente. Non è più possibile osservare i tubuli
dentinali
Superficie dentinale dopo l‟applicazione del materiale per
6 ore. Si nota uno strato apparentemente spesso con una
fitta rete di aree mineralizzate, non si osservano i tubuli
dentinali.
22
Parallelamente è stato condotto uno studio in vivo con l‟obiettivo di verificare l‟efficacia del
biomateriale nel ridurre l‟ipersensibilità dentinale.
La pasta dentifricia è stata sperimentata su un numero limitato di soggetti volontari (10) che
lamentavano ipersensibilità dentinale.
I pazienti sono stati preventivamente sottoposti a igiene orale professionale, motivazione e
istruzione alle tecniche di igiene orale domiciliare. Dopo 15 gg è stata rilevata per ogni elemento
dentario il valore di sensibilità dentinale
Quindi, i pazienti sono stati divisi random in 2 gruppi di trattamento che non differivano
inizialmente per i valori dell‟indice di sensibilità che risultava essere mediamente 2,8 e 2,6
rispettivamente per il gruppo test e per il gruppo controllo.
In un gruppo è stato applicato sugli elementi dentari sensibili Fluodentin vernice, emulsione al
fluoro (concentrazione floruri puri 0,12%) a base acquosa, in un‟unica applicazione professionale.
Nel gruppo test è stata consegnata la pasta dentifricia contenente il materiale sviluppato con la
prescrizione di utilizzarlo 3 volte al giorno spazzolando almeno un minuto.
Dopo 15 giorni l‟indice di ipersensibilità è stato nuovamente rilevato.
Sia al tempo iniziale sia al termine della sperimentazione il grado di ipersensibilità è il test di
ipersensibilità è stato effettuato da un operatore esperto con modalità “in cieco”.
E‟ stato calcolata la riduzione dell‟indice di sensibilità dentinale tra il valore osservato all‟inizio e al
termine dello studio. E‟ stato utilizzato il Test U di Mann-Whitney esatto utilizzando il Metodo
Monte Carlo per il calcolo della probabilità.
La Figura successiva mostra la diminuzione dell‟ipersensibilità dopo l‟utilizzo del dentifricio
contenente il biomateriale.
Decremento medio della sensibilità dentinale
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
decremento ipersensibilità
Fluodentin vernice
HA dentifricio
0,6
1,75
È stato calcolato il decremento ottenuto dopo 15 giorni rispetto al valore iniziale tramite Test U di
Mann Whitney esatto. Metodo Monte Carlo per il calcolo della probabilità P<0.005.
Il valore medio risulta significativamente minore rispetto al valore iniziale rispetto al gruppo al
quale è stato applicato professionalmente Fluodentin vernice. Infatti la riduzione ottenuta dopo 15
giorni nel gruppo test è stata dello 0,6 mentre nel gruppo di controllo si è osservato un decremento
di 1,75.
4) Interazione di sistemi biologici modello con superfici inorganiche
Nell‟ ambito delle ricerche condotte sui silicati aventi rilevanza per l‟ambiente e la salute umana, l‟
U.R. di Bologna ha recentemente messo a punto una metodologia di sintesi idrotermale, altamente
23
riproducibile che permette di ottenere nanocristalli di crisotilo sintetici come unica fase, avente
morfologia e stechiometria definita (1). Ciò ha reso possibile la disponibilità di una campionatura
di riferimento standard per studiare il monitoraggio, il comportamento chimico-fisico e citotossico
del crisotilo.
La microscopia a forza atomica mostra la morfologia cilindrica dei nanotubi e permette di stimarne
le dimensioni; il diametro esterno è pari a 24 ± 2nm e il diametro interno 7 ± 1nm, lo spessore della
parete esterna è di circa 10 ±1nm (figura 1). Questi valori indicano che sono presenti circa 10 strati
OT, in accordo con lo spessore critico per il piano di sfaldatura del minerale.
(a
)
7
(c)
21
7
Figure 1: Immagini AFM del
crisotilo a diversi ingrandimenti
(b)
La disponibilità di crisotilo
stechiometrico sintetico con
struttura costante e morfologia
uniforme ha permesso di
approfondire le conoscenze
sulle interazioni con sistemi biologici per cercare di capire il meccanismo di legame con le fibre di
asbesto che porta allo sviluppo di fibrogenesi (asbestosi) e carcinogenesi (carcinoma broncogenico
e mesotelioma). Quindi, i nanotubi di crisotilo sintetico stechiometrico sono stati utilizzati per
studiare l‟interazione sia con le cellule che con proteine modello (2).
Il risultato degli studi ha ben evidenziato il ruolo principale svolto dall‟assenza, nei nanotubi di
crisotilo sintetico, di ioni estranei, usualmente presenti nella fase minerale, come Fe, Ni, Al, Ti, Mn,
Zn, Co e Cr. L‟effetto e la formazione di radicali liberi da parte dei nanotubi di crisotilo sintetico
sono stati confrontati con gli effetti causati dal ben noto e tossico crisotilo naturale, utilizzando
cellule epiteliali A549 del polmone umano. Dopo 24 ore di incubazione, il naturale, ma non il
sintetico, evidenzia un effetto citotossico tramite un legame con la lattato deidrogenasi. La rottura
omolitica del legame C-H e la lipoossidazione delle cellule A549 ha luogo in presenza del crisotilo
naturale, ma non del sintetico. I sistemi antiossidanti sono anche attaccati diversamente. Il cammino
del pentoso fosfato e il suo enzima regolatore deidrodrogenasi glucosio 6-fosfato non sono inibiti
dai nanotubi di crisotilo sintetico e stechiometrico, come ben evidenziato dal grafico in Figura 2.
Quindi nanotubi di crisotilo sintetico stechiometrico possono essere proposti come standard di
riferimento (controllo negativo) per studi tossicologici.(1)
3
5
30
LDH esterna
(% contro LDH totale)
25
Figura 2. Effetto delle fibre di crisotilo sul
rilascio della lattato deidrogenasi (LDH) in un
supernatante di cellule A549. Dopo 24 h di
incubazione in assenza (controllo) o in
presenza di 6µg/cm2 di nanotubi di crisotilo
sintetico o naturale. Dal confronto con il
controllo, si nota che l‟attività della LDH non è
significativamente modificata dal crisotilo
sintetico.
20
15
10
5
0
controllo
crisotilo naturale
crisotilo sintetico
24
Il passo successivo è stato quello di sintetizzare crisotilo sintetico drogato con concentrazioni di
crescenti di Fe per ottenere una diretta evidenza sperimentale del ruolo del Fe nella reattività
chimica e nel danno cellulare legato all' amianto. La presenza di Fe, anche in concentrazioni molto
basse (0,2% wt) trasforma le fibre di crisotilo da inerti a biologicamente dannose.
Per chiarire il meccanismo chimico responsabile della tossicità degli asbesti viene studiata l‟
interazione superficiale tra fibre di crisotilo minerale, che rappresenta il 95% dell‟ asbesto che è
stato utilizzato per la preparazione di manufatti commerciali, e le principali proteine del siero
sanguigno quali l‟ albumina e la fibronectina. Tecniche spettroscopiche ( DC, FTIR, Raman, UV),
microscopiche ( TEM, SEM, AFM ) e diffrattometriche con sorgenti convenzionali e luce di
sincrotrone sono utilizzare per caratterizzare l‟ equilibrio chimico che si instaura tra la superficie
delle fibre e la siero-proteina che, nell‟ aderire alla superficie inorganica, modifica
apprezzabilmente ed irreversibilmente la propria struttura secondaria come mostrato in figura 3 e 4.
[ ] x 10-3 deg cm2 dmol -1
30
low conc.
med. conc.
high conc.
native BSA
20
0
-20
-30
200
220
240
260
Wavelength[nm]
Fig.3: Fig.1). Spettri CD dell‟ albumina prima dell‟ assorbimento sulla matrice inorganica ( blue) e dopo
essere stata messa in contatto con nanocristalli di crisotilo sintetico a diversa ricopertura superficiale: BSA =
2.6 mg m-2 (blue), BSA = 1.7 mg m-2 (azzurro), BSA = 0.9 mg m-2 (blue tenue).
Fig. 4 ) Spetti FTIR ottenuti in KBr
pellets di (a,b) crisotilo sintetico ; (c,b)
crisotilo sintetico con albumina
25
L‟ interazione con le siero-proteine modifica sostanzialmente l‟affinità cellulare e la biopersistenza
delle fibre intrappolate nei tessuti biologici e quindi in grado di sviluppare la propria tossicità. Per
superare le difficoltà sperimentali intrinseche con l‟ eterogeneità chimica e strutturale del crisotilo
minerale, viene studiata principalmente l‟ interazione chimica delle siero-proteine con nanocristalli
di crisotilo sintetici. Le fibre di crisotilo sintetiche presentano una stechiometria superficiale che
può essere modificata in funzione del drogaggio con gli ioni metallici più comunemente presenti
nelle fibre minerali quali Fe e Ni. In questo modo è possibile individuare il ruolo specifico dei
singoli ioni metallici sull‟interazione del crisotilo con la componente proteica e conseguentemente
acquisire informazioni sul meccanismo della tossicità degi amianti. I risultati sperimentali ottenuti
vengono utilizzati in uno studio comparativo computazionale-sperimentale che, utilizzando tecniche
di grafica molecolare, mette in evidenza le modificazioni strutturali della proteina studiata in
funzione di alcuni parametri chimico fisici superficiali del crisotilo determinati sperimentalmente.
5) Ricerca di Storia della Chimica e attività di divulgazione scientifica
La storia della chimica può agire da collegamento fra scienze chimiche ed umanistiche e
incrementare l'interesse degli studenti per lo studio della chimica. Per arricchire l'insegnamento
della stechiometria chimica può essere utile, ad esempio, ricorrere a materiale ricavato da fonti
primarie che riportano esperimenti ormai familiari agli studenti. In questo lavoro si citano esempi
dagli Opuscules di Lavoisier (1774), recentemente tradotti in italiano (2005), e vengono dati
suggerimenti per interpretare i risultati ivi riportati.
26
UNITA’ DI RICERCA DI CAMERINO
Direttore Scientifico: Prof. Alfredo Burini
Sintesi, studi strutturali e attività citotossica di composti di coordinazione dei metalli del
gruppo 11.
L‟unità operativa di Camerino si è occupata principalmente delle seguenti tematiche:
1)
2)
Sintesi di derivati del gruppo 11 della tavola periodica con leganti azotati.
Studio dell‟attività citotossica di alcuni dei derivati ottenuti.
E‟ noto che il rame gioca un ruolo cruciale in diversi enzimi (ad esempio citocromo-c ossidasi,
superossido dismutasi, ceruloplasmina etc.) che catalizzano reazioni redox correlate con il sistema
antiossidante dell‟organismo. Certi complessi di rame catalizzano la formazione di radicali, mentre
altri sembrano essere efficaci come antiosidanti. I diversi comportamenti dipendono dall‟intorno
chimico e dalla natura dell‟agente chelante. In considerazione di quanto detto, la nostra attenzione si
è focalizzata su complessi di rame(I) con leganti “scorpionato”. I leganti poli(azolil)borati e i
relativi scorpionati sono leganti potenzialmente tridentati ampliamente impiegati come leganti
anionici ζ-donatori in un‟ampia varietà di complessi metallici che hanno avuto interessanti
applicazioni anche nella chimica bioinorganica. In particolare i poli(pirazolil)borati di rame sono
stati sintetizzati per ottenere modelli di prodotti naturali contenenti rame aventi varie proprietà. In
questo campo di ricerca, ci siamo interessati alla chimica di coordinazione di leganti
poli(azolil)borati con sostituenti elettron attrattori che generalmente migliorano la resistenza
all‟ossidazione dei centri metallici, la stabilità termica e la solubilità dei complessi. Ad esempio
abbiamo utilizzato il legante di seguito riportato per ottenere derivati di Cu(I) contenenti fosfine
terziarie mono- o bidentate come co-leganti.
I complessi ottenuti sono stati caratterizzati allo stato solido (analisi elementare e FT-IR) ed in
soluzione tramite 1H e 31P NMR. Su alcuni complessi selezionati sono stati eseguiti test su molte
linee cellulari tumorali umane per valutarne la loro attività citotossica (vedi tabella 1).
27
I complessi 1 e 5 mostrano valori di IC50 apprezzabilmente più bassi da quelli esibiti dal cisplatino, è inoltre interessante notare che tutti i tre derivati di Cu(I) testati sembrano essere
particolarmente attivi contro le cellule del carcinoma A459 che sono resistenti ai trattamenti con il
cis-platino.
Modificazioni dei poli(azolil)borati possono essere fatte rimpiazzando l‟atomo di boro a ponte con
altri elementi come il carbonio, il silicio o il fosforo oppure sostituendo i gruppi pirazolici con
quelli triazolici, imidazolici, o cambiando i sostituenti nell‟anello eterociclico. Tali cambiamenti
possono preservare o alterare la carica del legante. Diversi lavori sono stati recentemente pubblicati
usando come leganti derivati del bis(pirazol-1-il)metano aventi una struttura generale del tipo
[RR‟C(pz)2] dove R‟ può essere un gruppo acetato, ditioacetato, solfonato, etossido, fenolato,
tiolato etc.. Noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui derivati di rame(I) con il legante
monoanionico eteroscorpionato bis(3,5-dimetil-pirazol-1il)acetato, ([HC(CO2)(pzMe2)2]-). Inoltre
abbiamo sintetizzato un nuovo legante scorpionato contenente il triazolo, bis(triazol-1il)acetato,
([HC(CO2)(tz)2]-), in cui i gruppi triazolici, rispetto ai gruppi pirazolici, sono elettron attrattori
(figura 1).
Figura 1. Bis(triazol-1il)acetato, ([HC(CO2)(tz)2]-), 1a; bis(3,5-dimetil-pirazol-1il)acetato,
([HC(CO2)(pzMe2)2]-), 1b.
Facendo reagire questi leganti con [Cu(CH3CN)4][PF6] abbiamo ottenuto i complessi di rame(I)
sotto riportati in cui il legante ausiliare coordinato al centro metallico è la triidrossimetilfosfina, una
fosfina solubile in acqua che aiuta a risolvere il delicato problema della solubilità dei complessi in
condizioni fisiologiche.
I nuovi complessi di rame(I) sono stati testati per le loro proprietà citotossiche su un pannello di
molte linee cellulari di tumore umano. I risultati ottenuti mostrano che i complessi 2 – 4 presentano
un‟attività antitumorale in vitro simile o migliore del cis-platino. In particolare il complesso 3 ha un
valore di IC50 marcatamente più basso rispetto ai composti di riferimento su tutte le linee cellulari
tumorali investigate. Inoltre i test di chemiosensitività hanno dimostrato che i derivati 2 – 4 sono
capaci di superare la resistenza al cis-platino, facendo avanzare l‟ipotesi di un diverso meccanismo
d‟azione (Tabelle 2, 3).
28
Un‟altra linea di ricerca svolta da diversi anni dall‟unità di Camerino, riguarda la sintesi e la
reattività di derivati trinucleari ciclici di Au(I). In particolare abbiamo dimostrato che tali complessi
aventi un intorno chimico C-Au-N mostrano proprietà π-basiche. In virtù di tale caratteristica questi
derivati di oro sono in grado di riconoscere ed interagire con substrati acidi di Lewis. Si sono così
isolati diversi derivati luminescenti in cui la specie acido di Lewis è intercalata ai substrati
trinucleari di oro. Continuando la nostra indagine abbiamo fatto interagire i derivati trinucleare di
oro e argento sotto riportati.
In questo caso non si è isolato il prodotto di intercalazione atteso ma si sono formati derivati
trinucleari eterometallici di oro(I) e argento(I): [Au(carb)Ag2(μ-3,5-Ph2pz)2], [Au2(carb)2Ag(μ-3,5Ph2pz)]•CH2Cl2, [Au(bzim)2Ag2(μ-3,5-Ph2pz)] e [Au2(bzim)2Ag(μ-3,5-Ph2pz)]. Il rapporto Au/Ag
dei derivati dipende dalla stechiometria usata nella reazione. I Composti sono luminescenti, sono
stati caratterizzati tramite analisi elementare, 1H NMR, spettrometria di massa e determinazione
della struttura ai raggi-X. La figura 2 riporta due delle strutture ottenute.
29
Figura 2. Diagrammi ORTEP dei composti[Au(carb)Ag2(μ-3,5-Ph2pz)2]) e [Au2(carb)2Ag(μ-3,5-Ph2pz)]
(sinistra e destra rispettivamente).
Questi cicli eteronucleari formano specie dimeriche attraverso delle interazioni metallofiliche
intermolecolari. Considerando che piccoli clusters oro-argento sono risultati altamente efficaci in
catalisi ed in medicina, i derivati da noi ottenuti potrebbero avere attività farmacologica.
30
UNITA’ DI RICERCA DI CATANIA
Direttore Scientifico: Prof. Enrico Rizzarelli
Le linee di ricerca perseguite hanno riguardato:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
l‟effetto degli ioni metallici nei processi di aggregazione di proteine e loro frammenti;
sintesi e proprietà di recettori abiotici di β-ciclodestrine funzionalizzate;
effetto antiossidante di carnosina in studi in vitro;
Riconoscimento molecolare tra sistemi complessi in soluzione acquosa;
Interazione di compessi prionici contenenti rame con ossido di azoto.
I principali risultati ottenuti sono di seguito riportati
1) Caratterizzazione della stabilità termodinamica delle proteine (Prione, amilina, a-beta
amiloide e alfa-sinucleina) e correlazione con le loro caratteristiche conformazionali.
E‟ stato studiato l‟unfolding termico della proteina prionica SHaPrP29-231. Tutti i risultati ottenuti
evidenziano un comportamento termico molto complesso per questa proteina. Una comparazione
dei dati DSC con le curve di unfolding termico monitorate mediante analisi CD a lunghezza d‟onda
di 222 nm mostrano una discrepanza nella temperatura di transizione misurata dalle due tecniche.
Questo suggerisce che una descrizione dell‟unfolding termico di questa proteina solo in termini di
demolizione delle alfa-eliche è incompleta e che altre trasformazioni conformazionali sono
coinvolte nel processo. Quando lo ione rame(II) viene aggiunto al SHaPrP29-231 la temperatura e
l‟entalpia del primo picco calorimetrico sono modificati in dipendenza del rapporto molare
proteina/rame. A rapporto molare proteina/rame di 1:1 la presenza di rame stabilizza la proteina ed
il fenomeno dell‟aggregazione è completamente inibito. Se il rame viene aggiunto al prione in
rapporto molare 1:2 il primo picco, normalmente presente in assenza del metallo, scompare ed è
probabilmente convoluto con il secondo picco che risulta essere fortemente accresciuto in termini di
entalpia. A più alte concentrazioni, il rame promuove l‟aggregazione e non è possibile osservare il
fenomeno dell‟ unfolding nelle curve DSC. E‟ stato studiato il differente effetto del trealosio e della
tetraciclina su, rispettivamente, la stabilità e l‟aggregazione della proteina prionica permettendo da
un lato di confermare la capacità di questo zucchero di interferire con la conversione patologica
della proteina prionica, e dall‟altro, di proporre la DSC come una tecnica efficace per lo screening
di farmaci finalizzato a ottimizzare l‟approccio farmacologico nella terapia delle malattie prioniche.
2) Sintesi e caratterizzazione di peptidi fibrillogenici, loro interazione con le membrane e con
altre proteine native in assenza ed in presenza di ioni metallici Cu (II) e Zn (II).
E‟ noto che la formazione di fibrille amiloidi da amilina umana (hIAPP) è associata al diabete
mellito tipo II e che aggregati protofibrillari di hIAPP possono permeare bilayer lipidici. Tuttavia
non è noto né il ruolo giocato da ioni metallici nel controllo dell‟interazione peptide/membrana, né
quello dovuto a singole mutazioni nella sequenza amminoacidica. E‟ tuttavia indicativo che
l‟amilina di topo, che differisce dalla umana solo per alcuni aminoacidi, non provoca in questi
animali, la malattia. La ricerca è stata indirizzata allo studio dell‟interazione dei frammenti
VHSSNNFGAILSS (hIAPP 17-29) appartenente all‟amilina umana, VRSSNNLGPVLPP (rIAPP
17-29) appartenente all‟amilina di topo e VHSSNNLGPVLPP (rIAPP 17-29 R18H) un mutante di
quest‟ultima, con bilayers di 1,2-dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) in assenza ed in presenza di
ioni rameici. L‟utilizzo della DSC applicata a sistemi proteina-membrana, con diversi protocolli di
preparazione dei campioni, è capace di evidenziare un comportamento differente per i tre peptidi. In
particolare gli esperimenti hanno dimostrato che il frammento hIAPP 17-29 (umano) è in grado di
interagire significativamente con il bilayer DPPC senza risentire della presenza o meno di ioni rame
31
mentre il frammento rIAPP 17-29 (topo) non mostra alcuna significativa interazione con la DPPC
e non risente della presenza di ione rame. Assolutamente diverso invece il comportamento della
rIAPP R18H che mostra una moderata interazione con la membrana, dipendente dalla presenza di
ioni rame. I risultati degli esperimenti DSC qui ottenuti, ci permettono di ipotizzare un possibile
meccanismo generale delle interazioni metallo-assistite lipide/peptide. Inoltre misure CD
arricchiscono il quadro complessivo dei risultati permettendoci di proporre dei possibili modelli
molecolari per questo tipo di patologia. In particolare appare chiaro che il diverso comportamento
dei frammenti rispetto alle interazioni con le membrane è riconducibile a 5 diversi aminoacidi, sui
75 che costituiscono l‟intero peptide, appartenenti ai frammenti studiati, ed in particolare all‟Istidina
18. Inoltre il frammento umano, a differenza di quello di topo, è stabilizzato nella membrana in
conseguenza alla sua trasformazione da random-coil ad aggregati -sheet, che rappresentano il
primo step per la formazione delle fibrille insolubili implicate nella patologia. Lo stesso approccio
su riportato è stato utilizzato nello studio di interazioni tra il frammento prionico PrP 106-126 con
membrane costituite da DPPC. Ioni rame influenzano il comportamento del sistema secondo il
metodo di preparazione del campione. L‟iniziale formazione di complessi Cu(II) /peptide in
soluzione previene la spontanea inserzione del frammento prionico nella membrana DPPC.
L‟addizione di ioni rame al sistema peptide/membrana già formato implica una progressiva
diminuzione dell‟energia di transizione gel-cristallo liquido della membrana all‟aumentare della
concentrazione di Cu(II). Un comportamento differente si è evidenziato utilizzando Zn(II) al posto
di Cu(II). Tale risultato mostra un‟interessante differenza nell‟effetto modulante dei due ioni sui
sistemi peptide-membrana, i cui meccanismi richiedono di essere ulteriormente approfonditi. Con
l‟utilizzo combinato di ESI-MS, UV-Vis, CD, EPR, DSC e metodi potenziometrici, lo studio è stato
quindi esteso a peptidi analoghi corrispondenti alla regione dell‟elica II del prione, PrP 180-193. In
particolare, sono stati studiati tutti i possibili derivati con i gruppi N- e C- terminali liberi o,
rispettivamente, acetitati e ammidati. PrP Ac180-193 mostra un‟elevata tendenza ad aggregare,
rendendo difficile una stima quantitativa delle proprietà chimico-fisiche in soluzione. PrP 180-193
NH2 ha mostrato la capacità di legare Cu(II) all‟His187 con stechiometria 1:1. In modo analogo, il
complesso del Cu(II) con il frammento PrP Ac180-193 NH2 ha mostrato caratteristiche
spettroscopiche riconducibili a studi condotti in precedenza sull‟intera proteina, suggerendo che la
scelta del modello è giustificata. Inoltre, è stato evidenziato che l‟aggiunta del metallo al peptide
induce una transizione conformazionale alfa-elica -> beta sheets. Un dettagliato studio
potenziometrico delle varie specie chimiche coinvolte nella reazione di complessazione ramepeptide ha richiesto la sintesi di un peptide modello più piccolo (PrPAc184-188NH2). L‟utilizzo di
tale modello, validato anche da un‟analisi comparata dei parametri ESR relativi al frammento
PrPAc184-188NH2 PrP Ac180-193NH2 e all‟intera proteina, ha consentito non solo la
caratterizzazione delle caratteristiche geometriche del complesso, ma anche la misura della costante
di stabilità relativa delle varie specie, suggerendo che tale sito può essere altamente competitivo per
il binding del metallo rispetto ad altri siti già studiati in precedenza. Analoghi studi condotti sugli
octarepeats del prione umano e sugli esarepeats del prione aviario hanno messo in evidenza che le
specie maggiormente popolate nell‟equilibrio Cu(II) – dodecarepeats del prione aviario hanno una
maggiore stabilità delle corrispondenti specie del prione umano. Dettagliate analisi spettroscopiche
ci hanno permesso di stabilire che ciò è ascrivibile alle proline, le quali costituiscono punti di
discontinuità nella formazione del complesso metallico e inducono quindi la formazione di
macrochelati e complessi di nucleari ad elevata stabilità. Tali risultati propongono una significativa
chiave di lettura a livello molecolare del fatto che finora non risultano documentate malattie
prioniche negli uccelli.
3) Progettazione e sintesi di molecole con potenziale attività antifibrillogenica, antiossidante
chelante e antiglicante.
In aggiunta alle tradizionali indicazioni terapeutiche dei faramaci anti-infiammatori (NSAIDs) sono
oggi in fase di studio applicazioni di queste molecole nella cura e nella prevenzione di alcune
32
patologie neurodegenerative quali il morbo di Alzheimer. E‟ stato infatti dimostrato che alcuni
NSAIDs riducono la produzione di A-beta 42 in colture cellulari. Alla luce di queste osservazioni
la ricerca in questo settore appare essere particolarmente interessante e per quanto riguarda la
veicolazione di farmaci in vivo e per quanto riguarda la sintesi di nuove molecole. Per quanto
riguarda il primo punto è stata messa a punto e brevettata la funzionalizzazione con ciclodestrine di
ETODOLAC, un farmaco antinfiammatorio di cui sono noti gli effetti inibitori della COX. Per
quanto concerne il secondo punto è stata dimostrata l‟attività protettiva della Carnosina, un
dipeptide endogeno, nei confronti degli stress nitrosativi in colture cellulari astrogliali,
prospettandone un promettente utilizzo in strategie terapeutiche neuroprotettive.
4) Studio delle interazioni proteine-peptidi-piccole molecole e utilizzo dei risultati come
“constraints” nelle analisi computazionali;
Dati di letteratura e recenti nostre osservazioni sperimentali confermano l‟ipotesi che un‟anomala
interazione del PrP con membrane lipidiche può innescare la conversione del PrPc in PrPsc. In
particolare, il frammento studiato, PrP 180-193, ha mostrato in vitro: i) di interagire con membrane
modello, ii) di formare fibrille ricche in strutture beta-sheet, iii) di essere tossico per cellule
neuronali. Simulazioni di Dinamica Molecolare hanno permesso di studiare la stabilità della alfaelica dei due peptidi.: il peptide zwitterionico PrP 180-193 (L1) e derivati in cui le normali cariche
elettrostatiche presenti ai gruppi terminali sono state neutralizzate (L2). In acqua, la struttura ad
elica dell‟ L1, è instabile; al contrario, nell‟ L2
-elica si divide nella zona centrale alla Gln 186,
e le due risultanti eliche connesse tra loro sono abbastanza stabili. La stabilità della struttura ad elica
dell‟ L1 diminuisce in ambiente idrofobico (etano); questo effetto è ancor più evidente per l‟ L2 per
il quale i residui nella zona C-terminale a partire dall‟ His 187 sono in struttura random-coil. In
quest‟ultimo caso l‟unfolding della zona C-terminale è seguita dalla formazione di legami idrogeno
intramolecolari che legano l‟His 187 con il residuo 191 che “forzano” la struttura a piegarsi in
corrispondenza della Gln 186.
5) Processi di riconoscimento molecolare.
Le porfirine sono tra le molecole più studiate dai chimici. Le ragioni di tale interesse dipendono non
solo dal fatto che esse svolgono un ruolo fondamentale in diversi sistemi biologici, ma anche dalla
facilità con cui esse possono essere studiate grazie alle peculiari proprietà spettroscopiche. Esse
presentano, infatti, proprietà spettroscopiche notevoli (quali l‟elevato coefficiente di estinzione
molare e l‟alta resa di emissione di fluorescenza) che possono essere facilmente modulate inserendo
sia diversi ioni metallici (al centro dell‟anello), sia diversi sostituenti (alla periferia, per esempio in
posizione meso-). In particolare, l‟introduzione di gruppi carichi in posizione meso- ha reso
possibile l‟ottenimento di porfirine solubili in acqua. E‟ importante sottolineare a questo punto che,
in funzione del numero e/o della disposizione dei vari gruppi carichi, le porfirine presentano in
acqua una naturale tendenza verso la auto-aggregazione. I gruppi carichi rendono, infatti, tali
molecole solubili in acqua, ma non idrofiliche. Del resto, la stessa struttura di queste molecole (un
ampia superficie piana, elettron-ricca) favorisce interazioni tipo van der Waals anche in solventi
meno polari dell‟acqua. Chiaramente le porfirine con un alto numero di cariche sono quelle che
restano monomeriche per un più ampio intervallo di concentrazione e forza ionica. In relazione a
ciò, vi era in letteratura la diffusa convinzione che l‟aggregazione su matrici di carica opposta a
quella delle porfirine fosse una prerogativa specifica di porfirine con una forte tendenza verso
l‟auto-aggregazione. poiché in acqua, in presenza di una matrice, sono guidate da specifici processi
di riconoscimento molecolare. Ciò è vero anche per porfirine tetra-cariche che non mostrano alcuna
tendenza ad auto-aggregare (in assenza di una specifica matrice) anche ad „alte‟ concentrazioni (10 4
M) e forze ioniche. La specificità di queste interazioni insieme alla inerente presenza di
cooperatività dei processi di aggregazione, indirizzerà la nostra ricerca verso settori applicativi
33
come quello dei sensori. Infatti, sia la specificità che la cooperatività sono dei requisiti essenziali
per ottenere , rispettivamente, una buona selettività ed una elevata sensibilità.
i) interazioni in soluzione acquosa tra porfirine cationiche e porfirine anioniche, e ii) interazioni tra
le porfirine e templati di carica opposta la cui funzione è quella di organizzare e modulare il numero
di porfirine aggregate. I templati investigati sono stati sinora biopolimeri chirali quali polipeptidi
recanti in catena laterale gruppi ionizzabili al variare del pH. La variazione della densità di carica
sul polipeptide è stata sfruttata per modulare con il pH il numero di porfirine aggregate. Questo ha
consentito di ottenere tutta una serie di sensori per pH, ioni metallici, DNA o RNA. Grazie alle
peculiarità elettroniche e coordinative dei metalli coordinati nel core della porfirina è stato inoltre
dimostrato che è possibile controllare la geometria di aggregazione. Comunque, sia in presenza che
in assenza di templati non è stato ancora acquisito il controllo sulle dimensioni degli aggregati.
Infatti, l‟auto-aggregazione delle porfirine porta alla formazione di specie in cui il rapporto
stechiometrico non coincide con la reale stechiometria delle specie che sono di dimensioni notevoli
e variabili
In questo progetto si propone il disegno, la formazione e la caratterizzazione in soluzione
acquosa di aggregati di porfirine aventi stechiometria determinata e modulabile utilizzando le
interazioni elettrostatiche tra cariche nette di segno opposto quale forze guida dei processi di selfassembly. Questi complessi saranno progettati in maniera tale da renderli attivi verso processi di
trasferimento elettronico fotoattivati o per essere utilizzati come sensori. Il progetto prevede due
approcci diversi, uno in presenza e l‟altro in assenza di templati. Nel primo caso si propone
l‟ottenimento di aggregati di porfirine di carica opposta utilizzando metallo-porfirine pentacoordinate per limitare la crescita dei complessi supramolecolari alle dimensioni desiderate. Infatti,
a differenza delle porfirine planari, i derivati pentacoordinati hanno una sola faccia disponibile
all‟aggregazione e quindi fungono da “stopper”. Nel secondo caso verranno studiati complessi
calixarene-porfirina in cui i calixareni esplichino una funzione di templato organizzatore per
l‟ottenimento di aggregati a stechiometria nota e modulabile. Infatti, dati preliminari indicano che i
calixareni carbossilati inducono l‟aggregazione di un numero discreto e modulabile di porfirine
poiché il numero di siti disponibili per la complessazione varia con il pH. L‟uso di queste molecole
come templati presenta anche altri vantaggi. Infatti: i) possono essere variamente funzionalizzate
variando sia il numero che la natura (cationica, anionica, chirale etc.) dei siti complessanti,
consentendo il disegno di specifiche specie supramolecolari, e ii) sono particolarmente adatti ad
essere utilizzati quali sensori.
6) Caratterizzazione chimico-fisica di complessi di rame(II) con leganti correlati alle proteine
prione da mammiferi o uccelli e loro interazione con ossido di azoto
Lo studio della proteina prione (PrP) si inserisce nel contesto delle malattie provocate da modifiche
conformazionali delle proteine, e dei fattori ambientali che ne determinano l‟eziopatologia. Come
glicoproteina si trova principalmente sulla membrana plasmatica dei neuroni e delle cellule gliali
dei mammiferi. L‟isoforma conformazionale della PrPC, la proteina PrP(scrapie), è il fattore
responsabile delle encefalopatie spongiformi finora identificato. Il protein misfolding può essere
indotto da cambiamenti dell'omeostasi degli ioni metallici, dalla presenza di proteine chaperon
patologiche, da modifiche di pH e da stress ossidativi. E‟ stato dimostrato che la proteina prione ha
un ruolo come trasportatore del rame all‟interno della cellula (per endocitosi), e potrebbe avere
attività SOD-like, anche se questa evidenza è oggetto di grandi controversie in letteratura. La
regione N-terminale del prione umano, costituita dai residui 60-91, possiede quattro sequenze
octapeptidiche, altamente ripetitive, PHGGGWGQ. Studi spettroscopici hanno dimostrato che il
Cu(II) induce la formazione di strutture ordinate in questa regione; infatti, utilizzando peptidi
sintetici corrispondenti a tali sequenze, alcuni autori hanno dimostrato che il legarsi del Cu(II) a PrP
sia necessario a fare assumere la corretta conformazione che consente alla proteina di espletare la
sua funzione antiossidante. Allo scopo di comprendere il tipo di interazione tra metalli e le
specifiche sequenze della PrP, sono stati effettuati numerosi studi utilizzando frammenti peptidici
34
della proteina PrP, che possono essere considerati un modello semplificato, ma rappresentativo.
Determinare, quindi, la precisa coordinazione del rame(II) all'interno del dominio octarepeat è
stato un obiettivo primario per comprendere il ruolo della PrP come "copper protein". A tale scopo,
sono stati effettuati studi spettroscopici e spettrofotometrici dei complessi di Cu(II) con i peptidi
Ac-HGGG-NH2 e Ac-PHGGGWGQ-NH2 , in soluzione acquosa, variando il pH da 4 a 11 per
avere una chiara conoscenza di tutte le specie che si formano in questo intervallo di pH, delle loro
relative percentuali, della loro stechiometria e delle loro caratterstiche geometriche.
Successivamente, per verificare la presenza di molecole d'acqua nella sfera di coordinazione, come
riportato nella struttura cristallografica del Cu-Ac-HGGGW-NH2 , sono stati effettuati studi di ESIMS nei complessi di rame a pH neutro e basico. Spettri EPR in banda X a temperatura ambiente e a
bassa temperatura hanno consentito di determinare il numero di atomi di azoto direttamente legati al
rame nel piano equatoriale. In particolare, a pH fisiologico, i complessi di rame(II) con i peptidi AcHGGG-NH2 ed Ac-PHGGGWGQ-NH2 danno luogo alla specie [Cu(L)H-2] (dove con L si indica
uno dei generici peptidi ed H-2 indica la deprotonazione di due atomi di azoto ammidici, in
conseguenza della complessazione), che presenta una geometria piramidale a base quadrata, con tre
atomi di azoto donatori nel piano equatoriale, provenienti dall‟imidazolo e dai gruppi ammidici, ed
un atomo di ossigeno carbonilico. Negli spettri EPR a bassa temperatura si è ottenuto sia un basso
valore di g|| che della costante di accoppiamento iperfine. Il basso valore della costante di
accoppiamento parallela implica una forte interazione apicale e, quindi, la presenza di un forte
legame con il rame lungo la direzione perpendicolare al piano equatoriale, mentre, la struttura
superiperfine a 7 righe, dovuta all'interazione dell'elettrone spaiato nell'orbitale dx2-y2, o dxy,
centrato sul rame, indica la presenza di tre atomi di azoto nel piano equatoriale. Questi fatti indicano
che la stereochimica del complesso si avvicina di più ad una piramide a base quadrata.
In una seconda fase, viste le elevate potenzialità dell‟ossido di azoto come probe per lo studio
strutturale e redox dei centri metallici, è stata valutata il tipo di interazione con NO da parte dei
complessi Cu- Ac-HGGG-NH2, Cu- Ac-PHGGGWGQ-NH2, come precedentemente fatto con
metalloproteine. In particolare, in questo studio sono state impiegate molecole di NO-donors che
rilasciano ossido di azoto in maniera controllata. Recenti evidenze, inoltre, hanno mostrato che la
PrP influenza l‟attività enzimatica della nNOS (neuronal nitric oxide synthase), l‟enzima deputato
alla sintesi dell‟ossido di azoto nei neuroni. E‟ stato dimostrato che la PrP e la nNOS sono
colocalizzate ed entrambe sono associate a microdomini membranosi ricchi in colesterolo, insolubili
nei detergenti, detti rafts. La nNOS è alterata negli encefali di topi infettati con la proteina scrapie, e
la riduzione della sua attività è dovuta all‟assenza della nNOS dalla sua consueta localizzazione di
membrana, a causa della sua dissociazione dai rafts. La nNOS solubile, infatti, è parzialmente
attiva; sembra, inoltre, che la PrP possa determinare la corretta localizzazione della nNOS o
comunque, che entrambe facciano parte dello stesso sistema funzionale, che può in qualche modo
essere responsabile dell‟attivazione di altre proteine, alcune delle quali capaci di indurre i sintomi
della scrapie. Questi risultati suggeriscono quindi un ruolo della PrP nella regolazione
dell‟efficienza catalitica della nNOS, mentre non è noto come l‟attività dell‟enzima neuronale, o del
suo prodotto NO, possa influenzare la stabilità delle diverse isoforme della PrP. In questo tipo di
misure, si realizzerebbe un modello mimetico della condizione in vivo in cui la presenza dei due
sistemi proteici, il prione e la nNOS, sono colocalizzati. Sperimentalmente, in seguito
all‟interazione del monossido di azoto con questi complessi si osserva una notevole riduzione del
Cu(II), che lascerebbe pensare ad un processo di electron transfer mediato dalla formazione di un
legame debole tra il rame e l‟NO (probabilmente nitrito, cioè la forma ossidata), con successivo
trasferimento dell‟elettrone al centro metallico. Gli shifts spettroscopici osservati sia negli spettri
visibili che nei parametri magnetici, suggeriscono un‟espansione della sfera di coordinazione del
rame(II) che cambia da una piramide a base quadrata ad una geometria pseudo-ottaedrica. La
formazione dell'addotto potrebbe coinvolgere la posizione apicale libera. In presenza di ossigeno,
gli spettri UV-Vis ed EPR (RT) dei due sistemi mostrano le stesse caratteristiche del complesso
originario. Comunque, non si può escludere la possibilità che lo scambio elettronico avvenga anche
a sfera esterna supponendo che la reazione non sia sotto un controllo termodinamico, ma cinetico.
35
36
UNITA’ DI RICERCA DI FERRARA
Direttore Scientifico: Prof.ssa Paola Bergamini
A) Complessi idrosolubili di Renio con 1,3,5-triaza-7 phosphaadamantane (PTA)
B) Studio di composti di coordinazione del platino con molecole naturali o loro derivati finalizzato
alla messa a punto di farmaci innovativi.
A) Complessi Idrosolubili di Renio con 1,3,5-Triaza-7 Phosphaadamantane (PTA)
Introduzione
L‟interesse verso la chimica di coordinazione del renio e del tecnezio è dovuto principalmente alle
applicazioni radiofarmaceutiche dei loro radionuclidi in medicina nucleare; in particolare il 99mTc è
il radionuclide maggiormente impiegato in campo diagnostico (imaging molecolare) per le sue
ideali proprietà fisiche ( -emettitore, Emax = 140 keV, t1/2 = 6 h) e in quanto può essere facilmente
disponibile grazie al generatore 99Mo/99mTc. Entrambi gli isotopi di renio, (186Re, Emax = 1.1 MeV,
t1/2 = 90.64 h; 188Re, Emax = 2.1 MeV, t1/2 = 17 h), sono -emettitori e ottimi candidati per
applicazioni terapeutiche in radioisotopoterapia, ma la disponibilità del generatore 188W/188Re rende
il renio-188 più promettente per lo sviluppo di radiofarmaci antitumorali.
Tecnezio e renio mostrano una chimica molto vasta, a causa del fatto che possono trovarsi in stati di
ossidazione da -1 a +7, e coordinano una grande varietà di leganti assumendo diverse geometrie di
coordinazione. Tale versatilità è accentuata in particolari core, che sono stati ampliamente studiati
per lo sviluppo di nuovi potenziali radiofarmaci.
Fosfine mono e polidentate solubili in acqua giocano un ruolo importante nella chimica di
coordinazione sia nel settore della catalisi che in quello della medicina nucleare (diagnostica per
imaging, Tc-99m; radioisotopoterapia, Re-188). Il legame metallo-fosforo rende i complessi
altamente stabili anche nelle condizioni non favorevoli che si possono incontrare in vivo.
La chimica di coordinazione di Tc-99 e del suo congenere renio si basa sullo studio della reattività
di complessi precursori che, nella maggior parte dei casi, sono stabilizzati da fosfine aromatiche o
alifatiche, in particolare dalla trifenilfosfina, come ad esempio [ReOCl3(PPh3)2],
[M(NCMe)Cl3(PPh3)2], [MNCl2(PPh3)2], (M=Tc, Re). La presenza di PPh3 aumenta notevolmente il
peso molecolare dei complessi, li rende prevalentemente insolubili in mezzo acquoso e quindi non
ideali nella sintesi di radiofarmaci che vengono iniettati in soluzione fisiologica.
L‟attività di ricerca da noi condotta ha portato a sintetizzare e caratterizzare una nuova classe di
precursori di renio e tecnezio non contenenti trifenilfosfina, impiegando la fosfina 1,3,5-triaza-7fosfaadamantano (PTA), ideale sia per la sua solubilità in acqua (ca. 235 g/L), che per le sue piccole
dimensioni. In particolare la nostra attenzione si è focalizzata sul nitruro precursore
[ReNCl2(PTA)3] 1 e sul dioxo-complesso [ReO2Cl(PTA)3] 2 che hanno mostrato una buona
reattività con il legante modello dietilditiocarbammato di sodio (i risultati ottenuti sono stati
riportati nella precedente relazione). Si è quindi pensato di estendere lo studio di reattività ad altre
classi di leganti tra cui riportiamo i monotioli p-Tiocresolo e 1-Tio- -glucosiotetracetato (Tio-Glu).
Risultati e discussione
Reattività di [ReNCl2(PTA)3] 1
Il nitruro-precursore 1 reagisce a temperatura ambiente con il legante Tio-Glu, in presenza di Et3N,
per dare un complesso rosso-arancio in buona resa (Schema 1). La reazione è stata seguita tramite
spettroscopia 31P NMR; inizialmente è presente il sistema doppietto-tripletto a δ= –78.5 e –75.0
ppm, relativo al precursore, che via via sparisce sostituito da un nuovo sistema doppietto-tripletto a
37
-83.5 e -78.2 ppm attribuibile al prodotto finale. Lo spettro protonico NMR, non è particolarmente
significativo in quanto i segnali relativi al PTA nella regione tra 4-5 ppm coprono le risonanze
relative ai protoni del legante; sono invece visibili i singoletti relativi ai CH3 del Tio-Glu tra 2.3-1.8
ppm, la cui integrazione permette di confermare un rapporto legante-PTA 2:3. Lo spettro IR
evidenzia la presenza del legante coordinato e del PTA e anche le analisi elementari sono in accordo
con l‟ipotesi di un complesso nitrurico ottaedrico contenente tre molecole di fosfina e due di
legante. Trattandosi di un complesso diamagnetico nitrurico di Re(V), che presenta tre PTA nella
sfera di coordinazione, il legante dovrà necessariamente essere legato al metallo come monodentato
attraverso l‟atomo di zolfo deprotonato.
Il prodotto [ReN(Tio-Glu)2(PTA)3] risulta solubile in acqua e in tutti i comuni solventi organici; tale
fatto ha reso fino ad oggi praticamente impossibile l‟ottenimento di cristalli idonei alle indagini
strutturali ai raggi X.
Schema 1
N
Cl
PTA
Re
ATP
PTA
N
Glu
S
Tio-Glu
CH2Cl2/MeOH
PTA
Re
ATP
PTA
Cl
S
Glu
Il complesso [ReN(p-Tiocresolo)2(PTA)2] è stato ottenuto nelle medesime condizioni di reazione
impiegate per il composto sopra descritto (Schema 2). In questo caso, seguendo la reazione al 31PNMR, si osserva la progressiva scomparsa del sistema doppietto-tripletto del precursore e la
conseguente comparsa di un singoletto a -74.3 ppm relativo ai due fosfori equivalenti dei PTA. lo
spettro 1H-NMR è risultato fondamentale per la caratterizzazione del prodotto finale: oltre a
sottolineare il diamagnetismo del complesso permette di dare una completa assegnazione di tutti i
protoni relativi al PTA e al legante. Tra 7.20-7.40 ppm è presente il classico sistema para-paraI del
p-tiocresolo, nell‟intervallo 4.0-4.5 ppm sono presenti i segnali del PTA e infine a 2.4 ppm
risuonano i CH3 del legante. L‟analisi elementare e lo spettro di massa confermano l‟ipotesi che si
tratti di un nitruro-complesso di Re(V) a classica geometria piramidale pianoquadrata contenente
due molecole di fosfina idrosolubile e due di legante. Dalle indagini analitiche e spettroscopiche
finora descritte e non essendo in possesso ad oggi della struttura ai raggi X, non è possibile dire con
certezza se si tratti del composto cis o trans.
Schema 2
CH3
N
Cl
PTA
Re
ATP
PTA
H3C
N
SH
ATP
CH2Cl2, Et3N
S
Cl
Re
S
PTA
H3C
Reattività di [Re2O3(Et2Dtc)4] 2
Il dioxo-precursore 2 reagisce con il p-tiocresolo nella miscela CH2Cl2/MeOH, in blande condizioni
di reazione, per dare il prodotto [Re(p-tiocresolo)3(PTA)2] come solido viola scuro microcristallino
(Schema 3).
Il prodotto è solubile in CH2Cl2, CHCl3 e benzene, scarsamente solubile in alcoli e praticamente
insolubile in acetone e acqua.
38
Schema 3
CH3
O
ATP
PTA
PTA
H3C
SH
Re
Cl
PTA
CH2Cl2/MeOH
S
H3C
S
Re
S
O
PTA
CH3
Lo spettro di risonanza magnetica nucleare al 31P presenta un singoletto molto allargato a -78 ppm
mentre all‟NMR protonico, anch‟esso mal risolto, sono visibili i segnali relativi ai metili (2.4 ppm)
e ai protoni aromatici (7.3 ppm) del legante; tra 3.8-4.6 ppm cadono, nel classico intervallo, i
protoni del PTA. Le integrazioni dei segnali permettono di stabilire il rapporto 2:3 tra fosfina e
legante. Gli spettri di massa, e le analisi elementari sono in accordo con l‟ipotesi di un complesso a
geometria trigonale bipiramidale contenente due PTA nelle posizioni apicali e tre molecole di
legante sul piano equatoriale, in cui il renio ha subito una riduzione da (V) a (III).
La reazione del precursore [ReO2Cl(PTA)3] con il legante Tio-Glu in rapporto 1:4, condotta in
CH2Cl2/MeOH a temperatura ambiente, porta ad ottenere un composto rosso brillante, ad oggi non
completamente caratterizzato; la successiva reazione con AsPh4Cl porta ad isolare il complesso
[ReO(H2O)(Tio-Glu)4]-[AsPh4]+.
B) Studio di Composti di Coordinazione del Platino con Molecole Naturali o loro Derivati
Finalizzato alla Messa a Punto di Farmaci Innovativi
i) PLATINO E ACIDO ASCORBICO
In questo anno, nell‟unità di Ferrara sono stati progettati, preparati e caratterizzati una serie di
composti modello, esemplificativi di diverse modalità di coordinazione, sia note che nuove,
dell‟acido L-ascorbico al platino (II).
Questa chimica potrebbe avere grande rilevanza in campo farmacologico qualora i complessi
ottenuti associassero le note proprietà antitumorali dei componenti (platino e acido ascorbico) con
la capacità dell‟acido ascorbico di superare la barriera ematoencefalica attraverso trasportatori
specifici. E‟ noto infatti che il cisplatino e congeneri non sono attivi contro i tumori del sistema
nervoso centrale in quanto non superano la barriera emato-encefalica. Recenti lavori del gruppo del
Prof. Manfredini dell‟Università di Ferrara, hanno mostrato che alcuni farmaci, somministrati in
forma coniugata con l‟acido ascorbico, acquisiscono la capacità di superare la barriera ematoencefalica, sfruttando la strategia denominata del “cavallo di Troia”.
Sebbene il potenziale utilizzo di complessi di platino con l‟acido ascorbico come antitumorali sia
già stato proposto, si è ritenuto che valesse la pena di rivisitare e ampliare questa chimica nella
prospettiva di impiegare i prodotti come farmaci capaci di raggiungere il SNC.
Per cominciare sono state studiate le diverse modalità di coordinazione dell‟acido ascorbico al Pt(II)
come legante anionico. Sul metallo sono presenti anche leganti neutri (ammine o fosfine) in
configurazione cis secondo lo schema consolidato per gli antitumorali di platino.
Le gamma di modalità di coordinazione teoricamente realizzabili sono:
39
OH
O
H3N
NH3
O
O
OH
O
Pt
O
OH
O
HO
O
Ph3P
OH
Ph3P
O
Pt
O
O
Pt
Ph3P
O
OH
O
PPh3
Coordinazione O2-O3
Coordinazione C2-O5
HO
O
O
Coordinazione O5-O6
HO
O
O
OH
HO
HO
OH
O
NH3
O
Pt
CH3
X
Pt
Ph3P
NH3
PPh3
Coordinazione monodentata O3
Coordinazione monodentata C2
Coordinazione O2-O3
E‟ stata ottenuta la coordinazione O2-O3 dell‟acido ascorbico al platino
facendo reagire precursori platino carbonato-fosfinici (es. [Pt(PPh3)2CO3] e [Pt(dppe)CO3] con
l‟acido libero. L‟indagine spettroscopica conferma la formazione dei complessi 2 e 4, stabili sia allo
stato solido che in soluzione in solventi organici, ma pochissimo solubili in acqua.
.
O
Ph3P
Pt
Ph3P
O
Ph2
P
O
O
Pt
O
P
Ph2
O
OH
2
O
O
OH
4 HO
HO
A partire da [Pt(PTA)2Cl2] e passando attraverso la preparazione dell‟aquo-complesso, è stato
ottenuto il complesso [Pt(PTA)2O2-O3Asc] (5), dove il PTA (1,3,5-triaza-7-fosfo-adamantano) è
una fosfina di grande interesse in quanto poco ingombrante e molto solubile in acqua.
O
P
PTA
Pt
N
N
O
N
O
PTA
O
OH
1, 3, 5- triaza -7-fosfo-adamantano (PTA)
5
HO
Coordinazione O5-O6
Questa modalità di coordinazione risulta particolarmente interessante in
vista dell‟utilizzo dell‟acido ascorbico come trasportatore del Platino attraverso la barriera ematoencefalica, in quanto pare che l‟interazione dell‟acido ascorbico con il suo trasportatore specifico
attraverso la barriera emato-encefatica (una proteina detta SVCT2) si realizzi attraverso il sistema
enediolico, che deve perciò rimanere libero. Per ottenere complessi O5-O6 coordinati, è
indispensabile proteggere selettivamente gli OH più acidi (2 e 3) tramite benzilazione. L‟acido
40
ascorbico protetto, fatto reagire con [Pt(PPh3)2CO3] e con [Pt(dppe)CO3], ha permesso di isolare i
complessi 6 e 7. E‟ stata ottenuta la struttura ai raggi X di 7, primo esempio di caratterizzazione
cristallografica della coordinazione O5-O6 dell‟acido ascorbico.
O
PPh3
Pt
O
O
BnO
OBn
Pt
PPh3
O
6
Ph2
P
O
O
O
O
BnO
P
Ph2
7
OBn
7
Coordinazione C2-O5 Si ottiene solo con precursori amminici. E‟stato preparato il complesso 8
secondo la metodica di Hollis per studiarne la caratterizzazione NMR e la stabilità in acqua con lo
scopo di verificare la possibilità di proporlo come profarmaco per il passaggio delle barriere, dato
che sia O2 che O3 non vengono coinvolti nella coordinazione.
NH2
H2N
Pt
O
O
HO
O
OH
O
8
Coordinazione monodentata O3.
Seguendo tramite il 31P-NMR la protonolisi del [Pt(dppe)Me2]
da parte di due equivalenti di acido L-ascorbico, dopo due ore si è isolata la specie
[Pt(dppe)Me(O3-asc)] (9). Lasciando il complesso 9 in soluzione per altre 24 ore, si ottiene la
completa chiusura del metallaciclo con formazione del complesso 4 sopra menzionato.
Ph2
P
CH3
Pt
OH
P
Ph2
O
OH
HO
O
O
9
Lo studio della coordinazione al platino dell‟acido ascorbico è stato completato prendendo in
considerazione una delle forme idrogenate (D-galatto-γ-lattone) e la forma ossidata (acido
deidroascorbico).
41
Coordinazione del D-galatto-γ-lattone
OH
6
O
O
1
5
4
2
OH
3
OH
HO
Figura 1 D-galatto-γ-lattone
Le proprietà chimiche di questa molecola differiscono molto da quelle dell‟acido ascorbico in
quanto la mancanza del sistema ene-diolico determina la mancanza del carattere acido e della
capacità riducente.
In questa molecola sono presenti due sistemi diolici il 2-3 e il 5-6; la reazione col carbonato
complesso [Pt(PPh3)2CO3] avviene in maniera selettiva su uno solo dei due. Data la maggiore
acidità dell‟OH(6) primario, riteniamo l‟isomero O5-O6 più probabile.
OH
O
PPh3
O
O
Pt
O
OH
O
PPh3
O
O
O
Pt
OH
HO
Ph3P
PPh3
10
Coordinazione dell’acido deidro-L- ascorbico
L‟acido deidroascorbico commerciale è un solido cristallino, costituito principalmente dalla forma
dimerica c) , mentre in soluzione è una miscela di più forme in equilibrio:
OH
OH
HO
O
O
O
O
O
O
O
HO
OH
O
O
O
O
OH
O
O
OH
HO
a)
b)
O
O
O
c)
La reazione con [Pt(PPh3)2CO3] è stata condotta tentativamente per vedere se la maggiore reattività
dell‟OH6 primario col Pt fosse in grado di spostare l‟equilibrio a favore della forma monomerica a),
dando così il complesso col platino coordinato agli O5 e O6. La reazione porta invece
all‟isolamento di un unico prodotto (11), caratterizzato attraverso la struttura ai raggi X.
42
O
OH
O
O
PPh3
Pt
PPh3
O
O
H
11
O
11
Conclusioni
L‟acido L-ascorbico coordina al platino(II) come legante anionico solo quando i complessi
precursori contenenti il platino presentano buoni gruppi uscenti che vengono sostituiti da
funzionalità dell‟acido ascorbico stesso. Esempi di questi precursori sono i carbonato derivati
([Pt(PP)CO3]) e i dimetilderivati (es. [Pt(dppe)Me2] che subiscono protonolisi con formazione di un
prodotto collaterale gassoso (H2CO3 e CH4 rispettivamente), oppure gli aquocomplessi cationici (es
[PtNN(H2O)2]2+).
I precursori fosfinici, siano carbonati (vedi formazione di 2 e di 4), siano aquocomplessi (vedi
formazione di 5), siano dimetili (vedi formazione di 4 via 9), reagiscono invariabilmente con l‟acido
ascorbico per dare coordinazione O2-O3, anche nei casi in cui la fosfina ha ingombro sterico ridotto
come PTA. Questi complessi non soddisfano il requisito di avere il sistema enediolo invariato, che
sembra indispensabile per la interazione con il trasportatore specifico per l‟acido ascorbico SVCT2.
Degna di nota è comunque la preparazione del nuovo complesso di PTA, 5 , di cui verrà testata
l‟attività antiproliferativa su linee cellulari cisplatino resistenti. Esso infatti associa in un‟unica
molecola il gruppo cis-Pt(PTA)2 che, oltre a rendere il complesso altamente idrofilo, in precedenti
studi svolti in questo gruppo ha mostrato buona attività antiproliferativa e l‟acido ascorbico, che
potrebbe potenziare tale attività con effetto sinergico.
I precursori amminici reattivi e facilmente accessibili sono gli aquocomplessi, che con l‟acido
ascorbico danno coordinazione C2O5, molto stabili, ragionevolmente solubili in acqua e la cui
attività citostatica è già nota. In questo caso il gruppo enediolico è coinvolto nella coordinazione,
ma non attraverso gli ossigeni. Riteniamo che valga la pena effettuare test di binding per verificare
la possibilità di interazione del complesso 8 e di altri analoghi amminici con i trasportatori specifici
dell‟acido ascorbico.
Infine la coordinazione O5-O6, ottenuta con l‟acido ascorbico protetto, da noi caratterizzata per la
prima volta anche per mezzo della struttura ai raggi X del complesso 7, sembrerebbe la più adatta
alla interazione dei complessi coi trasportatori specifici dell‟acido ascorbico, in quanto è
spazialmente e elettronicamente isolata rispetto al gruppo enediolo essenziale per tale interazione.
Purtroppo abbiamo osservato che questi platino diolati non sono stabili e non sopravvivono alle
condizioni necessarie alla rimozione dei gruppi protettori dell‟acido ascorbico, né alla presenza in
soluzione di ioni cloruro.
Il complesso 11 dell‟acido deidroascorbico potrebbe essere testato per il trasporto attraverso i
trasportatori della vitamina C ossidata, che sono meno specifici. Tuttavia gli aspetti sperimentali
delle prove di binding in questo caso sono più problematici, in quanto non sono ancora stati messi a
punto sistemi modello accessibili e soddisfacenti.
La conclusione di questo studio è che la coordinazione diretta dell‟acido ascorbico al platino non
produce complessi con caratteristiche promettenti per l‟interazione coi trasportatori dell‟acido
43
ascorbico, in quanto non siamo riusciti a preparare composti in cui gli OH in 2 e in 3, necessari per
l‟interazione col trasportatore specifico, siano liberi sia dalla coordinazione che dalla protezione.
La strategia alternativa che si intende attivare è quella di usare dei chelanti connettori tra l‟acido
ascorbico e il platino, tali da rendere la coordinazione estremamente robusta e adatta all‟attività
antitumorale, nonché lontana dalle funzionalità che l‟acido ascorbico utilizza per il legame col
trasportatore.
Per soddisfare tutti questi requisiti è necessario che l‟acido ascorbico non sia il legante anionico per
il Pt, ma un componente del legante neutro.
ii) PLATINO E TIOTEOFILLINE
Nell‟anno 2006 è stato esteso lo studio relativo al design e sintesi di complessi di Pt(II) con alcuni
derivati dell‟ 8-tioteofillina (forniti dal gruppo del Prof. A.Romerosa, dell‟Università di Almeria)
con l‟obiettivo di migliorare l‟ attività antitumorale già osservata da noi in altri complessi
contenenti leganti di questo tipo.
O
O
7
6
H3C
1
5
N
8
O
2
N
4
3
SMe
1
9
5
N
7
7'
NH
NH
8
O
N
O
6
H3C
NH
2
N
4
3
N
S(CH 2)nS
9'
CH 3
CH 3
N
CH 3
1'
8'
N
9
6'
5'
4'
3'
N
2'
O
CH 3
n = 1, MBTTH2 b
n = 2, EBTTH2 c
n = 3, PBTTH2 d
8- MTTH, a
I complessi cis-[PtCl(8-MTT)(PPh3)(PTA)] e cis-[Pt(8-MTT)2(PPh3)(PTA)] (MTTH2 = 8methylthiotheophylline, PTA = 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane), sono stati preparati dal
precursore cis-[PtCl2(PPh3)(PTA)] che contiene due fosfine diverse, l‟idrofila PTA e la lipofila
PPh3 e del quale abbiamo determinato la struttura ai raggi X. L‟introduzione di due fosfine con
diverse caratteristiche conferisce ai complessi un‟attività antiproliferativa superiore agli analoghi
che contengono due fosfine uguali dello stesso tipo (due PTA o due PPh3) in configurazione cis sul
platino.
44
PTA
Cl
Pt
Ph3P
S
H3C
L/Pt/NaOH
1/1/1
O
N
N CH3
N
N
O
H3C
H
N
N
O
PTA
Cl
Pt
SCH3 +
N
O
H3C
N
CH3
L/NaOH
2
Cl
Ph3P
H3C
1
O
N
N
Ph3P
N CH
3
H3C
PTA
S
PTA
L/Pt/NaOH
Cl
Ph3P
Pt
Ph3P
O
N
O
S
2/1/2
Cl
Ph3P
N
Pt
H3C
N CH3
N
N
O
H3C
3
E‟ stata poi studiata la reattività dei precursori dicloruro cis-[PtCl2(PPh3)2], cis-[PtCl2(PTA)2] e cis[PtCl2(PPh3)(PTA)] con le bis-tiopurine bis(S-8-thiotheophylline)methane (MBTTH2) (b), 1,2bis(S-8-thiotheophylline)ethane (EBTTH2) (c), and 1,3-bis(S-8-thiotheophylline)propane (PBTTH2)
(d), che produce complessi binucleari indipendentemente dalla stechiometria usata, suggerendo
quindi una sorta di effetto cooperativo tra i due nuclei metallici nell‟interazione col legante. Una
serie di tali complessi binucleari sono stati isolati e caratterizzati
PAPh3
PBPh3 Pt Cl
O
H3C
PA'Ph3
PB'Ph3 Pt Cl
7
6
5
N
1
7'
N
8 S(CH2)nS
O 2
N
4
3
N
9
N
PTAA
PTAB
O
6'
5'
N
6
H3C
1'
8'
1
N 4'
9'
3' N
5
N
7' N
N
4
3
N
9
S(CH2)nS
8'
N
N 4'
9'
CH3
3'
N 2' O
CH3
CH3
n = 1, MBTT 4
n = 2, EBTT 5
n = 3, PBTT 6
6'
5'
1'
8
O 2
Pt PTAB' O
N7
2' O
CH3
CH3
Pt
O
CH3
PTAA'
Cl
n = 1, MBTT 7
n = 2, EBTT 8
n = 3, PBTT 9
E‟ stata valutata la loro attività antiproliferativa su le linee cellulari tumorali umane T2 (cisplatino
sensibile) e SKOV3 (cisplatino resistente), che si è trovata di entità paragonabile a quella dei
corrispondenti complessi mononucleari, indicando che, per quanto riguarda l‟attività
antiproliferativa, non sussiste un effetto sinergico tra i due nuclei metallici dello stesso complesso.
iii) PLATINO E ACIDI BILIARI
E‟ stata messa a punto la sintesi e la caratterizzazione dei complessi cis-[(3-dehydrocholanoylidenL-tartrate)-diammineplatinum(II)]
and
cis-[di(dehydrocholanoate)-bis(triphenylphosphine)platinum(II)] poi testati per la loro capacità di indurre differenziaizione eritroide nelle cellule
45
leucemiche umane K562, a confronto coi loro leganti liberi e i precursori Pt-dicloruri. Si è rilevato
che i complessi stimolano la differenziazione eritroide e aumentano la produzione di emoglobina
fetale. I risultati hanno importanza pratica perché è noto che un aumento nella produzione di HbF
migliora il quadro clinico di pazienti affetti da -thalassemia e sicke cell anemia.
46
UNITA’ DI RICERCA DI FIRENZE
Direttore Scientifico: Prof. Luigi Messori
L‟attività dell‟Unità di Ricerca di Firenze del CIRCMSB, nel corso del 2006, condotta
principalmente presso il Laboratorio sui Metalli in Medicina (Dip. Chimica, Univ. Firenze) si è
focalizzata sui sottoelencati filoni di ricerca. In particolar modo, i primi tre argomenti sono
strettamente attinenti alla tematica “Nuovi Farmaci Inorganici in Oncologia”, una delle tematiche di
riferimento del CIRCMSB.
1. Sviluppo di Complessi di Oro(III) come Agenti Citotossici ed Antitumorali.
2. Studio di Composti Antitumorali di Rutenio.
3. Interazioni di Antitumorali Metallici con Proteine.
4. Interferenza dell’Artemisinina con i Processi del Metabolismo del Ferro.
5. Complessi di Rame con Peptidi Lineari e Ciclici.
6. Metalli e Processi di Aggregazione di Proteine; Metalli e Neurodegenerazione.
7. Altri studi.
Di seguito cerchiamo di descrivere i progressi più significativi conseguiti in ciascun settore di
ricerca nell‟anno 2006.
1. Sviluppo di complessi di oro(III) come agenti citotossici ed antitumorali
Presso il Dipartimento di Chimica dell‟Università di Firenze è attiva da alcuni anni una linea di
ricerca tesa a valutare le proprietà chimiche e biologiche di composti di oro(III) come possibili
agenti antitumorali. I complessi di oro(III), isolettronici ed isostrutturali ai complessi di platino(II),
sono infatti degli eccellenti candidati come possibili agenti antitumorali. In anni recenti abbiamo
dimostrato che alcuni complessi di oro(III), opportunamente sostituiti, mostrano una accettabile
stabilità in ambiente fisiologico ed, al contempo, sono dotati di significative proprietà antitumorali
in vitro. I risultati più significativi su questa linea di ricerca, da noi ottenuti nel corso dell‟anno
2006, sono riportati di seguito.
i) Aspetti farmacologici e meccanicistici di complessi organometallici dinuclearidi oro(III).
In collaborazione con un gruppo di chimici inorganici dell‟Università di Sassari (Prof. Cinellu e
Minghetti) avevamo precedentemente dimostrato le favorevoli proprietà citotossiche ed
antitumorali di alcuni complessi organometallici di oro(III). Quest‟anno abbiamo sviluppato gli
studi su una serie di complessi dinucleari di oro(III) con leganti bipiridilici (AuOXO-1,6). I
composti di interesse sono mostrati in figura 1.
47
Me 3C
N
Au
O
N
N
N
O
Au
CMe3
N
O
Au
[PF6]2
O
N
N
Au
[PF6]2
N
Me 3C
CMe3
Auoxo2
Auoxo1
Me
R
N
N
N
N
O
Au
[PF6]2
Au
O
Me
Me
R
Auoxo3: R = Me
Auoxo4: R = CH2CMe3
Auoxo5: R = C 6H3Me2-2,6
Au
O
N
N
N
O
Au
[PF6]2
N
Me
Auoxo6
Figura 1.
In dettaglio, in collaborazione con il gruppo del Prof. Mini, farmacologo presso l‟Università di
Firenze, abbiamo valutato gli effetti cellulari di questi composti su selezionate linee cellulari
tumorali umane sensibili e resistenti al cisplatino (A2780). I risultati di questo screening hanno
evidenziato che solo il composto denominato AuOXO6, della serie in analisi, ha proprietà
citotossiche comparabili con il cisplatino ed addirittura migliori nei confronti della linea cellulare
resistente al cisplatino. Quindi, i composti sono stati studiati per le loro proprietà di interazione con
alcune proteine selezionate (ad es. ubiquitina e citocromo c) e nei confronti di DNA calf-thymus,
tramite diverse tecniche spettroscopiche e di spettrometria di massa. Studi precedenti avevano
dimostrato che i complessi di oro(III) mostrano una affinità relativamente scarsa nei confronti del
DNA. Al contrario, era emersa un buona affinità dei complessi di oro(III) nei confronti di alcune
proteine modello. I risultati da noi ottenuti sui complessi dinucleari di oro(III) sembrano confermare
questo quadro.
Più recentemente abbiamo sviluppato studi di caratterizzazione delle proprietà strutturali, chimiche
e di ossidoriduzione, di questa famiglia di composti, in modo tale da stabilire relazioni strutturaattività in grado di giustificare le osservate proprietà biologiche. Gli studi elettrochimici sono
condotti in collaborazione con il gruppo del prof. Zanello dell‟Università di Siena.
ii) Studi di carattere generale sui complessi di oro.
Nel corso del 2006 è stata approntata dal nostro gruppo una rassegna di letteratura riguardo al
ruolo dei complessi di oro come agenti antitumorali. La pubblicazione di questi articoli su invito,
testimonia il grado di riconoscimento internazionale raggiunto dal nostro gruppo di ricerca in questo
specifico settore di attività.
2. Studio su nuovi composti antitumorali di rutenio.
È noto che alcuni complessi di rutenio, in particolar modo di rutenio(III), mostrano promettenti
attività antitumorali. Ad oggi, dopo i complessi di platino(II), i complessi di rutenio sono i composti
metallici più intensamente studiati come possibili agenti antitumorali. Da alcuni anni, l‟unità di
Firenze sta valutando alcuni aspetti chimico-bioinorganici di rappresentativi composti di rutenio, in
particolare NAMI-A e KP1019 (Figura 2).
48
-
H
N
N
Cl
Cl
Ru
Cl
Cl
S
O
CH
CH3 3
Cl
HN
N
NH
Cl
Ru
NH+
Cl
N
Cl
H
N
HN
+
HN
NAMI-A
KP1019
Figura 2
Nel corso del 2006 abbiamo proseguito in queste attività ponendo particolare attenzione a 2 nuovi
tipi di composti di rutenio.
Un nuovo composto di rutenio(III) tipo “keppler” è stato preparato e caratterizzato dal Dr.
Pasquale Mura (Istituto di Cristallografia, CNR, Montelibretti). Abbiamo riassunto l‟analisi del
comportamento in soluzione di questo composto, gli studi di interazione con biomolecole (proteine
modello e DNA) e le proprietà di inibizione dell‟enzima Tioredossina Reduttasi (in collaborazione
con il Dr. Bindoli del CNR di Padova) in un lavoro in preparazione.
Il prof. Renzo Cini ci ha invece fornito un interessante composto di rutenio(II) con alcuni ligandi
carbonilici di cui abbiamo analizzato le interazioni con calf thymus DNA e con le proteine albumina
e transferrina. Ne sono state anche analizzate le proprietà antiproliferative in vitro.
Nel frattempo stiamo proseguendo gli studi sul meccanismo di azione del noto composto
antitumorale ed antimetastatico di rutenio(III) denominato NAMI A.
3. Interazioni di antitumorali metallici con proteine.
Abbiamo messo a punto delle procedure per valutare le interazioni di complessi di platino(II),
oro(III) e rutenio(III) con alcune proteine modello. La procedura è basata su prove di
ultracentrifugazione abbinate a determinazioni spettrofotometriche oppure di ICP-OES. La
procedura ci ha consentito di dimostrare in alcuni casi la formazione di addotti stabili fra complessi
di oro e varie proteine modello. Abbiamo proceduto ad una ulteriore caratterizzazione degli addotti
ottenuti mediante tecniche di spettrometria di massa e di cristallografia.
i) Studio delle interazioni metallofarmaco/proteina tramite spettrometria di tipo ESI-MS
È stato messo a punto un metodo per lo studio degli addotti metallofarmaco/proteina, utilizzando
la spettrometria di massa di tipo ESI (ESI-MS). Con questa tecnica, infatti, grazie all‟introduzione
di un metodo di ionizzazione “soft”, è possibile trasferire l‟addotto complesso metallico/proteina
intatto nella fase di gas, e determinarne, in modo accurato, la massa molecolare. L‟efficacia di tale
approccio è dimostrata dal nostro precedente lavoro sul citocromo c. È stata effettuata una attenta
selezione delle condizioni sperimentali, in modo da ottenere spettri ESI-MS di alta qualità di addotti
metallofarmaco/proteina. Abbiamo scelto per questi studi alcuni farmaci noti a base di Pt
(cisplatino, transplatino, oxaliplatino e carboplatino) ed alcuni complessi di platino più nuovi,
sintetizzati nel gruppo di ricerca del Prof. Natile, dell‟Università degli Studi di Bari. Abbiamo
selezionato, come proteina modello, il lisozima. Questa proteina, infatti, ha una serie di
caratteristiche favorevoli per lo studio all‟ESI-MS. Infatti, è una proteina relativamente piccola, con
la quale è possibile ottenere spettri ben risolti nel range da 1000 a 2000 m/z. Possiede inoltre una
serie di possibili siti per i complessi metallici, tra i quali quelli maggiormente accessibili sono una
istidina (His15) e due metionine (Met12 e Met105).
49
In questo ambito, quindi, è stato messo a punto un protocollo sperimentale, per lo studio di
addotti tra i 4 complessi di Pt(II) sopra menzionati con la proteina modello lisozima. Particolare
attenzione è stata data alla selezione delle condizioni di preparazione dei campioni, per cui è stato
scelto di usare tampone ((CH3)4N)CH3COO 25 mM pH 7.4, che è quello che ci ha dato i risultati
migliori per quanto riguarda la risoluzione degli spettri di massa. Sono stati preparati campioni con
rapporti platino proteina 3:1, che sono stati lasciati ad incubare per 72 h a 37 °C. Successivamente,
ciascun campione è stato ultrafiltrato estensivamente, per eliminare il complesso metallico che non
si era legato alla proteina.
Come si può vedere dagli spettri di massa deconvoluti (Figura 3), oltre al picco della proteina
nativa (14305 Da), in tutti e quattro i casi, si osservano anche altri picchi relativi alla formazione di
addotti del lisozima con i complessi di platino selezionati. La presenza in tutti gli spettri della
proteina nativa indica una non completa platinazione del lisozima, che viene confermata anche da
studi di ICP-OES delle soluzioni degli addotti.
Considerando poi più in dettaglio gli spettri relativi a ciascun complesso di platino, sono state
associate formalmente le masse molecolari, ricavate dai vari picchi, ai possibili frammenti dei
farmaci legati alla proteina. In ogni caso si è notata una prevalente formazione di mono-addotti, e
Cisplatin
Transplatin
Carboplatin
Oxaliplatin
Figura 3
solo in alcuni casi picchi di minore intensità, relativi alla presenza di bis-addotti, che suggeriscono
la presenza di un sito di legame preferenziale per il platino.
Nel caso dell‟addotto con il cisplatino, quello che si osserva è la presenza di due picchi di simile
intensità, a 14569 e 14605 Da, formalmente attribuibili ad un monoaddotto in cui si è legato al
lisozima, rispettivamente, un cisplatino parzialmente idrolizzato, che ha perso un cloruro, ed un
cisplatino intatto. Una situazione simile è stata descritta da Dyson e collaboratori nel caso dei
sistemi cisplatino-transferrina, ed interpretata in termini di un processo a due step per il binding del
cisplatino alla proteina .
Si possono inoltre osservare ulteriori picchi di forma simile ai precedenti, ma di minore intensità,
consistenti con la formazione di bis-addotti, ed in misura minore si riscontrano tracce di tris-addotti,
il che fa pensare che ci sia più di un sito accessibile al platino.
Nel caso dell‟addotto di lisozima con il carboplatino, invece, lo spettro mostra un picco a 14676
Da la cui massa corrisponde formalmente all‟aggiunta di un frammento di [Pt(NH3)2CBD]
(CBD=cis-(1,1-cyclobutanedicarboxylate)) alla proteina, molto probabilmente come il risultato di
un classico processo di ring opening. Inoltre si possono riscontrare tracce anche di un bis-addotto.
50
Lo spettro di massa dell‟adotto con l‟oxaliplatino mostra invece un picco principale a 14612 Da
che ben corrisponde ad un frammento di [Pt(R(NH2)2)]2+ (dove R = cyclohexane) legato al
lisozima.
Infine, lo spettro di massa dell‟addotto formato tra il lisozima ed il transplatino, evidenzia un picco
a 14569 Da che corrisponde al binding alla proteina di un frammento della molecola che ha perso
un cloruro.
ii) Studi cristallografici
Ancora una volta, anche in questo ambito, è stato selezionato il lisozima come proteina modello, di
cui è ben nota la struttura a raggi-X, ed è stata messa a punto la tecnica di soaking della proteina
con diversi complessi metallici di platino e rutenio. I cristalli di addotti sono stati quindi analizzati
tramite tecniche di diffrazione a raggi-X. Il primo risultato ottenuto è stata la risoluzione della
struttura dell‟addotto del noto farmaco antitumorale cisplatino con il lisozima.
La struttura dell‟addotto cisplatino-lisozima, risolta a 1.9 Å, è molto simile a quella della proteina
nativa (Figura 4).
La platinazione avviene al solo residuo di His15, il quale è situato sulla superficie della proteina ed
è quindi altamente accessibile. Particolare attenzione è stata data anche all'analisi dell‟ambiente
circostante i due residui di metionina, che comunemente rappresentano i siti preferenziali per il
legame dei composti di platino(II), ma non è stata osservata alcuna significativa modificazione.
Il legame del platino all‟azoto imidazolico di un‟istidina era stato già riscontrato nello studio di un
cristallo di cisplatino con la superossido dismutasi.
Figura 4
In conclusione gli studi svolti in questo ambito, sia tramite ESI MS che cristallografia a raggi X,
sono stati riassunti in una pubblicazione scientifica su Chem. Commun. Nel corso del 2006 è stata
anche completata la procedura di pubblicazione di un nostro articolo riguardante la struttura ai raggi
X di un addotto fra cisplatino e superossido dismutasi.
4. Interferenza dell’artemisinina con i processi del metabolismo del ferro.
Nel corso del 2006 abbiamo esteso gli studi sul meccanismo di azione dell‟agente antimalarico
artemisinina, focalizzando la nostra attenzione sulle interferenze con i processi del metabolismo del
ferro. È stato completato uno studio relativo alla reattività dell‟artemisinina con l‟emoglobina.
Successivamente è stata analizzata in dettaglio la reazione dell‟artemisinina con emina (Figura 5) e
microperossidasi 11 (MP11) tramite spettrofotometria UV-visibile, ESI MS e più recentemente
tramite NMR. I dati ottenuti sono in fase di sottomissione per la pubblicazione. Gli studi sono
condotti in stretta collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell‟Università di
Firenze (gruppo del Prof. Vincieri).
51
Artemisinina
Emina
Figura 5
Inoltre, in collaborazione con il Dr. Severini dell‟Istituto Superiore di Sanità di Roma, abbiamo
condotto studi di inibizione della crescita di Plasmodium Falciparum, tramite catechine, principali
componenti del tè verde. Questi studi sono stati oggetto di pubblicazione.
5. Complessi di rame con peptidi lineari e ciclici.
Abbiamo proseguito studi precedentemente avviati sulle interazioni di peptidi sintetici, lineari e
ciclici, con lo ione rame. I complessi risultanti vengono caratterizzati mediante varie tecniche
spettroscopiche e mediante potenziometria. Gli studi vengono condotti in collaborazione con il
gruppo del Prof. M. Ginanneschi, Laboratory of Peptide & Protein Chemistry & Biology,
dell‟Università di Firenze, e con il gruppo del Prof. Kozlowski, dell‟Università di Wroclaw,
Polonia. Stiamo elaborando alcuni risultati relativi alla caratterizzazione del complesso di rame con
un tetrapeptide ciclico variamente sostituito (Figura 6).
H
N
N
O
NH
O
NH
HN
HN
O
O
H 2N
N
N
H
Figura 6
6. Effetto dei metalli sui processi di aggregazione di proteine; metalli e neurodegenerazione.
In collaborazione con il gruppo di ricerca dei Prof. Ramponi, Taddei e Stefani, attivo presso il
Dipartimento di Scienze Biochimiche dell‟Università di Firenze, abbiamo esteso gli studi sugli
effetti degli ioni metallici sull‟aggregazione di proteine e sulla formazione di fibrille potenzialmente
patogene. Sono stati sviluppati saggi fluorimetrici per valutare gli effetti degli ioni rame e zinco e di
alcuni anioni, sull‟aggregazione fibrillare della proteina Acil Fosfatasi da Sulfolobus Sulfataricus
(SSoAcP).
Abbiamo proseguito la collaborazione con il gruppo del Prof. Zatta presso il CNR di
Padova, sviluppando una caratterizzazione chimica, tramite diverse tecniche chimico-fisiche e di
spettrometria di massa, del complesso Cu-cuprizone per elucidare le basi molecolari della sua
52
neurotossicità. Dai risultati ottenuti sembra emergere che il rame, nel complesso con il cuprizone,
si trovi nello stato di ossidazione +3. Ulteriori studi sono finalizzati alla valutazione di vari agenti
chelanti come una possibile opzione terapeutica a livello sperimentale di processi
neurodegenerativi.
7. Altri studi.
In collaborazione con il Prof. Di Vaira dell‟Università di Firenze e con il Prof. Giannella
dell‟Università di Camerino, proseguono gli studi chimici e strutturali di sostanze di potenziale
interesse farmaceutico.
53
54
UNITA’ DI RICERCA DELL’INSUBRIA
Direttore Scientifico: Prof. Giovanni Palmisano
L‟attività di ricerca si inquadra nella sezione tematica “1” (Diagnostici innovativi in oncologia e
malattie cardiovascolari) del Consorzio CIRCMSB ed è stata condotta in collaborazione con il
gruppo del Prof. Aime.
Negli ultimi anni sono apparsi numerosi lavori concernenti la sintesi e la caratterizzazione di
ciclodestrine dimeriche (bis-CD) connesse mediante linkers diversamente strutturati e di differente
lunghezza. Questi dimeri, avendo due unità lipofile vicine tra loro e formando addotti
supramolecolari stabili, mostrano binding e selettività molecolari più elevate rispetto alle singole
CD. Sono state così sintetizzate bis(β-CD) connesse mediante linkers tra le posizioni2-2‟, 3-3‟ e 66‟. Le bis(β-CD) 1 e 2 contenenti le subunità 6,6‟-ureido e –tioureido sono state ottenute in alte
rese mediante reazione di aza-Wittig(promossa da microonde) in presenza di Ph3P supportata su
matrice polimerica. Le bis(β-CD) 3 e 4 connesse, rispettivamente, tra le posizioni 2,2‟ e 3,3‟ sono
accessibili dalle corrispondenti monoalchenil-(β-CD) mediante reazione di omodimerizzazione
indotta dal catalizzatore di Grubbs(2° generazione) in presenza di ultrasuoni. La facile accessibilità
di queste bis(β-CD) ha permesso la preparazione e la caratterizzazione degli addotti stabili con gli
agenti di contrasto a base di chelati di Gd(III). In particolare, i complessi di inclusione con il
chelato G-1 sono risultati 2-3x più stabili di quelli formati con la singola β-CD ( Kass 4.3*104M-1 vs
8.0*102M-1)con aumento della relassività di 3-4x da 9.1mM-1s-1 (β-CD) a 27.7 – 35.0mM-1s-1.
HO
OH
O
O
HO
OH
O
OH
HO
O
X
H
N
HN
O
O
OH
OH
O
O
OH
OH
OH
HO
O
O
OH
HO
O
O
OH
OH
OH
OH
O
O
O
O
HO
HO
OH
OH HO
OH
HO
O
O
O
O
OH
OH
O
O
OH
HO
HO
OH
O
O
O
HO
O
OH O
O OH
HO
OH
1: X= O
2: X= S
55
OH
OH
OH
HO
HO
O
O
OH
O
O
O
HO
O
OH
HO
OH
HO
O
OH
O
OH
OH
OH
OH
O
OH
HO
O
O
O
O
O
HO
n
OH
n
OH
O
O
O
OH
O
OH
OH
HO
HO
O
OH
O
OH
O
OH
OH
OH
OH
HO
O
O
OH
O
O OH
O
HO
O
HO
OH O
HO
O
OH
O
OH
HO
3
OH
HO
HO
O
O
OH
O
O
HO
O
O
OH
OH
O
HO
OH
HO
O
OH
O
O
OH
HO
OH
OH
O
O
OH
O
n
n
OH
OH
O
O
O
HO
O
OH
O
OH
O
OH
OH
HO
HO
O
OH
OH
O
OH
OH
OH
O
HO
O
O
O OH
OH
O
HO
HO
O
OH O
HO
O
OH
O
OH
HO
4
-
OOC
-
OOC
COO
N
N
N
-
COO
G-1
56
Ga3+
-
COO-
UNITA’ DI RICERCA DI LECCE
Direttore Scientifico: Prof. Francesco Paolo Fanizzi
Gruppo Francesco Paolo Fanizzi
Sintesi, caratterizzazione ed attività citotossica di nuovi complessi di Platino.
Complessi di platino contenenti leganti acetilacetonato. In precedenti lavori dell‟unità
di ricerca chimica del Prof. Fanizzi sono stati sintetizzati complessi del Pt contenenti acetilacetonato
(acac) nella sfera di coordinazione del metallo: [PtCl (O,O‟-acac)(DMSO)] (1a) con un solo acac Ochelato, [Pt (O,O‟-acac)(C-gamma-acac)(DMSO)] (2a) contenente un acac O,O‟-legato e uno Ccoordinato (C-gamma-acac), ed i loro analoghi con il DMS in sostituzione del DMSO, [PtCl (O,O‟acac)(DMS)] (1b) e [Pt (O,O‟-acac)(C-gamma-acac)(DMSO)] (2b). Gli ulteriori sviluppi di questa
linea di ricerca sono stati rivolti allo studio in vitro del comportamento biologico dei nuovi
complessi contenenti acac , che ha evidenziato per tutti una citotossicità molto elevata (misurata su
diverse colture cellulari, adoperando il saggio dell‟MTT) a dosi relativamente basse, persino più
alta del cisplatino nel caso del complesso [Pt(O,O’-acac)( -acac)(DMS)]. Tale composto ha
evidenziato in particolare un‟elevata efficacia nei test eseguiti su colture di cellule MCF7, derivanti
da carcinoma mammario umano e caratterizzate da resistenza al cisplatino. Per i nostri composti di
nuova sintesi è, quindi, probabile uno spettro d‟azione differente rispetto ai tradizionali
chemoterapici a base di platino.
In seguito alla valutazione dell‟effetto citotossico in vitro del complesso [Pt(O,O’-acac)( acac)(DMS)], risultato il più attivo, abbiamo studiato l‟induzione di alcuni processi di trasduzione
cellulare pro-apoptotici. In particolare, nell‟apoptosi indotta dal cisplatino, è già noto il ruolo
centrale della MAP chinasi ERK. Il confronto della fosforilazione di ERK in seguito alla
somministrazione del cisplatino e del [Pt(O,O’-acac)( -acac)(DMS)] in concentrazione 100 µM su
cellule HeLa ha evidenziato una cinetica molto diversa. Infatti, mentre con il cisplatino il processo
era tempo-dipendente e raggiungeva un massimo dopo 12 ore, con il composto di nuova sintesi si
osservavano livelli significativi di ERK fosforilata dopo appena 30 minuti dalla somministrazione e
si raggiungeva un massimo dopo 3 ore. Per le molecole contenenti acac sono, quindi, ipotizzabili
meccanismi di attivazione dell‟apoptosi (peraltro confermata dal clivaggio dell‟enzima PARP)
diversi rispetto al cisplatino.
Un altro dato interessante che evidenzia differenze profonde tra i farmaci a base di platino
tradizionali ed i nostri nuovi composti deriva dalla misura dell‟uptake cellulare di tali molecole
attraverso spettroscopia di assorbimento atomico. Dopo la separazione per mezzo di centrifugazione
differenziale di nuclei, membrane e citoplasma di cellule HeLa ed MCF7 trattate con cisplatino e
[Pt(O,O’-acac)( -acac)(DMS)], si è verificata una diversa distribuzione del platino nei vari comparti
subcellulari. Complessivamente nel caso del cisplatino si è osservato un maggiore accumulo nei
nuclei, mentre per il [Pt(O,O’-acac)( -acac)(DMS)] è stato verificato un accumulo prevalente nel
citoplasma. Tale risultato è in accordo con la scarsa reattività con le basi nucleiche dei complessi
contenenti acac come legante carrier, già dimostrata dal nostro gruppo di lavoro, e con la più
marcata tendenza a reagire con le proteine.
Complessi di platino contenenti leganti fenantrolinici.
Sono stati sintetizzati e
1
13
195
caratterizzati attraverso spettroscopia H, C e Pt NMR i complessi fenantrolinici tetracoordinati
[Pt(BPS)Cl2] (1a) (BPS = 4,7-difenil-disolfonato sodico-1,10-fenantrolina; batofenantrolina
solfonato) e [Pt(BCS)Cl2] (1b) (BCS = 2,9-dimetil-4,7- difenil-disolfonato sodico-1,10fenantrolina; batocuproina solfonato), ed un nuovo complesso pentacoordinato, [Pt(BCS)Cl2(eta-2etilene)] (2b), avente geometria trigonale bipiramidale, con i leganti cloruro in posizione assiale ed
il legante bidentato fenantrolinico e l'olefina sul piano equatoriale. La formazione del complesso
[Pt(BPS)Cl2(eta-2-etilene)](2a) come specie transiente è stata rilevata per via spettroscopica 1H
NMR, ma non è isolabile in quanto perde rapidamente l'olefina e si trasforma nella corrispondente
57
specie quadrato-planare. I tre complessi 1a, 1b e 2b sono stati ottenuti come miscele di isomeri
derivanti dalle diverse posizioni di solfonazione sul legante fenantrolinico. La stabilità e la elevata
solubilità in acqua dei complessi [Pt(BPS)Cl2], [Pt(BCS)Cl2] and [Pt(BCS)Cl2(eta-2-etilene)]
hanno consentito di effettuare i test di citotossicità in vitro su cellule HeLa, usando il test
colorimetrico MTT . Tutti i nuovi composti hanno mostrato, a bassi e medi valori di concentrazioni
testate (< 200 M) a differenti tempi di incubazione (24, 48 e 72 ore) attività citotossica minore
rispetto al cisplatino, probabilmente a causa del notevole ingombro sterico del legante solfonato ed
alla presenza di gruppi carichi, che rendono tali composti scarsamente liposolubili, limitandone
consistentemente l'uptake cellulare per diffusione passiva attraverso la membrana. Alle più alte
concentrazioni testate (>200 M) la citotossicità dei nuovi complessi è risultata maggiore ed in
particolare 1b mostra una citotossicità comparabile, sebbene ancora inferiore, rispetto al cisplatino.
Nel confronto tra i due complessi [Pt(BCS)Cl2] e [Pt(BCS)Cl2(eta-2-etilene)], è stato interessante
studiare il profilo di citotossicità delle due specie ai diversi valori di concentrazione utilizzati e nei
diversi tempi di incubazione. Alle concentrazioni più alte testate, dopo 24 ore di incubazione, la
citotossicità di 1b risulta sensibilmente più elevata rispetto ai composti 1a e 2b. Dopo 48 ore di
incubazione, a basse concentrazioni, la citotossicità di 2b aumenta considerevolmente rispetto ai
valori presentati per incubazioni a breve termine (24 ore), e risulta persino maggiore della
citotossicità di 1b. Il profilo di citotossicità di 2b potrebbe essere razionalizzato sulla base di due
fattori. La più alta saturazione nella sfera di coordinazione del platino e la minore reattività della
specie pentacoordinata 2b verso i target cellulari, rispetto alla specie omologa quadrato-planare 1b,
potrebbero spiegare la differente citotossicità dei due composti. La determinazione GFAAS
dell'uptake di platino totale in colture di cellule HeLa, dopo tre ore di incubazione con i complessi
1a, 1b, 2b e cisplatino, ha evidenziato uptake cellulare dei composti testati, che, nel caso di 1b e 2b,
è risultato persino maggiore del cisplatino, sebbene tali composti abbiano dei gruppi solfonato
carichi negativamente. Nonostante la minore citotossicità dimostrata dal complesso 2b rispetto ad
1b dopo brevi tempi di incubazione, sono stati rilevati livelli di uptake cellulare di platino totale più
elevati per 2b rispetto ad 1b, in seguito ad incubazione delle cellule con concentrazioni 100 M di
composto di platino. I risultati ottenuti hanno dimostrato che la differente citotossicità in vitro del
cisplatino e dei tre nuovi composti non può essere spiegata in termini di differente uptake cellulare,
e suggeriscono una possibile dipendenza da differenti fattori farmacodinamici. Per la prima volta è
stato possibile confrontare l'attività biologica di specie omologhe a diversa geometria di
coordinazione, quadrato planare e bipiramidale trigonale. La tendenza della specie pentacoordinata
2b a dare, per tempi di incubazione maggiori, una simile citotossicità rispetto alla specie quadratoplanare 1b, suggerisce un possibile uso di complessi pentacoordinati con geometria bipiramidaletrigonale come profarmaci.
Derivati organometallici analoghi della vitamina E. Sono state sfruttate delle nuove vie
di sintesi che partono da complessi cationici del Pt(II) con olefine -legate. Tra le possibili reazioni
che possono dare le olefine coordinate a centri metallici si sono sfruttate soprattutto le addizioni
nucleofile. In particolare, la reattività delle olefine coordinate a centri metallici si è dimostrata in
grado di permettere la realizzazione di strutture organometalliche complesse, di interesse per
applicazioni di tipo bioorganometallico. Scegliendo complessi con leganti carrier amminici del tipo
[PtCl( 2-olefina)(N-N)]+ (N-N = diammina o diimmina alifatica o aromatica), siamo stati così in
grado di sintetizzare dei derivati organometallici con una struttura analoga a quella del cromano
che è un importante elemento strutturale della vitamina E. Attualmente sono in corso ulteriori studi
per la sintesi di altri derivati analoghi alla vitamina E e per la determinazione della loro eventuale
attività biologica e farmacologica.
Possibile coinvolgimento di nucleotidi purinici platinati liberi nel meccanismo di azione del
cisplatino.
I cross-link 1,2-intrastrand formati dal cisplatino con due purine adiacenti su uno stesso filamento di
DNA sono ritenuti fattori di induzione di apoptosi nelle cellule tumorali. Nel contesto di questo
58
programma, è stata studiata la possibilità di incorporare nucleotidi purinici platinati liberi, durante
la sintesi degli acidi nucleici. Sono stati utilizzati monoaddotti modello del tipo [Pt(dien)(N7-G)] (
G = nucleotide/nucleoside guaninico). La possibile incorporazione di Pt è stata studiata mediante
tecniche di primer extension (PE) e polymerase chain reaction (PCR) con l'utilizzo della Taq DNA
polimerasi, di opportune sequenze di DNA (templati e primers), e del complesso modello
[Pt(dien)(N7-5'dGTP)] (1). In un primo esperimento è scelto uno stampo composto da 100
nucleotidi
e
caratterizzato
dalla
seguente
sequenza:
3'TCAAATCCTCACCCCACTG(T)40C(G)40-5'. Come innesco per la reazione di polimerizzazione,
da parte dell'enzima Platinum® Taq DNA polimerasi, si è adoperato un primer complementare
all'estremità 3' dello stampo, con la seguente sequenza: 5'-AGTTTAGGAGTGGGGTGAC-3'. Sulla
base della sequenza opportunamente scelta, l'ottenimento di un filamento di 100 paia di basi (pb)
indica che la Taq DNA polimerasi è in grado di inserire nel filamento di nuova sintesi il complesso
[Pt(dien)(N7-5'-dGTP)], mentre l'ottenimento di un oligonucleotide molto più corto indica che la
polimerasi non è in grado di inserire il dGTP platinato.Per verificare la capacità della Taq DNA
polimerasi di inserire il complesso [Pt(dien)(N7-5'-dGTP)] in un filamento di nuova sintesi, sono
state preparate due diverse miscele di reazione per PCR. Nella prima miscela si sono aggiunti i
quattro nucleotidi precursori (dNTP), per ottenere la sintesi completa del filamento di 100 pb. In
una seconda miscela di reazione per la PCR il dGTP è stato sostituito con [Pt(dien)(N7-5'dGTP)]/5'-dGTP = 95/5. In entrambi i casi è stato ottenuto un filamento di 100 pb. Questo risultato
ha dimostrato in maniera inequivocabile l'avvenuto inserimento, in una catena complementare di
DNA di nuova sintesi, della base previamente platinata, [Pt(dien)(N7-5'-dGTP)], ad opera della Taq
DNA polymerasi. I prodotti di PE sono stati analizzati mediante gel elettroforesi. L'analisi della
concentrazione di Pt nel gel, in corrispondenza delle bande elettroforetiche, mediante GFAAS ha
confermato l'avvenuto uptake di [Pt(dien)(N7-5'dGTP)]. Per accertare l'abilità della polimerasi di
incorporare una sequenza di nucleotidi platinati, in un secondo esperimento è stato usato un
templato di 40 nucleotidi, contenente un poli C. L'analisi gel elettroforetica dei prodotti di PE ha
evidenziato la presenza di solo un numero ridotto di frammenti di DNA con una lunghezza da 20 a
40 basi. Questo risultato indica che il legame di diverse G platinate consecutive può abbattere
l'efficienza della TAQ DNA polimerasi. E' stato anche misurato l'effetto inibitore sull'attività della
polimerasi, quando si usano rapporti crescenti di complesso (1) rispetto al dGTP nella miscela di
nucleotidi precursori dNTP. In questo caso è stato condotto un esperimento tipo PCR con due
primers, forward (F6789) e reverse (M13 reverse), il templato pUC19 e otto diverse soluzioni con
rapporti crescenti di complesso 1 rispetto al dGTP nella miscela di dNTP. L'analisi gel
elettroforetica dei prodotti di reazione dopo 30 cicli di PCR mostra una forte preferenza della TAQ
polimerasi per il dGTP, rispetto al complesso (1). Per valori del rapporto complesso(1)/dGTP
superiori a 95/5 i prodotti di PCR diminuiscono considerevolmente e si osserva la formazione di
frammenti di DNA che hanno una mobilità elettroforetica leggermente diversa. Questo indica che
quando essenzialmente solo il complesso (1) è disponibile, l'attività della TAQ polimerasi è ridotta,
ma non annullata del tutto. I risultati ottenuti nel contesto di questa ricerca dimostrano che è
possibile un meccanismo d'azione alternativo del cisplatino, secondo il quale non si ha soltanto una
platinazione diretta del DNA ma anche una incorporazione di nucleotidi previamente platinati.
Questa prospettiva pone le basi per la sintesi di nuovi farmaci sottoforma di monoaddotti con basi
puriniche derivati dal cisplatino o analoghi.
Gruppo Prof. Santo Marsigliante
Valutazione dell’attività citotossica di [PtCl(O,O’-acac)(DMSO)],
acac)(DMSO)] e [Pt(O,O’-acac)(γ-acac)(DMS)]
[Pt(O,O’-acac)(γ-
L‟unità coordinata dal prof. Marsigliante ha effettuato la caratterizzazione biologica di nuovi
complessi del platino(II): [PtCl(O,O‟-acac)(DMSO)], [Pt(O,O‟-acac)(γ-acac)(DMSO)] e [Pt(O,O‟acac)(γ-acac)(DMS)]). Questi complessi del platino contenenti acetilacetonato (acac) e
dimetilsolfossido (DMSO) o DMS nella sfera di coordinazione del metallo hanno una ridottissima
59
reattività con le nucleobasi e una specifica reattività con ligandi solforati, suggerendo che i
bersagli cellulari preferiti possano essere i tioli proteici. Per questi nuovi composti, interessanti
anche per la loro dimostrata citotossicità in vitro (cellule tiroidee di ratto), ne avevamo ipotizzato
l‟efficacia anche verso tumori cisplatino-resistenti/refrattari (in funzione della loro interazione con
le proteine), anche in base alla possibile presenza di bersagli proteici tumore-specifici. Per cui la
valutazione della citotossicità/resistenza cellulare in assenza e in presenza dei composti a base di Pt
è stata effettuata mediante tecniche analitiche e spettroscopiche, attraverso due fasi: (a) studio delle
citotossicità in vitro dei nuovi farmaci in cellule tumorali umane, in particolare cellule di carcinoma
endometriale, cellule HeLa (cisplatino-sensibili), e cellule di carcinoma mammario, cellule MCF-7
(cisplatino-resistenti) e (b) valutazione delle risposte trasduzionali.
Poichè le cellule MCF-7 non esprimono caspasi-3, a causa di una delezione all'interno di esone 3
del suo gene codificante, esse sono relativamente insensibili a molti agenti chemioterapeutici,
cisplatino compreso; ma tutti i nuovi complessi del platino(II) hanno mostrato una marcata
citotossicità a dosi e a tempi relativamente bassi, anche su questo tipo cellulare, oltre che sulle
cellule HeLa, cisplatino-sensibili. Inoltre, in entrambi le linee cellulari il complesso [Pt(O,O‟acac)(γ-acac)(DMS)] ha mostrato un effetto citotossico maggiore rispetto agli altri composti.
In particolare, dall‟analisi del processo apoptotico (mediante valutazione (i) morfologica dopo
colorazione con Dapi; (ii) della variazione del potenziale di membrana mitocondriale, (iii) della
frammentazione del DNA; (iv) dell‟attivazione delle caspasi e della proteolisi di PARP)) di
entrambi i tipi cellulari, trattati con [Pt(O,O‟-acac)(γ-acac)(DMS)], è emerso che questo nuovo
composto è un promettente agente antitumorale poiché ha esibito un‟alta e soprattutto veloce
attività apoptotica sia in cellule HeLa, che nelle cellule MCF-7 resistenti al cisplatino.
Gli effetti sullo stato di attivazione delle MAPK (ERK, JNK e p38), valutati mediante western
blotting, ha messo in evidenza che il segnalamento intracellulare provocato dalle nuove molecole di
sintesi, prevede il cross-talk con altre vie trasduzionali (PKC, AKT, EGFR ecc.) coinvolte
nell‟apoptosi/resistenza cellulare.
I risultati ottenuti incoraggiano la continuazione di questo studio allo scopo di chiarire i meccanismi
di azione e la comprensione delle vie di trasduzione coinvolte nella risposta cellulare alla azione dei
nuovi complessi del platino (II) interessanti per le modalità di interazione con le proteine cellulari
piuttosto che con gli acidi nucleici.
Gruppo Prof. T. Schettino Prof. Santo Marsigliante
Nel corso dell‟anno 2006 il gruppo di ricerca diretto dal prof. Schettino ha continuato lo studio del
metalloenzima anidrasi carbonica e, in particolare, della sua sensibilità in vitro alle principali classi
di contaminanti chimici ambientali, quali metalli pesanti, pesticidi e PCB, intrapreso negli anni
precedenti. L‟anidrasi carbonica è un metalloenzima che catalizza la reazione reversibile di
idratazione dell‟anidride carbonica a bicarbonato. Tale enzima ha un‟ampia diffusione nel mondo
vivente, essendo presente in alcuni batteri, nelle piante e negli animali. Il sito attivo dell‟enzima è
localizzato in una profonda tasca, situata nel centro della molecola in cui è alloggiato lo ione Zn 2+
che si lega a tre residui di istidina della proteina. In precedenti lavori pubblicati dal gruppo di
ricerca diretto dal prof. T. Schettino (Lionetto et al., Comparative Biochemistry and Physiology (A),
120: 89-91, 1998; Lionetto et al.,Aquatic Toxicology,48 (4): 561-571, 2000; Lionetto et al.,
International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 85: 895-903, 2005) era stato
dimostrato come questo metalloenzima fosse suscettibile di inibizione da parte dei cationi di metalli
pesanti (cadmio, mercurio e rame), ma anche dei composti di sintesi quali pesticidi carbammati e
policlorobifenili.
Nel corso del 2006 si è proseguito lo studio sulla sensibilità dell‟enzima alle principali classi di
contaminanti chimici rilevanti dal punto di vista della contaminazione chimica ambientale
utilizzando anidrasi carbonica (isoenzima II) estratta da globuli rossi di bovino.
I risultati ottenuti hanno consentito di mettere a punto un bioassay in vitro rapido e a basso costo
basato sull‟utilizzo di questo enzima per la precoce individuazione delle presenza di sostanze
60
tossiche in matrici ambientali (acqua e sedimenti). Nel corso del 2006, infatti, è stata attuata la
validazione del bioassay basato sull‟anidrasi carbonica su campioni reali, rappresentati da
sedimenti portuali. I risultati ottenuti sono sovrapponibili a quelli ottenuti con test di tossicità in
vivo già standardizzati.
Nel corso del 2006, inoltre, il gruppo di ricerca del prof. Schettino ha proseguito lo studio,
intrapreso nel corso del 2005, delle metallotioneine, proteine citoplasmatiche ad elevata affinità per
i cationi dei metalli pesanti, su invertebrati terrestri, ai fini dello studio della contaminazione del
suolo da metalli pesanti.
Gruppo Prof.ssa Luciana Dini
Studio delle Alterazioni Indotte in Cellule Umane Tumorali Hela Mediante Terapia
Fotodinamica
La terapia fotodinamica (PDT) dal punto di vista clinico è il trattamento dei tumori basato
sull‟azione di molecole fotosensibilizzanti (PS), che si localizzano, spesso in modo preferenziale,
nelle cellule tumorali rispetto a quelle sane circostanti, e svolgono un‟azione citotossica, quando
sono eccitate dalla luce ad opportune lunghezze d‟onda. In seguito all‟eccitazione, la dissipazione di
energia assorbita avviene attraverso processi fotochimici, con conseguente comparsa di nuove
specie chimiche ossidanti instabili e quindi capaci di interagire fortemente con le molecole del
microambiente circostante, inducendo morte cellulare sia per necrosi che per apoptosi.
Sono stati presi in considerazione gli effetti del trattamento fotodinamico per la capacità di indurre
apoptosi, usando come substrato fluorogenico il Rosa Bengala (RB) e cellule HeLa come linea
cellulare tumorale. Il RB, infatti, grazie alla presenza sull‟anello xantenico della sua molecola di
atomi di cloro e di iodio, è un potente fotosensibilizzante ed è molto efficiente nel produrre
ossigeno allo stato di singoletto.
I primi studi, riportati in un lavoro pubblicato su Journal of Photochemistry and Photobiology, ci
hanno portato a concludere che il tipo di morte preferenzialmente indotta dal nostro protocollo
sperimentale è l‟apoptosi. Infatti, stabilita la non tossicità del RB in assenza di irraggiamento e del
solo irraggiamento senza somministrazione del RB tramite i test MTT e NR, si è passati alla
valutazione delle modificazioni morfologiche cellulari tipiche della morte per apoptosi, mediante
microscopia ottica ed elettronica. Si è evidenziata l‟emissione di filopodi, seguita dalla formazione
di protrusioni citoplasmatiche e loro contrazione con il successivo rilascio di corpi apoptotici. Il
reticolo endoplasmatico è risultato l‟iniziale bersaglio del danno da irraggiamento: si osservano
impacchettamento, dilatazione e polarizzazione delle cisterne. Anche il citoscheletro, sia nella sua
componente actinica che microtubulare, risulta profondamente alterato. Le cellule apoptotiche che
sono derivate dall‟irraggiamento presentano moltissimi blebs di superficie, come evidenziato
dall‟osservazione in microscopia elettronica a scansione, mentre l‟osservazione al microscopio a
fluorescenza, dopo aver marcato le cellule con Hoechst 33342, ha evidenziato alterazioni a carico
del nucleo, tipiche della morte cellulare per apoptosi, come ad esempio, la condensazione della
cromatina sulla faccia interna della membrana nucleare e la frammentazione del nucleo e della
cellula a formare corpi apoptotici.
Attraverso la doppia colorazione Annexina-Ioduro di Propidio, abbiamo stabilito che la morte
cellulare avviene per apoptosi e non per necrosi: la percentuale di necrosi aumenta ai tempi più
lunghi, si tratta di necrosi secondaria, come prevedibile in un sistema in vitro dove manca l‟azione
di fagociti che rimuovono le cellule morte. La nostra indagine è proseguita, quindi, cercando di
definire i meccanismi molecolari alla base dell‟apoptosi indotta dal nostro tipo di trattamento. Tra i
diversi pathways di induzione apoptotica ci siamo concentrati su quello che parte dai recettori di
membrana (estrinseco) e su quello che coinvolge i mitocondri (intrinseco). Valutando l‟attività
enzimatica di 3 diverse caspasi, la 8 per la via estrinseca, la 9 per quella intrinseca e la 3, abbiamo
concluso che entrambi i pathways vengono indotti dal trattamento in modo tempo-dipendente: il
segnale di morte parte precocemente dai mitocondri, mentre ai tempi più lunghi è mantenuto
dall‟attività della caspasi 8. Ci siamo concentrati, comunque, sul danno mitocondriale, valutando
61
innanzitutto alterazioni del potenziale transmembrana al microscopio a fluorescenza tramite
marcatura con MitoTracker e, quindi, la quantità di citocromo c che viene riversata dai mitocondri
nel citoplasma e il coinvolgimento dei geni della famiglia Bcl-2, i cui prodotti formano canali sulla
membrana mitocondriale per il passaggio del citocromo c.
In particolare, i prodotti di cleavage di Bid da parte della caspasi 8 scompaiono, ai tempi più lunghi
di trattamento, dal pattern proteico del citoplasma e li abbiamo ritrovati in quello delle proteine di
membrana. La proteina Bax, invece, sia nella sua forma monometrica che dimerica, aumenta sia nel
citosol che sulle membrane.
Bax è coinvolto anche nell‟omeostasi della concentrazione dello ione Ca2+, ed al momento stiamo
valutando alterazioni a carico di quest‟ultimo, estendendo, in questo modo, lo studio delle vie di
induzione apoptotica verso il pathway che coinvolge il reticolo endoplasmatico.
Durante le nostre indagini microscopiche, abbiamo osservato una significativa frequenza di cellule
caratterizzate da molti blebs (caratteristica delle cellule in apoptosi) sulla membrana plasmatica ma
che non esponevano residui di fosfatidilserina (marcatore di apoptosi). Questo ci ha portato a
decidere ampliare la nostra indagine sulle vie di induzione di apoptosi verso danni che partono dal
citoscheletro.
Gruppo Prof. Michele Maffia
Il rame è un metallo di transizione essenziale in tracce per la sopravvivenza di tutti gli organismi,
tuttavia risulta tossico se in eccesso rispetto alle necessità fisiologiche. L‟introduzione di rame
nell‟organismo avviene essenzialmente attraverso le mucose intestinali ed è mediata da un sistema
di trasporto saturabile. Sebbene i meccanismi cellulari e molecolari responsabili dell‟assorbimento
intestinale dello ione non siano stati completamente caratterizzati, è probabile che il rame subisca
una variazione dello stato di ossidazione propedeutica all‟ingresso in cellula ad opera di reduttasi di
membrana. L‟intake cellulare avviene in misura preponderante ad opera del carrier ad elevata
affinità per il rame CTR1, distribuito ubiquitariamente nei tessuti di mammifero. Il trasporto
intracellulare è mediato da una famiglia di proteine altamente conservate nei procarioti e negli
eucarioti, i chaperon del rame, che consentono di veicolare lo ione verso specifici compartimenti
subcellulari ed enzimi che lo richiedono come cofattore. L‟efflusso cellulare avviene
essenzialmente ad opera di due ATPasi di tipo P, le proteine di Menkes e Wilson, che, localizzate a
livello dell‟apparato di Golgi, in presenza di un eccesso di rame si spostano verso la membrana
plasmatica. Alterazioni del delicato equilibrio omeostatico del rame dovute al malfunzionamento di
queste ATPasi sono associate a diversi stati patologici. Nonostante il riconosciuto coinvolgimento
del rame nell‟insorgenza di svariate patologie neurodegenerative (es. Encefalopatie Spongiformi
Trasmissibili), i meccanismi che presiedono all‟omeostasi cellulare dello ione, in particolare nei
tessuti nervosi, non sono stati ancora del tutto definiti. Alla luce di queste premesse, l‟attività
sperimentale è in gran parte consistita nella caratterizzazione del modello cellulare di
neuroblastoma di ratto B104 in riferimento ai meccanismi molecolari che presiedono al controllo
delle attività enzimatiche Cu-dipendenti.
Mediante Immunoblotting e tecniche di amplificazione genica, è stata dimostrata nella linea
cellulare B104 l‟espressione del trasportatore di rame ad elevata affinità CTR1, del trasportatore di
metalli divalenti DMT1, della proteina prionica cellulare (PrPC), delle ATPasi di Menkes (ATP7A)
e Wilson (ATP7B) coinvolte nel processo di escrezione cellulare del rame e delle metallotioneine,
proteine in grado di tamponare l'eccesso dello ione nel citosol. L‟attività sperimentale è stata
successivamente indirizzata allo studio dei meccanismi di regolazione dell‟espressione dei
trasportatori CTR1, DMT1 e della proteina PrPC in funzione della disponibilità di rame nel mezzo
extracellulare. In particolare, mediante tecniche di Immunoblotting è stato osservato in cellule B104
esposte ad una condizione di overesposizione al rame (CuCl2 50–150 µM) per 48 ore un sensibile
incremento nell‟espressione di CTR1. Protraendo il trattamento per 96 ore, non è stata rilevata,
invece, alcuna variazione significativa della stessa.
62
Particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione degli effetti di livelli deficitari di rame nel
mezzo extracellulare. La regolazione dell‟espressione delle proteine di interesse, CTR1, DMT1 e
PrPc, in relazione alla deprivazione di rame nel mezzo esterno è stata valutata mediante
Immunoblotting e Real-Time PCR. I dati sperimentali dimostrano come nella linea cellulare B104
la deprivazione di rame attivi dei meccanismi di regolazione a livello trascrizionale, modulando
l‟espressione dei trasportatori CTR1, DMT1 e PrPC. In sintesi, dopo 48 ore di deprivazione di
rame, le cellule B104 mostrano ridotti di espressione delle proteine DMT1 e PrPC, compensati da
un considerevole incremento nella sintesi del trascritto relativo a CTR1. Protraendo per 96 ore
l‟esposizione al cuprizone, si rileva un incremento, sebbene più contenuto, dell‟espressione di
CTR1 rispetto alla condizione Controllo, unitamente ad un recupero dei livelli di espressione del
trasportatore DMT1. I livelli di trascritto relativi alla PrPC risultano invariati rispetto a quanto
riscontrato dopo 48 ore di deplezione di rame.
Gli aspetti funzionali relativi al trasporto di rame nel modello cellulare B104 sono stati valutati
mediante la messa a punto di una metodica spettrofluorimetrica basata sulla specificità della
risposta del colorante fluorescente Phen Green SK a variazioni dei livelli intracellulari dello ione.
Gli studi cinetici hanno consentito di dimostrare che l'ingresso dello ione in cellula è mediato
essenzialmente da un sistema di trasporto saturabile, la cui costante di Michaelis e Menten
(0.22±0.06 µM) risulta compatibile con i valori riportati per i trasportatori della famiglia CTR (0.65 µM).
Recentemente numerose evidenze sperimentali hanno avvalorato l‟ipotesi di una stretta correlazione
tra il mantenimento dell‟omeostasi cellulare dello ione rame e la fisiologia della proteina prionica
cellulare PrPc, glicoproteina ancorata al versante esterno delle membrane cellulari ed espressa
prevalentemente a livello dei tessuti nervosi. La sua capacità di legare ioni metallici ed in particolar
modo il rame (Cu2+) a livello della regione N-terminale induce a supporre ragionevolmente che
possa essere coinvolta nell‟uptake cellulare dello ione. Attualmente si ritiene che un‟isoforma
aberrante della proteina prionica cellulare nota come PrPsc (isoforma scrapie) possa rappresentare
l‟agente eziologico di un vasto numero di patologie neurodegenerative ad esito costantemente fatale
note come Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE). La differenza tra le due isoforme della
proteina appare essere unicamente di natura conformazionale. Dal momento che la transizione
PrPc PrPsc rappresenta l‟evento cruciale per l‟insorgenza delle TSE, particolare attenzione è stata
rivolta ad una porzione della proteina prionica ritenuta un possibile sito di interazione e compresa
tra gli amminoacidi 173 e 195 (elica 2). Si è, quindi, scelto di adoperare come modello di studio un
peptide sintetico riproducente la sequenza 173-195 all‟elica 2 della proteina prionica umana,
hPrP[173-195]Ac Am., allo scopo di testarne gli eventuali effetti citotossici sulla linea cellulare
B104.
L‟esposizione delle cellule a concentrazioni crescenti di peptide per diversi intervalli di tempo (18,
24, 48 ore) ha dimostrato che il frammento in questione esplica il suo effetto neurotossico in modo
dose-dipendente (LC50 67.7 µM dopo 48 h). Per valutare l‟importanza della formazione di ponti
disolfuro rispetto alla citotossicità del peptide hPrP[173-195] ac. am., è stato analizzato un altro
frammento peptidico riproducente l‟elica 2 priva del tratto N-terminale contenente il residuo di
cisteina in posizione 179, hPrP[180-195] Ac. Am. Quest‟ultimo frammento ha esibito una
citotossicità maggiore rispetto alla linea cellulare B104 (LC50 10.8 µM), evidenziando come i
residui C-terminali dell‟elica 2 della proteina prionica umana (190-195) siano in buona parte
responsabili della tossicità indotta dal peptide wild-type. Al fine di individuare un‟eventuale
correlazione tra effetti biologici indotti dai frammenti prionici sulla linea cellulare B104 e le loro
propensioni strutturali valutate tramite spettroscopia CD, sono stati sintetizzati diversi peptidi
corrispondenti alla porzione 180-195 della proteina prionica umana, recanti ciascuno la sostituzione
di un singolo amminoacido con un residuo di alanina a partire dall‟istidina in posizione 187. I
risultati dei test biologici (hPrP[180-195] ac. am. H187A: LC50 1.6 µM; T188A: LC50 290.8 µM;
63
V189A: LC50 356.3 µM; T190A: LC50 19.4 µM; T191A: LC50 179.0 µM; T192A: LC50 4.3
µM; T193A: LC50 271.9 µM; K194A: LC50 234.1 µM) valutati alla luce dei dati strutturali,
hanno dimostrato come non esista un‟evidente correlazione tra neurotossicità e conformazione
secondaria assunta dai peptidi.
Al fine di chiarire la natura dell‟interazione del frammento corrispondente all‟elica 2 della PrP c
(hPrP[173-195]) con le cellule di neuroblastoma, è stata messa a punto una metodica di analisi
mediante microscopia confocale, che ha consentito di evidenziare l'internalizzazione del frammento
fluoresceinato corrispondente all‟elica 2 integrale, evidenziando l‟emissione di un intenso segnale
fluorescente sia nel citoplasma che nel nucleo delle cellule trattate.
Infine, sono stati utilizzati approcci proteomici per ottenere ulteriori informazioni sui meccanismi
cellulari di insorgenza di patologie neurodegenerative. I risultati ottenuti su soggetti affetti da
sclerosi multipla e altre patologie sia cardiovascolari che neoplastiche sono stati oggetto di
comunicazioni a congresso e pubblicazioni.
Gruppo: Prof. Bruno Di Jeso
Abbiamo continuato i nostri studi sulle SERCA delle cellule tiroidee ( Ulianich L, Secondo A, De
Micheli S, Treglia S, Pacifico F, Liguoro D, Moscato F, Marsigliante S, Annunziato L, Formisano
S, Consiglio E, Di Jeso B.TSH/cAMP up-regulate sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPases
expression and activity in PC Cl3 thyroid cells. Eur J Endocrinol. 2004 Jun;150(6):851-61. Pacifico
F, Ulianich L, De Micheli S, Treglia S, Leonardi A, Vito P, Formisano S, Consiglio E, Di Jeso.The
expression of the sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPases in thyroid and its down-regulation
following neoplastic transformation.J Mol Endocrinol. 2003 Jun;30(3):399-409) dimostrando che
queste pompe del Ca2+ giocano un ruolo importante nel modulare i transienti di Ca2+ in seguito a
stimolazione purinergica delle cellule tiroidee. In particolare, la stimolazione purinergica attiva le
PKCs che a loro volta attivano le SERCA, che concorrono al ristabilimento della concentrazione di
Ca2+ di riposo.
Abbiamo inoltre intrapreso uno studio degli effetti della microgravità sulla sopravvivenza cellulare
con particolare riguardo alla regolazione dei transienti di Ca2+.
64
UNITA’ DI RICERCA DI MESSINA
Direttore Scientifico: Prof. Luigi Monsù Scolaro
Composizione e settore di indagine
L‟unità di ricerca di Messina è composta da sei distinti gruppi di ricerca, ciascuno dei quali
possiede delle competenze specifiche in settori di interesse del Consorzio.
Obiettivi e Metodi
Gruppo di Ricerca dei Proff. Luigi Monsù Scolaro e Raffaello Romeo. Questo gruppo di ricerca si
interessa allo studio di processi di auto-aggregazione e di organizzazione supramolecolare a carico
di specie planari (porfirine e relativi metallo-derivati, e complessi planari di platino(II)) su
biomolecole o su sistemi polimerici di rilevanza biologica.
In linea con studi precedenti, sono state condotte nuove indagini su processi di aggregazione di
porfirine sia in mezzo acquoso che non-acquoso, investigando il ruolo svolto dal solvente e dai
contro-ioni presenti in soluzione. Tali sistemi aggregati presentano interessanti proprietà fotofisiche
ed in alcuni casi specifici si prestano allo sviluppo di sensori acido-base.
L‟interazione di porfirine recanti gruppi carbossilici sui sostituenti periferici con polimeri
biocompatibili basati su polipropilenglicole e dotati di terminazioni amminiche produce complessi
supramolecolari atti alla solubilizzazione di porfirina ad elevate concentrazioni.
Nell‟ambito dello sviluppo di sistemi antenna artificiali, una serie di batteriofagi M13
opportunamente ingegnerizzati sono stati impiegati per auto-organizzare porfirine cationiche. I
sistemi non-covalenti così ottenuti hanno evidenziato delle notevoli potenzialità legate al
trasferimento di energia da residui triptofano presenti sulla matrice virale alle porfirine.
Una serie di ciclodestrine anfifiliche, in grado di auto-organizzarsi in vescicole, è stata studiata
come sistema per il trasporto di porfirine all‟interno del comparto cellulare, dove ne è stata misurata
la capacità di produzione di ossigeno singoletto. L‟introduzione di opportuni residui glicosidici
sulla superficie delle vescicole ha consentito l‟interazione selettiva di tali sistemi con delle lectine.
La reattività di vari complessi organometallici di platino(II) è stata indagata quale ausilio per la
sintesi mirata di specifici composti di questo ione metallico.
Gruppo di Ricerca del Prof. Matteo Cusumano. Questo gruppo si dedica allo studio delle proprietà
di intercalazione di una serie di complessi planari quadrati di platino(II) e palladio(II) contenenti
leganti aromatici nei confronti di acidi nucleici ed alle variazioni di reattività indotte dal
microambiente specifico. Un sensore elettrochimico per la rivelazione di interazioni tra acidi
nucleici e specifici complessi metallici è stato sviluppato in collaborazione con il gruppo del Prof.
Osella.
Gruppo di ricerca dei Proff. Giuseppe Bruno ed Enrico Rotondo. Questi ricercatori si occupano
essenzialmente della determinazione di strutture di composti inorganici ed organici di potenziale
interesse farmacologico tramite l‟impiego di tecniche di diffrazione di raggi-X e di risonanza
magnetica nucleare.
Gruppo di Ricerca del Prof. Giuseppe Teti. Questo gruppo di ricerca opera nel settore della
microbiologia, sviluppando sia attività di ricerca indipendente che di supporto ai vari gruppi
dell‟Unità di ricerca.
Gruppo di Ricerca del Prof. Franco Felici. Questi ricercatori svolgono della ricerca indipendente
nei settori della biologia molecolare e genetica, e forniscono attività di supporto al gruppo del Prof.
Monsù nello sviluppo di sistemi antenna basati su virus filamentosi e porfirine e di biosensori
specifici per batteri patogeni.
65
66
UNITA’ DI RICERCA DI NAPOLI
Direttore Scientifico: Prof. Carlo Pedone
L‟attività scientifica dell‟Unità operativa di Ricerca di Napoli è stata svolta per l'anno 2006
pricipalmente nell‟ambito delle seguenti tematiche:
Sonde per la diagnosi in medicina nucleare basate su peptidi
I coniugati peptidici costituiscono sonde biospecifiche per la diagnosi mediante le tecniche
della medicina nucleare e per la terapia del cancro in quanto consentono di veicolare un metallo
radioemittente verso tessuti tumorali. Essi possono riconoscere infatti con alta affinità recettori
espressi in cellule tumorali. Pertanto nell‟ultimo decennio queste molecole hanno riscosso un ampio
interesse sia da parte di gruppi di ricerca accademici, che di aziende farmaceutiche. L‟ U.O. di
Napoli negli ultimi anni ha sviluppato sonde per il riconoscimento di recettori della colecistochinina
veicolando gli isotopi 111In e 99mTc. Per coordinare l‟isotopo del tecnezio è stato utilizzato un
approcccio multilegante stabilizzando il Tc nello stato di ossidazione cinque mediante un chelante
di tipo PNP (N,N-bis(dimethoxypropylphosphinoethyl)methoxyethylamine) e saturando le ulteriori
posizioni di coordinazione con una cisteina legata all‟estremità N terminale del peptide CCK8, un
peptide endogeno in grado di riconoscere i recettori 1 e 2 della colecistochinina. Il complesso è
stabile in solutzone acquosa ed in tampone fosfato. In vitro gli esperimenti di scambio con un
eccesso di cisteina e glutatione indicano che non si verificano reazioni di transchelazione,
confermando l‟alta stabilità termodinamica ed inerzia cinetica di questi composti. Studi di stabilità
condotti in siero umano e di topo, come in omogenato di fegato di topo, mostra che il composto
radiomarcato resta intatto per prolungata incubazione a 37°C. Le prove biologiche hanno dimostrato
selettività verso il target e specificità che non risulta alterata dalla presenza sull‟estremità Nterminale del chelante. La costante di binding (Kd) infatti risulta (19.0 ± 4.6 nmol/l) valutata su
A431 cellule sovraesprimenti il recettore 2. Prove di spiazzamento con la sonda “fredda”
confermano l‟internalizzazione nella membrana cellulare dell‟addotto. Anche in vivo i coniugati
mostrano una stabilità sufficiente a marcare le cellule e una buon metabolismo, anche se questa
sonda come analoghe precedentemente preparate necessita di ulteriori modifiche al fine di
aumentare l‟idrofilicità che si è dimostrata essenziale per ottenere la migliore clearance da parte
della cavia.
Aggregati supramolecolari peptidi-chelanti come tools per la diagnosi oncologica mediante la
tecnica della risonanza magnetica imaging (MRI).
Negli ultimi anni a seguito della bassa sensibilità della tecnica della risonanza imaging
(RMI) sono stati messi a punto opportuni agenti di contrasto (MdC) per ottenere immagini definite.
Mentre in medicina nucleare (MN) è sufficiente una concentrazione molto bassa di mezzo di
contrasto nel tessuto da evidenziare dell‟ordine di 10-10M, per l‟RMI è necessaria una
concentrazione di 10-4M. Il mezzo di contrasto per la RMI è costituito da un metallo paramagnetico
quale il Gd(III). Pertanto per ottenere un contrasto sufficiente è necessario portare un gran umero di
ioni paramagnetici sulla cellula ed ottimizzare la relassività intrinseca per ogni singolo complesso
paramagnetico, aumentando il tempo di riorientamento molecolare. A tal fine negli ultimi anni l‟UO
di Napoli in collaborazione con l‟UO di Torino ha preparato sistemi supramolecolari, come micelle
miste, che espongono sulla loro superficie un vettore peptidico in grado di riconoscere un recettore
sovraespresso dalle cellule tumorali. Anche in questo caso i recettori target oggetto della ricerca
sono stati i recettori della colecistochinina. Inizialmente è stata preparata un‟ampia serie di
monomeri in grado di assemblarsi costituiti da una catena o due catene alchiliche a 18 atomi di
carbonio e da una testa idrofilica rappresentata dal chelante o dal peptide CCK8, rispettivamente.
67
Per aumentare l‟idrofilicità del monomero-peptide e migliorarne l‟esposizione sulla
superficie esterna della micella mista, sono stati inseriti un numero variabile di spaziatori polietossilici (2 oppure 5) oppure catene di polietilenglicole tra la catena idrofobica e il peptide. Le
caratterizzazioni strutturali sugli aggregati misti contenenti il monomero (C18)2(Link) 5CCK8,
(C18)2Peg2000-CCK8, (C18)2DSPE(Peg2000)-CCK8 con (C18)2DTPAGlu sono state condotte sia
con il chelante coordinato allo ione Gd3+ che come base libera. Dall‟analisi degli spettri di
scattering neutronica si evince che nelle soluzioni preparate esiste una coesistenza di micelle di
diversa forma e dimensione. Nel caso del monomero (C18)2DSPE(Peg2000)-CCK8 modulando la
percentuale dei due monomeri negli aggregati si ottengono micelle o, a partire dal 70% di
monomero peptidico (C18)2DSPE(Peg2000)-CCK8, doppi strati lipidici. Il valore della cmc è dell‟
ordine di grandezza di 10-6 mol Kg-1. Gli aggregati sono di tipo cilindrico, e non sferico come per le
micelle contenenti una coda idrofobica. Il valore della relassività compreso tra R1p = 18 mM-1s-1 e
21 mM-1s-1 a 20 MHz e 25°C è superiore a valore misurato per le micelle di prima generazione ed
ad aggregati riportati in letteratura. Successivamnete è stato sintetizzato un'unica molecola anfifilica
(fig 1) in cui la testa idrofilica è costituita dal peptide CCK8 e dal chelante GluDTPA. Questa
molecola autoassemblandosi forma un aggregato in cui il peptide e il chelante costituiscono la testa
idrofilica. Il valore di cmc è stato determinato da misure di fluorescenza usando l‟ 8anilinonaftalene-1-sulfonato (ANS) come probe di fluorescenza ( 10-4 mol kg-1). I dati strutturali
ottenuti dallo scattering neutronico indicano che gli aggregati micellari hanno forma ellissoidale. Il
numero di aggregazione (Nagg), dell‟aggregato supramolecolare è di ~ 35. Il valore molto basso del
numero di aggregazione, rispetto a quanto evidenziato nelle micelle di prima generazione, può
essere spiegato in base a due effetti: uno derivante dall‟elevato ingombro sterico della parte polare,
dovuta alla copresenza del chelante e del peptide sul singolo monomero; l‟altro derivante dalla
repulsione elettrostatica dovuta alla presenza delle cariche negative sul chelante DTPAGlu Il raggio
idrodinamico delle micelle è ~ 50 Å. La caratterizzazione rilassometrica del monomero (C18)2(Link)-Lys(DTPAGlu(Gd))-(Link)2-G-CCK8 ha evidenziato che il tempo di reorientazione
molecolare (ηr) ha un valore di 4.6 ns e il tempo medio di residenza, nel centro paramagnetico, della
molecola d‟acqua in rapido scambio con l‟acqua di “bulk” della soluzione (ηM) un valore di 1.1 μs e
quindi la relassività molare dell‟aggregato per atomo di Gd(III) è 15 mM -1s-1 a 25°C e 20 MHz. Il
ηr, in accordo con le premesse fatte in fase di progettazione, ha un valore molto elevato, indice di
un‟alta rigidità strutturale del sistema. Attualmente sono in corso prove di spiazzamento e binding
su cellule per definire le costanti di binding.
O
N
O
N
H
O
H
N
O
O
O
O
N
H
(CH2)4
N
O
N
(C18)2(Link)Lys(DTPAGlu)(Link)2-G-CCK8
O2
COO -
N
-OOC
H
N
O
N
Gly CCK8
COO -
COO-
-OOC
Figura 1: Rappresentazione schematica del monomero anfifilico contenente il peptide CCK8
e agenet chelante DTPAGlu. (C18)2LLys(DTPAGlu)L2-G-CCK8
68
Sviluppo di nuove molecole come antagonisti dell’integrina
v
L‟angiogenesi è un processo fisiologico, che, implica una cascata di eventi sequenziali che
portano alla formazione di nuovi capillari da vasi sanguigni preesistenti. La formazione di capillari può
diventare patologico in risposta alla presenza di cellule tumorali. Tale processo avviene a seguito del
rilascio di fattori pro-angiogenici che si legano ai recettori delle cellule endoteliali dei vasi sanguigni
preesistenti, portando alla loro attivazione e proliferazione. L‟interazione fra cellule tumorali ed
endoteliali conduce alla secrezione e all‟attivazione di vari fattori proteolitici, come le MMP, in grado di
degradare la membrana basale e la matrice extracellulare (ECM); tale degradazione permette alle cellule
attivate di migrare verso il tumore formando nuovi vasi grazie al riconoscimento e all‟interazione delle
Integrine (αvβ3 e αvβ5) con diversi ligandi liberati dall‟ ECM. Diversi studi clinici hanno dimostrato che
l‟angiogenesi è un processo essenziale per la crescita di tumori solidi e che la soppressione, anche di una
sola delle sue fasi, inibisce la formazione di nuovi vasi, influendo così sulla crescita del tumore e la
generazione di metastasi. In tale contesto si inserisce questa tematica di ricerca dell‟UO di Napoli
avente come obiettivo la progettazione, lo sviluppo e la caratterizzazione di nuove molecole di
natura peptidica e peptidomimetica in grado di modulare l‟attività di sistemi molecolari coinvolti
nella cascata angiogenica. A tale scopo è stato scelto come sistema modello più noto e studiato
nell‟ambito della regolazione del processo di angiogenesi patologica il recettore per le proteine delle
matrice Integrina αvβ3. L‟attività di ricerca è stata rivolta all‟Integrina αVβ3, glicoproteina
transmembrana, costituita da due subunità α e β non covalentemente associate. Tale Integrina
appartiene ad un‟ampia famiglia di recettori di adesione cellulare costituiti da differenti subunità α e
β. Le subunità possono dar luogo a più di 20 diverse combinazioni di eterodimeri, la maggior parte
dei quali interagisce con specifici ligandi dell‟ECM che contengono la sequenza amminoacidica di
riconoscimento RGD. In particolare è stato dimostrato che l‟Integrina αVβ3, normalmente espressa
sulla superficie cellulare in bassa concentrazione, risulta sovraespressa in presenza di patologie
neoplastiche. In seguito all‟interazione con opportuni ligandi dell‟ECM, le Integrine αVβ3 formano dei
cluster molecolari e attivano pathway di segnali intracellulari necessari alla sopravvivenza, proliferazione
e migrazione cellulare. Diversi studi indicano che antagonisti in grado di bloccare tale legame inducono
l‟apoptosi bloccando il processo angiogenico. L‟Echistatina, una proteina da 49 residui, può svolgere
questo ruolo. Come tutti i ligandi dell‟Integrina αVβ3, anche l‟Echistatina possiede la sequenza di
riconoscimento RGD e studi strutturali e di mutagenenesi su tale proteina hanno indicato che la struttura
del loop RGD, i residui adiacenti e il dominio C-terminale sono critici per l‟affinità e il riconoscimento
selettivo del recettore. Sono attualmente note le strutture ai raggi X dell‟Integrina αVβ3 e del complesso
che questa forma con il ciclo(RGDf-NMeV) (f= D-Phe), la più piccola molecola sintetica capace di inibire
il binding dei ligandi naturali all‟Integrina αVβ3.
Pertanto sono state progettate molecole peptidiche e peptidomimetiche basate sul modello
del ciclo(RGDf-NMeV), per assicurare l‟affinità di binding, e su quello dell‟Echistatina in modo da
aumentarne la selettività nei confronti dell‟Integrina αVβ3 mediante studi di docking sovrapponendo
il tratto RGD della struttura dell‟Echistatina depositata nel Protein Data Bank con quello del
ciclo(RGDf-NMeV) nel complesso Integrina-ciclo(RGDf-NMeV). Si è quindi valutato il
comportamento e l‟orientazione degli altri residui della sequenza dell‟Echistatina rispetto
all‟Integrina. Dalla sovrapposizione realizzata si è osservato, in particolare, che la porzione Cterminale (Arg41-Thr49) e la sequenza Met28-Asp30 dell‟Echistatina interagiscono principalmente
con la subunità β3 dell‟Integrina. Alla luce di tale risultato si è stato progettato e sintetizzato un
peptide ciclico con sequenza RGDeK (e= D-Glu) e di legarlo alla sequenza Met28-Asp30 e agli
ultimi 9 residui della porzione C-terminale dell‟Echistatina mediante il dipeptide Pro-Gly allo scopo
di stabilizzare ulteriormente l‟orientazione relativa delle due sequenze peptidiche nel modello. Questo è
stato realizzato impiegando tecniche di Drug Design con l‟ausilio di programmi di grafica molecolare e di
minimizzazione dell‟energia.
69
La sequenza amminoacidica del peptide progettato, denominato RGDechi, risulta quindi:
Met-Asp-Asp-Pro-Gly-Arg-Asn-Pro-His-Lys-Gly-Pro-Ala-Thr19
Lys1-Arg-Gly-Asp-DGlu
A partire dalla molecola progettata sono stati sintetizzati con la stessa metodologia due
analoghi, Echi 14 ed Echi 9, costituiti rispettivamente dagli ultimi 14 e 9 residui del peptide
RGDechi, ciò allo scopo di evidenziarne le differenze nel binding all‟Integrina αVβ3 rispetto alla
sequenza ciclica completa.
Allo scopo di valutare l‟attività biologica e la selettività del peptide RGDechi nei confronti
dell‟Integrina αVβ3, sono stati realizzati esperimenti di binding su linee cellulari iperesprimenti le integrine
αVβ3 e αVβ5. Gli esperimenti realizzati hanno indicato sia per il ciclo(RGDfV) che per quello progettato
RGDechi un valore di IC50 nel range μM. Comparando i valori di IC50 dei due ligandi, si è potuta
osservare per il peptide ciclo(RGDfV) una affinità solo leggermente superiore (IC50= 0.64 μM) rispetto a
quella del peptide RGDechi (IC50=0.88 μM). Per quanto riguarda gli esperimenti di adesione cellulare
condotti sui peptidi Echi 9 e Echi 14, non contenenti la sequenza RGD, i risultati ottenuti hanno indicato
che i due peptidi non sono in grado di legare l‟Integrina αVβ3 se non è presente la sequenza RGD nella
molecola RGDechi.
Parallelamente sono stati eseguiti esperimenti di marcatura sul ciclo(RGDfV) che è stato
modificato mediante introduzione di una Tyr al posto della Phe per permetterne la marcatura con 125I.
Tali esperimenti hanno mostrato che il ciclo(RGDyV) presenta un valore di IC50 paragonabile a quello
ottenuto nel saggio di adesione. La nuova molecola di natura peptidica progettata e sintetizzata è in grado
di legare con alta affinità e specificità l‟Integrina αVβ3 e quindi, opportunamente funzionalizzata, potrebbe
essere utilizzata come sonda biospecifica nella diagnosi e nella terapia delle malattie neoplastiche.
Inoltre nell‟ultimo periodo e‟ stata affrontata la problematica di ottenere il peptide ciclico
contenente la sequenza RGD funzionalizzato con sistemi chelanti per coordinare radionuclidi, come
lo 111In and 90Y, per effettuare esperimenti in vivo con tecnica SPECT. Il ligando è stato legato alla catena
laterale della lisina nel peptide ciclico, residuo che in sede di progetto era stato scelto proprio per svolgere
questa funzione. La sintesi del composto è stata eseguita ed è in corso l'allestimento un modello animale
basato sull‟inoculo nell‟animale delle cellule iperesprimenti v
o le integrine correlate da
utilizzare in vivo per saggiare tutti i peptidi radiomarcati ottenuti nell‟ambito del progetto.
Studi Strutturali su Anidrasi Carboniche.
L'anidrasi carbonica (CA) è un enzima ubiquitario, presente negli Archaea, nei procarioti
e negli eucarioti, codificato da tre differenti famiglie di geni (alfa, beta e gamma) i cui membri
hanno in comune molto poco della loro sequenza e della loro struttura, anche se svolgono tutti la
stessa funzione e richiedono uno ione zinco nel loro sito attivo. L'anidrasi carbonica catalizza la
rapida interconversione di anidride carbonica e acqua in acido carbonico, protoni e ioni
bicarbonato, svolgendo, quindi, un ruolo chiave nella regolazione del pH e nell'equilibrio dei
fluidi in diverse parti del nostro corpo. Nello stomaco contribuisce alla secrezione di acido,
mentre lo stesso enzima aiuta a rendere il succo pancreatico alcalino e la nostra saliva neutra. Il
trasporto dei protoni e degli ioni bicarbonato prodotti nei reni e negli occhi influenza il
contenuto di acqua nelle cellule di questi organi. Gli isoenzimi di anidrasi carbonica, quindi,
compiono funzioni diverse nei vari organi, e la loro assenza o il loro cattivo funzionamento
possono condurre a stati di malattia, che vanno dalla mancanza di produzione di acido nello
stomaco, al blocco renale, al glaucoma. La progettazione di inibitori specifici per i vari
isoenzimi di questa famiglia di proteine costituisce, quindi, uno step fondamentale nello
sviluppo di farmaci selettivi per le differenti patologie correlate alle diverse isoforme.
70
L‟attività catalitica delle anidrasi carboniche può essere modulata mediante l‟utilizzo di
molecole contenenti un gruppo solfonamidico che, coordinandosi allo ione zinco del sito catalitico,
impedisce la formazione della specie attiva dell‟enzima.
Studi recenti hanno dimostrato che l‟isoforma IX dell‟anidrasi carbonica umana (CA IX) è
coinvolta nel processo di acidificazione dei tessuti tumorali ipossici. L'ipossia tumorale rappresenta
una condizione unica, che può essere sfruttata per trattamenti selettivi basati sull'uso di farmaci
bioriducibili. Tali pro-farmaci necessitano di attivazione metabolica per generare specie tossiche
dotate di attività antitumorale; tale attivazione avviene preferenzialmente nella cellula tumorale
ipossica in cui è prodotto il set appropriato di reduttasi. In tale contesto la UO di Napoli si e‟
occupata della caratterizzazione di una serie di composti disolfurici, contenenti il gruppo
sulfonamidico, che sono stati progettati, sintetizzati e testati per le loro capacità inibitorie
sull‟isoforma IX. Tra i composti studiati, la molecola 4-(2-ditiodifenilcarbossiamido)dibenzensolfonamide è risultata particolarmente interessante per la sua elevata affinità per la CAIX.
La caratterizzazione strutturale del complesso della forma ridotta di questa molecola con l‟isoforma
II, insieme al confronto con il complesso con l‟isoforma IX, ha consentito di identificare le basi
molecolari della specificità di quest‟inibitore nei confronti della CAIX. Le informazioni ottenute
costituiscono un importante punto di partenza per la progettazione di inibitori più specifici con
importanti applicazioni farmacologiche.
71
72
UNITA’ DI RICERCA DI PADOVA
Direttore Scientifico: Prof. Ulderico Mazzi
1. Sezione Radiofarmaci
a)
Sviluppo di radiofarmaci target-specifici marcati con 99mtecnezio e 186/188renio
Il “Seventh International Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine” tenutosi
a Bressanone dal 6 al 9 Settembre 2006 organizzato dal gruppo appartenente all‟Unità del
CIRCMSB di Padova è stato un punto di riferimento importante per gli operatori per verificare lo
stato della ricerca e le prospettive di sviluppo nel settore della produzione ed applicazione dei
radiofarmaci marcati con radionuclidi di tipo metallico ed in particolare marcati con Tecnezio-99m
e Renio-186/188.
Tali radiofarmaci sono impiegati in medicina nucleare a scopo diagnostico (imaging) o terapeutico
(radioterapia) in funzione delle proprietà nucleari del radionuclide in essi contenuto. Si è osservato
che ormai i radiotraccianti anche di tipo metallico sono utilizzati per marcare vettori biologici che
presentano alta affinità e selettività per siti specifici implicati in forme patologiche e che svolgono
quindi la funzione di veicolare il radionuclide (molecola direzionatrice) su uno specifico target.
Isotopi radioattivi di metalli di transizione offrono molte opportunità nello sviluppo di radiofarmaci,
e tra di essi il tecnezio-99m ed il renio-186/188 giocano un ruolo importante in ambito,
rispettivamente, diagnostico e terapeutico. A differenza di isotopi di atomi naturalmente presenti
nelle molecole biologiche (O, C, N), che possono essere incorporati nelle molecole direzionatrici
attraverso la formazione di un legame covalente, gli isotopi di natura metallica per essere
incorporati nelle biomolecole devono essere stabilizzati da un sistema chelante in un complesso di
coordinazione.
Nell‟ultimo decennio è stata sviluppata un‟ampia gamma di tecniche per la marcatura di
biomolecole con radiometalli, ma la metodica più ampiamente studiata e impiegata consiste
nell‟approccio del chelante bifunzionale (Bifunctional Chelating Agent, BFCA). Il chelante
bifunzionale presenta da un lato un set coordinativo in grado di stabilizzare il metallo, dall‟altro un
gruppo funzionale per l‟ancoraggio covalente della biomolecola, che può essere diretto oppure
mediato da uno spaziatore (linker), a dare il derivato BFCA(-linker)-BM. La scelta accurata del
BFCA è uno degli aspetti fondamentali nella progettazione di radiofarmaci target-specifici.
BM
Un BFCA ideale dovrebbe garantire la formazione di un complesso con alta resa e a concentrazioni
molto basse del coniugato BFCA-BM. Tale complesso non dovrebbe sottostare a reazioni di
ossidoriduzione, dovrebbe essere termodinamicamente stabile e cineticamente inerte e presentare un
basso numero di isomeri, in quanto tutte questi parametri possono influenzare notevolmente le
caratteristiche biologiche e farmacocinetiche del coniugato BFCA-BM. Infine, l‟attacco del BFCA
alla biomolecola dovrebbe essere facilmente realizzabile.
73
La selezione del BFCA dipende dal tipo di radiometallo e dal suo stato di ossidazione. Il core
[M=O]3+ viene largamente impiegato per la marcatura di biomolecole con 99mTc- e 186/188Re e negli
ultimi 15 anni sono stati sintetizzati e valutati molti chelanti bifunzionali, la maggior parte dei quali
possiede un set coordinativo di tipo NxS(4-x). Questi chelanti, sebbene abbiano trovato applicazione,
soffrono di alcune limitazioni quali l‟elevata lipofilia, una scarsa flessibilità strutturale, più forme
isomeriche spesso difficili da separare e limitata stabilità in vivo. Inoltre la loro marcatura richiede
spesso condizioni drastiche. Lo sviluppo di BFCA più efficienti resta quindi uno degli interessi
principali nell‟ambito della medicina nucleare.
Nel 2006 l‟Unità del CIRCMSB di Padova ha continuato a sviluppare chelanti bifunzionali
tetradentati contenenti una o più fosfine che hanno dimostrato di produrre complessi di Re-oxo e
99m
Tc-oxo di elevata stabilità. Tra di essi, il chelante di natura peptidica N-[N-(3difenilfosfinopropionil)glicil]-S-benzil-L-cisteina metilestere contenente un set PN2S ha dimostrato
alta affinità per il core [Me=O]3+ (Me = Re, Tc), ed il complesso esacoordinato ReOCl[PN2S(Bzl)]OMe è stato isolato e ampiamente caratterizzato. Sulla base dei risultati ottenuti sulla
complessazione del legante esterificato N-[N-(3-difenilfosfinopropionil)glicil]-S-tritil-L-cisteina
metilestere (PN2S(Trt)-OMe) con 185/187renio non radioattivo, che ha portato alla formulazione dei
complessi sin- ed anti-ReO(PN2S)OMe, si sono eseguiti gli studi di marcatura con 99mTc dei
chelanti detritilati PN2S-OH e PN2S-OMe al fine di definire le condizioni migliori per una
marcatura efficiente, in grado di garantire la formazione di una sola forma isomerica con alta
purezza radiochimica.
Come precedentemente detto, un BFCA deve stabilizzare il radiometallo cosicché il complesso
finale possegga alta stabilità alle reazioni redox e/o alla transchelazione con altri chelanti presenti
nei sistemi biologici. Inoltre, un altro aspetto cruciale nello sviluppo di un radiofarmaco targetspecifico riguarda la farmacocinetica del BFCA marcato che può seriamente influenzare quella
della molecola direzionatrice, soprattutto nel caso in cui questa abbia dimensioni ridotte (piccoli
peptidi). Allo scopo sono continuati gli studi per modificare le catene laterali del gruppo fosfinico in
modo da avere a disposizione più BFCA e modulare il contributo del chelante soprattutto in
funzione delle caratteristiche di interazione con il pool sanguigno.
Gli studi di biodistribuzione di un nuovo BFCA marcato sono fondamentali al fine di valutare il
livello di tale influenza e l‟eventuale necessità di apportare delle modifiche chimiche al BFCA. Ci si
è quindi dedicati agli studi in vitro, effettuati in plasma umano per determinare la stabilità
metabolica delle specie marcate derivate dai chelanti PN2S, e agli studi in animale, per valutare sia
la stabilità vivo che la farmacocinetica delle stesse specie. La biodistribuzione è stata determinata in
topo tramite analisi scintigrafica e conteggio della radioattività negli organi ex-vivo. L‟analisi
scintigrafica è stata condotta con una YAP-camera, γ-camera di recente sviluppo avente una
risoluzione di 1.0-1.2 mm e un campo di vista 40x40 mm2, utile per studi di biodistribuzione in
topo.
Prima di individuare la biomolecola su cui sperimentare i nuovi BFCA, sono stati eseguiti studi
utilizzando il linker polietilenglicole (PEG) un polimero estremamente versatile, utilizzato come
direzionatore di farmaci, per poi utilizzare tutta la molecola PN2S-PEG come carrello marcante,
portatore in toto delle proprietà di delivery utili per il raggiungimento del target specifico della
biomolecola marcata.
E stata eseguita la coniugazione del chelante bifunzionale PN2S-COOH al NH2-PEG. I coniugati
hanno mostrato alta stabilità e le reazioni di complessazione con 185/187Renio e 99mTecnezio hanno
portato allo formazione degli stessi complessi con il solo PN2S previa detritilazione con acido
trifluoroacetico e trietilsilano dei leganti PN2S(Trt)-PEG5 and PN2S(Trt)-PEG20.
E‟ stato allora verificato che, quando una soluzione acida di 99mTcO4- (pH = 2) veniva aggiunta ai
coniugati PN2S-PEG in forma solida, si otteneva in resa quantitativa una singola specie marcata
individuata avere una struttura analoga a quella dei complessi sopra riportati. La reazione avveniva
in meno di 15 minuti a temperatura ambiente. Una ragionevole spiegazione di questo risultato è
stata trovata nella riduzione e coordinazione del tecnezio attraverso una catalisi micellare dovuta
all‟aggregazione del PN2S-PEG in acqua. Infatti, i coniugati possiedono un carattere anfifilico, con
74
la parte PN2S altamente lipofilica e la catena polimerica PEG altamente idrofilica, e la formazione
di micelle notoriamente catalizza reazioni redox. D‟altra parte, il gruppo fosfinico è notoriamente
un buon riducente per il tecnezio.
I composti per marcatura diretta sono stati studiati in vivo per valutare la stabilità il tempo di
resistenza nel sangue e la biodistribuzione. I risultati hanno mostrato una buona stabilità e la
prevedibile biodistribuzione, analoga a quella del PEG, con eliminazione preferenziale per via
renale. Si è scelto quindi di coniugare i leganti PN2S-PEG a carrier biospecifici quali il peptide
UBI-29-41, l’octreotide e la biotina, per seguire la loro biodistribuzione in vivo e per verificare la
possibilità di impiego nell’imaging diagnostico tumorale. Studi preliminaro hanno già dato qualche
buon risultato e ci si prefigge di approfondire gli studi nel prossimo anno.
Nel 2006 , con il contributo della borsa di studio del CIRCMSB alla Dott.ssa Anna Nadali, si è
sviluppato lo studio comparato del comportamento in vivo dell’UBI-29-41.
L‟Ubiquicidina (UBI) 29-41 è un frammento peptidico antimicrobico cationico umano ed è stato
ampiamente dimostrato legarsi preferibilmente con le membrane anioniche cellulari microbiche in
corrispondenza dei siti d‟infezione. Questo frammento peptidico è stato marcato direttamente con
99m
Tc ed ha dimostrato selettività per i batteri, ma non nel caso di processi infiammatori sterili, in
esperimenti con animali ed ha dimostrato di essere utile nella pratica clinica per la valutazione
dell‟efficacia di una terapia antibiotica. Studi preclinici di 99mTc-UBI29–41 in modelli animali con
infiammazione ed infiammazione in corso hanno dimostrato l‟assenza di effetti collaterali. Studi di
biodistribuzione nell‟uomo hanno evidenziato che il composto 99mTc-UBI29–41 presenta una rapida e
prevalente escrezione renale e la mancanza di effetti collaterali. Tuttavia la struttura chimica del
radiofarmaco marcato direttamente non è attualmente definita. L‟obiettivo del progetto sviluppato
nell‟Unità di Padova con il supporto di una borsa di studio quello di marcare in maniera indiretta
l‟UBI29-41 coniugando al peptide il chelante bifunzionale (PN2S) attraverso il polietilenglicole
(PEG5000). Il complesso è stato quindi marcato con 99mTc ed è stata valutata l‟influenza del sistema
chelante PN2S-PEG5000 sulla biodistribuzione dell‟UBI29-41 in modelli animali sani; e verificato il
potenziale utilizzo di 99mTc-PN2S-PEG5000-UBI29-41 come tracciante per immagini d‟infezioni
indotte da Staphlococcus aureus.
La purezza radiochimica del prodotto 99mTc-PN2S-PEG5000-UBI29-41, determinata via RP-HPLC, è
risultata pari a 98 ± 1% ed è anche stata confermata la presenza di un singolo prodotto con tempo di
ritenzione pari a 17 min. 99mTc-PN2S-PEG5000-UBI29-41 ha dimostrato, dopo incubazione in
soluzione salina e in soluzione di buffer fosfato, di essere stabile fino a 6 h e di avere purezza
radiochimica maggiore del 95 %.
Studi di biodistribuzione in topi sani del 99mTc-PN2S-PEG5000 dimostrano alta attività nelle urine, il
che suggerisce che la clearance sia preferenzialmente renale. Comunque la presenza di UBI29-41
induce una riduzione del tempo di emivita nel sangue e porta ad un uptake epatico più elevato. Studi
di biodistribuzione di 99mTc-PN2S-PEG5000 in animali con infezione hanno dimostrato che l‟ attività
nel sito d‟infezione è paragonabile agli studi effettuati con il 99mTc-UBI29-41.
Studi effettuati in topi con infezione hanno dimostrato una buona clearance epatobiliare e renale ed
anche un accumulo nel sito d‟infezione analogo a quello riscontrato con il 99mTc-UBI29-41.
L‟introduzione dello spaziatore PEG5000 quindi non ha portato miglioramenti nel rilevamento di siti
d‟infezioni, ma non ha neppure influenzato la biospecificità dell‟ UBI. L‟inconveniente maggiore,
che ha prodotto la riduzione dell‟effetto dell‟introduzione del PEG, è stato dovuto all‟accumulo del
99m
Tc-PN2S-PEG5000-UBI29-41
b)
Studio Chimico sul Tantalio
In questi ultimi anni è in corso di progettazione e sviluppo una nuova generazione di gammacamere denominata MWGC (Multiwire Gamma Camera). Tra i vantaggi che le MWGC presentano
nei confronti delle tecniche tomografiche attualmente in utilizzo, vi sono:
- velocità di conteggio più elevata;
- superiore risoluzione;
75
- minor peso e dimensioni ridotte che ne consentono una maggior facilità di trasporto.
Una sola limitazione ha precluso lo sviluppo e la diffusione di tali rivelatori dalle potenzialità così
elevate. I detector gassosi mostrano un‟ efficienza ridotta a 140KeV. Tale valore corrisponde
all‟energia dell‟emissione g del Tc-99m (149 KeV) che resta a tutt‟oggi il più diffuso tra i nuclidi
utilizzati in radiodiagnostica. L‟efficienza tipica per una MWGC è del 25% a 140 KeV del 70% a
80 KeV e dell‟ 80% a 60 KeV.
Si è quindi di fronte alla necessità di utilizzare isotopi radioattivi caratterizzati da emissioni energia.
a più bassa.
Il Ta-178 è un candidato con eccellenti proprietà. Tale radionuclide è caratterizzato da emissioni X
con energia comprese tra i 55 ed i 65 KeV, quindi ottimali per la rivelazione con MWGC. Altri
importanti vantaggi sono invece correlati alla suo breve tempo di emivita di soli 9.3 minuti. Altri
radionuclidi utilizzati in Medicina Nucleare quali 99mTc o 201Tl hanno tempi di emivita superiori alle
6 ore i quali impongono differenti limitazioni dal punto di vista clinico sia per l‟alta dose di
radiazioni somministrata, sia per l‟assenza di un decadimento fisico durante il tempo di una rapida
analisi clinica.
La massima dose iniettabile risulta essere di 30mCi per il 99mTc e di 3mCi per 201Tl, mentre il tempo
di emivita relativamente lungo non rende possibili analisi multiple.
Il Ta-178 viene prodotto dal generatore 178W/178 Ta per decadimento del 178W (t1/2=21.7 giorni). Il
W-178 viene prodotto tramite reazione 181Ta(p,4n)178W per bombardamento con un fascio di
protoni a 24MeV di fogli di Ta-181 isotopo freddo del Tantalio. Il generatore è costituito da una
colonna a scambio ionico in cui viene legato il W-178 sottoforma di tungstenato. Si procede quindi
all‟eluizione del Ta-178 tramite una soluzione acquosa contenente HCl 0.1N e l‟1% di H2O2.
Fino ad oggi non è stato condotto alcun tentativo per determinare la forma chimica in cui il Ta-178
viene eluito dal generatore. E‟ possibile che in soluzione di acido cloridrico il metallo si presenti
sottoforma di ossidi ed idrossidi polinucleari i quali verrebbero eluiti con difficoltà dalla resina a
scambio ionico. Nelle condizioni in cui opera il generatore tuttavia, il Tantalio viene a trovarsi in
soluzione in concentrazione estremamente bassa. E‟ possibile che le specie in soluzione possano
essere Ta(OH)4+ e/o Ta(OH)5 che mostrano scarsa affinità per la resina a scambio ionico. Come
proposto da Babko et al. queste sono le principali specie in cui si presenta il Tantalio in una
soluzione a pH inferiore a 2 in assenza di complessi polinucleari.
La chimica del Tantalio comprende differenti stati di ossidazione, sono noti composti in tutti gli
stati di ossidazione tra il +V ed il -III con la sola eccezione del –II. Sono tuttavia molto più comuni
stati di ossidazione elevati , in particolare il +V.
Il Tantalio presenta un‟elevatissima affinità per l‟ossigeno, la chimica in soluzione acquosa è
dominata dalla formazione di ossidi ed idrossidi del metallo sottoforma di polianioni. La grande
affinità del Tantalio nei confronti dell‟ossigeno viene evidenziata in reazioni di estrazione di
ossigeno da molecole quali acidi carbossilici, alcoli, chetoni, dimetilsolfossido ed altri composti
contenenti ossigeno.
Sono noti in letteratura numerosi complessi con leganti donatori all‟ossigeno, fra questi gli alcossidi
di Tantalio rivestono una grande importanza. Questi vengono sintetizzati a partire dal pentacloruro
del metallo per reazione diretta con alcoli. La reazione porta alla formazione di complessi di
formula generale TaClx(OR)5-x (x=1-3), la sostituzione completa degli atomi di cloro da parte dei
gruppi alcossidici può essere ottenuta, per gli alcoli a più basso peso molecolare, tramite l‟utilizzo
di un accettore di protoni quale l‟ammoniaca.
Gli studi sulla chimica di coordinazione del tantalio non sono numerosi e per lo più la letteratura
riporta sintesi e caratterizzazioni di complessi metallici da utilizzare quali precursori per MOCVD o
CVD. Per la natura intrinseca del loro impiego tali complessi non devono di norma presentare
un‟elevata stabilità. Sono noti complessi di tantalio con leganti donatori all‟ossigeno (alcoli, acidi
carbossilici, etc.) o all‟azoto (ammine, piridine, etc.). In diversi casi, tuttavia, la loro
caratterizzazione appare limitata e molto raramente vengono riportati studi di stabilità.
76
Nelle prime fasi della ricerca condotta presso i nostri laboratori la scelta dei leganti da utilizzare
nella complessazione del metallo si è orientata verso donatori all‟ossigeno capaci di soddisfare il
forte carattere acido del metallo. Si sono condotte reazioni a partire da TaCl 5 e Ta(OEt)5 utilizzando
come leganti per il centro metallico ossiacidi, ossichetoni ecc. con risultati non ancora ben definiti.
L‟utilizzo del tropolone e della -thujaplicina invece ha portato alla sintesi e all‟isolamento di
derivati trisostituiti stabili e completamente caratterizzati. Questi complessi risultano stabili alla
reazione di idrolisi e non danno formazione di ossido di tantalio in acqua. La struttura di tali
composti è stata determinata tramite studi in soluzione ed allo stato solido. Per il complesso
[TaO(trp)3] è stata determinata la struttura tramite diffrazione di raggi X. La geometria di tale
composto è bipiramidale a base pentagonale e presenta tre molecole di tropolone coordinate al core
[Ta=O]3+.
Figura. Struttura del complesso [TaO(trp)3].
La formazione della specie oxo risulta molto interessante dal punto di vista dell‟applicazione in
radiodiagnostica. Sono infatti noti ed efficacemente impiegati in Medicina Nucleare numerosi
complessi contenenti l‟analogo gruppo [99mTc=O]3+. Complessi come quelli sopra riportati sono
quindi ottimi candidati per trasferire al Ta(V) quanto già noto per i complessi Tc(V).
Pur non essendo solubile in ambiente puramente acquoso, i composti ottenuti interessanti come
precursore metallici o come modello da cui sviluppare sintesi di radiofarmaci in ambiente organico.
Ciò risulta di estrema rilevanza, anche in virtù del fatto che, per i farmaci d‟urgenza tra i quali sono
annoverati anche i radiofarmaci, è consentita la somministrazione endovenosa di soluzioni
contenenti percentuali (fino ad un massimo del 10%) di solventi quali l‟etanolo.
Si è eseguita la sintesi di complessi di Ta(V) contenenti come legante la molecola deferiprone.Di
particolare interesse è risultato essere il complesso [TaO(def)3]. Tale composto di coordinazione
risulta solubile in acqua a pH fisiologico e risulta stabile nel tempo.
La struttura del complesso [TaO(def)3] è stata determinata allo stato solido tramite diffrazione di
raggi X. La geometria di tale composto è analoga a quella del complesso precedentemente descritto
ovvero quella bipiramidale a base pentagonale.
Si sono effettuati studi in soluzione, tramite spettroscopia 1H-NMR, che evidenziano come il
complesso sia in realtà flussionale a temperatura ambiente.
Analisi di spettroscopia infrarossa in soluzione di acqua pesante ed in matrice di KBr evidenziano
un‟analogia tra la struttura in soluzione ed allo stato solido del complesso.
Altri composti con leganti simili e con diverse derivatizzazioni sono in corso di studio per verificare
i parametri che influenzano la stabilità termodinamica.
2. Sezione farmaci inorganici in oncologia.
Parte 1
L‟attività svolta in questo anno dal nostro gruppo rientra all‟interno di un filone di ricerca dal titolo:
“Design, sintesi e caratterizzazione chimica e biologica in vitro ed in vivo di complessi di metalli di
77
transizione come innovativi agenti antitumorali”. Da diversi anni il nostro gruppo sintetizza e
studia dal punto di vista chimico e biologico nuovi complessi metallici con leganti
ditiocarbammici al fine di ottenere dei composti che abbiano un migliore indice chemioterapico in
termini di elevata capacità antineoplastica e ridotta tossicità rispetto ai farmaci attualmente in uso
clinico. Oltre alla continuazione degli studi sui composti di Au(I,III) e Ru(II,III), sono stati
sintetizzati nuovi complessi di Cu(II) che sono stati caratterizzati e sottoposti a test in vitro.
Complessi ditiocarbammici di Au(III)
L‟oro è stato scelto come candidato alternativo ai farmaci contenenti platino per la sintesi di
complessi ditiocarbammici con proprietà antineoplastiche, in quanto è noto il suo tradizionale uso
nel trattamento dell‟artrite reumatoide. Infatti, dato che l‟attività antiartritica dei farmaci a base di
oro, è dovuta alle loro ben note proprietà immunosoppressive ed antinfiammatorie, questo
stabilisce, in linea di principio, una connessione tra le due terapie. Inoltre, i complessi di Au(III)
possiedono caratteristiche chimiche simili a quelle dei complessi di Pt(II) già in uso clinico, avendo
entrambi la stessa configurazione elettronica d8 (isoelettronici) e la predisposizione a formare
complessi in geometria quadrato-planare (isostrutturali). Sorprendentemente, nonostante queste
similitudini in letteratura sono riportati relativamente pochi esempi (se confrontati all‟enorme
quantità di dati pubblicati sugli analoghi complessi di Pt(II)) di complessi di Au(III) dotati di
proprietà antitumorali. In questo caso la ricerca ha seguito tre vie: 1) sintesi di nuovi complessi
ditocarbammici di Au(III) con la pirrolidinaditiocarbammato; 2) valutazione su cellule HeLa
(provenienti da un carcinoma uterino umano) e 293T (cellule renali embrionali intrinsecamente
resistenti al cisplatino) dell‟attività apoptotica di complessi ditiocarbammici di Au(III) già
sintetizzati ([Au(ESDT)Br2] ed [Au(DMDT)Br2]), che, in studi precedenti, avevano evidenziato
risultati estremamente incoraggianti dal punto di vista dell‟attività antitumorale; 3) studio del
meccanismo di induzione di morte cellulare dei due complessi sopra citati attraverso la loro
influenza sul funzionamento della caspasi-3 e sulla formazione di ROS (specie radicaliche attive),
coinvolti in diverse fasi del meccanismo di morte cellulare e nelle alterazioni di alcune proteine
mitocondriali; 4) sintesi e studio dell‟attività antiproliferativa ed apoptotica di complessi di Au(III)
con metilsarcosina ditiocarbammato([Au(MSDT)X2] X= Cl, Br) su linee cellulari di leucemia
mieloide acuta.
Risultati:
1) I nuovi complessi sintetizzati con il legante pirrolidinaditiocarbammato sono stati
caratterizzati mediante spettroscopia NMR mono- e bidimensionale, FT-IR, analisi
termogravimetrica ed elementare. La scelta di tale legante si è basata su dati di letteratura che ne
riportano le proprietà antiossidanti, antivirali ed antinfiammatorie, e, in aggiunta, la capacità di
indurre o inibire il processo apoptotico in diverse linee cellulari tumorali.
La valutazione delle proprietà citotossiche in vitro e gli studi riguardanti l‟inibizione del
proteasoma, sono tuttora in corso presso il Dipartimento di Patologia del Barbara Ann Karmanos
Cancer Institute, Wayne State University di Detroit con il quale è stata instaurata una
collaborazione.
Il proteasoma è un grosso complesso macromolecolare adibito alla degradazione di molte proteine
mal costruite o non più utili al metabolismo cellulare, la cui azione è strettamente legata ai
meccanismi di apoptosi della cellula. In particolare la sua inibizione porta alla morte delle cellule
tumorali, risparmiando quelle sane, in molti tipi di colture cellulari, ed ha anche un effetto sulle
cellule tumorali umane resistenti a diversi farmaci.
2)-3) L‟attività apoptotica relativa ai complessi [Au(ESDT)Br2] ed [Au(DMDT)Br2] è stata
testata in base all‟attivazione delle caspasi-3, una classe di cistein-proteasi che, con meccanismo a
cascata, vengono attivate in numerosi modelli di apoptosi. Tale misura è stata rilevata attraverso la
percentuale di clivaggio del PARP (poli-ADP-ribosio-polimerasi) che viene operato dalle caspasi-3
attivate.
78
I risultati valutati sulle linee cellulari tumorali umane HeLa e 293T testando il cisplatino in
parallelo come riferimento, hanno evidenziato come i due complessi di oro inducano la morte
cellulare in entrambe le linee testate mentre il farmaco di riferimento risulta essere attivo solo sulle
cellule HeLa. Sulla base della valutazione della percentuale di clivaggio del PARP si è visto come
per i complessi di oro non si è registrata una corrispondenza diretta tra la morte cellulare e la
percentuale di clivaggio, su entrambe le linee cellulari. L‟attivazione della caspasi-3 pertanto, non
sembra essere l‟unico meccanismo che porta alla morte cellulare, ma tali composti di oro devono
esercitare la loro capacità citotossica attraverso un qualche meccanismo alternativo. Tale via di
morte cellulare è stata valutata attraverso la formazione di ROS utilizzando un test che prevede
l‟utilizzo della diidrorodamina (HDR), fluorocromo potenziale dipendente, che penetra nel
mitocondrio ed in presenza di radicali si ossida a rodamina divenendo così fluorescente e rilevabile
attraverso l‟uso del citofluorimetro. Nel caso del cisplatino, misure citofluorimetriche non hanno
evidenziato la formazione di ROS, mentre per quanto riguarda i due complessi di oro testati la
formazione di specie radicaliche è stata evidenziata dalla fluorescenza verde a livello mitocondriale
(collaborazione con l‟Istituto Oncologico Veneto). Si è svolto inoltre, uno studio sull‟interazione
con proteine mitocondriali e citosoliche e sul loro effetto sul potenziale di membrana, mettendo in
evidenza una notevole inibizione della tioredoxina reduttasi accompagnata da uno swelling della
membrana mitocondriale (Chemistry & Biology inviato per la pubblicazione). Tali studi sono stati
eseguiti in collaborazione con il Dipartimento di Chimica Biologica dell‟Università di Padova e con
l‟Istituto di Neuroscienze, Sezione di Biomembrane del CNR di Padova.
Per quanto riguarda lo studio dell‟inibizione del proteasoma esercitata dai complessi
[Au(ESDT)Br2], [Au(DMDT)Br2], [Au(ESDT)Cl2] ed [Au(DMDT)Cl2], eseguita su estratti
cellulari di tumore mammario, è stato evidenziato come tali derivati di oro siano in grado di inibirne
l‟attività già a concentrazioni nell‟ordine di 10 M.. Inoltre per il complesso [Au(DMDT)Br2] è
stato identificato il proteasoma come target primario sia in vitro che in vivo ed è stata riscontrata
una capacità di inibizione della crescita tumorale di circa il 50%., su tumori xerografici, (tumori
umani trapiantati su topi immunodepressi) dopo trattamento per 29 g con il composto in esame 34.
4) Gli studi condotti su leucemie mieloidi acute, in collaborazione con il Centro di
Riferimento Oncologico di Aviano, hanno messo in evidenza come i nostri composti inducano solo
modeste perturbazioni del ciclo cellulare permettendo di ipotizzare un meccanismo d‟azione diverso
da quello dei classici complessi di Pt(II).
Complessi ditiocarbammici di Ru(III)
In anni recenti è stato riscontrato che alcuni derivati di tale metallo possiedono interessanti attività
antitumorali e antimetastatiche, fornendo approcci innovativi nel campo della chimica farmaceutica.
La geometria ottaedrica dei complessi di Ru(III), diversa da quella quadrato-planare dei classici
complessi antitumorali di Pt(II), comporta un diverso meccanismo di azione rispetto alla lesione
diretta al DNA, meccanismo individuato per i composti di platino. Tale approccio, conosciuto come
“activation by reduction”, considera i complessi di Ru(III) come profarmaci i quali vengono attivati
da una riduzione in vivo a Ru(II), da parte del glutatione (GSH) o di altre proteine riducenti, per
poter coordinare più velocemente le biomolecole. Il primo esempio di “activation by reduction”
riscontrato per complessi di Ru(III) è stato il NAMI (trans-Na[RuCl4(DMSO)(Im)]; Ru(III), Im =
imidazolo) che ha mostrato incoraggianti proprietà antimetastatiche e che si presenta come una
molecola pseudoottaedrica con i quattro atomi di cloro in posizione equatoriale e con il DMSO e
l‟imidazolo in posizione assiale. Il NAMI è stato poi modificato in NAMI-A sostituendo il
controione Na+ con l‟ImH+; tale modifica ha apportato al complesso una maggiore stabilità in
soluzione, permettendogli di entrare nella seconda fase di sperimentazione clinica. Si ipotizza che la
selettività d‟azione del NAMI-A sia dovuta alla sua capacità di riconoscere una via metabolica delle
cellule metastatiche dei carcinomi sensibili non condivisa dalle altre cellule tumorali o dalle cellule
sane dell‟organismo, che sia in grado di modificare l‟espressione genica delle cellule tumorali
metastatiche silenziando i geni che sostengono la malignità e l‟immortalità neoplastica, e attivando i
geni che regolano la normale crescita e morte cellulare.
79
Sulla base di queste considerazioni, è stato proseguito lo studio di alcuni complessi
ditiocarbammici di Ru(III) a stechiometria metallo:legante 1:3 e 2:5 (Figura 1), sintetizzati,
caratterizzati e testati in vitro su diverse linee cellulari tumorali umane, sensibili e resistenti al
cisplatino (manuscript in preparation). Contrariamente al NAMI-A, tali composti si sono dimostrati
attivi direttamente sui tumori primari, in accordo con quanto riportato in letteratura per un composto
analogo di Ru(III) attualmente in sperimentazione clinica (trans-[HIn][RuCl4(Ind)2]; Ind =
indazolo).
R
S
N CR'
S
R= -CH3;
-CH2C(O)OCH3;
-CH2C(O)OC2H5;
-CH2C(O)OC(CH3)3
R' =-CH3
S
S
S
Ru
S
(a)
S
S
S S S
S
Ru
Ru
S
S
S S S
S
+
Cl-
(b)
Figura 1: Complessi ditiocarbammici di Ru(III)
Di particolare importanza è stato lo studio delle proprietà elettrochimiche dei complessi
[Ru(DMDT)3], [Ru(MSDT)3], [Ru(TSDT)3], [Ru2(DMDT)5]Cl, [Ru2(ESDT)5]Cl, [Ru2(TSDT)5]Cl
(DMDT = N,N-dimetilditiocarbammato; MSDT, ESDT, TSDT = metil-/etil-/terbutilsarcosinaditiocarbammato) in solventi quali DMSO e CH2Cl2 al fine di valutare se anche per
questi complessi, fosse possibile ipotizzare un meccanismo d‟attivazione per riduzione, analogo a
quello del NAMI-A. Inoltre ne è stata studiata la stabilità nel tempo in soluzione tramite
l'acquisizione di spettri UV-Vis in tre differenti solventi (DMSO, tampone fosfato e tampone
fosfato con la proteina sierica bovina (BSA)) raccogliendo le curve di assorbanza nell'arco di 24 h a
intervalli di tempo predefiniti, in quanto gli studi di stabilità, in diverse condizioni, vengono
normalmente eseguiti per poter poi passare ai test di attività biologica su linee cellulari tumorali.
Queste ultime, di fatto, vengono cresciute in terreno di coltura completo (TCC) contenente diversi
amminoacidi, vitamine, sali inorganici e zuccheri. Si è voluto quindi eseguire anche un preliminare
studio UV-Vis in TCC scegliendo il complesso [Ru(ESDT)3] come campione di riferimento per
valutarne una possibile interazione.
I dati raccolti, uniti all'analisi spettroscopica FT-IR dei precipitati di alcuni complessi e ad uno
studio CD per uno solo di essi preso come campione, hanno permesso di determinare la reattività in
soluzione dei composti studiati.
Risultati:
1) Il comportamento elettrochimico dei complessi di Ru(III) monomerici: [Ru(DMDT)3],
[Ru(MSDT)3], [Ru(TSDT)3] (valutato sia in DMSO che in CH2Cl2) evidenzia una riduzione
chimicamente e elettrochimicamente reversibile. Mediante elettrolisi è stato possibile accertare la
natura monoelettronica del processo, imputabile alla riduzione della coppia Ru(III)/Ru(II). Inoltre, i
potenziali redox misurati risultano essere sempre più negativi rispetto al potenziale di riduzione
della coppia GSH/GSSG (-0.44 V vs. SCE), portando così ad escludere l‟ipotesi di una attivazione
per riduzione analoga a quella ipotizzata per il NAMI-A.18 Tale evidenza sperimentale
supporterebbe quindi l‟ipotesi secondo cui la forma farmacologicamente attiva per questo tipo di
complessi è quella contenente il centro metallico nello stato di ossidazione +3. I complessi
dinucleari [Ru2(DMDT)5]Cl, [Ru2(ESDT)5]Cl, [Ru2(TSDT)5]Cl presentano invece due successivi
processi di riduzione elettrochimicamente quasi-reversibili; misure condotte mediante elettrolisi
evidenziano che tali riduzioni sono monoelettroniche, e che l‟attività redox è imputabile alla
sequenza Ru(III)Ru(III)/Ru(II)Ru(III)/Ru(II)Ru(II). Anche per questi derivati il potenziale redox
80
misurato è sempre più negativo rispetto al valore soglia di -0.44 V vs. SCE, portando a concludere
che, anche questi complessi non possono essere ridotti dal glutatione e di conseguenza la loro
attività citotossica è dovuta alla forma ossidata Ru(III)Ru(III).
2) Gli studi spettroscopici di stabilità dei complessi ditiocarbammici di Ru(III) nei diversi
ambienti hanno dimostrato che in DMSO, solvente organico nel quale i composti studiati sono
altamente solubili, i valori di assorbanza ottenuti rimangono invariati nelle 24 h per tutti i complessi
esaminati. Al contrario, in tampone fosfato si è osservata una certa instabilità in soluzione con
formazione di precipitato; le successive indagini FT-IR sui solidi, hanno rivelato che i leganti
ditiocarbammici permangono quasi totalmente inalterati per il complessi a stechiometria 1:3 ad
indicare che i precipitati sono dovuti solo ad una scarsa solubilità dei complessi, mentre per i
composti con rapporto metallo:legante 2:5, si è osservato un comportamento in tale solvente
completamente differente. Infatti, il corrispondente spettro FT-IR è caratterizzato dalla completa
sparizione delle bande dovute ai leganti e dalla comparsa di nuovi picchi che potrebbero essere
dovuti ad una completa idrolisi del complesso stesso. Nella successiva fase di studio la presenza
della BSA ha determinato per tutti i composti un andamento paragonabile a quello riscontrato in
DMSO. Si è ipotizzato pertanto l‟insorgere di una qualche interazione tra i complessi e la proteina,
in grado di limitare la reattività e quindi l‟instabilità dei complessi quando questi vengono disciolti
nel buffer salino di tampone fosfato.
Al fine di verificare tale ipotesi sono stati eseguite misure dicroiche a temperatura ambiente, ad una
concentrazione di BSA pari a 0.14 μM con un rapporto composto ditiocarbammico-proteina 1:1 per
il complesso [Ru(ESDT)3] preso come riferimento. Si è osservato che la presenza del complesso
induce una variazione, sebbene non particolarmente accentuata, della conformazione ad α-elica
della BSA. Questo modesto cambiamento ha permesso di avvalorare l'ipotesi dell‟instaurarsi di
deboli interazioni tipo legami a ponte idrogeno e/o di van der Waals tra il composto
ditiocarbammico e la proteina, ipotesi supportata in seguito dall‟osservazione dell'elevata stabilità
di tutti i complessi quando al medium di tampone fosfato viene aggiunta la BSA, rispetto al
comportamento instabile verificatosi nel solo tampone fosfato.
Come ultima analisi lo studio spettrofotometrico UV-Vis in terreno di coltura completo (TCC) per il
complesso [Ru(ESDT)3] ha fatto registrare degli spettri invariati nelle 48 h sottolineando la stabilità
del composto in TCC e avvalorando l‟ipotesi dell‟assenza di interazione tra la specie
ditiocarbammica ed i costituenti del medium utilizzato.
Complessi ditiocarbammici di Cu(II)
La sintesi dei nuovi complessi di rame è stata eseguita seguendo recenti studi che hanno dimostrato
che, tra i metalli di transizione, soltanto il rame è concausa nel processo di angiogenesi durante la
crescita tumorale. L‟angiogenesi è un fenomeno da cui dipende l‟accrescimento e la
metastatizzazione dei tumori. È noto infatti che i tumori sviluppandosi consumano molto ossigeno e
producono nuovi vasi sanguigni (neovascolarizzazioni) che tuttavia non sono in grado di soddisfare
la continua richiesta di ossigeno da parte delle cellule tumorali in crescita portando ad un‟ipossia
cellulare. Alti livelli di rame sono stati trovati in molti tipi di tumore umano come quello alla
prostata e al colon; inoltre sembra sia richiesta una quantità specifica e localizzata di rame affinché
l‟angiogenesi possa avvenire. È stato anche dimostrato che profarmaci a base organica, utilizzati nel
trattamento della malattia di Wilson (malattia ereditaria caratterizzata da un eccessivo accumulo di
rame in diversi organi) hanno un effetto anti-angiogenico su modelli di tumore murino. È stato poi
scoperto che l‟efficacia di questi farmaci non è dovuta solo al loro potere di rimuovere il rame, ma
anche alle proprietà citotossiche dei complessi di coordinazione che si formano tra essi e il rame
stesso. Alcuni di questi complessi infatti hanno una notevole capacità di inibire l‟azione del
proteasoma.
Sulla base di queste considerazioni sono stati sintetizzati e caratterizzati nuovi complessi
ditiocarbammici di Cu(II) scegliendo come donatori allo zolfo gli stessi leganti precedentemente
utilizzati per i complessi di oro e rutenio (MSDT, ESDT, TSDT). Sono stati inoltre testati due
composti di Cu(II) con leganti N,N dimetilditiocarbammato e la pirrolidinaditiocarbammato
81
(Figura 2) già esistenti in letteratura, ma di cui sono stati pubblicati soltanto alcuni studi
preliminari di attività biologica.
H3C
H3C
N C
S
S
S
Cu
C N
S
O H
2
R O C C
H3C
CH3
N C
CH3
N C
S
S
Cu
S
S
S
S
Cu
C N
S
C N
S
O
CH2 C O R
CH3
R = CH3-; CH3-CH2-; (CH3)3C-;
Figura 2. Complessi di Cu(II)
Oltre alla caratterizzazione tramite spettroscopia NMR mono e bidimensionale, FT-IR, analisi
elementare e termogravimetria, sono stati eseguiti i seguenti studi: 1) valutazione delle proprietà
elettrochimiche dei complessi in CH2Cl2; 2) studi preliminari di citotossicità in vitro su linee
cellulari tumorali umane (MTT test); 3) valutazione dei loro effetti sul ciclo cellulare.
Risultati:
1) Le indagini elettrochimiche eseguite sui complessi di Cu(II) mostrati in Figura 2 hanno
evidenziato sia l‟ossidazione a Cu(III) che la riduzione a Cu(I) del centro metallico originario; tali
processi decorrono in un range di potenziale probabilmente accessibile da parte di componenti
cellulari.
2) Gli studi di citotossicità in vitro (MTT test) eseguiti preliminarmente sulle due linee
cellulari tumorali umane sensibili al cisplatino 2008 (carcinoma ovarico) e A431 (carcinoma della
cervice uterina), e sulle corrispondenti linee cellulari rese resistenti, hanno evidenziato valori di IC50
(concentrazione di sostanza necessaria ad indurre il 50% di inibizione della crescita cellulare)
comparabili se non nettamente superiori a quelli del cisplatino.
3) Il ciclo cellulare è costituito da una serie di eventi successivi che coinvolgono diverse
molecole e che comprendono diversi meccanismi rigorosamente regolati a livello cellulare. Difetti
nella regolazione delle varie fasi del ciclo inducono la formazione di cellule tumorali; pertanto
riuscire a determinare con esattezza i meccanismi e le molecole coinvolte è di vitale importanza
nell‟ambito dell‟oncologia. La valutazione dell‟effetto dei complessi di Cu(II) sul ciclo cellulare, è
stata effettuata attraverso l‟uso del citofluorimetro, strumento in grado di analizzare le cellule
mentre passano, una alla volta, attraverso un raggio laser generato da un gas di Ar ionizzato
raffreddato ad aria che emette una luce blu a 488 nm. Lo spettro di emissione fluorescente che si
ottiene nel tempo, è una gaussiana la cui area è proporzionale al tempo che impiega la cellula ad
attraversare il raggio laser e di conseguenza, è proporzionale al diametro della cellula stessa.
Integrando i dati registrati per ogni singola cellula si ottengono i valori medi relativi all‟intera
popolazione. I risultati ottenuti hanno dimostrato che i complessi ditiocarbammici di Cu(II) sono in
grado di alterare il ciclo cellulare, manifestando effetti diversi nelle varie fasi del ciclo, con evidente
induzione di apoptosi su tutte le linee cellulari tumorali testate.
82
2. Sezione farmaci inorganici in oncologia.
Parte 2
I tiolati d‟oro(I) sono da tempo impiegati nel trattamento di alcune forme di artrite reumatoide e
sono studiati come potenziali farmaci per il trattamento di cancro, AIDS, malaria e asma bronchiale.
In particolare, notevole interesse è rivolto allo studio delle proprietà citotossiche e antitumorali
mostrate da composti d‟oro(I) di formula generale [Au(SR‟)(PR3)]. In quest‟ottica, ci siamo
occupati di studiare l‟attività antitumorale in vitro di Auranofin, un complesso di oro(I) a geometria
lineare con struttura P-Au-S .
I test di attività biologica, condotti su una coppia di linee cellulari di adenocarcinoma ovarico
opportunamente selezionate per la loro resistenza al cis-platino, hanno evidenziato un‟attività
notevolmente maggiore a quella del chemioterapico di riferimento, con valori di IC50 da venti a
novanta volte inferiori a quelle ottenute con cis-platino. In particolare, Auranofin è in grado di
ridurre considerevolmente la vitalità cellulare a concentrazioni dell‟ordine del nanomolare e già
dopo tre ore di trattamento, supportando così l‟ipotesi che agisca con meccanismo d‟azione diverso
da quello del cis-platino, che necessita di tempi e di concentrazioni maggiori per esplicare la sua
attività citotossica mediata dal danno al DNA. Per tempi di trattamento prolungati, inoltre, l‟attività
di Auranofin si dimostra maggiore nella variante resistente al cis-platino, e tale comportamento
correla perfettamente con i dati di up-take cellulare, dove si evidenzia infatti, un maggior accumulo
intracellulare nelle cellule resistenti per tali tempi di esposizione. I test clonogenici, inoltre,
mostrano come Auranofin sia in grado di ridurre l‟efficienza di clonazione di entrambe le linee
cellulari in maniera molto più efficace del cis-platino. Il calcolo del fattore di resistenza, risultato
circa quindici volte inferiore a quello del cis-platino, ci ha permesso di stabilire che Auranofin non
presenta resistenza crociata con il chemioterapico di riferimento.
Particolare attenzione è stata rivolta al chiarimento del meccanismo d‟azione e del target biologico
coinvolto, poiché poco si conosce del meccanismo di induzione di morte cellulare da parte di questi
composti, ed in collaborazione con il gruppo di ricerca del Dr. A. Bindoli del Dipartimento di
Scienze Biologiche dell‟Università di Padova, sono stati compiuti studi su enzimi isolati e su cellule
in coltura.
Recentemente è stato osservato che, a differenza dei composti di platino che, come risaputo,
agiscono principalmente a livello del DNA, Auranofin agisce come inibitore specifico ed
irreversibile della tioredossina reduttasi. Già a concentrazioni nanomolari Auranofin si è rivelato un
potente inibitore della tioredossina reduttasi, oltre che di altri selenoenzimi come la glutatione
perossidasi e la iodotironina deiodinasi, poiché interagisce con la selenocisteina presente nel sito
catalitico di questi enzimi. L‟enzima tioredossina reduttasi, esistente in diverse isoforme tra cui
quella
mitocondriale
e
quella
citosolica,
attraverso
il
sistema
tioredossina
reduttasi/tioredossina/tioredossina perossidasi svolge un ruolo fondamentale nella regolazione redox
cellulare mediata dai tioli e partecipa tramite la tioredossina perossidasi alla detossificazione
cellulare dagli idroperossidi, proteggendo la cellula dallo stress ossidativi.
Tale sistema enzimatico si è dimostrato, inoltre, di fondamentale importanza in eventi come il cellsignaling, l‟apoptosi e la proliferazione cellulare. Forme troncate di tioredossina reduttasi agiscono,
infatti, come fattori in grado di promuovere l‟apoptosi mentre di recente si è potuto apprendere che
una diminuzione dell‟espressione di tale enzima, dovuta a piccoli RNA interferenti (siRNA),
reversa completamente le caratteristiche morfologiche e funzionali caratteristiche di alcuni tipi di
cellule tumorali.
Perciò, è stato valutato il contenuto citosolico di citocromo c, noto fattore proapoptotico cellulare, il
cui rilascio dal compartimento mitocondriale determina la formazione dell‟apoptosoma e di
conseguenza l‟attivazione della via mitocondriale di morte cellulare programmata. Auranofin si è
dimostrato in grado di promuovere il rilascio di tale fattore proapoptotico in entrambe le linee
cellulari testate, al contrario del cis-platino che risulta invece inefficace nella variante resistente.
Studi paralleli di valutazione del grado di frammentazione del DNA nucleare confermano che, in
accordo coi risultati ottenuti dagli studi di rilascio di citocromo c, l‟azione apoptotica di Auranofin
83
risulta proporzionale alla concentrazione e che, nella variante resistente, il grado di apoptosi è
nettamente superiore a quello determinato dal cis-platino.
E‟ noto inoltre, che i mitocondri svolgono un ruolo di primaria importanza nell‟attivazione e nella
propagazione dell‟apoptosi, e che, mediante autossidazione a livello di siti specifici della catena
respiratoria, quali il complesso I (NADH deidrogenasi) e il complesso III (ubichinolo-citocromo c
reduttasi), siano coinvolti nella produzione di specie reattive dell‟ossigeno (ROS). In accordo con
ciò, il trattamento di entrambe le linee cellulari da noi impiegate con Auranofin porta ad un netto
incremento nella produzione basale di H2O2, che risulta fortemente accentuato in concomitante
presenza di antimicina (inibitore della catena respiratoria a livello del complesso III) ed Auranofin,
in special modo nella variante resistente al cis-platino. Per converso, il cis-platino risulta invece
molto meno efficiente nell‟incrementare la formazione di ROS.
Poiché Auranofin, alle concentrazioni impiegate nei nostri studi non esercita nessun effetto
inibitorio sulla catena respiratoria, è da ritenere che tale risultato sia attribuibile unicamente al
blocco di uno dei principali sistemi di rimozione degli idroperossidi cellulari, ovvero del sistema
della tioredossina .
Tale sistema enzimatico è stato dimostrato essere sovraespresso in numerosi tipi di cellule tumorali,
anche se la relazione esistente tra espressione di tioredossina reduttasi e sviluppo di cancro non è
ancora ben compreso.
Abbiamo, perciò, verificato se il sistema tioredossinico e quello della glutatione reduttasi, altro
sistema fondamentale per il mantenimento dell‟equilibrio redox cellulare, fossero sovraespressi
nella coppia di linee cellulari sensibile e resistente al cis-platino. Allo stesso tempo sono state
saggiate le attività tioredossina reduttasica e glutatione reduttasica in altre linee cellule tumorali
umane. I nostri risultati dimostrano chiaramente che l‟attività della tioredossina reduttasi, ed in
minor modo anche quella della glutatione reduttasi, risulta marcatamente aumentata in tutte le linee
cellulari considerate ed in particolare modo nella linee cellulari resistenti al cis-platino. Auranofin,
inoltre, nelle varie linee considerate, si dimostra in grado di inibire solamente la tioredossina
reduttasi, sottolineando con ciò la sua elevata selettività nei confronti di tale selenoenzima.
La sovraespressione di tale sistema enzimatico, riscontrata in tutte le linee cellulari considerate,
mette in evidenza una importante correlazione tra attività tioredossinica e sviluppo di tumore
legittimando lo studio di nuovi inibitori selettivi e irreversibili di tale enzima, quali potenziali
farmaci antitumorali meno tossici che vadano ad arricchire l'attuale arsenale terapeutico.
Sempre nell‟ambito delle indagini volte a promuovere lo sviluppo di nuovi composti “metal-based”
per superare la farmacoresistenza al cis-platino acquisita da varie cellule tumorali, recentemente il
nostro gruppo di ricerca si è indirizzato verso lo studio di complessi metallici di rame (in particolare
Cu(I)). Il crescente interesse per tali tipi di complessi scaturisce dal fatto che il rame è, a differenza
di altri metalli impiegati nella progettazione di molecole con proprietà citotossiche, un elemento
essenziale per gli esseri viventi in quanto fa parte di numerose attività enzimatiche che catalizzano
reazioni ossidoriduttive. E‟ stato anche notato come vari complessi di rame presentino attività
biologiche interessanti poiché, a seconda dei leganti utilizzati, possono essere in grado di catalizzare
la formazione di radicali oppure, viceversa, avere attività antiossidante. Il nostro gruppo di ricerca,
in collaborazione con il gruppo di ricerca del Prof. Carlo Santini dell‟Università di Camerino, si è
quindi occupato dell‟analisi delle proprietà biologiche di nuovi complessi idrosolubili di Cu(I)
caratterizzati dalla presenza di leganti scorpionati e di differenti specie di fosfine alchiliche ed
ariliche. Le indagini, preliminarmente condotte in vitro, hanno consentito di individuare alcuni
derivati dotati di attività citotossica superiore a quella del cisplatino . L‟attività di ricerca è stata
quindi orientata verso l‟approfondimento dello studio del meccanismo d‟azione di
[HC(CO2)(pzMe2)2]Cu[P(CH2OH)3]2, un complesso di Cu(I) di nuova sintesi, idrosolubile e
stabile in condizioni fisiologiche. Test di chemiosensibilità su varie coppie selezionate di cellule
tumorali umane sensibili e resistenti al cisplatino hanno rivelato che questo composto non mostra
resistenza crociata con il chemioterapico di riferimento suggerendo per esso un differente
meccanismo d‟azione antiproliferativa. Le indagini di citometria a flusso hanno evidenziato che
cellule tumorali trattate con [HC(CO2)(pzMe2)2]Cu[P(CH2OH)3]2 vanno incontro a morte
84
cellulare attraverso un meccanismo di tipo non apoptotico. In particolare, il chemiotrattamento
promuove nella popolazione cellulare un notevole aumento della complessità intracellulare come
anche delle dimensioni. Queste evidenti modifiche a livello morfologico delle cellule trattate sono
probabilmente da correlarsi alla capacità di [HC(CO2)(pzMe2)2]Cu[P(CH2OH)3]2 di indurre una
severa vacuolizzazione intracellulare. Indagini biochimiche concernenti l‟attivazione di specifici
trasduttori ed effettori implicati nel processo apoptotico sembrano indicare che il nuovo derivato di
Cu(I) attivi un meccanismo di morte cellulare identificabile come paraptosi. Tale caratteristica apre
nuove prospettive verso la ricerca di composti metal-based dotati di migliori proprietà
farmacocinetiche, in termini di aumentata solubilità e biodisponibilità, capaci di promuovere una
marcata azione antiproliferativa anche nei confronti di forme tumorali refrattarie o che hanno
acquisito resistenza ai farmaci a base di platino.
2. Nuovi farmaci inorganici in oncologia.
Parte 3.
Ruolo dei leganti ancillari nella interazione di complessi analoghi al cisplatino con nucleobasi
modello
Nell‟ambito dell‟indagine sul ruolo dei leganti ancillari in complessi analoghi al cisplatino nella
interazione con nucleobasi modello, sono state studiate le reazioni degli idrosso complessi cis[L2Pt( -OH)]2X2 (X- = NO3, ClO4; L= PMe3, PMe2Ph, PMePh2 e PPh3) con 1-metilcitosina (1MeCy).
N(4)H2
(3)N
O
N(1)
Me
1-MeCy
Risultati precedentemente acquisiti avevano mostrato che l‟idrosso complesso stabilizzato da PMe3,
in acqua e DMSO, è in grado di deprotonare il gruppo esociclico NH2 dell‟1-MeCy portando alla
formazione di un complesso dinucleare cis-[(PMe3)2Pt{1-MeCy(-H)N3,N4}]22+, dove la nucleobase
si coordina a ponte tra due centri metallici attraverso gli atomi N(3) e N(4). Lentamente ma
quantitativamente questo composto converte nel corrispondente trinucleare cis-[(PMe3)2Pt{1MeCy(-H)N3,N4}]33+ mantenendo lo stesso modo di coordinazione (Schema 1).
2+
L
L = PMe3
fast
Pt
L
N4
N4
N3
Pt
Pt
L
L
L
2+
H
O
L
N3
L
slow
+ 1-MeCy
Pt
O
H
L
- H2O
L
L
3+
Pt
N4
L
L= PMe2Ph
1
Pt
L
N4
N4
N3
Schema 1.
N3
N3
Pt L
L
Con la fosfina PMe2Ph, la reazione condotta in acqua o in acetonitrile, porta direttamente alla
formazione dell‟analoga specie trinucleare cis-[(PMe2Ph)2Pt{1-MeCy(-H)N3,N4}]33+ (1), la cui
struttura, recentemente pubblicata, è riportata in figura 1.
85
Figura 1. Struttura del catione cis-[(PMe2Ph)2Pt{1-MeCy(-H)}]33+ (1)
Abbiamo ora osservato che se la reazione di condensazione viene condotta in DMSO, è possibile
caratterizzare l‟intermedio dinucleare cis-[(PMe2Ph)2Pt{1-MeCy(-H)N3,N4}]22+, il quale converte
solo lentamente nella specie trinucleare 1, come si può vedere dalla figura 2, in cui è riportato lo
spettro 31P NMR della miscela di reazione. E‟ stata studiata la conversione dinucleare
trinucleare dimostrando che in DMSO-d6 la reazione, condotta a 50 °C, segue una cinetica del
primo ordine, con un tempo di dimezzamento di circa 5 ore.
Figura 2. 31P 1H NMR di cis-[(PMe2Ph)2Pt( -OH)]2(NO3)2 e 1-MeCy (rapporto molare 1:2) in
DMSO-d6, a temperatura ambiente: (a) subito dopo il mescolamento dei reagenti; (b) dopo 45 ore;
(c) dopo 3 settimane.
La reazione di condensazione, condotta in solventi clorurati, ha permesso la caratterizzazione di un
altro intermedio, la cui struttura è riportata nello schema 2, e risultato essere un isomero del
complesso trinucleare 1.
86
3+
PBII
PAII
Pt
PA
I
PB
I
N(3)
(4)N
N(4)
(3)N
N(3)
Pt
N(4)
Pt
III
PA
III
PB
Schema 2.
Tale struttura è stata proposta sulla base di una completa indagine NMR multinucleare (1H, 31P, 15N
e 195Pt) bidimensionale, la quale ha permesso di dimostrare che le tre nucleobasi a ponte sono
coordinate in modo non simmetrico, ovvero un atomo di platino è coordinato a due ioni citosinato,
entrambi attraverso N(3), un altro ne ha due coordinati attraverso N(4) e il terzo centro metallico
risulta coordinato sia all‟N(3) che all‟N(4). Il complesso, in soluzione, lentamente isomerizza nella
specie trinucleare simmetrica 1, come appare dallo spettro 31P NMR della miscela di reazione,
riprodotto in figura 3.
Figura 3. 31P 1H NMR di cis-[(PMe2Ph)2Pt( -OH)]2(NO3)2 e 1-MeCy (rapporto molare 1:2) in
CDCl3: (a) dopo 50 minuti; (b) dopo 24 ore
L‟intermedio è caratterizzato da 3 multipletti AB, di pari intensità relativa, a
–16.70 (1JPPt =
3230) e –20.70 (1JPPt = 3291) per la coppia PAI e PBI (2JPP = 24.8 Hz), a –19.79 (1JPPt = 3164 Hz) e
–20.05 (1JPPt = 3164 Hz) per la coppia PAII e PBII (2JPP = 25.8 Hz), e –23.40 (1JPPt = 3388 Hz) e –
25.70 (1JPPt = 3370 Hz) per la coppia PAIII e PBIII, (2JPP = 23.3 Hz), rispettivamente. Nello stesso
solvente, il complesso simmetrico 1 mostra un solo multipletto AB –17.83 (1JPPt = 3221 Hz) e –
21.11 (1JPPt = 3334 Hz) con 2JPP = 24.7 Hz.
In tutti i casi quindi, indipendentemente dal solvente di reazione, la specie termodinamicamente
stabile degli addotti platino-citosinato è il complesso trinucleare ciclico cis-[L2Pt{1-MeCy(H)N3N4}]33+ (L = PMe3 e PMe2Ph) riprodotto in Figura 1, per il derivato contenente PMe2Ph.
Una reattività completamente diversa si osserva nella reazione di 1-MeCy con l‟idrosso complesso
stabilizzato da PPh3. La reazione di condensazione, infatti, decorre a completezza solo quando il
rapporto platino/nucleobase è 1/2, portando alla formazione della specie mononucleare cis[(PPh3)2Pt{1-MeCy(-H)}(1-MeCy)]+, secondo l‟equazione:
cis-[(PPh3)2Pt( -OH)]22+ + 4 1-MeCy
2 cis-[(PPh3)2Pt 1-MeCy(-H) (1-MeCy)]+ + 2 H2O
Le due molecole di citosina, una neutra e una deprotonata, sono coordinate allo stesso centro
metallico attraverso gli atomi N(3) e N(4), rispettivamente. Questo modo di coordinazione della
nucleobase, che non ha precedenti in letteratura,3 era stato studiato l‟anno scorso attraverso tecniche
87
NMR multinucleari, ed è stato ora confermato mediante uno studio di diffrazione di raggi-X su
cristallo singolo. Il complesso, cis-[(PPh3)2Pt{1-MeCy(-H)}(1-MeCy)]NO3 H2O DMF, è stato
cristallizzato condensando vapori di Et2O su una soluzione di DMF.
Figura 4. Struttura del catione cis-[(PPh3)2Pt{1-MeCy(H)}(1-MeCy)]+
Il legame Pt-N(3), di 2.100(3) Å, è significativamente più lungo di Pt-N(4)a (2.061(4) Å). Come si
può notare, entrambe le basi sono coinvolte in un‟interazione - con uno degli anelli fenilici delle
trifenilfosfine con distanze tra i due centri di 3.347(3) e 3.653(3) Å. Il complesso è stabilizzato
inoltre da un legame idrogeno intramolecolare tra un protone del gruppo amminico NH2 della
nucleobase neutra e l‟N(3) dell‟altra nucleobase coordinata (distanza N N 2.843(6) Å).
L‟impaccamento cristallino (Figura 5) mostra come le singole molecole di complesso siano disposte
lungo un asse con molecole d‟acqua a ponte che interagiscono con i carbonili di due molecole
consecutive. I complessi appartenenti e due file diverse interagiscono attraverso legami ad idrogeno
tra l‟N(4)H e l‟O2a e attraverso interazioni - che coinvolgono gli anelli di due citosine adiacenti
N(3)-coordinate.
Figura 5. Crystal packing di
cis-[(PPh3)2Pt{1-MeCy(-H)}(1MeCy)]NO3 H2O DMF
L‟atomo di idrogeni in N4a agisce da donatore verso l‟O5 dello ione nitrato mentre la DMF non
mostra interazioni con nessun atomo.
Una reattività non completamente chiarita al momento, si osserva con l‟idrosso complesso
contenente la fosfina PMePh2. In questo caso, solo operando in CH3CN è stato possibile isolare un
composto di definita stechiometria, il quale tuttavia è risultato essere un prodotto di inserzione di
una molecola di sovente nel legame Pt-nucleobase.
88
UNITA’ DI RICERCA DI PALERMO
Direttore Scientifico: Prof. Lorenzo Pellerito
L'attività scientifica dell‟unità locale di Palermo, come conseguenza della sua composizione, si è
svolta nell‟ambito di quattro differenti tematiche di ricerca:
1. Sintesi, struttura allo stato solido ed in soluzione di complessi di ioni metallici
ed organometallici con molecole presenti nei sistemi biologici, e loro attività
citotossica in vitro ed in vivo.
2. Proprietà termodinamiche standard per la formazione di complessi.
3. Termodinamica di sistemi acquosi copolimero/tensioattivo convenzionale.
4. Indagini Archeometriche.
1. Sintesi, struttura allo stato solido ed in soluzione di complessi di ioni metallici ed
organometallici con molecole presenti nei sistemi biologici, e loro attività citotossica in vitro
ed in vivo.
Nell'ambito del progetto di ricerca proposto dall'unità di Palermo dal titolo "Nuovi complessi
metallici ed organometallici con potenziale attività antiproliferativa: metodologie integrate di
valutazione", l'attività di ricerca si è sviluppata lungo due diverse linee. La prima, preliminare al
progetto, ha riguardato la sintesi, le indagini configurazionali allo stato solido ed in soluzione, e
l'attività citotossica di nuovi complessi metallici ed organometallici nei confronti di organismi
modello. La seconda linea di ricerca ha riguardato l'interazione dei complessi metallici ed
organometallici con polipeptidi che simulassero sistemi proteici coinvolti nella crescita di cellule
tumorali onde poterne bloccare la proliferazione. In particolare, sono stati indagati effetti
istopatologici di soluzioni di TBTCl nei confronti di differenti organi di Liza saliens. Le variazioni
osservate sono dose e tempo dipendenti e indicano che TBTCl interferisce con i sistemi
immunodifensivi degli organi alterando i loro percorsi metabolici. Vari complessi di Ph 3Sn sono
stati ottenuti con leganti contenenti gruppi -OH o -COOH e atomi {N} donatori aromatici. I siti di
coordinazione dei leganti sono stati determinati con misure di spettroscopia FT-IR. I valori di
splitting di quadrupolo ricavati con spettroscopia Mössbauer in accordo con il formalismo a carica
puntiforme confermano la formazione di strutture molecolari tbp o Oh. Il complesso trifenilstagno3-fenolato-2(1H)-piridinone-O,O' è stato ottenuto sotto forma di cristallo singolo. Lo studio della
diffrazione di raggi X ha mostrato che {Sn} si trova in un intorno tbp. Alcuni nuovi complessi di
organostagno(IV) con MCln[meso-tetra(4-sulfonatofenil)porfinato], (R2Sn)2MCln[meso-tetra(4sulfonato fenilporfinato] e (R3Sn)4MCln[meso-tetra(4-sulfonatofenil)porfinato] [M=Fe(III), Mn(III):
n=1; R=Me, Bu, Ph; M = Sn(IV): n=2; R=Me; Bu] sono stati sintetizzati e la loro struttura allo stato
solido è stata studiata con spettroscopia FT-IR e Mössbauer nonché spettroscopia 1H e 13C NMR in
D2O. Per tutti i complessii dati FT-IR e Mössbauer suggeriscono un'intorno di tipo ottaedrico e
bipiramidale trigonale polimerico ottenuto nei diorganostagno derivati attraverso gruppi solfonati
chelanti o a ponte coordinanti nel piano quadrato e nei complessi di triorganostagno(IV) attraverso
l'uso di atomi di ossigeno dei gruppi solfonati a ponte in posizione assiale. Indagini 1H e 13C NMR
mostrano che le geometrie ipotizzate per lo stato solido si mantengono anche in soluzione.
È stata pubblicata una review che riassume la letteratura e i dati in essa disponibili in anni molto
recenti su organostagno derivati e sui composti loro derivati con molecole biologicamente attive.
Indagini termodinamiche (potentiometria e calorimetria) e spettroscopiche (1H NMR, 119Sn
Mössbauer) sono state condotte in soluzione acquosa per potere caratterizzare la interazione tra la
metà dimetilstagno(IV) e lo ione citrato. Sono state individuate ben sei specie {(CH3)2Sn(cit)-;
[(CH3)2Sn]2(cit)22-;
(CH3)2Sn(cit)H0;
(CH3)2Sn(cit)OH2-;
[(CH3)2Sn]2(cit)OH0;
e
[(CH3)2Sn]2(cit)(OH)2-}. Tutte le specie formate sono molto stabili ed il loro percento di formazione
89
molto alto. Per esempio a pH 7.5 e [(CH3)2Sn2+]=[citrate-]=10mM, il percento di formazione per le
specie [(CH3)2Sn]2(cit)(OH)2- e (CH3)2Sn(cit)OH2- raggiunge 65%. I parametri termodinamici
ottenuti mostrano che il maggior contributo e di natura entropica. I dati spettroscopici confermano il
modello di speciazione definito potenziometricamente e mostrano che la specie mononucleare
hanno una struttura eq-(CH3)2Tbp, mentre in [(CH3)2Sn]2(cit)(OH)2- vi sono due differenti siti di
Sn(IV), in particolare uno trans-(CH3)2ottaedrico ed uno cis-(CH3)2Tbp.
L'attività citotossica dei nuovi complessi è stata saggiata nei confronti di embrioni di ricci di mare. I
risultati ottenuti mostrano che i derivati n-dibutilico e trifenilico esercitano un'azione antimitotica
sui primi stadi dello sviluppo. Inoltre l‟azione di (n-Bu2Sn)3(clorina)2 si manifesta con necrosi
distruttiva dei blastomeri. Dopo esposizione a (Ph3Sn)3clorina viene avviata la morte programmata
delle cellule osservata al microscopio ottico con saggi morfologici. L'evento apoptotico allo stadio
embrionale di due celluleha rivelato:i) frammentazione del DNAcon reazione TUNEL; ii)
traslocazione della fosfatidilserina nella membrana (saggio con Annexina-V) e iii) distruzione del
citoplasma con formazione di vescicole e reazione TUNEL. I risultati evidenziano che
(Ph3Sn)3clorina è il composto più tossico poichè esercita immediatamente l'azione antimitotica e
provoca l'apoptosi allo stadio di due cellule. Dati di tossicità sull'acido 5-[(E)-2-(aril)-1-diazenil]-2idrossibenzoico e sull'acido 2-[(E)-2-(3-formil-4-idrossifenil)-1-diazenil]benzoico e sui loro
complessi con tri-n-butilstagno sono stati ottenuti usando i primi stadi dello sviluppo dell'embrione
di riccio di mare. I complessi sintetizzati hanno causato il blocco della mitosi e indotto elevata
mortalità degli embrioni nel riccio di mare. L'effetto citotossico di numerosi diorganostagno e
triorganostagno-meso-tetra(4-sulfonatofenil)porfirina è stato testato e solo due(Bu2Sn)2TPPS e
(Bu3Sn)4TPPS hanno mostrato attività citotossica su cellule A375 di melanoma umano. Per
esaminare il modo in cui (Bu2Sn)2TPPS e (Bu3Sn)4TPPS portano alla morte delle cellule A375sono
state condotte alcune indagini: analisi della frammentazione del DNA; frazione legata di Annexina
V e riassorbimento dello ioduro di propidio (PI)nonché analisi dell‟attivazione della caspasi via
Western blot. Le cellule A375 trattate presentano parecchi segni caratteristici di apoptosi. Sia
(Bu2Sn)2TPPS che (Bu3Sn)4TPPS attivano la caspasi-8 e la caspasi-9 portando all'attivazione della
caspasi-3. Quindi i due derivati porfirinici portano all'apoptosi delle cellule di melanoma umano
utilizzando sia il percorso di morte mediata via recettore sia il percorso apoptotico mitocondriale.
Complessi formatisi dalla reazione tra carbossimetilcellulosa (CMC) ed il catione [Me2Sn(IV)]2+
sono stati caratterizzati allo stato solido mediante spettroscopia FTIR e Mössbauer. I complessi
contengono CMC con pesi molecolari variabili e gradi di carbossilazione. I complessi sono stati
isolate sia da soluzioni acide che neutre con vari rapporti [Me2Sn(IV)]2+/CMC. Le bande di
vibrazione del legante sono state individuate da spettri FTIR pH-dipendenti. Nei complessi
organostagno(IV) ottenuti a pH≈2, il gruppo -COO- si comporta da legante monodentato, e negli
spettri FTIR è stata anche identificata la banda caratteristica di un gruppo –COO- protonato. La
banda allargata attribuibile ad OH può essere interpretata come soma dei contribute dei gruppi OH
del gruppo glucosidico e degli acquocomplessi misti di organostagno(IV). Nei complessi ottenuti a
pH≈7, la banda allargata –OH si assottiglia significativamente, ciò che probabilmente è dovuto alla
deprotonazione indotta dallo ione metallico con conseguente coordinazione agli atomi di ossigeno
gli OH alcolici. Nello stesso tempo I gruppi carbossilati –COO- sono anche coinvolti nella
coordinazione dello ione metallico originando un complicato reticolo di ponti inter ed
intramolecolari. I valori di splitting di quadrupolo (Δ) osservati in tutti i complessi con
spettroscopia Mössbauer sono caratteristici dei derivati di organostagno(IV).
Un confronto tra i Δ sperimentali e quelli calcolati in accordo con il formalismo a carica puntiforme
suggerisce la presenza nei complessi di geometrie sia ottaedriche che trigonali bipiramidali La
struttura del complesso ottenuto dipende dal pH della soluzione, mentre è insensibile ad altri
parametric quail massa molare, grado di carbossilazione del legante o rapporto metallo/legante nella
miscela di reazione.
Sono stati sintetizzati ed indagati quattro nuovi complessi ottenuti dalla reazione delle metà
diorganostagno(IV) (R=Me, Bu) e triorganostagno(IV) (R=Me, Ph) con il sale disodico
dell‟antibiotico fosfomicina. I complessi sono stati studiati con spettroscopia FT-IR, Mössbauer, e
90
mediante diffrazione di raggi X dei cristalli di bis(trimetilstagno)fosfomicina. Le indagini a raggi
X, supportate dalle indagini FT-IR e Mössbauer hanno mostrato che la coordinazione attorno allo
stagno è trigonale bipiramidale, anche se la struttura tetraedrica non può a priori essere esclusa nei
diorganostagno fosfomicina derivati. Il gruppo PO32- della fosfomicina coordina i centri Sn(IV)
dando origine ad reticolo polimerico.
L'interazione dei cationi dimetilstagno(IV) e trimetilstagno(IV) con il sale disodico della
fosfomicina è stato studiato anche in soluzione acquosa, a 25°C e forza ionica 0.1M (NaClO4) con
metodo potenziometrico e mediante titolazione spettrofotometrica (UV-vis). Le specie individuate
in soluzione, in queste condizioni, sono risultate essere Me2SnLH, Me2SnL, Me2SnL2, Me2SnLOH
e Me2SnL(OH)2 (L=fosfomicinato2-), e le specie Me3SnL, e Me3SnLOH. Sono state inoltre
calcolate le costanti di protonazione dello ione fosfomicinato2- e le costanti di formazione dei
complessi ottenuti[8]. Due nuovi complessi di diorganostagno(IV) con l'acido N-acetilneuraminico, con formula R2Sn(IV)NANA (R=Me, Bu) sono stati sintetizzati e caratterizzati con
spettroscopia 1H, 13C e 119Sn NMR, sia in soluzione di D2O che DMSO-d6.
I dati sperimentali in DMSO suggeriscono che il monosaccaride si comporti da chelante bidentate
via gli atomi O1 del carbossilato e O2 dell'alcossido vicinale, che, in D2O,può essere esteso in modo
dinamico ad un terzo sito di legame (l'atomo O8) della catena pendente. La coordinazione
sull'atomo di stagno è stata inoltre discussa non solo sulle basi dei dati NMR sperimentali ma anche
sulle basi di calcoli DFT.
Il ruolo biologico della N-acetilcisteina (NAC) su linee cellulari tumorali è analogo ed alcune volte
complementare a quello del glutatione. È risultato quindi interessante studiare come alcuni derivati
organometallici di questo legante possano modificare l'attività delle cellule di melanoma. Per tale
motivo sono stati sintetizzati i complessi Me2SnNAC, Bu2SnNAC, Ph2SnNAC caratterizzati allo
stato solido con spettroscopia FT-IR e Mössbauer. Dall'analisi degli spettri FT-IR è stato osservato
che la coordinazione al centro metallico avviene attraverso lo ione carbossilato l‟atomo di zolfo e
l‟atomo di ossigeno del gruppo CONH. La razionalizzazione dei parametri Mössbauer ha permesso
di ipotizzare una geometria locale dell'atomo di stagno di tipo trigonale bipiramidale distorta. Per
studiare l'attività citotossica del legante NAC e dei complessi è stata analizzata la vitalità cellulare
dopo 24 e 48h usando il saggio al trypan blue. Gli effetti del trattamento sono stati quantificati come
percentuale di morte cellulare usando come controllo cellule non trattate o cellule trattate solo con il
solvente o con il legante (NAC). È emerso che dei complessi saggiati, Bu2SnNAC e Ph2SnNAC
sono tossici alle concentrazioni utilizzate mentre Me2SnNAC non presenta attività.
Sono stati sintetizzati nuovi complessi del rutenio (III) con alcune molecole di interesse biologico
quali gli aminoacidi glicina (Gly) [Ru2(Gly)5(EtOH)2Cl3]Cl·H2O (I), alanina (Ala)
[Ru2(Ala)5(EtOH)2Cl3]Cl (II), istidina (His) [RuHis(EtOH)2Cl2] (III), N-Acetilcisteina (NAC)
[RuCl2(NAC)(EtOH)2]H (IV), ed infine l'acido glicosamminico (Glun) [RuCl2(Glun-N,O)2]H (V). I
complessi sono stati caratterizzati allo stato solido ed in soluzione mediante spettrometria di massa,
spettroscopia FT-IR ed NMR.
Sono stati condotti sui complessi di nuova sintesi (II) e (III) test biologici atti a valutare la loro
attività antitumorale. I risultati di tali indagini sono stati oggetto di comunicazioni a congressi.
2. Proprietà termodinamiche standard per la formazione di complessi.
L‟attività scientifica svolta nell‟anno 2006 è stata indirizzata allo studio degli equilibri chimici che
si istaurano tra i componenti delle acque naturali, al fine di avere un quadro generale della
speciazione. Sono stati indagati in particolare tre differenti sistemi, per l‟importanza biologica ed
ambientale che essi rivestono nell‟ambito dei sistemi naturali.
A. Sistema carbonato in soluzioni di sali di tetraalchilammonio.
L‟interesse per lo studio di questo sistema è stato particolarmente elevato da parte della comunità
scientifica, dal momento che lo studio dei parametri termodinamici relativi all‟equilibrio della CO2
91
negli ecosistemi permette di definire gli equilibri chimici e geochimici necessari per determinare
alcuni dei parametri fondamentali dei sistemi oceanici, quali l‟alcalinità e comprendere in ultima
analisi le relazioni che regolano lo scambio della CO2 tra atmosfera e acqua.
Il comportamento acido base del sistema carbonato nelle acque naturali, ed in particolare nelle
acque marine, è stato largamente studiato ed una gran quantità di lavori sono riportati in letteratura.
Alcuni dei lavori in letteratura riportano le costanti di protonazione in differenti mezzi ionici (NaCl,
KNO3, NaClO4), senza tuttavia riportare le possibili interazioni del carbonato con i cationi del
mezzo ionico di supporto. Altri riportano in dettaglio le costanti di protonazione in mezzi ionici
multicomponenti contenenti i cationi macrocostituenti le acque di mare (Na+, K+, Ca2+, Mg2+),
riportando altresì informazioni sulle costanti di complessazione tra questi cationi e gli ioni
carbonato e bicarbonato, permettendo attraverso l‟uso di opportuni modelli chimici di definire la
speciazione del carbonato in acqua di mare. Il presente studio ha avuto come scopo quello di
stabilire una “linea di base” per determinare le di protonazione in mezzi ionici non interagenti,
come i sali di tetraalchilammonio, di confrontarli con i dati disponibili in letteratura, al fine di
potere definire gli effetti del catione sulla protonazione del sistema CO2.
B. Policarbossilati di natura polielettrolitica
L‟interesse per lo studio della sostanza organica naturale ed in particolare per le sostanze umiche
nasce dalla considerazione che queste ultime giocano certamente un ruolo fondamentale nei cicli
biologici, sia per la loro funzione di substrato energetico, sia per la loro elevata capacità legante nei
confronti di ioni metallici. Esse sono macromolecole a stechiometria non ben definita, con una
struttura di base costituita da uno scheletro carbonioso con un elevato grado di aromaticità, nel
quale sono presenti un gran numero di gruppi funzionali differenti, fra i quali ricorrono
maggiormente gruppi carbossilici, gruppi fenolici, gruppi idrossilici ed in rapporto minore, gruppi
solforati, nitroso e nitro-gruppi. La sostanza umica si forma per condensazione di prodotti di
decomposizione, ottenuti per degradazione batterica di macromolecole provenienti dal mondo
vegetale (cellulosa e lignina). Dal punto di vista chimico, dunque, la sostanza umica presenta
caratteristiche e proprietà tipiche dei polielettroliti polifunzionali. Al fine di comprendere i
meccanismi di interazione degli acidi umici e più ingenerali dei polielettroliti naturali o biopolimeri
con i macro e microcomponenti delle acque naturali, sono stati presi in esame due sistemi chimici
polifunzionali, l‟acido poliacrilico e l‟acido polimetacrilico, ad alto peso molecolare che possono
essere considerati per la loro struttura chimica, molecole utili per la definizione di modelli
previsionali. Una volta noto il comportamento chimico di questi polielettroliti sintetici, sono passata
allo studio del comportamento chimico in soluzione di alcuni leganti polielettrolitici naturali, quali
un acido fulvico standard (Elliot Soil) fornito dalla International Humic Substances Society, ed un
acido alginico commerciale, che è un copolimero naturale di acido guluronico e mannuronico
contenuto nelle alghe brune, di cui rappresenta il principale costituente. Questi due leganti
rappresentano una classe di sostanze in grado di bioadsorbire inquinanti organici ed inorganici e
quindi di essere utilizzati nel trattamento di bonifica di siti inquinati
C. Poliammine di interesse biologico ed ambientale
Nell‟intervallo di pH dei fluidi naturali molte ammine si presentano in forme variamente protonate,
costituendo dunque siti acidi utili per l‟interazione con leganti (organici ed inorganici) dotati di
caratteristiche basiche. Nelle acque naturali i gruppi amminici sono presenti insieme con i gruppi
carbossilici nelle macromolecole o in frazioni di esse (acidi umici e fulvici) che si formano per
effetto dei processi di degradazione della materia vegetale. Nei fluidi biologici un‟importante classe
di poliammine è rappresentata dalle ammine biogeniche, che nelle cellule contribuiscono a
stabilizzare la struttura e l‟attività del t-RNA e del DNA, mentre gli acidi policarbossilici rivestono
un ruolo fondamentale in tutti quei processi biochimici, che contribuiscono a regolare ed a
mantenere le funzioni cellulari degli organismi viventi. La presenza contemporanea nei fluidi
92
naturali (acque naturali e fluidi biologici) di gruppi funzionali amminici NH4+ e di gruppi
funzionali carbossilici COO- permette di ipotizzare l‟instaurarsi di interazioni di tipo legante legante, che conducono alla formazione di specie complesse stabili. L‟interazione tra leganti
poliamminici e leganti policarbossilici è di natura elettrostatica, pertanto i parametri di formazione
dei complessi dipendono fortemente dalle cariche dei leganti coinvolti.
Lo studio ha riguardato l‟interazione tra
alcune poliammine, l‟etilendiammina (en), la
dietilentriammina (dien), la tetraetilenpentammina (tetren), la pentaetilenesammina (penten), la
spermidina (spdr) e la spermina (sper), la cadaverina (cdv) e la putrescina (ptr) e l‟ acido fulvico
standard (Elliot Soil) fornito dalla International Humic Substances Society, ed un acido alginico. I
risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli derivati da analoghe indagini compiute nelle
soluzioni contenenti le medesime ammine e l‟acido poliacrilico 2.0 kDa, al fine di valutare la forza
delle interazioni tra leganti polielettroliti naturali e sintetici.
D. Interazione di leganti polielettrolitici naturali e sintetici con cationi metallici
La tossicità dei metalli è ben nota così come le loro caratteristiche acide in una scala di acidità di
Lewis. Gli ioni metallici in soluzione acquosa danno principalmente al processo di idrolisi, tuttavia
la presenza di leganti organici ed inorganici di varia natura potrebbe competere con i processi
idrolitici portando alla formazione di complessi metallo-legante stabili e fornendo, dunque, un
quadro definito sulle percentuali di distribuzione del metallo sotto forma libera, idrolizzata e
complessata. Tra i composti metallici di grande interesse per il loro impatto ambientale, sono stati
presi in esame lo ione UO22+, Cd2+, Zn2+, Cu2+, mentre i leganti utilizzati sono l‟acido poliacrilico e
l‟acido fulvico. Ulteriori indagini potenziometriche con elettrodo e vetro e con elettrodi iono
specifici sono attualmente in corso, al fine di definire la speciazione di questi ioni metallici. Questo
studio ancora in fase preliminare ha già portato ad alcuni interessanti risultati scientifici che sono
stati oggetto di una comunicazione orale al Congresso della SCI.
3. Termodinamica di sistemi acquosi copolimero/tensioattivo convenzionale
Il lavoro di ricerca ha riguardato la caratterizzazione chimico-fisica di nuovi sistemi microstrutturati
costituiti da tensioattivi polimerici e da loro miscele con tensioattivi convenzionali per la
solubilizzazione di contaminanti idrofobi in ambiente acquoso. In particolare, sono stati studiati
copolimeri tri-blocchi costituiti da unità propilenossido (PO) ed etilenossido (EO). Detti copolimeri
sono indicati come EOaPObEOa (PEO-PPO-PEO) dove a e b sono, rispettivamente, il numero di
unità ripetitive etilenossido e propilenossido. I tensioattivi studiati sono stati scelti al fine di
analizzare: 1) l‟effetto dell‟architettura del copolimero mantenendo costante il rapporto tra il
numero di unità propilenossido ed etilenossido e il peso molecolare analizzando EO11PO16EO11
(L35) and PO8EO23PO8 (10R5); 2) la variazione del peso molecolare del copolimero mantenendo
costante il rapporto idrofobo/idrofilo studiando EO76PO29EO76 (F68), EO103PO39EO103 (F88) e
EO132PO50EO132 (F108); 3) l'influenza della testa polare del tensioattivo convenzionale analizzando
il decanoato di sodio (NaDec) e il deciltrimetilammonio bromuro (DeTAB). Quali prototipi di
contaminanti idrofobi di bacini acquiferi, sono stati studiati il diclorometano, l‟1,2-dicloroetano e
l‟1,3-dicloropropano.
In particolare, sono stati caratterizzati i copolimeri in acqua e in presenza di contaminanti mediante
spettroscopia di fluorescenza, dynamic light scattering (DLS) e small-angle neutron scattering
(SANS). Dagli studi DLS sono stati ottenuti i raggi idrodinamici degli aggregati di copolimeri a
blocchi (Rh,M) in funzione della temperatura (T) e della concentrazione (mP). L‟architettura del
copolimero non influenza Rh,M negli intervalli di T e mP analizzati. Ad una data T, l‟aumento del
peso molecolare provoca una diminuzione di Rh,M. La spettroscopia di fluorescenza è una tecnica
molto utile per evidenziare processi di aggregazione in quanto la sonda fluorescente (pirene) è
sensibile alla natura del suo intorno. Gli spettri di emissione consistono essenzialmente di 5 bande.
Il rapporto tra l‟intensità della prima e la terza banda vibrazionale (I1/I3) è fortemente dipendente
93
dalla polarità del mezzo essendo ~1.8 in ambienti acquosi e 1.2÷0.8 in ambienti idrofobi. Su
questa base, sono state misurate le quantità (I1/I3) in funzione di T e mP. I dati DLS e di
fluorescenza indicano che la variazione della temperatura influenza l‟aggregazione solo di F88 e
F108. La presenza di contaminanti, a concentrazioni vicine alla loro solubilità in acqua, non genera
variazioni nella distribuzione del raggio idrodinamico per L35 e 10R5. Quantità più elevate di
contaminante inducono la formazione di aggregati misti polidispersi per L35 e di networks per
10R5. Nel caso di F88 e F108, basse concentrazioni di contaminante portano alla formazione di
aggregati misti con valori di Rh,M più piccoli. I risultati DLS combinati con quelli ottenuti dalla
spettroscopia di fluorescenza hanno inoltre fornito informazioni utili sul sito di solubilizzazione del
contaminante. Studi preliminari SANS hanno corroborato i risultati DLS e di fluorescenza
dimostrando che la presenza di contaminante favorisce l‟aggregazione del copolimero a causa della
sua solubilizzazione in micella.
Sono state, inoltre, caratterizzate le miscele copolimero-tensioattivo in acqua e in presenza di
contaminanti a T = 298 K mediante misure di volume, solubilità, conducibilità e SANS. Le misure
termodinamiche e di scattering hanno confermato che: i) monomeri di NaDec e unimeri di
copolimero formano piccoli aggregati misti al contrario di DeTAB; ii) unimeri di copolimero sono
solubilizzati sia in micelle NaDec sia in quelle di DeTAB. La presenza del contaminante induce
l'aggregazione di F108 anche a bassi valori di mP. L'aggiunta di tensioattivo convenzionale
distrugge gli aggregati di F108 e, conseguentemente, il contaminante viene espulso nella fase
acquosa. Una volta che il copolimero è nello stato unimerico, esso forma aggregati copolimeromicella i quali solubilizzano il contaminante. Per quanto riguarda l'F68, la presenza del
contaminante non influenza il copolimero unimerico. Inoltre, in accordo ai dati di solubilità per il
sistema acquoso DeTAB-F68 la solubilizzazione del contaminante negli aggregati copolimeromicella risulta essere maggiore rispetto a quella nella micella di tensioattivo. Per le miscele NaDecF68 acquose avviene un processo addizionale di solubilizzazione nelle microstrutture copolimerotensioattivo formate nella regione pre-micellare. Sia i dati SANS sia quelli di conducibilità hanno
evidenziato che la solubilizzazione del contaminante nelle micelle miste non influenza
essenzialmente le proprietà strutturali degli aggregati.
4. Indagini Archeometriche
Una parte non trascurabile delle problematiche connesse alle indagini archeometriche riguarda la
ricerca di metodi di indagine poco o non invasivi e non distruttivi. Questo, come è noto, trova la
sua ragion d'essere nella fragilità e/o nel valore intrinseco, spesso elevato, dei campioni analizzati
(reperti archeologici di grande valore culturale, pezzi unici, materiali altamente degradati ecc..).
L'utilizzo delle tecniche tomografiche, già ampiamente sperimentate in campo diagnostico e
medico, permette l'analisi approfondita di campioni di interesse culturale senza intaccarne
l'integrità.
In particolare, la tomografia neutronica è stata scelta per la debole capacità di interazione del
neutrone con i nuclei atomici, per il suo basso coefficiente di assorbimento in relazione alle specie
ad alto numero atomico (p.e. i metalli), in genere completamente opachi ad altri tipi di tecniche
simili. L'uso della sonda neutronica presenta, infine, il peculiare vantaggio di permettere l'ispezione
di campioni di massa notevolmente più grande rispetto a quanto altre sonde permettono di fare.
Le tecniche di tomografia neutronica e diffrazione neutronica sono state applicate ad un gruppo di
reperti (di probabile epoca tardo romana) gentilmente forniti dalla Soprintendenza del Mare della
Regione Sicilia.
In figura 1 viene mostrata la ricostruzione tomografica di un reperto fortemente concrezionato
(presumibilmente un pugnale), la figura 2 rappresenta una sezione orizzontale dello stesso
campione dal quale si evince come il processo di corrosione abbia completamente rimosso la
parte metallica che componeva la lama lasciandone solo lo "stampo".
parte metallica che componeva la lama lasciandone solo lo "stampo".
94
Fig. 1: ricostruzione del pugnale ritrovato
presso il sito di “Scoglio Bottazza”
Fig. 2: Sezione orizzontale del pugnale
La figura 4 presenta una sezione orizzontale ottenuta dalla stessa tecnica applicata ad un frammento
di spada (figura 3) costituito dall'elsa e da quella che si pensava essere una frazione della lama;
proprio in quest'ultima è interessante notare come la lama vera e propria sia stata totalmente erosa
dal processo corrosivo mentre la struttura lamellare la cui natura legnosa è evidenziata in figura 5 probabilmente utilizzata per proteggere la lama durante il trasporto- si sia conservata pressoché
intatta.
Fig. 4: sezione orizzontale del frammento
della spada
Fig. 3: Elsa e frammento della lama
Fig. 5: particolare dell‟elemento legnoso posto a
protezione della lama
95
Le misure successive hanno riguardato un bullone (figura 6) infisso in un frammento legnoso
(probabilmente parte dello scafo di un relitto del XVI secolo).
L'analisi tomografica del bullone permette di evidenziare il processo di corrosione del bullone
all'interno della matrice legnosa.
Fig. 6: Ricostruzione Tomografica del
bullone infisso nella matrice legnosa
Fig. 7: Sezione orizzontale del bullone. Le parti
colorate in rosso evidenziano la corrosione
subita dal bullone metallico
Allo stesso reperto sono state applicate tecniche di diffrazione neutronica che permettono di
analizzare la natura e la composizione delle specie chimiche che compongono un campione. Tali
misure effettuate sul bullone (mostrate in tabella 1) mostrano come esso sia composto da una lega
di rame e stagno permettendo di attribuire ad esso natura bronzea.
Tabella 1: Composizione chimica del bullone
Cu (w %) S n (w %) Cu 2 O (w %)
8 7 .8 9 7 (1 ) 1 2 .1 0 3 (1 )
t r a cce
96
UNITA’ DI RICERCA DI PARMA
Direttore Scientifico: Prof.ssa Marisa Ferrari Belicchi
Sono di seguito descritti i risultati ottenuti nell‟anno 2006 relativamente alle varie tematiche di
ricerca.
Complessi di Cu(I) con nuovi leganti scorpionati N/S donatori. Biomimetica di Cupredossine.
Sintesi e caratterizzazione di nuovi leganti scorpionati N,S donatori chirali (L2 e L3, Schema 1).
Sintesi di complessi di Cu(I) come modelli per siti attivi di blue copper proteins. Caratterizzazione
allo stato solido (mediante diffrazione a raggi X) e in soluzione (1H DOSY NMR). Il
comportamento redox della coppia Cu(I)/Cu(II) è stato valutato tramite voltammetria ciclica.
S
S
O
N
N
N
O
N
N
N
S
L1
O
N
N
S
L2
N
S
L3
Schema 1
Le blue copper proteins sono proteine adibite al trasporto elettronico caratterizzate dalla presenza
di un atomo di rame in un intorno di coordinazione tetraedrico distorto di tipo N2SX‟(N = istidina,
S = cisteina, X‟ = tioetere/carbossilato). Lo scopo del lavoro ha riguardato la sintesi di leganti che
fossero in grado di riprodurre sia le caratteristiche strutturali del sito attivo delle proteine che le
proprietà funzionali di trasporto elettronico. La sintesi dei complessi è stata effettuata utilizzando il
composto di Cu(I), [Cu(CH3CN)]BF4 per poter effettuare una caratterizzazione mediante NMR. In
associazione al legante tridentato L1 (N2S), si sono utilizzati due leganti monodentati per indurre
una coordinazione tetraedrica al metallo. In particolare, con la trifenilfosfina (PPh3) si ottiene una
struttura mononucleare del complesso [(L1)CuPPh3]BF4 (Figura 1a) mentre con il
pentafluorotiofenolato di sodio (F5C6SNa) si ottiene una struttura polinucleare dovuta alla
disposizione a ponte dei gruppi tiolato di F5C6S- (Figura 1b).
A differenza di L1, i leganti tetradentati L2 e L3, portano all‟ottenimento di complessi con strutture
dinucleari, [(L2)Cu]2(BF4)2 (Figura 1c) e [(L3)Cu]2(BF4)2 (Figura 1d). La nuclearità di questi due
ultimi sistemi è stata studiata mediante 1H-PGSE NMR, che ha confermato la presenza di strutture
dinucleari in diversi solventi deuterati, acetonitrile-d3, acetone-d6 e diclorometano-d2.
La caratterizzazione elettrochimica dei complessi [(L2)Cu]2(BF4)2 e [(L3)Cu]2(BF4)2 è stata
effettuata mediante voltammetria ciclica in diclorometano a diverse velocità di scansione (10-500
mV sec). I complessi [(L2)Cu]2(BF4)2 e [(L3)Cu]2(BF4)2 presentano un comportamento quasireversibile del sistema Cu(II)/Cu(I) caratterizzato da un Ep di 70 mV ([(L3)Cu]2(BF4)2, 10
mV/sec, E1/2 = 0.50 V) e 340 mV ([(L2)Cu]2(BF4)2, 50 mV/sec).
97
a
b
c
d
Figura 1
Complessi di Cu(II) a potenziale attività antitumorale
In un precedente lavoro è stato riportato come il composto,
H
H Cl
[CuCl2(HL)] (HL= 4-amino-1,4-dihydro-3-(2-pyridyl)-5-thioxo-1,2,4N N
+
N
triazole, presenta una attività citotossica in vitro sulla linea tumorale
S
N
HT1080 (fibrosarcoma umano) di 12 M, mentre è cinque volte meno
attivo sulle cellule non trasformate (fibroblasti umani).
NH2
Cu
Per meglio comprendere il meccanismo di azione di [CuCl2HL], è Cl
[CuCl2HL]
Cl
stato effettuato uno studio morfologico sulle cellule tumorali trattate
(HT1080) ed è stata confrontata la tipologia di morte cellulare indotta
da [CuCl2HL] con quella indotta dal cisplatino. Lo studio morfologico ha evidenziato le differenze
riscontrate tra tale processo e i già noti eventi correlati all‟apoptosi. Si è dimostrato che il
trattamento con cisplatino determina l‟insorgenza dei tipici caratteri morfologici dell‟apoptosi, quali
condensazioni cromatinica, picnosi e frammentazione nucleare, coartazione cellulare, formazione di
blebs e distacco di corpi apoptotici mentre in cellule trattate con [CuCl2HL], si è riscontrato un
quadro morfologico con cellule che presentano grandi vacuoli citoplasmatici, Figura 2. La conferma
che [CuCl2HL] induce una morte cellulare non apoptotica si è ottenuta analizzando gli effetti del
trattamento sull‟attività delle caspasi-3. In cellule trattate con [CuCl2HL] non è stata rilevata un
aumento dell‟attività di questa caspasi, aumento riscontrato viceversa in seguito a trattamento con
cisplatino. Inoltre in cellule coincubate con entrambi i composti si è osservata un‟inibizione di circa
il 90% dell‟attività caspasica rispetto ai valori ottenuti da cellule trattate con il solo cisplatino. La
98
comparsa di vacuoli citoplasmatici è un carattere morfologico tipico del processo autofagico, ma
l‟assenza di lipidi e proteine all‟interno dei vacuoli e la mancanza di colocalizzazione degli stessi
con autofagolisosomi ha permesso di escludere che il processo di morte fosse imputabile
all‟autofagia. Questi dati sono stati confermati con un‟analisi in microscopia elettronica di cellule
HT1080 in diversi stadi del processo di morte indotto da [CuCl2HL], che ha evidenziato la
comparsa, nelle prime fasi del processo, di vescicole elettron-negative disperse nel citoplasma, che
progressivamente si fondono a creare grandi vacuoli che arrivano ad occupare l‟intero citoplasma.
La presenza di ribosomi su alcuni dei vacuoli osservati anche nelle fasi tardive e l‟avvicendarsi
della comparsa delle vescicole alla scomparsa della struttura tubulare del reticolo endoplasmatico
dimostra la loro origine reticolare. In seguito alla caratterizzazione morfologica l‟attenzione della
ricerca si è spostata sulla comprensione del meccanismo d‟azione di [CuCl2HL] preso come
paradigma di una nuova classe di potenziali farmaci antitumorali ad azione non pro-apoptotica.
Poiché il Cu(II) è un metallo redox attivo, una ipotesi del meccanismo di azione di [CuCl2HL] è
stata inizialmente associata all‟innesco di cicli redox, mediante reazioni “tipo Fenton”, in grado di
causare stress ossidativo. Al fine di vagliare questa ipotesi si è misurata la produzione di ROS in
presenza o in assenza di [CuCl2HL] con sonde fluorescenti, sia nel medium di coltura in assenza di
cellule, che all‟interno delle cellule. Entrambi gli esperimenti hanno rivelato che lo stress ossidativo
causato da [CuCl2HL] non è imputabile alla produzione di ROS. In alternativa, la capacità ossidante
di [CuCl2HL] è stata vagliata quantificando i livelli intracellulari del glutatione ridotto GSH e del
glutatione ossidato GSSG. Il trattamento con [CuCl2HL] 25 μM induce una variazione nel
contenuto cellulare di glutatione totale che risulta significativamente diminuito rispetto alle cellule
non trattate o trattate con 25 μM di rame inorganico (CuCl2). I valori del glutatione ossidato GSSG,
ottenuti dagli estratti cellulari utilizzati per la determinazione del glutatione totale, dimostrano un
incremento progressivo nella quantità di GSSG. L‟aumento della quota intracellulare di glutatione
ossidato in seguito a trattamento con [CuCl2HL] e non con cloruro di rame, suggerisce una risposta
ad uno specifico stress ossidativo che potrebbe rappresentare il meccanismo alla base dell‟effetto
citotossico del complesso. Parallelamente a questo studio si è testata l‟attività citotossica di
[CuCl2HL] su un pannello di 25 linee tumorali di derivazione umana. Per ogni linea cellulare è stata
costruita una curva dose risposta sia per [CuCl2HL] che per il cisplatino. Da questi dati risulta come
[CuCl2HL] non agisca indistintamente con uguale potenza su tutte le linee tumorali, ma che vi sia
un determinante nella sua selettività d‟azione. Infatti 10 linee cellulari su 25 rispondono a
[CuCl2HL] con una IC50 minore di 30 M. Al fine di valutare se il determinante della sensibilità a
[CuCl2HL] potesse essere in relazione con la capacità d‟accumulo intracellulare del complesso, è
stato effettuato un esperimento di quantificazione del rame intracellulare mediante spettroscopia ad
emissione atomica. L‟esperimento è stato effettuato su lisati di due linee tumorali sensibili a
[CuCl2HL] (HT1080 ed HeLa), su una linea tumorale insensibile (SW872) e su fibroblasti umani
normali anch‟essi insensibili. I risultati dimostrano che la capacità di accumulo di rame all‟interno
delle cellule è in relazione con la sensibilità delle stesse a [CuCl2HL].
Figura
15-Metallacrown-5 di Eu3+ e Cu2+ con (S)-α-alaninaidrossammato: sintesi e caratterizzazione
in soluzione ed allo stato solido
99
Gli acidi amminoidrossammici sono una classe particolare di idrossammati largamente impiegati
grazie alle loro peculiari capacità complessanti presentate nei confronti di numerosi metalli di
transizione. Per tale ragione gli acidi amminoidrossammici sono stati utilizzati in anni recenti per la
preparazione dei metallacrown, analoghi inorganici degli eteri corona (Schema 1).
M
N
M
O
O
O
O
O
N
O
M
N
M
O
O
O
O
N
N
M
Schema 2. Rappresentazione di un 15-crown-5 (15-C-5) e della cavità centrale di un 15metallacrown-5 (15-MC-5).
In presenza di Cu(II), i leganti β-amminoidrossammici danno origine a composti 12-metallacrown-4
caratterizzati da 4 atomi di Cu nello scheletro del metallacrown ed una cavità in cui viene accolto
un quinto ione Cu(II), mentre i leganti α-amminoidrossammici formano complessi 15metallacrown-5, ma esclusivamente in presenza di uno ione lantanide(III) (o Ca2+ o UO22+) che va
ad occupare la cavità centrale formata da 5 atomi di ossigeno dell‟unità idrossammica coordinati ai
5 Cu2+ periferici (Schema 2). I complessi 15-MC-5 sono stati recentemente studiati per valutarne
l‟impiego quali nuovi agenti di contrasto in MRI.
2+
n+
H 2N
O
Cu N
N O
NH 2 Cu
O
O
N
O
H 2N
O
Cu
O
O
Cu NH
2
Cu
O
N
O N
N
O
M
NH 2
Cu
N
O
O
Cu
O N
NH 2 Cu O
N Cu
O
O
NH 2
Cu O
NH 2
{Cu[Cu4L4H-4]}2+
NH 2
{M[Cu5L5H-5]}n+
(a)
(b)
Schema 3. Strutture dei 12-metallacrown-4 [Cu5L4H-4]2+ di acidi β-amminoidrossammici (a) e dei
15-metallacrown-5 [M‟Cu5L5H-5]2+ di acidi α-amminoidrossammici (b). M‟ = Ln3+, Ca2+, UO22+.
La ricerca svolta ha avuto come obiettivo quello di sperimentare una nuova strategia di sintesi
mediante gruppi protettori dell‟ acido α-alaninaidrossammico ((S)-α-Alaha, HL) utilizzato come
legante nel complesso 15-metallacrown-5 di Cu2+ ed Eu3+ {Eu[Cu5L5H-5](NO3)2(OH2)3}
(NO3)∙6H2O.
Il sistema Eu3+ / Cu2+ / (S)-α-Alaha è stato caratterizzato in soluzione acquosa mediante ESI-MS a
diversi pH fra 3.3 e 5.5 con lo scopo di confermare il modello di speciazione ipotizzato in seguito a
precedenti studi potenziometrici e spettrofotometrici. Difatti tali studi avevano messo in evidenza la
presenza in soluzione di due specie, corrispondenti al complesso 15-MC-5 di Eu3+ ({Eu[Cu5L5H3+
2+
5]} ) ed alla sua idrosso-specie {Eu[Cu5L5H-5](OH)} . Da precedenti studi non era stato possibile
dimostrare la coordinazione dello ione OH mediante spettrofotometria nel visibile poiché le due
specie 15-MC-5 risultano essere caratterizzate da valori molto simili sia di λmax che di ε, risultato
che suggerisce che lo ione OH- sia coordinato all‟Eu3+ centrale anziché ad uno dei Cu2+ periferici.
100
I dati ESI-MS ottenuti confermano la presenza in soluzione a pH>4.5 dell‟idrosso-complesso
{Eu[Cu5L5H-5](OH)}2+. La formazione dell‟idrosso-specie è stata quindi attribuita alla
dissociazione di un protone da una molecola d‟acqua coordinata allo ione Eu3+.
Studi di 1H NMR hanno messo in evidenza che i 15-MC-5 con Cu(II) contenenti lantanide(III) sono
caratterizzati da un unico set di risonanza per ogni gruppo funzionale del legante. Tale situazione
risulta essere indicativa della presenza di cinque leganti chimicamente equivalenti. I protoni α e β
del legante in questi metallacrown presentano marcati shift paramagnetici. La specie {Eu[Cu5L5H3+
è stata caratterizzata mediante esperimenti di inversion recovery i quali hanno messo in
5]}
evidenza che i protoni dei gruppi CH e CH3 possiedono tempi di rilassamento longitudinale T1
dell‟ordine dei 3 – 6 ms.
Poiché gli acidi α-amminoidrossammici utilizzati nelle sintesi dei metallacrown, sono chirali e
otticamente puri i loro complessi con Cu(II) risultano essere otticamente attivi. La specie
{Eu[Cu5L5H-5]}3+ è stata caratterizzata mediante spettroscopia di dicroismo circolare e il confronto
con dati riportati in letteratura per diversi sistemi Cu2+/legante ha permesso l‟attribuzione delle
bande CD a supporto delle ipotesi strutturali in soluzione.
L‟ analisi strutturale ai raggi X del complesso {Eu[Cu5L5H-5](NO3)2(OH2)3} (NO3)∙6H2O (Figura 3)
ha messo in evidenza che la struttura quasi planare del 15-metallacrown-5 è dovuta alla presenza di
cinque leganti (S)-α-Alaha deprotonati al gruppo amminico e idrossammico e cinque ioni Cu2+. Lo
ione Eu3+ si colloca all‟interno della cavità centrale del metallacrown ed è coordinato sul piano dai
cinque atomi di ossigeno del gruppo idrossimminico. La coordinazione dello ione centrale è
completata da due molecole d‟acqua e da uno ione nitrato. Lo ione nitrato è coordinato
monodentato allo ione centrale con una interazione addizionale lunga fra un secondo atomo di
ossigeno e uno ione Cu2+ periferico. Due ioni nitrato si trovano non coordinati e formano legami
idrogeno con un certo numero di molecole d‟acqua di cristallizzazione.
N25
O24
Cu5
N1
O25
O3
N24
N2
O6
Cu1
O14
Cu4
O13
O1
Eu
N11
O11
O23
O2w
Cu3
O1w
O12
N21
O15
C31
C11
Cu2
C21
O21
O7w
N23
N22
O22
Figura 3. Rappresentazione ORTEP del complesso {Eu[Cu5L5H-5](NO3)2(OH2)3}(NO3)·6H2O. Le
molecole d‟acqua di cristallizzazione sono state omesse.
Studi su complessi di tiosemicarbazoni e idrazoni di rame e nichelio e valutazione della loro
attività biologica in vitro.
E‟ proseguito lo studio su complessi di nichelio e rame con leganti tiosemicarbazonici SN ed
SNO chelanti, approfondendo i meccanismi di azione che sono alla base dell‟attività biologica
101
esercitata in particolare da due complessi : [Ni(R-tcitr)(S-tcitr)] (1) (Htcitr = tiosemicarbazone di
R-citronellale) (chelazione S,N) e [Cu(HL)(OH2)]Cl.H2O (2) (H2L = tiosemicarbazone del
piridossale) (chelazione S,N,O) che inducevano apoptosi sulla linea cellulare leucemica umana
U937 ad un valore IC50 pari rispettivamente a 14.4 M. e 13.3 M.. Ad integrazione della
valutazione del processo apoptotico mediante tecniche elettroforetiche basate sulla frammentazione
del DNA, è stata utilizzata una tecnica di citometria a flusso che ha permesso di distinguere,
attraverso colorazione con AnnexinV e ioduro di propidio (PI), le cellule in apoptosi precoce (PI
negative, Annexin positive) e tardiva (PI positive, Annexin positive).
[Ni(tcitr)2]
1
complesso
[Cu(HL)(OH2)]Cl.H2O (2)
[Ni(R-tcitr)(S-tcitr)] (1)
E‟ stata inoltre determinata la concentrazione dei metalli presenti nei liquidi intracellulari
mediante voltammetria di stripping anodico e catodico adsorbitivo . Dopo aver trattato le cellule
con i complessi alla concentrazione IC50 queste sono state lisate ed ultracentrifugate per separare la
frazione nucleare da quella citoplasmatica. La tecnica voltammetrica impiegata ha permesso di
rivelare una significativa percentuale di metallo sia a livello citoplasmatico che nucleare mettendo
così in evidenza che l'uptake del rame è più efficace di quello del nichel (10:1). La quantità di
metallo presente a livello nucleare è però più rilevante nel caso del nichel.
Successivamente sono stati eseguiti, per entrambi i complessi, saggi di induzione di apoptosi
nelle fasi precoci e tardive, anche sulla linea cellulare CEM di leucemia acuta linfoblastica alle
concentrazioni IC50 = 7.5 µM (complesso (1)) e IC50 = 12.4 µM (complesso (2)). Sempre con
tecniche di citometria a flusso è stato notato che già a partire dalle 4 ore di incubazione i due
composti inducono apoptosi anche su questa linea cellulare. Su entrambe le linee cellulari U937 e
CEM è stata poi determinata l‟attività caspasica: il complesso (1) attiva la caspasi-3 a partire dalle 8
ore dopo il trattamento, mentre il complesso (1) dopo 12 ore. Per capire se sia coinvolta la via
intrinseca o quella estrinseca del processo apoptotico, vie che entrambe convergono nell'attivazione
della caspasi 3, abbiamo valutato l‟alterazione dello stato fisiologico dei mitocondri Infatti,
studiando la variazione del potenziale mitocondriale (sulle due linee cellulari) è stato verificato che
entrambi i complessi provocano la depolarizzazione della membrana mitocondriale dopo
trattamento di 24 ore suggerendo così un‟attivazione della caspasi-3 per via intrinseca.
102
Variazione del potenziale mitocondriale (
Controllo
[Ni(R-tcitr)(S-tcitr)]
m)
[Cu(HL)(OH2)]Cl.H2O
U937
CEM
% cellule Bcl-2 positive
Si è poi valutato che entrambi i complessi modulano l'espressione di antagonisti apoptotici in
particolare delle proteine Bcl-2 che controllano l'integrità della membrana mitocondriale. Mediante
tecniche citofluorimetriche con l'utilizzo di un anticorpo monoclonale coniugato con fluoresceina
isotiocianato ed eseguendo una marcatura intracitoplasmatica è stato possibile notare che rispetto
alle cellule di controllo, dove l'espressione di Bcl-2 rimane alta, tra 80-90%, nelle cellule trattate
con entrambi i complessi l'espressione di questa proteina diminuisce all'aumentare dei tempi di
esposizione. Si può quindi concludere che la inibizione dell'espressione di Bcl-2 e la perdita
dell'integrità della membrana mitocondriale comportano il coinvolgimento della via intrinseca
mitocondriale.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
controllo
complesso 1
complesso 2
4h
8h
12h
24h
Dato che il complesso (1), sintetizzato partendo dalla forma R del citronellale, dall'analisi ai raggi X
è risultato essere [Ni(R-tcitr)(S-tcitr)], abbiamo sintetizzato anche un nuovo complesso impiegando
la forma commercialmente pura dell‟ (S)-citronellale ed abbiamo ottenuto il complesso [Ni(Stcitr)2] (1') la cui struttura è stata determinata mediante analisi diffrattometrica ai raggi X.
103
Il comportamento dei due complessi è stato confrontato riguardo l'inibizione della proliferazione,
l'induzione di apoptosi e l'influenza sul ciclo cellulare su entrambe le linee cellulari U937 e CEM.
Si è potuto notare che per il complesso (1') l'induzione di apoptosi si verifica allo stesso valore di
IC50 del complesso (1) però con percentuale di cellule apoptotiche superiore.
Considerando che uno degli stimoli che attivano la via intrinseca dell'apoptosi è il danno al DNA,
abbiamo utilizzato la versione alcalina del saggio COMET per valutare la capacità di danneggiare il
DNA. I due complessi di nichel non inducono effetti significativi su leucociti freschi in fase G0,
mentre causano significativi incrementi in linfociti stimolati e cellule proliferanti U937. La specie
complessa [Ni(S-tcitr)2] (1') contenente soltanto la forma S del legante Htcitr mostra una più alta
attività del complesso [Ni(R-tcitr)(S-tcitr)] (1). Da
dati preliminari si è osservato che i composti causano
una perturbazione del ciclo cellulare con accumulo di
cellule in fase G2M, confermando così che la via
20
Leuco
mitocondrio-caspasi dipendente è attivata in fase G2.
U937
linf stim
TI ( )
15
10
Danno al DNA, rilevato come incremento della %
di DNA nella coda (TI), indotto dal trattamento
(1h) con il complesso 1’ in diversi tipi cellulari
(leucociti, U937, linfociti stimolati).
5
0
0
2
4
6
8
10
In parallelo, sono stati fatti studi per valutare l‟ attività antibatterica e antifungina di idrazoni della
3-(N-metil)isatina, che liberi o complessati come leganti chelanti ONO tridentati sono stati già
oggetto di studio per correlazioni struttura-attività. In particolare sono stati sintetizzati e
caratterizzati complessi di due leganti il 2-tiofenecarbonil e l‟isonicotinoil idrazone della 3-(Nmetil)isatina (HL1 ed HL2 rispettivamente) ed alcuni loro complessi di Ni(II), Cu(II), Zn(II) e
Co(II). HL1, HL2 ed un complesso di nichelio [Ni(L1)2].2CHCl3 sono stati anche caratterizzati
mediante analisi ai raggi X.
In figura è mostrato il complesso neutro
[Ni(L1)2] in cui il legante planare ONO
Cl3
Cl2
tridentato è il tiofenecarbonilidrazone
C14
C15
della 3-(N-metil)isatina. L‟atomo di
Cl1
O2
N3
C7
nichelio si trova su un asse binario, la
C9
C8
C6
geometria di coordinazione è ottaedrica ed
Ni1
C3
N2
i due leganti sono correlati dall‟asse che
C2
C4
C1
passa per la bisettrice dell‟angolo O1-Ni1C5
N1
O1
O1‟. L‟attività antimicrobica in vitro di
C11
C10
tutti i composti è stata testata su parecchi
S1
batteri e funghi. HL1 ed i suoi complessi
C13
C12
mostrano una forte inibizione nella
crescita di Haemophilus influenzae e una
buona attività antibatterica nei confronti del Bacillus subtilis . I risultati dello screening
microbiologico mettono in evidenza che la maggiore attività antibatterica è esercitata dai derivati
del tiofene se confrontata con quella degli analoghi isonicotinici. Probabilmente il diverso
comportamento lipofilico dei due eterocicli , tiofene e piridina è implicato nei meccanismi
104
dell‟attività biologica. Infatti il valore di log P di tiofene (1.82) e piridina (0.62) danno una chiara
indicazione che il residuo tiofenico è dotato di una maggiore lipofilicità e perciò di una maggiore
possibilità di penetrare nei microrganismi.
105
106
UNITA’ DI RICERCA DI PAVIA
Direttore Scientifico: Prof. Luigi Casella
Gruppo di Ricerca del Prof. Luigi Casella
Studi su Metalloproteine e loro Modelli
Attività scientifica
Lo sviluppo degli studi di modificazione chimica della mioglobina umana in condizioni di
stress ossidativo e nitrativo ci ha portato ad esaminare gli effetti di queste condizioni
sull‟emoglobina umana. Questa è costituita, come è noto, dall‟assemblaggio di quattro catene
polipeptidiche simili a quella della mioglobina in una struttura tetramerica 2 2. Per valutare le
potenzialità catalitiche dell‟emoglobina nei confronti delle specie che si accumulano in
conseguenza dello stress ossidativo e nitrativo, cioè perossido di idrogeno e nitrito, si sono
innanzitutto condotti degli studi di attività pseudo-perossidasica verso substrati fenolici correlati
alla tirosina. Queste indagini hanno dimostrato che l‟emoglobina ha attività catalitica anche
superiore alla mioglobina (anche tenendo conto della sua natura tetramerica) e in particolare questa
attività risulta significativamente più elevata per le singole subunità. Forse ancora più interessante è
stato il risultato che la capacità nitrante dell‟emoglobina (in presenza di perossido di idrogeno e
nitrito) appare circa cinque volte superiore alla semplice attività pseudo-perossidasica (in presenza
di solo perossido) sullo stesso substrato fenolico. In assenza di substrati esterni la proteina rivolge la
sua attività ossidante e nitrante verso i residui amminoacidici endogeni. In particolare il trattamento
della proteina con perossido di idrogeno e nitrito porta alla nitrazione delle tirosine Yα24, Yα42,
Yβ130 e Yβ145, del gruppo eme (in una delle posizioni viniliche) e alla conversione dei residui di
cisteina Cα104, Cβ93 and Cβ112 nei corrispondenti derivati solfinici. Per l‟individuazione dei
residui modificati e della natura di tale modifica si è ricorso alla digestione della proteina dopo la
reazione con tripsina e alla successiva analisi con HPLC-ESI-MS/MS dei frammenti triptici. Il
risultato forse più interessante è stato che il trattamento ossidativo dell‟emoglobina porta anche alla
formazione di un dimero covalente tra le subunità e , che si stabilisce tramite una reazione di
accoppiamento radicalico intramolecolare tra i residui Yα140 and Yβ145.
Nel campo dei rame enzimi è stato completato lo studio sull‟attività della laccasi da pianta
Rhus vernicifera in presenza di derivati fenolici. Questi possono agire da inibitori o da attivatori a
seconda della natura dei sostituenti presenti sull‟anello fenolico. Quando tali sostituenti sono
semplici atomi di alogeno si ha un moderato aumento dell‟attività, se invece il fenolo contiene un
gruppo carbossilico acido si ha inibizione. Questi processi dipendono dal fatto che la cavità
enzimatica è piuttosto ampia e può contenere simultaneamente due molecole di substrato o
inibitore/attivatore fenolico. Tramite questo legame simultaneo i fenoli possono modificare
l‟affinità dei substrati per l‟enzima e questa può essere sia aumentata, tramite interazioni di stacking
aromatico tra substrato e fenolo, o diminuita, probabilmente per protonazione di un intermedio
enzimatico da parte del gruppo acido presente sul fenolo.
Gruppo di Ricerca del Prof. Luigi Fabbrizzi
Attività scientifica
L‟attività di ricerca del progetto è stata rivolta (i) alla sintesi di nuovi recettori e sensori per
piccole molecole e anioni e (ii) allo studio delle interazioni tra recettore e substrato.
107
(i) Nuovi recettori e sensori
Quale sensore colorimetrico per l‟imidazolo stato sintetizzato un macrociclo contenente due
coppie di compartimenti polidentati capaci di legare ioni Cu(II) e comprendente due siti donatori
diammino-diammidici (DADA), tetradentati, e due siti piridino-diamminici (PDA), tridentati, che
condividono i quattro gruppi amminici secondari. Titolazioni spettrofotometriche hanno permesso
di accertare che, nell‟intervallo di pH tra 3 e 9.5, il macrociclo lega due ioni rame, ospitandoli nei
siti PDA come indicato dal colore blu della soluzione: innalzando il pH fino a 10.5 vengono
deprotonati i quattro gruppi ammidici e ha luogo una doppia traslocazione dei cationi verso i siti
DADA. La soluzione assume il colore rosa-porpora tipico dello ione Cu(II) tetracoordinato con
geometria planare quadrata da un sistema DADA doppiamente deprotonato. Gli ioni rame, quando
sono contenuti nei siti PDA, sono legati a tre soli atomi donatori del macrociclo e completano la
sfera di coordinazione con molecole di acqua, facilmente sostituibili. In effetti, titolando soluzioni
del complesso, tamponate a pH 7, con vari anioni bidentati, come dicarbossilati, fosfati e
imidazolato, si è osservata la formazione di addotti 1:1, con l‟anione disposto a ponte tra i due ioni
rame. Nel caso dell‟imidazolato, l‟addotto è stabile in un ampio intervallo di pH, fino a oltre pH 10,
e la traslocazione dei cationi verso i compartimenti DADA viene ritardata: si è poi osservato che
nell‟intervallo 10.0 < pH < 10.4 coesistono sia la specie con gli ioni rame nei compartimenti DADA
che quella con l‟imidazolato a ponte tra i due cationi contenuti nei siti PDA. Ci si attende pertanto
che, trattando con imidazolo una soluzione rosa di questo complesso, tamponata a pH 10.2, abbia
luogo la traslocazione dei cationi dai compartimenti DADA verso i compartimenti PDA: studi
spettrofotometrici hanno confermato che il fenomeno si verifica, sia pure con una certa lentezza, e
che la traslocazione dei cationi è indotta dalla formazione dell‟addotto con l‟imidazolo. Titolazioni
di una soluzione del complesso a pH 10.2 con altri leganti bidentati hanno dimostrato che la
traslocazione (e il conseguente viraggio della soluzione da rosa a blu) è indotta solo dall‟imidazolo
o da molecole che contengano questo frammento come istidina e istamina, anche in presenza di
massicce quantità di potenziali interferenti.
Sono stati preparati leganti a gabbia capaci di formare complessi binucleari in cui il legante
impegna solo una parte delle posizioni dei centri metallici. Questi complessi possono essere
impiegati per la preparazione di sensori fluorimetrici o colorimetrici per anioni basati sul principio
del chemosensing ensemble. Secondo questo approccio, il recettore forma un addotto con un
indicatore, colorimetrico o fluorimetrico, la cui stabilità è inferiore a quella dell‟addotto con il
substrato. L‟interazione tra recettore e indicatore spenge la fluorescenza di quest‟ultimo, o ne
modifica drasticamente il colore rispetto alla forma libera se si tratta di indicatore colorimetrico: al
momento del riconoscimento il substrato rimpiazza sul recettore l‟indicatore, liberandolo nella
soluzione e ripristinandone la fluorescenza o variandone il colore rispetto alla forma legata. In
particolare, il complesso di un legante a gabbia ottamminico contenente due ioni Cu(II) è stato
impiegato per realizzare un sensore fluorimetrico per il glutammato: in questo sistema, i gruppi
amminici a tripode presenti alle estremità della gabbia coordinano gli ioni rame secondo una
geometria a bipiramide trigonale, in cui una delle posizioni apicali è libera per l‟interazione con un
ulteriore legante (solvente o gruppo anionico portato dall‟indicatore o dal substrato). Trattando una
soluzione dell‟indicatore fluorescente rodamina, tamponata a pH 7, con una soluzione del
complesso dimetallico si osserva la scomparsa della fluorescenza arancio dell‟indicatore, in
conseguenza della formazione di un addotto 1:1 tra questo e il complesso, tenuto insieme
dall‟interazione coordinativa tra i gruppi carbossilato dell‟indicatore con le posizioni apicali degli
ioni rame. L‟aggiunta di glutammato alla soluzione contenente l‟addotto complesso-rodamina
tamponata a pH 7 provoca il ripristino della fluorescenza dell‟indicatore in seguito alla sua
espulsione dalla gabbia, i cui ioni rame interagiscono più fortemente con i gruppi carbossilato del
glutammato. Titolazioni in presenza di potenziali interferenti, quali altri aminoacidi o acidi
dicarbossilici, hanno dimostrato la selettività del recettore verso il glutammato, da ascriversi a una
ottimale corrispondenza della distanza tra i gruppi carbossilato del glutammato con la distanza tra
gli ioni rame all‟interno della gabbia. Impiegando un legante con una cavità di dimensioni maggiori
108
è stato poi realizzato un sensore fluorimetrico per la determinazione di anioni dicarbossilato in
acqua.
Il principio del chemosensing ensemble è anche stato applicato a un recettore a tripode,
contenente tre subunità Cu(II)cyclam, che è in grado di riconoscere specificamente il citrato in
acqua, grazie all‟interazione delle sue tre cariche negative con i tre centri metallici
coordinativamente insaturi.
Un derivato dell‟urea, legata a due subunità naftaleneimmide, è stato impiegato quale
sensore per la determinazione sia colorimetrica che fluorimetrica di carbossilati in DMSO. In
presenza di ioni carbossilato, il recettore dà luogo alla deprotonazione di uno dei frammenti NH:
alla deprotonazione sono associati un vistoso cambiamento di colore da giallo a rosso e lo
spegnimento della fluorescenza della naftaleneimmide, senza che si riscontri competizione da parte
di altri anioni (fosfato, nitrato, solfato, alogenuri). Queste caratteristiche del recettore possono
essere sfruttate per la determinazione specifica dell‟acido colico anche in presenza di altri acidi
biliari.
Un secondo tipo di recettore a tripode, in grado di stabilire interazioni particolarmente forti
con il substrato grazie alla capacità di offrire ben 6 legami a idrogeno, è stato impiegato per il
riconoscimento di anioni alogenuro e ossigenati in MeCN, dimostrandosi specifico per il cloruro in
presenza di fluoruro e bromuro.
Un recettore chirale per anioni è stato ottenuto partendo dal cicloesano 1,2-disostituito:
questo gruppo esiste nelle forme enantiomere R,R e S,S ed è stato unito a due subunità 4nitrofenilurea, per dare un recettore capace di interagire con vari tipi di anioni, quali carbossilati e
fosfati. Il riconoscimento viene segnalato dal cambiamento delle caratteristiche spettrali del
cromoforo nitrobenzene in presenza di interazione con gli anioni. In particolare, la forma S,S del
recettore si è dimostrata specifica per l‟anione D-2,3-glicerofosfato, la cui costante di associazione e
doppia rispetto a quella della forma R,R.
(ii) Studio delle interazioni tra recettore e substrato
Altri studi hanno riguardato la natura delle interazioni tra frammenti di vario tipo
impiegabili quali recettori e i rispettivi substrati. In particolare, è stata studiata l‟interazione tra due
recettori, uno dei quali contenente un frammento ammidico, e alcuni anioni in DMSO. I più basici
tra questi (acetato, fluoruro, diidrogenofosfato) inducono la deprotonazione del recettore contenente
il frammento ammidico, mentre i meno basici (cloruro, bromuro, nitrato) danno luogo alla
formazione di legami a idrogeno di forza decrescente. Il secondo recettore, meno acido, viene
deprotonato soltanto da acetato e fluoruro e forma legami a idrogeno con il diidrogenofosfato. Sulla
base dei risultati ottenuti è stato proposto un criterio empirico per discriminare tra neutralizzazione
e legame a idrogeno, basato sull‟impiego di tecniche spettroscopiche UV-Vis e NMR.
Un ulteriore studio ha riguardato il comportamento della 1,3-bis(4-nitrofenil)urea, che
interagisce formando legami a idrogeno con una varietà di ossoanioni in soluzione di MeCN a dare
addotti 1:1 di stabilità decrescente con la basicità dell‟anione. La natura dell‟interazione a ponte di
idrogeno tra urea e acetato è stata dimostrata dall‟isolamento in forma cristallina dell‟addotto sotto
forma del sale di tetrabutilammonio e dalla determinazione della struttura molecolare. Si è inoltre
osservato che il fluoruro forma inizialmente legami a idrogeno nell‟addotto 1:1, mentre l‟aggiunta
di un secondo equivalente porta alla deprotonazione dell‟urea con formazione di HF2-.
109
110
UNITA’ DI RICERCA DEL PIEMONTE ORIENTALE
Direttore Scientifico: Prof. Domenico Osella
L‟attività di ricerca si inquadra nelle sezioni tematiche del Consorzio:
“a” Diagnostici innovativi in oncologia e malattie cardiovascolari;
”d” Biosensori e biostrumentazione;
“e” Nuovi farmaci inorganici in oncologia.
Agenti di contrasto per MRI (tematica a).
a) Sonde paramagnetiche ad alta efficienza per diagnostica di risonanza magnetica nucleare.
La risonanza magnetica nucleare diagnostica (MRI, Magnetic Resonance Imaging) impiega da circa
20 anni una serie di complessi di Gd(III) come agenti di contrasto. La ricerca in questo ambito è
stata indirizzata all‟elaborazione di agenti di contrasto sempre più efficienti. La conoscenza delle
relazioni tra la struttura e la dinamica dei complessi di ioni lantanoidei hanno permesso di giungere
alla progettazione di leganti poliamminici funzionalizzati in grado di combinare un‟elevata stabilità
al corrispondente complesso e contemporaneamente di indurre proprietà ottimali per l‟impiego
come agente di contrasto. Di particolare interesse è l‟obiettivo di ottenere agenti di contrasto che
agiscano come sonda nei confronti di parametri chimico-fisici legati a specifiche situazioni
fisiologiche o patologiche. Sono stati perciò ricapitolati i progressi svolti negli ultimi anni da questa
unità di ricerca, in collaborazione con gruppi nazionali e internazionali, sottolineando la messa a
punto di agenti di contrasto angiografici (principalmente basati sull‟interazione con l‟albumina del
siero), di agenti per il labeling cellulare ed infine lo sviluppo di una nuova classe di agenti di
contrasto basati sulle proprietà di shift di complessi di ioni lantanoidei alternativi allo ione Gd3+.
Nello stesso ambito, sono da riportare inoltre i progressi ottenuti nella sintesi di nuovi agenti di
contrasto per MRI. In particolare:
a prosecuzione dell‟attività svolta nell‟anno precedente, sono stati sintetizzati vari derivati
del legante base AAZTA (acido 6-ammino-6-metilperidro-1,4-diazepin-N,N‟,N”,N”-tetraacetico).
AAZTA forma un complesso con lo ione Gd3+ sufficientemente stabile per garantire l‟impiego in
vivo e caratterizzato dalla buona relassività di base e dall‟elevata velocità di scambio delle due
molecole di acqua coordinate. Quest‟ultima proprietà è particolarmente favorevole per lo sviluppo
di agenti di contrasto ad alta rilassività in particolare mediante l‟aumento del tempo di correlazione
rotazionale (es. mediante interazione non covalente con macromolecole biologiche). Sono stati
preparati nuovi leganti AAZTA-like contenenti residui funzionali atti ad interagire non
covalentemente con macromolecole endogene o esogene. Le misure rilassometriche sui
corrispondenti complessi paramagnetici hanno evidenziato in particolare per un derivato lipofilo
(EptadecilAAZTA) la possibilità, prevista dalla teoria, di avvicinarsi a valori di relassività di 100
mM-1s-1, ottenendo il valore più elevato finora registrato per complessi di questo tipo. Sono stati
inoltre preparati altri derivati lipofili, dotati di due catene alifatiche, al fine di inglobare i complessi
paramagnetici all‟interno di formulazioni liposomiali.
Sono stati studiati nuovi leganti precedentemente sintetizzati per modifica strutturale del
legante commerciale EGTA, nei quali l‟unità ossietilenica centrale è condensata con sistemi
aromatici benzenici o poliaromatici. al fine di irrigidire la struttura del complesso risultante. Questi
ultimi hanno mostrato buoni valori di rilassività soprattutto in seguito all‟interazione con albumina
del siero. Purtroppo la riduzione della mobilità conformazionale dei complessi con ioni lantanoidei,
dimostrata via NMR, non ha determinato un sufficiente aumento della stabilità di tali complessi.
Sono in corso sintesi di nuovi leganti EGTA-like al fine di capitalizzare l‟esperienza appresa con
questo tipo di strutture e concretizzare le conoscenze acquisite in uno o più leganti in grado di
fornire caratteristiche ottimali ai corrispondenti complessi paramagnetici lantanoidei.
Una delle sfide per i prossimi anni è la messa a punto di sistemi che ottimizzino il contrasto
d‟immagine ai campi magnetici cui opereranno i tomografi NMR di prossima generazione.
111
Il “semplice” approccio di sfruttare l‟aumento del tempo di correlazione rotazionale non funziona
in quanto si ottengono dei massimi di efficacia a frequenze comprese tra i 20 ed i 60 MHz. Al fine
di ottenere alta relassività a frequenze maggiori occorre limitare la dimensione dei complessi ( R
dell‟ordine di ca. 200-600 ps) e sfruttare un alto contributo del meccanismo di seconda sfera. A
questo scopo si sono sintetizzati e studiati dei derivati dendritici del GdDOTA con gruppi glicosilici
caratterizzati da una geometria di tipo sferoidale, con lo ione Gd nel baricentro della struttura
macromolecolare e un elevato numero di gruppi funzionali in grado di “intrappolare” molecole
d‟acqua attraverso legami idrogeno. Il risultato è una relassività ottimizzata (> 25 mM -1 s-1 a 25°C)
e con un picco centrato circa a 100 MHz!
Un‟altra strada per ottenere un‟elevata relassività è la messa a punto di derivati multimerici
di ioni Gd(III), possibilmente compatti e rigidi. Quest‟anno l‟attività si è concentrata sullo studio di
dimeri e di complessi coniugati a dendrimeri (PAMAM) di diversa generazione. Un primo sistema
dimerico è costituito dal legante 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl(methylenebenzylphosphinic acid) in cui gruppi fosfinici si trovano a ponte tra due strutture con geometria di tipo
antiprisma quadrato “twisted”. Purtroppo la formazione del dimero impedisce la coordinazione di
molecole di acqua agli ioni Gd e pertanto il sistema è di tipo outer sphere. L‟altro dimero studiato è
costituito da due DOTA derivati monofosfinati con un ponte tioureidico. La presenza di una
molecola d‟acqua coordinata al metallo è stata confermata da misure di shift 17O per il complesso di
Dy(III). La relassività del dimero è più elevata di quella del monomero di un fattore due e quindi
indica sia una notevole rigidità del sistema che un non trascurabile contributo della seconda sfera di
idratazione. Entrambe queste ipotesi sono state corroborate da una analisi dei tempi di rilassamento
in alta risoluzione sui derivati diamagnetici e da procedure di molecular modeling. Infine, la
favorevole caratteristica del complesso DOTA-monofosfinato di possedere una elevata velocità di
scambio dell‟acqua coordinata ci ha suggerito di investigare i suoi coniugati con sistemi
macromolecolari al fine di analizzare in dettaglio i problemi associati alla presenza di moti di
rotazione interna in sistemi complessi. Sono stati preparati i coniugati con dendrimeri PAMAM di
generazione 1, 2 e 4, utilizzando il gruppo tiourea come “linker”. Si è studiata la relassività di
questi sistemi in funzione del pH (effetto della protonazione dei gruppi amminici del PAMAM sulla
dimensione e rigidità del dendrimero), campo magnetico e temperatura. I dati sono stati analizzati
utilizzando l‟approccio di Lipari-Szabo che permette di scomporre la dinamica rotazionale del
sistema in un moto globale a cui si sovrappone un moto di rotazione interna delle sonde attorno al
braccio di coniugazione. L‟effetto limitante di questi moti locali è stato valutato in modo dettagliato
e si è osservato un incremento di relassività di un fattore 2 in seguito all‟interazione con
poliaminoacidi cationici (formazione di coppie ioniche con i complessi anionici sulla superficie del
PAMAM) che ne rallenta la velocità.
E‟ continuato lo studio dei complessi di Gd della famiglia HOPO, caratterizzati da elevata
stabilità termodinamica e dalla presenza di due molecole d‟acqua di coordinazione. Si è trovato: i)
un aumento significativo della solubilità in acqua da parte di derivati trispironici pur mantenendo le
favorevoli proprietà rilassometriche;
ii) un aumento ottimale della relassività, soprattutto agli alti campi dei moderni tomografi MRI, in
seguito all‟azione templante di ioni Fe(III)
con formazione di sistemi “self-assembled”
caratterizzati
da
elevata
rigidità
stereochimica; iii) complessi stabili in
Fe
condizioni fisiologiche in cui lo ione Gd(III)
2 Gd
è nonacoordinato e quindi presenta 3
pH 9
molecole d‟acqua nella sua sfera interna di
coordinazione. L‟aumento del numero di
idratazione q mantenendo una elevata
stabilità, risulta in complessi di elevata relassività molto promettenti per la messa a punto di sonde
ad alta efficacia.
b) Metodologie di sintesi di sostanze poliazotate
3+
3+
112
L‟attività di ricerca in ambito sintetico si è focalizzata come sempre sulla messa a punto di
metodologie sintetiche originali per la preparazione di composti poliazotati. Questi ultimi, in
particolare le poliammine, rappresentano strutture base chiave per la preparazione di leganti per una
larga varietà di metalli. In questo anno, la ricerca in questo ambito ha permesso di scoprire una
nuova reazione multicomponente di particolare utilità per la preparazione di derivati poliamminici
funzionalizzati. Le reazioni multicomponente sono reazioni nelle quali tre o più reagenti si
combinano in una specifica sequenza di passaggi elementari per dare origine ad una struttura
risultante dall‟unione dei reagenti elementari, con l‟eventuale eliminazione di piccole molecole
(H2O, CO2). Nel caso specifico, è stata scoperta una variante della nota reazione di Ugi;
quest‟ultima prevede la reazione di quattro componenti (un ammina primaria, un acido carbossilico,
un aldeide o un chetone e un isonitrile) che condensano per dare un‟acilamminoammide. La
sostituzione dell‟ammina primaria con una diammina secondaria ha portato ad una variazione del
meccanismo di reazione Ugi-like, che non procede attraverso il classico riarrangiamento di Mumm
bensì attraverso un riarrangiamento di Mumm remoto, con migrazione di un gruppo acilico su un
gruppo amminico diverso da quello su cui è avvenuta la formazione dell‟intermedio ione imminio e
successivo attacco dell‟isonitrile. I prodotti ottenuti sono acilammino-amminoammidi, formalmente
aza-omologhi dei prodotti della reazione di Ugi e potenzialmente convertibili in un solo passaggio
riduttivo in triammine sostituite. La estrema versatilità strutturale di questa nuova reazione (detta
“N-split-Ugi”), permette di preparare rapidamente strutture poliamminiche estremamente diverse e
si presta in particolar modo alla chimica combinatoriale.
c) La messa a punto di sonde per imaging molecolare consiste di due parti: la sintesi di vettori
peptidici in grado di procedere al riconoscimento di molecole-reporter di alcune determinate
patologie per diagnostica oncologica e/o cardiovascolare e l‟ottimizzazione di sistemi ad elevata
capacità contrastante nelle immagini di risonanza magnetica. La coniugazione delle due parti
permette la preparazione di una sonda per imaging molecolare. I target molecolari sono
rappresentati da molecole che siano un‟espressione caratteristica del tumore, possibilmente comune
a più tipologie di tumore oppure molecole che siano espresse in eccesso nel corso di determinate
patologie (ad es. la fibrina nelle placche arteriosclerotiche). I target possono trovarsi: nello spazio
extracellulare in stretta prossimità della superficie cellulare (a), sulla superficie delle cellule
tumorali (b), o sulle cellule endoteliali dei vasi neoformati all‟interno della massa tumorale (c). Nel
particolare è stato sintetizzato e studiato un peptide tetramerico (C3d) che, attraverso l‟interazione
con molecole di adesione delle cellule neuronali (NCAM), riconosce selettivamente le cellule
tumorali endoteliali. Successivamente tale peptide è stato utilizzato per visualizzare in vivo
l‟angiogenesi tumorale attraverso la sintesi del peptide biotinilato e l‟utilizzo di un sistema ad
elevata capacità contrastante quale l‟apoferritina riempita con complessi di Gd. Le due parti della
sonda per imaging molecolare sono state coniugate attraverso l‟uso del sistema avidina/biotina.
Biosensori e biostrumentazione (tematica d)
L‟interazione di biomolecole con sostanze a potenziale attività
farmacologica è un aspetto essenziale nello studio degli effetti biologici
di un nuovo farmaco. Una gran varietà di tecniche provenienti dalla
biologia molecolare sono in grado di studiare questi aspetti, ma sono
tuttavia tecniche che richiedono complesse strategie di marcamento e
costose procedure sperimentali che ne impediscono l‟applicabilità a
screening su larga scala. Per questi motivi negli ultimi anni la nostra
U.O. ha sviluppato device elettrochimici, in particolare biosensori
elettrochimici, al fine di ottenere risposte rapide, in maniera semplice,
Elettrodo stampato
controllabile ed economica. Un biosensore può essere definito come un
(SPE)
dispositivo analitico contenente un sistema biologico reattivo in intimo
e connettore
contatto con un trasduttore di segnale. Nel nostro caso il trasduttore è
una striscia serigrafata monouso che costituisce una mini-cella elettrochimica piana di dimensioni
113
estremamente ridotte (diametro di cella 7 mm, lunghezza dell‟elettrodo 3 cm). Essa contiene un
elettrodo di lavoro e un contro-elettrodo stampati entrambi con inchiostro a base di grafite e un
elettrodo di pseudo-riferimento di argento. Il sistema biologico reattivo è costituito da ds- o ss-DNA
che viene immobilizzato sull‟elettrodo di lavoro mediante adsorbimento elettrochimico.
Successivamente, con l‟ausilio della voltammetria ad onda quadra (SWV), si registra il picco di
ossidazione della guanina (G): ogni composto in grado di alterare la densità elettronica delle G
determina una perturbazione del suo processo ossidativo che si traduce con una diminuzione
dell‟intensità di picco di ossidazione della nucleobase.
Con questi biosensori sono è stata testata in maniera semi-quantitativa l‟interazione con DNA di
alcuni complessi metallici antitumorali (cisplatino, carboplatino, oxaliplatino [Pt(bpy)py2]2+,
titanocene dicloruro e NAMI-A). Nonostante lo studio dell‟interazione venga fatto in soluzione e
non in un ambiente cellulare, le informazioni ottenibili possono fornire indicazioni sulla
farmacocinetica dei complessi metallici. In particolare si può esaminare la loro possibile reazione in
seguito ad attivazione per idrolisi, la sensibilità del composto all‟effetto di massa svolto dai leganti
presenti in soluzione, o l‟affinità con la biomacromolecola. La rapidità, la facilità ed i bassi costi di
analisi rappresentano ulteriori vantaggi di tale tecnica che va tuttavia integrata con una serie di test
in vitro e in vivo più specifici e significativi. Il termine profarmaco (pro-drug) definisce un
composto non dotato di una sua intrinseca attività farmacologica ma che diventa attivo dopo aver
subito una biotrasformazione di tipo chimico od enzimatico. Il profarmaco (inattivo) costituisce
pertanto il precursore del farmaco, rappresentato dal suo prodotto di scissione metabolica o
idrolitica. Un discreto numero di medicamenti, storicamente anche molto importanti, è stato
utilizzato senza la comprensione che il principio attivo in realtà fosse costituito da uno dei loro
metaboliti (per esempio l'attività di alcuni sulfamidici deriva da un loro prodotto di scissione, la
sulfanilammina). Recentemente alcuni complessi di rutenio(III) contenenti eterocicli hanno
mostrato interessanti proprietà chemioterapiche e due di essi (NAMI-A e IndCR o KP-1019) sono
attualmente in fase di sperimentazione clinica. Per essi è stato ipotizzato che la loro attività
farmacologica sia dovuta ad una selettiva riduzione nell‟ambiente dei tessuti tumorali (tipicamente
ipossico) nella corrispondente specie di Ru(II) cineticamente più labile e quindi potenzialmente più
attiva. Infatti a causa della rapida divisione cellulare, all‟interno di una massa tumorale si instaurano
condizioni di insufficiente irrorazione sanguigna (scarsa ossigenazione e quindi ambiente riducente)
e bassi valori di pH (risultante dalla produzione di acido lattico). E‟ stato quindi confrontato il
comportamento redox di [LH][trans-RuIIICl4L2] (L = imidazolo ICR o indazolo, IndCR) con quello
di [ImH][RuCl4(DSMO)(Im)] (NAMI-A) allo scopo di ipotizzare la natura dei metaboliti prodotti
per riduzione in ambiente debolmente acido. Nonostante la apparente somiglianza delle strutture, le
specie Ru(II) elettrogenerate sono profondamente diverse: a seguito della riduzione nel caso di ICR
e NAMI-A viene rilasciato imidazolo, seguito da uno ione cloruro, mentre per IndCR si notano due
successive sostituzione di Cl- con H2O. Le nostre misure suggeriscono confermano quindi la
possibilità che complessi di Ru(III) possano agire da pro-drugs, essendo attivati in ambiente
sufficientemente riducente.
Nuovi farmaci inorganici in oncologia (tematica e)
Valutazione sperimentale del coefficiente di partizione ottanolo/acqua (Log Po/w) dell‟accumulo
intra-cellulare di complessi antitumorali a base di Pt(II).
E‟ stato stimato il coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua, log PO/W, di una serie di
complessi di Pt(II), che rappresentano potenziali farmaci antitumorali. Il log P O/W è un indice di
lipofilia, cioè un parametro che indica la solubilità relativa di un composto in fase organica e in fase
acquosa. Nel caso dei farmaci esso rappresenta la loro capacità di attraversare la membrana
cellulare, un doppio strato fosfolipidico a struttura complessa, essenziale per la funzionalità della
cellula. Il doppio strato fosfolipidico forma una zona interna apolare che regola il passaggio di
piccole molecole neutre attraverso il plasmalemma, dal mezzo acquoso extracellulare a quello
acquoso intracellulare e viceversa. I composti più lipofili, quindi più affini al doppio strato lipidico,
114
entreranno più facilmente dentro la cellula per diffusione passiva. Nel caso dei complessi di Pt(II)
risulta particolarmente importante conoscere il log PO/W poiché esiste una relazione esponenziale
tra il log PO/W e il Pt-uptake, cioè la quantità di platino (e quindi di farmaco) che entra all‟interno
della cellula.
Per realizzare questo lavoro sono stati studiati 23 complessi di Pt(II), contenenti diversi carrier e
leaving groups, analoghi a quelli usati in terapia clinica (cisplatino, carboplatino e oxaliplatino).
Sono stati valutati alcuni metodi HPLC per stimare il valore di log PO/W dei composti di Pt(II)
arrivando a determinare un metodo adatto a tale scopo. Tale metodo è stato validato mediante
confronto con i dati presenti in letteratura e mediante procedura di cross-validation leave-one-out.
In base ai dati di log PO/W ottenuti è stato possibile stabilire una tendenza alla lipofilia basata sulla
differenza di carrier group e di leaving group (il grafico illustra ad es. l‟effetto sulla lipofila di
diversi leaving groups).
Per ottenere una predizione di altri valori di log P O/W tramite analisi QSAR è stato intrapreso
un calcolo quanto-meccanico grazie alla collaborazione con il Dr. James A. Platts della School of
Chemistry, Cardiff University (UK).
L‟efficacia con cui il cisplatino e i suoi omologhi attraversano la membrana cellulare è molto
importante per l‟azione complessiva di questi farmaci a base metallica. Accanto al tradizionale (ed
ancora ben accreditato) meccanismo di diffusione passiva, recenti articoli in letteratura hanno
proposto che il cisplatino sia trasportato (in toto od in parte) da un carrier, precisamente la proteina
CTR1, responsabile per il trasporto del rame. Infatti in alcune linee cellulari la resistenza all‟ uptake
di Cu e cisplatino vanno di pari passo.
Si è studiato l‟uptake di cisplatino, carboplatino ed ossaliplatino in funzione del tempo di
trattamento, della concentrazione e della temperatura, fino al limite dei 43°C (ipertermia).
Assumendo che l‟accumulo iniziale in funzione del tempo rappresenti la velocità iniziale del,
processo k, si è applicata l‟equazione di Eyring :
ln
k
T
H 1
R T
ln
kB
h
S
R
ottenendo i parametri di attivazione del processo. Tutti i dati ottenuti sono a favore di meccanismo
di ingresso nella cellula via diffusione passiva attraverso il plasmalemma.
Polichemioterapia del mesotelioma maligno della pleura e genomica/ proteomica associata.
Il mesotelioma maligno della pleura (MMP) è una neoplasia estremamente aggressiva e pressoché
costantemente letale con una sopravvivenza media <1 anno dalla diagnosi e una probabilità di
sopravvivenza a 3 e a 5 anni rispettivamente del 10% e del 3%. Le difficoltà di diagnosi,
stadiazione e terapia distinguono il MMP dalle altre neoplasie. La diagnosi è di solito tardiva a
malattia già avanzata; la chemio- e la radioterapia standard non modificano significativamente la
storia naturale del MMP, mentre le strategie aggressive multimodali hanno migliorato la
sopravvivenza, anche fino ad una media di 23 mesi, però solo in pazienti accuratamente selezionati.
Il ruolo causale dell‟inalazione dell‟amianto è inequivocabilmente dimostrato dagli studi
epidemiologici degli ultimi 40 anni e non vi è prova dell‟esistenza di un valore soglia minimo di
rischio espositivo. La mortalità per MM continua ad aumentare del 5-10%/anno nella maggior parte
dei Paesi industrializzati e, nonostante la messa al bando della produzione e della
commercializzazione delle fibre naturali di amianto, questa tendenza continuerà nei Paesi
dell‟Europa occidentale, Italia inclusa, almeno fino al prossimo decennio, pur se l‟entità
complessiva dei decessi da MM sarà probabilmente inferiore ai 250.000 casi complessivi
inizialmente stimati. Sebbene in passato il MM sia stato considerato una neoplasia di origine
professionale, il crescente numero di casi ambientali di MM testimonia il rischio oncogeno
115
potenziale per la popolazione generale, associato alla presenza ubiquitaria e continuativa
dell‟amianto, anche a basse concentrazioni. È quest‟ultima la cosiddetta “terza ondata” delle
malattie amianto-correlate riconducibile agli effetti dell‟inquinamento esterno di fondo delle aree
urbane ed extraurbane e soprattutto al rilascio di fibre all‟esterno e all‟interno di edifici e strutture
coibentate con materiali asbestosici friabili. Lo sviluppo del MMP rappresenta un processo di
cancerogenesi multifattoriale, complesso e finora solo parzialmente compreso, in cui parecchi geni
tumore-soppressore possono essere persi e parecchi oncogeni possono essere attivati. Inoltre, la
flogosi locale evocata dall‟asbesto con la liberazione di citochine può indurre una crescita cellulare
fuori controllo, a cui può contribuire anche la liberazione di sostanze immunosoppressive, quali
NO. Infine il danno di tipo ossidativo al DNA causato dalle fibre di amianto, in difetto di risposte di
adattamento cellulare, può portare ad una condizione di instabilità genomica, che conferisce un
vantaggio proliferativo alle cellule mesoteliali trasformate. Attualmente poco si sa della sequenza di
eventi genetici tra l‟iniziazione delle cellule mesoteliali e la comparsa delle cellule a potenziale
metastatico, la chiave più probabile per ridurre la mortalità del MMP: le più frequenti precoci
modificazioni sono a livello dei geni tumore soppressore p16 (INK4a) e NF2, la cui perdita o
inattivazione si accompagna alla produzione autocrina di fattori di crescita e fattori angiogenici. Nel
periodo 1988-1997 preso in esame in uno studio dell‟ISS sulla mortalità per MMP, la Liguria e il
Piemonte sono le prime due regioni con un tasso di mortalità per MMP superiore a quello nazionale
e in particolare nella provincia di Alessandria è stato registrato il tasso standardizzato più elevato in
Italia di mortalità totale per MMP (6,59 casi/100.000 abitanti). Casale M.to, polo dell‟industria del
cemento-amianto in provincia di Alessandria, rappresenta un‟area geografica di rilevante interesse
scientifico in quanto l‟epidemia di MMP in corso interessa non solo i lavoratori dell‟impianto per la
produzione di manufatti in cemento-amianto e i loro familiari ma anche la popolazione residente,
ancorché non esposta professionalmente, quest‟ultima con un eccesso di rischio di MMP di 15-25
volte rispetto ai residenti nelle aree rurali circostanti.
Il trattamento non chirurgico del MMP consiste in un protocollo di polichemioterapia basato su
cisplatino od omologhi in combinazione con farmaci a differente meccanismo di azione quali
antimetaboliti tra i quali spicca la gemcitabina, antifolati od alcaloidi vegetali.
Sorprendentemente, rarissimi sono gli studi in vitro su linee cellulari stabilizzate di questa
combinazione di farmaci già in uso clinico in quanto impiegata per il trattamento del tumore
polmonare. Tale studio permetterebbe di comprovare o meno se esiste un razionale
nell‟associazione cisplatino/gencitabina, verificando se l‟effetto globale sia sinergico o additivo o
addirittura antagonista. Le linee cellulari originali sono prelevate da pazienti (decorticazione o
essudato pleurico) e stabilizzate nell‟ospedale di Alessandria (banca dati nazionale per il MMP).
Quando due farmaci di cui è noto singolarmente l‟IC50 sulla linea cellulare tumorale in esame sono
somministrati insieme l‟effetto può essere sinergico, ovvero i farmaci si potenziano a vicenda,
semplicemente additivo, ovvero il risultato biologico è la somma dei due effetti singoli o
antagonista, ovvero i farmaci interferiscono l‟uno con l‟altro. Per una valutazione rigorosa di tali
effetti che vada altre il semplice confronto delle somme degli IC50, si può analizzare con un
programma apposito l‟andamento delle curve dose farmaco – risposta in vitalità cellulare come
suggerito da Chou and Talalay [T.C. Chou, P. Talalay, Quantitative analysis of dose-effect
relationships: the combined effects of multiple drugs or enzyme inhibitors, Adv. Enzyme Regul.,
22, 1984, 27-55]. Inoltre, tramite le tecniche di genomica (micro array ) e proteomica, ovvero 2Delettroforesi, digestione e analisi di massa con il MALDI-TOF è possibile evidenziare la possibile
differenza nella risposta cellulare. In prima istanza si studiano le proteine rilasciate dalle cellule
tumorali (trattate e non) nel mezzo di cultura.
Farmaci antitumorali a base di Pt(II) ancorati ad ormoni steroidei quali agenti antitelomerasici.
L‟ attività dell‟enzima telomerasi è stata dimostrata in ca. il 90 % dei tumori umani, marcatamente
nelle metastasi, mentre è assente nei campioni di tessuto non tumorale ed in neoplasie con prognosi
benigna. La telomerasi quindi rappresenta, oltrechè un marker diagnostico e prognostico, un target
116
ideale per una terapia selettiva antitumorale. Sostanze in grado di inibire tale enzima, infatti,
potrebbero causare una progressiva riduzione dei telomeri nelle sole cellule tumorali, fino al
raggiungimento di una lunghezza minima ed alla conseguente induzione di un forte stimolo
apoptotico. Per attuare una possibile strategia antineoplastica specificamente diretta contro la
telomerasi sono stati impiegati complessi di platino(II), in virtù dell‟alta affinità di legame del Pt
per le basi nucleotidiche, in particolare di G ampiamente presente nello stampo hTERC. Il gruppo
dei chimici dell‟UO ha preparato svariati complessi con la struttura di base del cis-DDP, utilizzando
diversi leganti aromatici a base di azoto. La derivatizzazione di complessi citotossici di Pt(II) con
ormoni ha implicazioni anche nella strategia antitelomerasica suesposta. Recentemente, é stato
dimostrato che l'attività della telomerasi viene modulata positivamente attraverso l'espressione
diretta di hTERT indotta da estrogeni. Infatti, sulla sequenza 5'-flanking del promoter sono stati
identificati "estrogen responsive elements" (EREs) in grado di legare il recettore per estrogeni di
tipo
(ER ). La stimolazione dei recettori con 17 -estradiolo in cellule estrogeno-responsive
(ER+) e' in grado di indurre una notevole attività trascrizionale di hTERT. Queste osservazioni ci
hanno indotto a formulare una strategia chemioterapica che utilizzi complessi metallorganici con
cui funzionalizzare ormoni ed in particolare il 17 -estradiolo. Con questo approccio si vuole ridurre
l'attività della telomerasi e quindi limitare la capacità proliferativa delle sole cellule neoplastiche.
117
118
UNITA’ DI RICERCA POLITECNICA DELLE MARCHE
Direttore Scientifico: Prof. Giorgio Tosi
Biospetroscopia Micro FT-IR Imaging
In collaborazione con l‟Unità di Ricerca di Bologna, è stato finalizzato allo sviluppo di una
nuova tecnica per la preparazione di biomateriali da poter utilizzare come protesi ossee. Numerosi
studi clinici condotti a riguardo hanno dimostrato che il calcio fosfato, in particolare l‟idrossiapatite
Ca10[PO4]6[OH]6 (HAP), è ben tollerato dal tessuto osseo, soprattutto se associato al collagene. Il
lavoro è stato perciò suddiviso in due parti: una prima parte dedicata alla progettazione delle protesi
ed una seconda parte rivolta, invece alla caratterizzazione delle stesse. Le protesi sono costituite da
una superficie di titanio rivestita da telopeptidi di HPA-collagene generati mediante una tecnica di
deposizione elettrochimica, con la quale le molecole di collagene vengono addizionate ad una
soluzione acquosa di NH4H2PO4-Ca(NO3)2 in modo da garantire la formazione sinergica di HAP e
fibre di collagene sulla superficie di titanio. Nella seconda parte del lavoro, di nostra competenza, si
è cercato di seguire il processo di deposizione del collagene e dell‟HAP nel tempo, per
caratterizzare la morfologia, le proprietà termiche e la struttura del prodotto di rivestimento. L‟FTIR Microimaging, in particolare, ha permesso di evidenziare la natura chimica e l‟omogeneità dello
strato di HAP-collagene nel corso della deposizione elettrochimica. Gli spettri IR hanno evidenziato
che, per brevi periodi di deposizione, l‟HPA si presenta sottoforma di fosfato di calcio amorfo e che
cristallizza aumentando il tempo di deposizione. Il processo di deposizione del minerale sulla
superficie di titanio, inoltre, viene favorito dalla presenza del collagene, che ne migliora la
cristallinità e facilita la formazione di una rete fibrosa mineralizzata.
3
A
1
collagene
2
4000,0
3600
3200
2800
2400
2000
1800
cm-1
1600
1400
1200
1000
800
700,0
Sempre in collaborazione con l‟Università di Bologna, abbiamo iniziato uno studio relativo alla
citotossicità del crisotilo (o amianto bianco). Questo silicato, costituito da fogli tetraedrici di silice
(Si2O5)n2- inseriti tra strati ottaedrici di brucite Mg(OH)2, è caratterizzato da un‟elevata resistenza
termica e meccanica, oltre che da una buona tenuta agli agenti alcalini e a causa di tali proprietà ha
trovato numerose applicazioni industriali, soprattutto in campo edilizio. Recentemente è stato
possibile sintetizzare dei nanocristalli di crisotilo da poter utilizzare come standard per lo studio
delle loro proprietà fisicochimiche e le loro interazioni con i sistemi biologici. L‟FT-IR, in
particolare, ha permesso di investigare le variazioni conformazionali della BSA (albumina sierica di
bue), strutturalmente simile all‟HSA (albumina sierica umana) nel momento in cui interagisce con
la superficie del crisotilo. L‟analisi spettroscopica della regione dell‟AI mediante il curve-fitting ha
evidenziato, infatti, una modificazione della struttura secondaria della proteina, che da β-sheet
(nella proteina liofilizzata) passa a β turn (nell‟addotto BSA-crisotilo). Questa riorganizzazione
strutturale della proteina determina una maggiore interazione tra le proteine idrofiliche e la
superficie del minerale, così da creare un sito per il riconoscimento molecolare.
Un secondo lavoro, svolto in collaborazione con l‟Università di Alessandria, riguarda la
caratterizzazione della fluoro-edenite mediante spettroscopia FT-IR. Tale minerale è un anfibolo
119
naturale, caratterizzato da una morfologia asbestiforme, prismatica o fibrosa ed è stato individuato
in concentrazioni elevate nella lava dell‟Etna. La sua presenza, inoltre, è stata associata ad
un‟elevata incidenza di neoplasie polmonari riscontrate negli ultimi anni nell‟area siciliana di
Biancavilla. Lo scopo del lavoro è stato, quindi, quello di determinare le caratteristiche spettrali
della fluoro-edenite e di differenziarla dalla tremolite o da anfiboli analoghi, simili tra loro per
composizione chimica e dichiarati altamente tossici dalla legge. L‟analisi spettrale ci ha permesso di
escludere la presenza della tremolite sulle fibre da noi analizzate.
Si è anche utilizzato l‟FT-IR per valutare il grado di polimerizzazione di un materiale composito
a base di zirconio, sottoposto a processi di levigatura e di invecchiamento artificiali, da utilizzare
come rivestimento per i denti.
E‟ continuata anche l‟analisi su „building blocks‟ di composti bioattivi nella fattispecie di
derivati pirrolidinici preparati con la reazione di Baylis-Hillman, al fine di meglio comprendere il
meccanismo della reazione. Determinazioni FT-IR e studi di meccanica molecolare hanno permesso
di delucidare la stabilità conformazionale in vari solventi.
Come già riportato in precedenti relazioni, ci occupiamo da molti anni all‟analisi spettroscopica
di campioni biologici, come cellule o tessuti inoculati e tessuti umani da resezione chirurgica
nonché su fluidi biologici, nell‟ottica di effettuare analisi quali- e quantitative a livello molecolare
con la possibilità di usare questa tecnica nella diagnosi di patologie tumorali. Ci siamo interessati,
in particolare, allo studio FT-IR di tumori della cavità orale, del colon e del seno (quest‟ultimo in
collaborazione con l‟università di Atene) usando sia una sorgente IR convenzionale, abbinata ad un
microscopio, sia dispositivi multidetector. Gli spettri sono stati effettuati su linee cellulari, su
sezioni di tessuto di provenienza analoga, caratterizzate da zone neoplastiche e non. I risultati della
Cluster Analysis e dell‟Analisi delle Componenti Principali (PCA) sulle linee cellulari e sui tessuti
sono stati confrontati con modelli spettrali di proteine, acidi nucleici, lipidi e altri componenti di
sistemi biologici. Sono stati inoltre analizzati alcuni rapporti di bande rappresentativi utili per
differenziare i campioni sani da quelli malati e per valutare il grado di avanzamento del tumore.
Impegnativo è risultato lo studio delle singole cellule al fine di ricavare informazioni riguardo le
modificazioni biochimiche che avvengono a livello cellulare nel processo di carcinogenesi.
Abbiamo quindi cercato di ottenere spettri relativi alla componente nucleica e a quella
citoplasmatica delle cellule e lo studio è risultato particolarmente impegnativo, considerate le
difficoltà incontrate nell‟isolamento delle cellule e soprattutto nell‟interpretazione degli spettri
stessi.
In collaborazione con l‟Università di Verona, inoltre, ci siamo dedicati allo studio sia di colture
cellulari transfettate con PSMA (Prostate Specific Membrane Antigen) sia di linfomi di tipo nonHodgkin. Abbiamo analizzato l‟effetto della trasfezione di PSMA nella linea cellulare CHO-WT
(Chinese Hamster Ovary cell-Wild Type), dal momento che non sono noti in letteratura studi
condotti su linee cellulari che correlino le modifiche spettroscopiche con i meccanismi coinvolti nei
processi patologici di questa ghiandola. Questi studi preliminari ci hanno permesso di constatare
che la trasfezione del PSMA nelle cellule CHO determina un aumento del contenuto proteico a
livello cellulare ed incrementa l‟attività di sintesi del DNA.
I linfomi non-Hodgkin sono un gruppo eterogeneo di malattie linfoproliferative di varia
malignità e aggressività che originano dai linfociti, L‟analisi spettale ha evidenziato notevoli
120
differenze spettrali tra i campioni sani e quelli malati permettendoci di confermare l‟ipotesi che nel
processo di carcinogenesi l‟intera cellula subisce delle modificazioni riguardanti sia la
concentrazione lipidica e proteica sia il numero dei legami idrogeno tra i gruppi fosfato degli acidi
nucleici.
Per ultimo in collaborazione con l‟Istituto di Biochimica è continuato il lavoro sul ruolo del
chiosano nei sistemi biologici con particolare riferimento alla capacità del chiosano taurocolato di
legare lipidi e di dar luogo a idrolisi enzimatica.
Complessi ternari lipidi-DNA-ioni metallici
Complexes composed of cationic liposomes (CLs) and DNA exhibit great potential in gene
therapy (GT), an innovative technique for correcting defective genes responsible for disease
development. Realization of the full potential of the GT will depend mainly on the future
development of safe and efficient nonviral gene delivery reagents. Cationic lipid-DNA complexes
are presently the most diffuse DNA carriers in nonviral gene delivery applications and are
extensively used in clinical trials worldwide because of their ability to mimic natural viruses as
chemical carriers of extracellular DNA across outer-cell and nuclear membranes (transfection).
However, their transfection efficiency is still low compared to the one of viral vector, the
complexes are unstable in the presence of serum, which creates difficulties for in vivo applications.
Also, CLs are frequently toxic for the cells. Complexes composed exclusively of neutral
(zwitterionic) lipids offer an alternative to CLs, in that they exhibit lower inherent cytotoxicity and
much longer circulation lifetimes. These main drawbacks have presently stimulated scientists to
look for new synthetic gene vectors and focus major efforts to understand the structure-function
relationships, with the ultimate goal of enabling a design-based approach to gene delivery. Within
this frame, we have recently started the study of new complexes formed by the self-assembled
association of neutral liposomoes (L), DNA and bivalent metal cations in water solution.
We have studied L-DNA-Me2+ complexes having different microstructures reflecting the
structure and phase symmetry of the parent pure lipids, prepared from different neutral liposomes
(DOPC, DLPC, DPPC and DOPE), DNA (from calf thymus, salmon sperma and -phage) and
bivalent metal cations (Mn2+, Mg2+, Ca2+, Co2+, Fe2+). The supramolecular packing forms lyotropic
liquid crystals that display richness of phase behaviour and structures. It was found that the L-DNAMe2+ complexes exhibit the liquid crystalline L c phase (c stands for complex) consisting of the
multilamellar aggregation of stacked alternating lipid bilayers and hydrated DNA monolayers (fig.
1). In view of the surface functionalization of these complexes to develop competent target-specific
gene carriers, we have studied the structural properties of some new complexes in which the neutral
lipids are functionalized by PEG (polyethylene glycol) with chains of different length. PEG is the
natural choice to serve as a protective coat or act as a tether for a specific ligand on the surface of
these complexes due to its biocompatibility and ability to convey stealth-like properties.
Preliminary XRD measurements were carried out at the synchrotron radiation facilities on
complexes whose lipidic mixture was formed of DOPE/DOPE-Peg350. To such a mixture was
added DNA from calf-thymus and metal cation Mn2+. The obtained results show interesting phase
transitions of the complex, from hexagonal (2D) to cubic phases (3D), increasing the DOPEPEG(350) concentration in the complex. Recently we have also attempted an in vitro transfection of
plasmid DNA on mouse fibroplast NIH 3T3 cell lines, using DOPC-DNA(plasmid)-Me2+ (either
Ca2+ or Mn2+). The preliminary results are quite heartening, as they unquestionably show the
capability of these complexes to transfect DNA (fig 2). Studies are in progress to try to improve the
transfection efficiency which is at the moment too low for practical applications. Therefore,
efficient encapsulation of DNA plasmids in these neutral complexes may represent an important
alternative to current systemic gene approaches.
121
c
Fig. 1
Intensity (arb. units)
L (
Me2+(H2O)n
L
Me2+(H2O)n
c
L (
Fig. 2
L
0.1
0.2
c
L (
0.3
-1
q( Å )
c
L (
0.4
Fig. 1. SAXS pattern of the DOPC-DNA-Mn2+ complex. Inset: schematic picture of the lamellar structure of
the L c phase. Fig. 2. Fluorescence micrograph of mouse fibroplast NIH 3T3 cell lines transfected with
pGreenLantern.
122
UNITA’ DI RICERCA DI ROMA “La Sapienza”
Direttore Scientifico: Prof. Elena Borghi
Gruppo: Prof. Claudio Ercolani
Aspetti Inorganici e Bioinorganici nella Chimica di Sistemi Macrociclici ad alta
Delocalizzazione Elettronica (Porfirine, Ftalocianine, Porfirazine)
L‟attività scientifica del gruppo durante l‟anno 2006 ha proceduto, con ulteriori sviluppi,
lungo linee di ricerca che riguardano la sintesi, la caratterizzazione chimico-fisica, lo studio della
struttura molecolare ed elettronica, nonché l‟approccio ad alcuni importanti aspetti applicativi di
nuove classi di sistemi macrociclici tetrapirrolici di tipo flalocianinico, porfirinico e
porfirazinico. Nell‟ambito degli aspetti applicativi, una parte preponderante dell‟attività è stata
diretta alla verifica delle potenzialità di alcune classi di macrocicli porfirazinici di agire come
fotosensibilizzatori per la produzione di ossigeno di singoletto, 1O2, primo stadio del percorso che
riguarda la cura di alcune forme di cancro nell‟ambito della terapia fotodinamica (PDT). Questa
tematica di lavoro era stata iniziata con significativi risultati nel 2005, portata all‟interno del
CIRCMSB come linea di ricerca innovativa e non sviluppata da altri gruppi. Tale linea ha potuto
ricevere l‟apporto della dottoranda Elisa Viola entrata a far parte del gruppo di lavoro,
usufruendo di una borsa di studio per l‟anno 2005 da parte dello stesso Consorzio CIRCMSB.
Nel corso del 2006 si è potuto creare un panorama di ulteriori importanti risultati, di cui si è in
diverse occasioni relazionato, circa l‟effettiva capacità delle due classi di macrocicli porfirazinici
studiati, e cioè la tetrakis(tiadiazol)porfirazina, [TTDPzH2] (Figura 1A) e la
tetrakis(dipiridinopirazino)porfirazina, [Py8TPyzPzH2] (Figura 1B) ed una serie di loro derivati
metallici (M = ZnII, MgII, CuII, PdII) di funzionare come fotosensibilizzatori.
N
N
S
N
N
N
N
N
N
S
N
N
HN
N
N
NH
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
NH
N
N
HN
N
N
N
S
N
N
N
N
S
N
N
N
N
A
N
B
Figura 1
Le misure di resa quantica di ossigeno di singoletto ( ), effettuate su queste specie, hanno
comportato studi spettroscopici in soluzione di dimetilformammide. Queste misure sono state
precedute da accurate indagini riguardanti la presenza di fenomeni di aggregazione molecolare,
facilmente ricorrenti per questo tipo di sistemi macrociclici ad alta delocalizzazione elettronica, e
123
la stabilità di detti sistemi in soluzione è stata verificata sia in assenza che in presenza di
appropriate radiazioni (600-900 nm). Si è potuto verificare che, nelle condizioni sperimentali
attuate, l‟esposizione dei composti alle radiazioni per le misure di resa quantica non produce
significativa decomposizione dei materiali. I valori di resa quantica
ottenuti per i complessi di
ZnII e di PdII dei due tipi di macrocicli cadono all‟interno dell‟intervallo 0.7-0.9 e sono
significativamente più alti di quelli delle altre specie studiate (M = MgII, CuII, 2HI). Tali valori
sono inoltre decisamente più elevati di quelli noti per le analoghe specie di ftalocianine e
porfirazine contenenti gli stessi metalli e della stessa ftalocianina di Zn II, [PcZn], usata come
riferimento negli esperimenti effettuati ( = 0.56) . Nella relazione del gruppo del 2005 per il
CIRCMSB si è riferito circa la sintesi e la caratterizzazione dei complessi di PdII della
tetrakis(dipiridinopirazino)porfirazina, [Py8TPyzPzH2] (Figura 1B), e precisamente della specie
monopalladata [Py8TPyzPzPd], della specie pentapalladata [(PdCl2)4Py8TPyzPzPd] (Figura 2A),
e dello ione ottacationico [Py8TPyzPzPd]8+(Figura 2B).
Cl
Cl
Pd
Cl
N
N
Pd
Cl
N
+
+N
H3C
CH3
N
N
N
N
Cl
Pd
+
Pd
Pd
Cl
Cl
A
(I-)8
N
CH3
N
N
N
N
+
+
CH3
N
N
N
N
N
N
N
N
H3C
+
N
Cl
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
H3C
N
N
N
N
Pd
N
N
N
N
N
N
N
N
N+
N
H3C
CH3
N
+
B
Figura 2
Su queste tre specie, delle quali è stato estesamente studiato il comportamento spettroscopico
(IR e UV-vis) ed elettrochimico, sono state effettuate misure di resa quantica di ossigeno di
singoletto. Si è notato che mentre i valori riscontrati per le due specie mono e pentapalladata
[Py8TPyzPzPd] e [(PdCl2)4Py8TPyzPzPd] sono elevati, (> 0.8), per la specie ottacationica
[Py8TPyzPzPd]8+ si ha un valore molto più basso (~ 0.3). Si ipotizza che tale valore sia
determinato dalla presenza degli ioni ioduro (I-) presenti come controioni e che possono agire
come agenti destabilizzanti dello stato di tripletto del catione. Nel complesso, i risultati fino ad
ora acquisiti in termini di resa quantica sembrano creare le premesse per un possibile passaggio
per il 2007 allo studio di fenomeni di contatto dei macrocicli studiati con lipidi carichi di varia
natura per la formazione di liposomi adatti alla veicolazione dei fotosensibilizzatori verso i
tessuti malati. Alcuni esperimenti preliminari hanno permesso di stabilire che questo contatto
effettivamente avviene ed il lavoro è pertanto suscettibile di ulteriori promettenti sviluppi.
L‟attività dei fotosensibilizzatori studiata è connessa, come detto sopra, alla capacità da parte
degli stessi di trasferire energia dal loro stato di tripletto eccitato all‟ossigeno molecolare, 3O2,
1
per attuare la transizione 3O2
O2. La necessità di un approfondimento interpretativo di tale
comportamento richiede una conoscenza della possibilità da parte del fotosensibilizzatore di
accedere ai diversi stati eccitati, della popolazione e dei tempi di vita media degli stessi e
dell‟aspetto cinetico del passaggio da uno stato ad un altro. Si rendono pertanto necessarie misure
di fluorescenza e di fosforescenza, misure che per quanto riguarda la fluorescenza sono già state
in parte effettuate in modo qualitativo per la serie [TTDPzM] (M = ZnII, MgII, CuII, 2HI).
E‟ noto dalla letteratura, e provato anche dalla esperienza acquisita dal gruppo di lavoro per
gli studi effettuati sulle specie a cui si è accennato più sopra, che i valori più elevati di resa
124
quantica si osservano per derivati metallici contenenti centri metallici a guscio pieno (ZnII, MgII,
AlIII) ed è pertanto in programma l‟effettuazione di misure di resa quantica di ossigeno di
singoletto per le specie [TTDPzMX] (M = AlIII, GaIII; X = Cl, Br).
A seguito degli studi effettuati sul comportamento elettrochimico (voltammetria ciclica e
spettroelettrochimica) delle specie [TTDPzM] e [Py8TPyzPzM] (M = MnII, CoII, ZnII, MgII, CuII,
2HI) è stato verificato che la prima riduzione monoelettronica per le diverse specie avviene a
potenziali (V vs SCE) solo debolmente negativi o molto vicini allo zero. Alla via elettrochimica
si è voluta sostituire la via chimica ed è stata studiata la reazione di riduzione delle specie
[Py8TPyzPzM] (M = CoII, ZnII, MgII, CuII, 2HI) in soluzione di diversi solventi usando NaBH4
come agente riducente. Risultati positivi sono stati ottenuti, come accennato nella relazione per il
2005, per il complesso di CoII, [Py8TPyzPzCo], che viene convertito, con una riduzione metallocentrata, nel sale sodico della specie monoanionica [Py8TPyzPzCo]-1 contenente CoI. Il
complesso, stabile in ambiente inerte e discretamente stabile all‟aria per brevi periodi, è stato
isolato e caratterizzato allo stato solido mediante analisi elementare e spettroscopie IR, UV-vis e
EPR. Il processo di riduzione, che avviene in modo stechiometrico, può essere facilmente seguito
per via spettrofotometrica (UV-vis) all‟aria in soluzione di DMSO. Dello stesso complesso di
CoII [Py8TPyzPzCo] è stato preparato anche il prodotto di ossidazione monoelettronica
[Py8TPyzPzCo]+ probabilmente contenente CoIII. Uno studio analogo di processi redox
monoelettronici per via chimica, con buone prospettive di riuscita, è stato avviato per l‟analogo
complesso di CoII della tetrakis(tiadiazol)porfirazina, [TTDPzCo]. I risultati dello studio
spettroscopico (UV-vis) ed elettrochimico sulle specie [TTDPzM] (M = ZnII, MgII, CuII, 2HI)
sono stati considerati alla luce di un dettagliato studio teorico effettuato mediante calcoli
DFT/TDDFT.
L‟intenso e variegato lavoro scientifico compiuto negli ultimi anni sulla
tetrakis(tiadiazol)porfirazina, [TTDPzH2] (Figura 1A), e sull‟analogo macrociclo contenente Se
in luogo di S, [TSeDPzH2], è stato presentato in un recente lavoro di review. E‟ anche giunto a
pubblicazione un lavoro riguardante un complesso eterodinucleare (Mn-Cr) ed eterolettico,
contenente un anello ftalocianinico ed uno tetrafenilporfirinico, e nel quale due centri metallici
sono tenuti uniti da un ponte -idrosso.
Un nuovo studio di diffrazione di raggi X è stato effettuato allo scopo di analizzare la struttura
di stato solido della specie nanostrutturata [PcFe-O-FePc] (Pc = anione ftalocianinico).
L‟arrangiamento delle unità dinucleari nel solido è stato determinato usando il metodo di
Rietveld su dati di Angular Dispersive X-ray Diffraction (ADXD), mentre la geometria
intramolecolare è stata ottimizzata mediante Energy Dispersive X-ray Diffraction (EDXD). La
dimensione delle nanoparticelle è stata stimata dalla trasformata di Fourier della funzione
strutturale sperimentale EDXD.
Il complesso [Py8TPyzPzMg(H2O)] è stato approfonditamente studiato per la sua capacità di
manifestare limitazione ottica in soluzione di DMSO, solvente nel quale esso non presenta
fenomeni di aggregazione molecolare che, come noto, possono influire negativamente sul grado
di efficienza del macrociclo. Il lavoro è stato condotto in collaborazione con il Prof. M.
Meneghetti dell‟Università di Padova. E‟ stata verificata per tale complesso una ottima risposta
di limitazione ottica a 532 nm. Ciò è dovuto ad un processo di “reverse saturable absorption”
(RSA) che coinvolge lo stato di tripletto del complesso ed un processo di assorbimento a due
fotoni che riceve il contributo del monoanione radicalico dello stesso complesso che si forma per
fotoriduzione.
125
Gruppo: Prof.ssa Elena Borghi
Nel corso del 2006 l‟Unità Operativa dell‟Università "La Sapienza" di Roma ha operato secondo le
seguenti linee di ricerca:
1) Metalloproteine come catalizzatori biologici
2) Composti inorganici d‟interesse ambientale
Metalloproteine come catalizzatori biologici
Caratterizzazione Strutturale di Centri Metallici di Metalloproteine e Composti Modello (BioX Ray Absorption Spectroscopy)
La caratterizzazione strutturale dei centri metallici riveste molta importanza nella genomica
strutturale e nella metalloproteomica. C‟è interesse nel combinare la diffrazzione ai raggi X di
proteine con la spettroscopia di assorbimento ai raggi X di campioni biologici (BioXAS) in modo
da ottenere un‟alta risoluzione della struttura fine dei centri metallici, sfruttando la sinergia e la
complementarità dei due approcci spettroscopici.
XAS, oltre a fornire una risoluzione subatomica nell‟intorno locale del metallo, dà informazioni
sulla struttura elettronica del metallo (stato di ossidazione, occupanza orbitalica). Questo non è il
solo vantaggio rispetto alla diffrazione X in quanto applicando XAS il campione di proteina può
essere un cristallo, una polvere, o una soluzione. Proteine insolubili (come le proteine di membrana)
sono caratterizzabili. La flessibilità di questa tecnica spettroscopica è di particolare significato in
studi di relazioni struttura-funzione di sistemi biologici e di complessi molecolari rilevanti per i
materiali biologici.
Correntemente l‟analisi dei dati XAS è basata sul confronto tra calcoli teorici e dati sperimentali
accurati, ed in particolare è importante per applicazioni BioXAS l‟analisi quantitativa della zona
XANES (X-Ray Absorption Near Edge Structure) dello spettro. Infatti il segnale XANES è di
almeno due ordini di grandezza più intenso del segnale EXAFS, che nelle metalloproteine cade a
bassi valori di k nello spettro. L‟approccio XANES permette di ridurre la concentrazione della
proteina e dei complessi molecolari modello.
I nostri recenti risultati XAS sulla caratterizzazione di forme ossidate di enocianine (Hcs) e di
composti modello correlati hanno mostrato come sia possibile riconoscere le caratteristiche
strutturali di centri metallici, sia mononucleari che binucleari. Per queste caratterizzazioni abbiamo
sia raffinata la modulazione del segnale EXAFS con calcolo in multiplo-scattering (MS) (con
GNXAS), sia simulato il segnale XANES con calcolo MS (con CONTINUUM), sia modulato in
approccio MS il segnale XANES (con MXAN). I nostri risultati hanno anche mostrato le difficoltà
legate alla caratterizzazione di questi centri metallici ed hanno evidenziato i vantaggi dell‟analisi
XANES e dell‟uso del programma MXAN.
È importante comparare i dati di diffrazione e i dati di assorbimento X, anche considerando la
mancanza di una banca dati XAS, e testare e comprendere come la natura e la quantità
dell‟informazione chimica (Z-tipo del legante, distanze ed angoli tra i leganti) siano sufficienti per
rifinire in modo “univoco” il dato XAS e per ottenere una rappresentazione strutturale del centro
metallico.
L‟attività di calcolo del 2006 si è principalmente focalizzata sugli importanti aspetti indicati,
disponendo di dati XAS (raccolti al sincrotrone di Grenoble) su campioni di una serie di composti
modello con leganti poly(benzimidazolo), con e senza diffrazione ai raggi X, forniti dal prof. L
Casella di Pavia. Questi composti hanno proprietà strutturali e/o di reattività correlate a quelle dei
derivati delle proteine Hcs.
La modulazione del segnale XANES con MXAN è stata applicata alla famiglia dei composti
mononucleari del legante 2-BB, in cui le distanze di legame e gli angoli non risentono della
variazione della stereochimica al centro metallico. Abbiamo già pubblicato una simulazione dello
126
spettro XANES di questa famiglia con CONTINUUM che ha indicato come sia possibile produrre
simulazioni con strutture XANES diverse in presenza di sottili differenze strutturali.
I risultati ottenuti con MXAN mostrano come i dati strutturali di assorbimento X siano in perfetto
accordo con i dati strutturali di diffrazione X (test del complesso del legante 2-BB a struttura nota)
e come tramite un approccio XANES quantitativo sia possibile ricavare informazioni strutturali
univoche e sicure, pur partendo da strutture di diversa simmetria, nella modulazione dello spettro
sperimentale di un complesso del legante 2-BB senza struttura X.
In uno stadio precedente della nostra ricerca abbiamo considerato e risolto aspetti
fondamentali dei siti binucleari a rame di tipo 3 sia dei composti modello sia dei derivati proteici
(cioè corretti valori della distanza Cu-Cu, presenza di distorsione assiale al sito a Cu, presenza e
tipo di gruppi a ponte). Tuttavia la risoluzione degli aspetti strutturali fini per questi siti binucleari a
rame di tipo 3 è particolarmente difficile. Tra i composti modello binucleari di Casella uno col
legante L-55 ha struttura nota, per cui il passo successivo sarà ottenere la modulazione con MXAN
del suo segnale XANES, gia da noi simulato con CONTINUUM [2] (test del complesso binucleare
del legante L-55 a struttura nota). È molto importante ottenere un paragone della complementarità
dei due approcci strutturali a raggi X possibili. Questo permetterà di estendere con sicurezza la
caratterizzazione strutturale XAS ad altri composti binucleari senza struttura X e a derivati ossidati
di Hcs.
Caratterizzazione dell’Interazione dell’Albumina Umana con Composti di Platino(II)
Abbiamo studiato l‟interazione tra la proteina modello, Human Serum Albumin (HSA), e due composti di
platino, cis-diamminodicloroplatino (cis-Pt) e trans-diamminodicloroplatino (trans-Pt), in soluzione acquosa a
pH fisiologico nel rapporto molare 1:1 e 1:2. Si sono applicate la spettroscopia FTIR e CD. in quanto danno
indicazioni qualitative - ed anche quantitative - sulle variazioni strutturali della proteina nella
formazione dell‟addotto con il composto di platino. Le misure sono state eseguite presso il
laboratorio di “Struttura della materia biologica” della prof. A. Congiu Castellano del Dipartimento
di Fisica de La Sapienza.
Lo studio FTIR è stato condotto in approccio ATR (Attenuated Total Reflection), in modo da
utilizzare ridotte quantità di campione in soluzione, e si è finora concentrato sull‟analisi della zona
della banda dell‟ammide I della proteina. La banda Amide I degli spettri ATR-FTIR (intervallo di
energia 1700 –1616 cm-1) è stata fittata, con il programma OPUS, per determinare la struttura
secondaria della proteina,
Con ATR sono corrette essenzialmente misure qualitative, ed inoltre, poiché è probabile la presenza
di più addotti in soluzione, non ha senso considerare la FTIR differenza per cercare di arrivare ad un
assegnamento strutturale. Per uno studio FTIR quantitativo in soluzione e per misure nel mediolontano infrarosso è stato richiesto - ed ottenuto - tempo macchina presso gli strumenti FTIR - con
sorgente convenzionale e sorgente a luce di sincrotrone - dei Laboratori Nazionali di Frascati (LNFINFN).
Gli spettri CD in soluzione sono stati simulati con DICHROWEB, un server del Birkbeck College
dell‟Università di Londra per analisi CD on-line. Per la simulazione tra i programmi disponibili sul
server abbiamo scelto il programma CDSSTR, che utilizzando un set di 48 proteine di struttura nota
calcola la radice quadrata della deviazione media quadrata normalizzata (N.R.M.S.D.) tra
l‟ellitticità sperimentale e l‟ellitticità calcolata dalle strutture di riferimento. I segnali CD
sperimentali sono stati fittati con un valore di N.R.M.S.D. ≤ 0.002. Inoltre, poichè il segnale CD di
una proteina può essere considerato la combinazione lineare di ogni singola conformazione
secondaria legata ad un diverso stato di folding presente, è stato possibile determinare la percentuale
di ciascun tipo di struttura secondaria (α-elica, β-sheet, random coil). La procedura di simulazione
eseguita sugli spettri CD ha anche permesso di quantificare per le strutture α-elica e β-sheet il grado
di distrorsione presente negli addotti HAS-cis/trans-Pt (determinazione dei parametri αR = strutture
α-elica regolari, αD= strutture α-elica distorte, βR = strutture β-sheet regolari e βD= strutture β-sheet
distorte).
127
I risultati ottenuti con le due tecniche, nell‟ambito dei rispettivi errori sperimentali, indicano lo
stesso andamento: a parità di condizioni il trans-Pt produce distorsioni strutturali maggiori rispetto
al suo isomero. L‟interazione di HSA con il cisplatino produce una diminuzione di strutture αeliche. Con FTIR l‟effetto maggiore si ottiene nell‟addotto HSA-cis-Pt in rapporto molare 1:2 dopo
24h di incubazione. La diminuzione di alfa eliche nell‟addotto HSA-trans-Pt 1:1 incubato per 2 ore
diventa molto accentuata dopo 24 ore. Nel caso del rapporto molare 1:2 invece vi è una forte
diminuzione di α-eliche dopo solo 2 ore di incubazione che rimane costante dopo le 24 ore, con un
parziale unfolding della proteina.
Caratterizzazione XAS alla soglia L3 del Pt di composti modello di platino(II)
E‟ noto che la spettroscopia di assorbimento X (XAS), ed in particolare la zona XANES (X-Ray
Absorption Near Edge Structure) dello spettro sperimentale, fornisce importanti informazioni sullo
stato di ossidazione del metallo e sulla geometria dell‟intorno atomico, permettendo quindi di
identificare con estrema accuratezza i leganti dell‟atomo assorbitore, le distanze e gli angoli di
legame. Tuttavia manca ancora una banca dati di spettri XAS.
Lo scorso novembre abbiamo iniziato ad acquisire spettri di composti modello di platino(II), con
misure effettuate alla soglia L3 del Pt presso il sincrotrone ELETTRA di Trieste sulla linea EXAFS.
I lavori di assorbimento X alle soglie (L1, L2, L3) del Pt disponibili in letteratura sono pochi. Il
principale assorbimento dopo la soglia L3, white line, è dovuta a transizioni 2p3/2 → nd5/2
dell‟atomo assorbitore; l‟intensità della white line diminuisce al riempirsi degli orbitali più esterni e
per questo motivo lo spettro XANES alla soglia L3 è sensibile anche allo stato di ossidazione
dell‟atomo metallico.
I complessi di Pt(II) considerati sono stati cis-[Pt(NH3)2Cl2], trans-[Pt(NH3)2Cl2], K2[PtCl4] e
[Pt(NH3)4]Cl2 allo scopo di testare la sensibilità di questa spettroscopia con differenti intorni
dell‟atomo assorbitore, in presenza di una diversa geometria di legame e di differenti strutture.
Le misure sono state effettuate in transmittanza su pasticche, preparate sotto vuoto con la pressa da
IR, costituite da una miscela di cellulosa e composti di platino secondo una metodica in uso sulla
linea EXAFS ad Elettra, calibrando per pesata i componenti essiccati in modo tale da ottenere un
assorbimento dopo soglia di circa 1. Così si possono apprezzare, già da un esame qualitativo, le
diversità nelle oscillazioni degli spettri indicanti una diversa coordinazione dell‟intorno del platino.
La misura XAS in stato solido stressa il contributo strutturale per cui la simulazione degli spettri
XANES dei complessi di Pt(II) considerati deve necessariamente tener conto degli effetti
geometrici delle proprietà di simmetria presenti. Pertanto nella simulazione, pur essendo i complessi
considerati molecole con un peso molecolare di ~ 300 Dalton, si deve considerare un cluster di
raggio ionico opportuno per tener conto anche della presenza di distanze intermolecolari < di 3.6
Å. Questo approccio complica ed allunga i tempi di calcolo.
Gli spettri XANES dei quattro composti modello considerati vengono simulati con il programma
MXAN in grado di riprodurre lo spettro sperimentale con calcoli ab initio di uno spettro XANES
teorico a partire da dati cristallografici e di modularlo utilizzando la libreria MINUIT del CERN.
Queste misure inoltre ci permettono di testare la procedura di simulazione del programma MXAN
sulle soglie L3 del Pt. La simulazione è in corso.
Composti inorganici d’interesse ambientale
Caratterizzazione Magnetica del Crisotilo Sintetico Drogato con Fe(III)
Nell‟ambito della collaborazione iniziata nel 2005 con il gruppo di Bologna del prof. N. Roveri,
impegnato in una ricerca sul ruolo chimico, strutturale e morfologico dei silicati asbestosi, e sulla
loro tossicità, il gruppo di Roma, per determinare la struttura e la nuclearità dei siti a ferro, ha
investigato campioni di crisotilo stechiometrico drogato con Fe(III) usando un approccio combinato
EPR e DRS [1].
128
La combinazione della caratterizzazione EPR e UV/Vis-DRS ha permesso di distinguere e definire
nei loro parametri spettroscopici ioni Fe(III) isolati con differente coordinazione e cluster FexOy
con ioni Fe(III) magneticamente interagenti. Le differenze osservate negli spettri EPR a temperatura
ambiente ed alla temperatura dell‟azoto hanno indicato che la legge di Curie non era seguita
(presenza d‟interazioni antiferromagnetiche) e le caratteristiche UV/Vis nella regione 400-600 nm
hanno evidenziano la presenza di accoppiamento magnetico e quindi la presenza di cluster FexOy la
cui quantità e probabile grandezza aumenta all‟aumentare del contenuto in Fe.
Dal momento che la caratterizzazione strutturale e la corretta definizione della nuclearità dei siti a
Fe(III) sono importanti per interpretare l‟interazione delle fibre di crisotilo con sistemi biologici,
durante il 2006, il nostro studio è stato esteso alla descrizione delle proprietà magnetiche degli stessi
campioni misurandone la suscettività magnetica con un magnetometro SQUID in funzione della
temperatura. Le misure sono state effettuate in collaborazione con il dott. C. Bellitto presso
l‟Istituto di Struttura della Materia-CNR, Roma.
La dipendenza dalla temperatura della suscettività magnetica molare, χM, è stata misurata
nell‟intervallo 5-300 K. Il grafico µeff vs. T mostra una diminuzione del momento magnetico
effettivo, µeff,. all‟abbassarsi della temperatura. In questo tipo di grafico un andamento lineare è
indicativo di un sistema che segue la legge di Curie-Weiss, mentre la presenza di una curvatura è un
andamento indicativo della presenza di interazioni antiferromagnetiche.
La presenza di accoppiamento antiferromagnetico può meglio essere apprezzata considerando il
valore del prodotto χMT ed il grafico χMT vs T. Per ioni Fe(III) con S=5/2 non interagenti il valore
teorico χMT è noto, per cui un valore di questo prodotto significativamente più basso è indicativo di
interazioni antiferromagnetiche. In letterature sono riportati per il prodotto χMT valori che mostrano
come la sua diminuzione rifletta il numero dei centri di Fe(III) con S=5/2 interagenti.
I risultati EPR ed UV/Vis-DRS [1] hanno messo in luce la presenza di siti a Fe(III) isolati in
coordinazione tetraedrica e a più alto numero di coordinazione (presumibilmente ottaedrica e/o con
distorsione romboedrica) ed evidenziato, con la dipendenza dell‟intensità del segnale EPR a g=2.0
con la temperatura e le caratteristiche UV/Vis nella regione 400-600 nm, la presenza di un
accoppiamento magnetico la cui quantità e probabile grandezza aumenta all‟aumentare del
contenuto in Fe.
Le misure magnetiche effettuate su due campioni a diversa percentuale di Fe confermano questo
andamento [2]. In principio sarebbe possibile dedurre la presenza di specie isolate a S=5/2
paramagnetiche dal confronto tra le deviazion del prodotto χMT dalla curva teorica calcolata
considerando l‟Hamiltoniano.di interazione isotropica spin-spin. Risolvendo l‟equazione di van
Vleck per questo Hamiltoniano sarebbe possibile ricavare i valori delle costanti di accoppiamento J
il cui valore è indicativo della presenza di effetti intramolecolari. Per una più completa
comprensione delle proprietà magnetiche sarà necessario estendere l‟intervallo di temperatura sia a
più bassi che a più alti valori.
129
130
UNITA’ DI RICERCA DI ROMA “Tor Vergata”
Direttore Scientifico: Prof. Massimiliano Coletta
Nel corso del 2006 l‟Unità Operativa di Roma Tor Vergata ha effettuato una serie di ricerche sui
seguenti argomenti.
1) Emoproteine e composti modello
2) Metalloenzimi
3) Stress ossidativo
1) Emoproteine e composti modello
In questo campo si è completato lo studio sull‟espressione e la caratterizzazione della forma
ricombinante della Eosinofilo Perossidasi umana, che è stata oggetto di una pubblicazione su The
Biochemical Journal. Tale enzima, espresso tramite un organismo eucariotico (Pichia pastoris), è
adeguatamente glicosilato come l‟enzima nativo e mostra un‟attività assai marcata di ossidazione
(indotta da H2O2) di alogeni (quali Cl-, Br- e SCN-) ad ipoalogeni (ClO-, BrO-, e SCNO-), anche in
misura maggiore che nell‟enzima nativo.
Si è inoltre effettuato uno studio sugli intermedi di “folding” del citocromo c, ed in particolare sul
ruolo stabilizzante dei tre residui di istidina presenti nella sequenza aminoacidica. Tale studio, che
ha prodotto una pubblicazione su The Journal of Biological Inorganic Chemistry, ha permesso di
evidenziare, grazie all‟uso di mutanti sito-specifici, il ruolo fondamentale svolto dalla His26 nel
determinare la stabilità della proteina in condizioni denaturanti, permettendo di postulare che questo
è il residuo di istidina che forma l‟intermedio bis-istidinico nello stato A. Inoltre, si è continuato
l‟indagine sulla termodinamica e dinamica di formazione di tale stato intermedio. Infatti, il
citocromo c a pH 2.2 ed a bassa forza ionica è denaturato, mentre all‟aggiunta di sali viene
stabilizzato nella nuova conformazione quasi-nativa, denominata “stato A”, nel quale si osserva la
presenza di due forme (entrambe con il Fe dell‟eme esacoordinato), che variano per il tipo di
ligando assiale dell‟eme: una è la forma nativa, in cui i ligandi assiali sono His18 e Met80, mentre
nell‟altra Met80 è sostituita da un‟istidina (probabilmente His26, v. sopra). L‟indagine effettuata ha
permesso di evidenziare come ioni divalenti, quali solfato, inducano una transizione denaturatostato A in maniera più efficiente che ioni monovalenti, quali cloruro o perclorato. Inoltre, tali ioni
divalenti sembrano privilegiare la formazione della specie con la Met80 quale ligando assiale.
L‟utilizzo di mutanti sito-specifici ha permesso di escludere che le due lisine (Lys13 e Lys88), che
erano state proposte formare il sito per l‟interazione con gli anioni, siano effettivamente coinvolte.
Tale studio, che è stato oggetto di una pubblicazione su FEBS Journal, ha però rivelato come tali
lisine giochino un ruolo fondamentale nella strutturazione dello stato A e nella dinamica della
transizione denaturato-stato A. Infatti, la sostituzione di queste due lisine (sia individualmente che
entrambe in un doppio mutante) determina, rispetto alla forma wild-type, una maggiore propensione
alla formazione dello stato A bis-istidinico.
Si è infine completato, in collaborazione con l‟Unità Operativa dell‟Università di Pavia, la
caratterizzazione funzionale di due composti modello, in cui il protoeme mostrava il Fe coordinato
da un‟istidina (come nelle emoproteine), ancorata ad uno dei propionati tramite i) un semplice
legame metilestere (denominato composto Fe-His), oppure ii) un braccio analogo, ma intervallato
da una glicina (denominato Fe-His-Gly). Lo scopo della comparazione fra i due composti era quello
di stabilire il ruolo funzionale della tensione esercitata sul ligando assiale, che era ovviamente
maggiore nel composto Fe-His. Tale indagine, che ha portato ad una pubblicazione su The Journal
of Biological Inorganic Chemistry, ha permesso di evidenziare come tale tensione fosse
particolarmente rilevante nel modulare la dipendenza dal pH sia del potenziale redox sia della
cinetica della forma Fe(II) con il CO. Lo studio ha permesso un‟analisi estremamente dettagliata
della dipendenza dallo stato redox delle varie protonazioni coinvolte, dimostrando come la tensione
131
esercitata dal ligando assiale giuochi un ruolo importante nella protonazione dei vari gruppi
coinvolti.
2) Metalloenzimi
Lo studio si è prevalentemente rivolto alla caratterizzazione funzionale dell‟attività delle
Metalloproteasi di matrice (MMPs, che sono delle endopeptidasi con un atomo di Zn++ nel sito
attivo con un ruolo catalitico)) nei confronti di substrati naturali, in particolare di collageni di vario
tipo fra quelli presenti nel tessuto connettivo.
In particolare, un‟indagine, che ha portato ad una pubblicazione su Protein Science, si è rivolta
alla caratterizzazione funzionale del meccanismo di processamento del collagene IV (il componente
principale della membrana basale) da parte di MMP-2 o Gelatinasi A. Tale enzima, che nella sua
forma attiva è composto da tre domini strutturali (il dominio catalitico, il dominio fibronectinico ed
il dominio emopessinico), si è infatti rilevato particolarmente attivo nei confronti del collagene IV,
processando con efficienza catalitica diversa i due tipi di catene che formano la struttura
tridimensionale del collagene IV. Si è inoltre evidenziato come il dominio emopessinico della
MMP-2 sia fondamentale per il riconoscimento del substrato, in quanto tale dominio da solo è in
grado di inibire efficacemente l‟interazione dell‟enzima con il collagene IV. Inoltre, si è potuto
dimostrare come i prodotti di degradazione del collagene IV, prodotti dall‟attività enzimatica della
MMP-2, svolgano una funzione inibitoria nei confronti della migrazione dei neutrofili attraverso
una membrana artificiale di collagene IV, che simula la membrana basale.
3) Stress ossidativo
Nell‟ambito di tale argomento si è compiuta un‟indagine sulle modifiche intracellulari indotte nei
globuli rossi da stress ossidativi e sul ruolo protettore esercitato da alcuni composti naturali. In
particolare, si è effettuata un‟indagine sul ruolo svolto dalla mangiferina, un estratto naturale di
mango, che ha portato ad una pubblicazione su Biochimica et Biophysica Acta. In tale studio si è
mostrato come la mangiferina protegga gli eritrociti nel corso dell‟ossidazione indotta da H 2O2,
riducendo la deplezione di ATP e GTP e ristabilendo l‟energia di potenziale di carica grazie alla
propria attività di “free radical scavenging”.
Si sono inoltre effettuati degli studi sull‟enzima superossido dismutasi (SOD), che hanno prodotto
una serie di pubblicazioni . In particolare, si è isolata e purificata una SOD ricombinante da batterio
Caulobacter crescentus, in cui l‟atomo di Cu ha rivelato una particolare geometria assiale, associata
ad un‟assai ridotta accessibilità al solvente rispetto ad altre SOD di origine procariotica. Inoltre, è
stato possibile evidenziare in cellule gliali umane ad in motoneuroni di topo un ruolo fondamentale
svolto dalla SOD1 nella modulazione dell‟espressione del recettore della transferrina. Inoltre, anche
l‟espressione della ferritina sembra essere collegata alla presenza di SOD1, confermando un ruolo
centrale della SOD1 nel metabolismo del Fe. Il ruolo rilevante della SOD1 nell‟omeostasi del
potenziale ossido-riduttivo intracellulare è inoltre confermata dall‟effetto della sua iporegolazione
nelle cellule di neuroblastoma. Questa funzione risulta particolarmente importante nei mitocondri,
in quanto una riduzione dell‟espressione di SOD1 è associata ad un‟alterazione del potenziale di
membrana e ad un diminuzione della produzione di ATP. Infine, di particolare rilevanza
fisiopatologia è l‟osservazione che i mutanti naturali di SOD1, associati all‟insorgenza di sclerosi
laterale amiotrofica familiare, vengono segregati preferenzialmente nei mitocondri, in misura
decisamente superiore alla SOD1 nativa. Alla luce delle variazioni funzionali di questi mutanti, si
può perciò iniziare a formulare un meccanismo patogenetico per collegare le alterazioni della
SOD1 alla manifestazione di sclerosi laterale amiotrofica familiare.
132
UNITA’ DI RICERCA DI SIENA
Direttore Scientifico: Prof. Piero Zanello
Nel corso del 2006, l‟Unità di Ricerca di Siena si è ulteriormente arricchita di nuovi gruppi di
ricerca afferenti al Dipartimento Farmaco-Chimico della locale Università risultando così composta
da 7 gruppi di ricerca, ciascuno con proprie competenze nella sintesi, caratterizzazione chimicofisica (strutture molecolari mediante tecniche a Raggi X e mediante tecniche spettroscopiche,
proprietà elettro- e spettroelettro-chimiche e capacità complessante di metalloleganti mediante
misure calorimetriche) e caratterizzazione farmaco-bio-medicale di nuove molecole. Gran parte di
tali gruppi opera in collaborazione con gruppi di ricerca sia nazionali, che internazionali.
1.
Gruppo di ricerca del Professor Piero Zanello
Nel corso dell‟anno 2006 si sono continuate le collaborazioni con il gruppo della Prof. D. Fregona
(Dipartimento di di Scienze Chimiche dell‟Università di Padova) e del Professor L. Messori
(Dipartimento di Chimica dell‟Università di Firenze) sulla capacità ossido-riduttiva di molecole di
potenziale applicazione antitumorale. In particolare, sono stati studiati, e si stanno studiando, per
via elettrochimica e spettroelettrochimica composti sia di Au(III) che di Ru(III) con vari leganti per
determinare se la loro attività biologica possa essere innescata da un meccanismo intracellulare di
attivazione per scambio elettronico.
2.
Gruppo di ricerca del Professor Marco Ferrali
Nel corso dell‟anno 2006, sono continuate le ricerche sui leganti del ferro idrossocromeni
precedentemente sintetizzati (J.Med.Chem., 45, 5776 (2002)) non erano adatti per uso in vivo dal
momento che la complessazione del ferro intracellulare non era sufficiente alla sua estrazione. Si è
così sintetizzato un legante simile, ma più polare e di peso molecolare inferiore in modo che la
complessazione con Fe(III) favorisca ingresso e uscita attraverso le membrane cellulari. Il nuovo
legante mostra complessazione in rapporto legante:metallo 2:1 nei confronti del Fe(III)
nelll‟intervallo di pH da 0 a 9. Sono in corso accertamenti chimico-fisici in soluzione ed test
biologici su cellule in coltura e “in vivo”.
3.
Gruppo di ricerca del Professor Mario Casolaro
L‟attività di ricerca ha riguardato lo sviluppo di idrogeli polimerici „intelligenti‟ sensibili a
varie sollecitazioni esterne (pH, temperatura, concentrazione e tipo di sale, potenziale elettrico) e la
loro interazione con farmaci. Un particolare studio è stato rivolto alla sintesi di nuovi farmaci
polimerici contenenti residui di bis-fosfonati. Questi composti migliorano la crescita cellulare
(osteoblasti) a basse concentrazioni ed in tempi più lunghi rispetto ai corrispondenti farmaci a basso
PM (pamidronato, neridronato).
4.
Gruppo di ricerca dei Professori Vomero, Anzini, Cappelli.
L‟attività scientifica svolta nel 2006 dal gruppo di ricerca ha riguardato:
a)
la progettazione, la sintesi, la caratterizzazione strutturale, e farmacologica di
composti eterociclici di interesse farmaceutico;
b)
lo studio delle proprietà delle sostanze attraverso la determinazione dei parametri che
riguardano il loro successivo inserimento nella formulazione (solubilità, logP, pKa, forma
cristallina epolimorfismo, ecc);
133
c)
la sintesi, caratterizzazione e lo studio delle potenziali applicazioni nel rilascio
controllato di farmaci di matrici polimeriche innovative;
d)
la veicolazione di cluster icosaedrici del boro a cellule tumorali attraverso la
coniugazione con ligandi di recettori sovraespressi nei tessuti tumorali (drug targeting);
e)
lo sviluppo di traccianti per la tomografia ad emissione di positroni (PET).
5.
Gruppo di ricerca del Professor Giuseppe Campiani
Nel corso del 2006 sono proseguite le ricerche chimico-farmaceutiche nei settori delle
malattie neurodegenerative legate al misfolding delle proteine, delle malattie neuropsichiatriche, nel
campo dei farmaci antienzimatici, nel settore dei farmaci antivirali anti-HIV ed anti-HCV, nel
settore dei farmaci antitumorali a struttura taxanica o a struttura eterociclica e nel campo dei
diagnostici per malattie causate da prione e amiloide. L‟ attivita‟ di ricerca e‟ confermate dalle
pubblicazioni sotto riportate.
6.
Gruppo di ricerca del Professor Gianni Valensin
Nel corso del 2006 è proseguita la caratterizzazione strutturale in soluzione di complessi di
ioni metallici con leganti di interesse biologico e farmacologico. In particolare, si sono studiate
mediante tecniche potenziometriche e spettroscopiche (NMR, EPR, UV-Vis, CD) le interazioni tra
ioni Cu2+ e le sequenze aminoacidiche di proteine coinvolte in alcuni processi neurodegenerativi
(morbo di Alzheimer e morbo di Creutzfeldt-Jacob (BSE)). Tali studi sono stati condotti in
collaborazione con il gruppo di ricerca del Prof. H.Kozlowski (Università di Wroclaw, Polonia) e
con il Prof. M.Remelli (Università di Ferrara).
Sono stati caratterizzati mediante 1H-NMR ed altre tecniche spettroscopiche i complessi
metallici (Mg2+, Ce3+) dell‟antibiotico di natura peptidica Ciclosporina A disciolto in acetonitrile. I
dati sperimentali ottenuti sono stati utilizzati ai fini dell‟ottenimento di modelli molecolari e
dinamici dei complessi in questione.
7.
Gruppo di ricerca del Professor Renzo Cini
Nel corso del 2006 è continuata la ricerca su complessi metallici come potenziali farmaci, la
loro sintesi, la loro caratterizzazione strutturale mediante metodi diffrattometrici e di chimica
computazionale. Sono stati effettuati studi ab initio e di funzionali di densità su complessi metallici
e addotti substrato-proteina.
134
UNITA’ DI RICERCA DI TORINO
Direttore Scientifico: Prof. Silvio Aime
L‟attività di ricerca dell‟Unità di Torino si è articolata lungo le seguenti linee e i risultati ottenuti
sono stati oggetto di 31 pubblicazioni a stampa.
Progettazione di sonde MRI ad elevata sensibilità per applicazioni diagnostiche in vivo
Sono stati realizzati vari sistemi a base di Gd che mostrano significativi aumenti della relassività
rispetto ai sistemi pre-esistenti. In particolare è stato dimostrato che un controllo dell‟asse di
rotazione molecolare in coincidenza con l‟asse di coordinazione Gd-H2O porta ad un mancato
aumento della relassività. Altri sistemi a base di Gd che mostrano buona relassività sono stati
realizzati attraverso la formazione di addotti supramolecolari con diverse tipologie di dimeri e
oligomeri di ciclodestrine. Oltre ad un controllo ottimale della solubilità, questi addotti comportano
un buon contributo alla relassività dell‟acqua della seconda sfera di coordinazione, un contributo
che rimane sostanzialmente alto anche a campi magnetici superiori a 1.5T, come richiesto dalle
attuali tendenze nella strumentazione clinica.
Importanti risultati sono stati ottenuti nel contesto della collaborazione con l‟Unità dell‟Università
del Piemonte Orientale e l‟Università di Berkeley mettendo a punto procedure sintetiche per la
formazione di addotti supramolecolari a base di Fe e Gd. Questi sistemi mostrano valori di
relassività molto interessanti.
Nel processo di ottimizzazione delle relazioni tra i parametri strutturali e dinamici dei complessi di
gd e le loro proprietà rilassometriche sono stati studiati nuovi derivati nella classe degli HOPO e
nella classe dei complessi contenenti gruppi fosfonici. Questi studi hanno permesso un ulteriore
progresso nella messa a punto di un controllo accurato della velocità di scambio dell‟acqua
coordinata al centro metallico.
Oltre all‟aumento di relassività per ogni unità di Gd, il problema della scarsa sensibilità delle sonde
MRI per applicazioni di Imaging Molecolare è stato affrontato sviluppando sistemi contenenti molte
unità di complessi paramagnetici. Un sistema particolarmente efficiente è rappresentato dalla
apoferritina la cui cavità interna sia caricata di complessi paramagnetici. E‟ stato dimostrato che un
grande contributo alla relassività osservata arriva dall‟interazione tra i centri paramagnetici e i
protoni mobili della proteina. In questo contesto sono anche stati studiati sistemi micellari e
dendrimerici; per questi ultimi è stato dimostrato come un ulteriore aumento di relassività può
essere raggiunto attraverso il controllo del moto locale dei frammenti portanti le unità di chelato
paramagnetico.
Nell‟ambito dello sviluppo di sistemi la cui relassività sia responsiva ad uno specifico parametro del
microambiente in cui la sonda viene a distribuirsi, ci si è occupati di un sistema in grado “mappare”
il pH. Infatti è stato dimostrato che è possibile, con un opportuno “design” della sonda mettere a
punto un metodo raziometrico (basato sulla misura del rapporto R2/R1) che riporta sul valore locale
di pH in modo indipendente dal valore della concentrazione locale della sonda.
Ancora nel settore dei complessi di Gd è stato dimostrato che il loro uso può essere particolarmente
vantaggioso anche per l‟acquisizione di immagini di nuclei diversi da 1H, come 31P, 19F e 13C. Per
questa applicazione è necessario progettare la struttura del complesso paramagnetico in modo che
essa formi un complesso ternario con la specie contenente l‟eteronucleo di interesse (es. fosfato,
lattato,…).
Oltre ai complessi paramagnetici dei Lantanidi, molto lavoro è stato dedicato al settore delle
molecole iperpolarizzate ottenute dalla reazione del para-idrogeno e substrati insaturi. Queste
molecole sono di grande interesse per la messa a punto di una nuova classe di sonde MRI che
permettano l‟acquisizione di immagini di nuclei diversi da 1H, principalmente 13C. L‟attenzione si è
focalizzata sul meccanismo attraverso il quale l‟ordine di spin introdotto con l‟addizione simultanea
135
dei due atomi di idrogeno della molecola di p-H2 può essere trasformato in un grande aumento di
magnetizzazione della risonanza dell‟eteronucleo di interesse.
Studi rilassometrici e MRI di sistemi cellulari
Sono state messe a punto diverse procedure di marcatura delle cellule in vitro. Utilizzando un
agente di contrasto commerciale (Pro-Hance) sono state marcate insule pancreatiche umane
ottenendo un grado di contrasto molto elevato che ha permesso la visualizzazione delle insule sul
fegato di topo anche diversi mesi dopo il trapianto.
Un risultato importante è stato quello di mettere in relazione la stabilità dei complessi di Gd con la
capacità delle cellule di agire come “spugna” nei confronti di questo ione metallico. Infatti mentre
non ci sono problemi nella marcatura cellulare con complessi ad alta stabilità termodinamica (quali
Gd-DOTA, Gd-HPDO3A, Gd-DTPA logK>22), l‟uso di sistemi quali Gd-DTPA-BMA (logK ~ 17)
comporta il rilascio di significative quantità di ioni Gd3+. Essi vengono ad interferire con il
metabolismo degli ioni Ca2+ (bloccando i canali e interferendo con la sua omeostasi) causando una
elevata riduzione della vitalità cellulare.
L‟utilizzo MRI di cellule marcate con complessi di Gd richiede una buona conoscenza della
localizzazione della sonda. Infatti la relassività osservata è dipendente dalla localizzazione
citoplasmatica o nelle vescicole endosomiali del complesso paramagnetico in quanto l‟effetto
risultante nelle immagini MRI è dipendente dalla differenza tra la velocità di rilassamento tra i
diversi comparti (extracellulare/citoplasma/endosoma) e la relativa velocità di scambio dell‟acqua
attraverso le membrane che separano i comparti in questione. La modulazione della velocità di
scambio dell‟acqua attraverso la membrana cellulare è pertanto un parametro di estrema importanza
nel determinare il grado di contrasto in un‟immagine MRI di sistemi cellulari marcati con complessi
paramagnetici. Al fine di comprendere meglio questo aspetto è stato sviluppato uno studio su
sistemi modello costituiti da eritrociti utilizzando l‟HR-MAS come tecnica di indagine. Questa
ricerca ha permesso di misurare con buona accuratezza il valore della velocità di scambio
dell‟acqua attraverso la membrana cellulare e ha fornito interessanti spunti per sviluppare questa
procedura per la caratterizzazione funzionale di sistemi cellulari.
In collaborazione con il MaxPlanck Institute di Colonia (specializzato in Neuro-Imaging) è stato
sperimentato un nostro agente di contrasto responsivo all‟attività enzimatica in Astrociti. Si tratta di
un particolato di complessi insolubili di Gd che, internalizzati per fagocitosi, diventano solubili a
seguito dell‟attività di enzimi idrolitici. Il lavoro sta procedendo con la messa a punto di sistemi
responsivi alla differenziazione di cellule staminali.
Sonde e procedure MRI per la visualizzazione di tumori
Sono state messe a punto sonde a base di complessi di Gd funzionalizzate con la glutamina per la
visualizzazione delle cellule tumorali che mostrano una sovraregolazione dei trasportatori di questo
amminoacido. Infatti le cellule tumorali per poter proliferare rapidamente hanno bisogno di grandi
quantità di nutrienti quali zuccheri ed amminoacidi. La glutammina presente a concentrazioni
dell‟ordine di 0.4 mM nei fluidi biologici è ritenuta uno dei principali nutrienti delle cellule
tumorali. Utilizzando complessi di Gd funzionalizzati con la glutamina è stato possibile visualizzare
sia in vitro che in vivo diverse tipologie di cellule tumorali. Per quanto riguarda le applicazioni in
vivo sono stati utilizzati sia modelli murini basati sull‟inoculo sottocute di cellule tumorali, sia topi
transgenici che sviluppano spontaneamente tumori alla mammella (HER/c-neu) e che meglio
simulano lo sviluppo del tumore umano.
Un altro “target” ha riguardato le molecole di adesione (N-CAM) che vengono iperespresse sulla
parete delle cellule endoteliali della vascolatura neo-formata nella regione tumorale.
Con la tecnica del Phage-Dislay è stato identificato un peptide che presenta una buona affinità per
questo target. Quindi è stata messa a punto una procedura basata sul costrutto peptidebiotina/avidina/Apoferritinabiotinilata caricata con Gd-HPDO3A. Eè stato possibile raggiungere
136
una buona visualizzazione dell‟endotelio tumorale su topi immunodepressi ai quali erano state
inoculate le cellule dell‟aendotelio tumorale.
In questo settore il lavoro sta procedendo nella direzione di utilizzare anche atri target. La
validazione di questi target richiede innanzitutto la loro quantificazione per cui si sono messe a
punto procedure MRI basate sull‟impiego degli ossidi di ferro come agenti superparamagnetici ad
altissima sensibilità.
137
138
UNITA’ DI RICERCA DI TRIESTE
Direttore Scientifico: Prof. Ennio Zangrando
- Nuovi Composti di RUTENIO-DMSO con Leganti di Carbossilati
I farmaci di platino cosiddetti di seconda e terza generazione che sono attualmente in uso clinico
sono formalmente derivati dal cisplatino (cis-[PtCl2(NH3)2]) per sostituzione dei gruppi anionici
uscenti e/o dei gruppi amminici. Nel carboplatino, [Pt(cbdc)(NH3)2] (cbdc= 1,1-ciclobutandicarbossilato), i due cloruri uscenti sono stati sostituiti da un chelante dicarbossilato. Un altro
composto di platino con un legante dicarbossilato, recentemente approvato per il trattamento del
cancro al colon, è l‟ossaliplatino, [Pt(dach)(ox)] (dach = R,R-1,2-diaminocicloesano, ox = ossalato)
(Figura 1).
O
H3N
H2N
O
O
Pt
Pt
H3N
O
H2N
O
O
O
O
carboplatino
ossaliplatino
E‟ altresì noto che in soluzione fisiologica i composti antitumorali di Ru-Cl-dmso da noi sviluppati,
compreso il NAMI-A (Figura 2), idrolizzano dei cloruri generando le specie attive.
E‟ dunque ragionevole ipotizzare che, come nel caso dei composti
attivi di Pt(II), anche per i composti antitumorali di rutenio la
NH
sostituzione dei cloruri con carbossilati o dicarbossilati chelanti possa
provocare un significativo cambiamento nei processi di idrolisi e di
NH conseguenza nella bio-distribuzione e nell‟attività di tali composti.
N
Cl
Cl
Si è quindi intrapreso lo studio della reattività dei precursori di Ru-ClRu
dmso verso dicarbossilati allo scopo di sviluppare una nuova serie di
Cl
Cl
N
composti in cui, al posto degli alogeni, siano coordinati al Ru anioni
S
H
ossigenati. Si è iniziato dai composti di Ru(II) in quanto, essendo
O
diamagnetici, permettono l‟uso della spettroscopia NMR per la loro
caratterizzazione.
NAMI-A
Sono stati presi in considerazione tre precursori di Ru(II), i due isomeri
neutri cis,fac-[RuCl2(dmso-S)3(dmso-O)], trans-[RuCl2(dmso-S)4] ed il composto privo di cloruri
fac-[Ru(dmso-O)3(dmso-S)3][O3SCF3]2. I leganti dicarbossilati utilizzati sono stati il malonato
(mal), l‟1,1-ciclobutan-dicarbossilato (cbdc), il succinato (suc) e l‟ossalato (ox) (Figura 3).
O
C OC1
C OO
cbdc
O
C OC1
C OO
mal
OO C
C
C
C OO
suc
O
O
C
C
OO-
ox
In sintesi, sono stati preparati numerosi nuovi complessi, sia mono- (1 – 5) che di- (6 – 11) che
tetra-nucleari (12), raccolti schematicamente in Figura 4. Tutti i complessi sintetizzati sono stati
139
caratterizzati spettroscopicamente e, in quasi tutti i casi, ne è stata determinata anche la struttura
allo stato solido tramite diffrazione di raggi X. Tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro carica
e nuclearità, presentano il frammento fac-Ru(dmso-S)3, che è molto stabile.
n
X
S
Ru
X
O
S
S
O
1:
2:
3:
4:
5:
O
Ru
S
O
O
S
O
n
-1
0
-1
0
-1
X
n
6: Cl
0
7: O-dmso +2
S
Ru
S
O
S
X
S
O
S
O
O
O
S
S
S
Ru
Ru
S
S
O
O
O
O
9:
suc
H2O
O
S
O
X
H2O
S
O
O
mal
Ru
O
O
X
8:
S
X
O
S
S
Ru
S
X
ox
Cl
ox
O-dmso
mal Cl
mal O-dmso
cbdc Cl
n
S
S
Ru
S
O
O
S
S
O
O
S
10: cbdc H2O
Ru
12
11: cbdc NH3
E‟ interessante inoltre notare che cbdc e mal, nonostante la somiglianza strutturale, presentano
differenti modi preferenziali di coordinazione: mal preferisce legarsi come chelante (η2-mal) al
frammento fac-Ru(dmso-S)3, mentre cbdc preferisce la coordinazione a ponte (μ-cbdc). Infine, è
stato studiato il loro comportamento in soluzione acquosa tramite spettroscopia NMR nella
prospettiva di valutarne in seguito l‟eventuale attività antitumorale.
- Modelli della Vitamina B12 e complessi di cobalto
Recentemente l‟interesse per i bioconiugati della vitamina B12 (CNCbl, dove CNCbl =
cianocobalamina, vedi Figura) è cresciuto sensibilmente, soprattutto per quanto riguarda le
applicazioni in ambito terapeutico e diagnostico. E‟ noto da lungo tempo, infatti, che le cellule di
tessuti che proliferano rapidamente richiedono grandi quantità di vitamina B12. Tramite la sintesi di
opportuni bioconiugati si intende sfruttare questo fenomeno per veicolare agenti di contrasto per
l‟imaging o agenti citotossici all‟ interno di queste cellule.
La vitamina B12 è un nutriente essenziale per i mammiferi, i quali non la producono e devono
assumerla col cibo. Il suo passaggio dall‟apparato digerente alle cellule coinvolge tre proteine di
trasporto: l‟aptocorrina, il fattore intrinseco e la transcobalamina (TC). Nell‟ultimo stadio il
complesso TC-CNCbl entra nelle cellule tramite un processo di endocitosi mediata da un recettore
della membrana cellulare. La CNCbl è dotata di molti gruppi funzionali che possono essere
facilmente modificati, ma la scelta tra essi per la realizzazione del bioconiugato deve tenere conto
dell‟efficienza della molecola risultante nel raggiungere le cellule bersaglio. Quindi l‟affinità del
bioconiugato per la TC non deve diminuire significativamente. Recenti studi cristallografici
140
condotti presso la nostra unità di ricerca di Trieste sulla TC umana e bovina hanno rivelato che il
gruppo 5‟-idrossile della CNCbl può venire funzionalizzato senza compromettere sensibilmente la
formazione del complesso TC-CNCbl.
Sulla base di queste informazioni sono stati progettati e sintetizzati due leganti bioconiugati,
CNCbl-DTPA (vedi Figura) e CNCbl-TTHA, tramite l‟esterificazione del gruppo 5‟-idrossile della
CNCbl con la dianidride del DTPA (acido dietilenetriammino- N, N, N‟, N‟‟, N‟‟-pentacetico) e del
TTHA (acido trietilenetetrammino, N, N, N‟, N‟‟, N‟‟‟, N‟‟‟- esacetico).
La reazione di questi leganti bioconiugati con il Gd3+ porta alla sintesi dei potenziali agenti di
contrasto paramagnetici CNCbl-DTPA-Gd e CNCbl-TTHA-Gd.
Studi di caratterizzazione dei leganti bioconiugati e dei loro complessi col Gd3+ sono attualmente in
corso.
CONH2
CONH2
CONH2
CH3
CONH2
A
H
N
H2 NOC
CH3
O
NH
H
H3C
N
CH3
CONH2
O
P
O
CH3
C
CH3
CH3
CH3
N
CONH2
CH3
N
H
H3 C
O
HO
O
N
NH
CH3
N
N
CH3
CH3
O
O
O
C
N
D
H2 NOC
N
D
CN
Co
H
Co
B
N
H3C
N
N
H3C
A
H3 C
B
CN
CH3
CONH2
CH3
CONH2
H3C
CONH2
CH3
CONH2
CH3
HO
O
P
O
O O
COOH
O
O
HO
OH
N
N
O
OH
N
OH
O
O
CNCbl
CNCbl-DTPA
- Studio strutturale del riconoscimento molecolare tra antigene e anticorpo nella
crioglobulinemia mista di tipo II associata a infezione da HCV.
In collaborazione il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, si sta sviluppando uno
studio strutturale che si colloca all‟interno di un progetto di ricerca sulle problematiche inerenti alle
complicanze associate all‟infezione da virus dell‟epatite C (HCV) e, in particolare, la
crioglobulinemia mista di tipo II (CM), una malattia cronica di tipo autoimmunitario caratterizzata
da proliferazioni oligoclonali di linfociti B, che in un significativo numero di casi esita ad un
linfoma non Hodgkin (NHL) conclamato .
E‟ stato recentemente dimostrato che, in pazienti affetti da crioglobulinemia mista, le
immunoglobuline di tipo M (IgM) con attività di fattore reumatoide, presenti nel crioprecipitato,
sono analoghe ai recettori esposti delle cellule B monoclonali che in questi pazienti proliferano in
maniera incontrollata, generando in alcuni di essi linfomi non-Hodgkin. La crioglobulinemia è il
risultato della produzione da parte dei linfociti B di immunoglobuline di tipo M (IgM) bispecifiche,
capaci cioè di riconoscere non solo l‟antigene virale (la proteina non strutturale NS3 di HCV), ma
anche la regione costante delle immunoglobuline di tipo G (Fc-IgG). La risposta autoimmune, oltre
a causare la formazione di crioprecipitati composti dai complessi IgM-IgG (crioglobulinemia),
provoca una anomala stimolazione dei linfociti B che si ritiene possa facilitare l‟insorgenza della
patologia neoplastica.
141
L‟obiettivo del presente studio è quello di comprendere le basi molecolari di questa bispecificità,
attraverso l‟analisi della struttura cristallografica delle interazioni IgM-NS3 e IgM-Fc (IgG).
Le immunoglobuline sono glicoproteine flessibili, in grado di assumere un‟ampia varietà di
conformazioni grazie alla mobilità delle loro subunità. Questa caratteristica permette di assolvere
due compiti fondamentali, il riconoscimento e la successiva eliminazione dei corpi estranei come
virus e batteri, ma determina anche la difficoltà di cristallizzazione delle immunoglobuline e la
conseguente scarsità della letteratura al riguardo. Si è pensato quindi di utilizzare un approccio
indiretto a questo studio strutturale: si è deciso di procedere alla produzione, purificazione e
cristallizzazione di un frammento dell‟immunoglobulina in esame, costituito dalle parti variabili
della catena leggera e della catena pesante, responsabili del riconoscimento molecolare
dell‟antigene, legate in modo covalente attraverso un linker che permetta il corretto ripiegamento
delle subunità immunoglobuliniche.
La proteina ricombinante ScFv (Single Chain Variable Fragment) è stata prodotta dalla Dott.sa
Valli De Re presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, utilizzando una sequenza di IgM
individuata dal crioprecipitato di un paziente HCV positivo affetto da crioglobuninemia mista. La
proteina prodotta è costituita dalla sequenza della parte variabile della catena leggera del paziente,
legata attraverso il linker (Ser-Gly4)3 alla sequenza relativa alla parte variabile della catena pesante.
Sono inoltre presenti un frammento N-terminale (tag) utile per la purificazione e un frammento Cterminale che consente la formazione di frammenti attivi bispecifici utili alla verifica in vitro della
reattività della proteina prodotta.
Questa proteina è stata ottenuta nei corpi di inclusione di batteri E. Coli, utilizzando un vettore di
espressione inducibile. La lisi delle cellule, condotta presso il Laboratorio del Centro di Eccellenza
in Biocristallografia dell‟Università di Trieste, ha permesso di separare i corpi di inclusione,
successivamente solubilizzati in una soluzione tampone a pH 8.3 contenente guanidinio, utilizzato
come agente caotropico.
Il campione è stato successivamente purificato mediante cromatografia di esclusione FPLC, su
colonna Superdex 200 HR 10/30 (Amersham Biosciences), utilizzando come eluente la stessa
soluzione denaturante. L‟analisi elettroforetica su gel di poliacrilamide ha permesso di controllare la
purezza della proteina in questa soluzione.
A dispetto del vantaggio di ottenere in modo semplice una discreta quantità di proteina,
l‟espressione nei corpi di inclusione batterici presenta il notevole svantaggio di richiedere una
procedura di refolding della proteina purificata. Infatti, a causa della scarsa solubilità della forma
attiva del frammento di immunoglobulina, le cellule di E. Coli producono questa proteina in forma
denaturata. Presso il laboratorio del Centro di Eccellenza in Biocristallografia dell‟Università di
Trieste sono state eseguite prove di refolding del frammento di immunoglobulina prodotto,
utilizzando metodi di diluizione e di dialisi, in presenza di diversi additivi (ossidanti, additivi che
evitando l‟aggregazione) e a pH tra 4 e 9.5.
La resa massima, valutata per via spettrofotometrica, del processo di refolding nei diversi
esperimenti è risultata di 48%. Tuttavia, dopo aver concentrato questa soluzione, si è osservato che
la concentrazione di proteina non cambiava, mentre si riscontrava la presenza sempre più
abbondante di un precipitato bianco. E‟ probabile che la forma della proteina ottenuta sia poco
solubile ed abbia perciò raggiunto la massima concentrazione possibile (circa 0.11 mg/mL), non
sufficiente per i successivi esperimenti di cristallizzazione.
Considerando le difficoltà incontrate nella rinaturazione di questa proteina, si è deciso di
analizzarne la struttura, per verificare quali mutazioni nella sequenza primaria prodotta dal sistema
di espressione potessero aumentarne la solubilità. La solubilità è influenzata principalmente dagli
amminoacidi che si trovano esposti sulla superficie della proteina nella sua struttura
tridimensionale. Non disponendo di dati sperimentali per questa struttura, è stato necessario
modellizzarla a partire da strutture note di immunoglobuline.
Attraverso il software BLAST , è stata effettuata la ricerca di sequenze simili a quella della proteina
in esame nel database Protein DataBank (PDB), che contiene le strutture tridimensionali
determinate per via sperimentale attraverso diffrazione di raggi X oppure tecniche di risonanza
142
magnetica. Le strutture trovate sono state valutate in base alla somiglianza che presentavano con la
sequenza del ScFv e alla qualità dei dati da cui sono state ricavate. La struttura della proteina in
esame è stata quindi ricostruita a partire da frammenti appartenenti alle proteine individuate nel
Protein DataBank. Alcuni residui sono stati mutati utilizzando il programma di grafica molecolare
“O”.
Le strutture così ottenute hanno suggerito di apportare alcune modifiche alla sequenza della
proteina ricombinante prodotta dal sistema di espressione. La produzione della proteina con la
sequenza modificata è in corso presso il laboratorio del Centro di Riferimento Oncologico di
Aviano.
143
144
PUBBLICAZIONI E BREVETTI
145
146
A
Aime S., Geninatti Crich S., Gianolio E., Giovenzana G.B., Tei L., Terreno E.:
High Sensitivity Lantanide(III) Based Probes for MR-Medical Imaging.
Coord. Chem. Rev., 2006, 250(11+12), 1562-1579.
Aime S., Fedeli F., Sanino A., Terreno E.
A R2/R1 ratiometric procedure for a concentration-independent, pH-responsive, Gd(III)-based MRI
agent.
J. Am. Chem. Soc., 2006, 128(35), 11326-7.
Aime S., Gianolio E., Palmisano G., Robaldo B., Barge A., Boffa L., Cravotto G.
Improved syntheses of bis(β-cyclodextrin) derivatives, new carriers for gadolinium complexes.
Org. Biomol. Chem. 2006, 4, 1124-1130.
Aime S., Gianolio E., Uggeri F., Tagliapietra S., Barge A., Cravotto G.
New paramagnetic supramolecular adducts for MRI applications based on non-covalent interactions
between Gd(III)-complexes and beta- or gamma-cyclodextrin units anchored to chitosan.
J. Inorg. Biochem., 2006, 100(5-6), 931-8.
Aime S., Giovenzana G.B., Longo D., Terreno E.
Design of Contrast Agents for Molecular Imaging In Vivo. in “In Vivo MR Techniques in Drug
Discovery and Development.
(Ed. N. Beckmann), Taylor & Francis, New York, 2006, chap. 4, pp. 47-72.
Aime S., Gobetto R., Reineri F., Canet D.
Polarization transfer from para-hydrogen to heteronuclei: Effect of H/D substitution. The Case of
AA'X and A(2)A'X-2 spin systems.
Journal Of Magnetic Resonance, 2006, 178, 184-192.
Akinola O.B., Dosunmu O.O., Dini L., Ajayi S.
Proteinaceous diet inhibits gossypol-induced spermatototoxicity.
Eur. J. Histochem, 2006, 50(3), 205-8.
Aldinucci D., Lorenzon D., Stefani L., Giovagnini L., Colombatti A., Fregona D.
Antiproliferative and apoptotic effects of two new gold(III) methylsarcosinedithiocarbamate
derivatives on human acute myeloid leucemia cells in vitro.
Anticancer Drugs, 2006.
Alterio V., Vitale R.M., Monti S. M., Pedone C., Scozzafava A., Cecchi A., De Simone G.,
Supuran C.T.
Carbonic Anhydrase Inhibitors: X-ray and Molecular Modeling Study for the Interaction of a
Fluorescent Antitumor Sulfonamide with Isozyme II and IX.
Journal of the American Chemical Society, 2006, 128(25), 8329-8335.
Amendola V., Boiocchi M., Colasson B., Fabbrizzi L.
Metal-Controlled Assembly and Selectivity of a Urea-Based Anion Receptor.
Inorg. Chem. 2006, 45(16), 6138-6147.
Amendola V., Bonizzoni M., Esteban-Gómez D., Fabbrizzi L., Licchelli M., Sancenón F., Taglietti A.
Some guidelines for the design of anion receptors
Coord. Chem. Rev. 2006, 250(11+12), 1451-1470.
147
Amendola V., Esteban-Gómez D., Fabbrizzi L., Licchelli M.
What Anions Do to N-H-Containing Receptors
Acc. Chem. Res. 2006, 39(5), 343-353.
Amendola V., Fabbrizzi L., Foti F., Licchelli M., Mangano C., Pallavicini P., Poggi A., Sacchi D.,
Taglietti A.
Light Emitting Molecular Devices Based on Transition Metals.
Coord. Chem. Rev., 2006, 250, 273–299.
Aquilano K., Vigilanza P., Rotilio G., Ciriolo M.R.
Mitochondrial damage due to SOD1 deficiency in SH-SY5Y neuroblastoma cells: a rationale for
the redundancy of SOD1.
FASEB J. 2006, 20, 1683-1685.
Arnhold J., Monzani E., Furtmüller P. G., Zederbauer M., Casella L., Obinger C.
Kinetics and thermodynamics of halide and nitrite oxidation by mammalian heme peroxidases.
Eur. J. Inorg. Chem., 2006, 3801-3811.
Arrais A., Gobetto R., Rossetti R., Diana E.
Synthesis and spectral characterization of water-soluble derivatives of C-70 and high-order
fullerene mixture (C-76, C-78 and C-84) achieved by chemically induced air oxidation.
New Diamond And Frontier Carbon Technology, 2006, 16(2), 79-96.
Auriemma F., De Rosa C., Triolo R.
Slow Crystallization Kinetics of Poly(vinyl alcohol) in Confined Environment during Cryotropic
Gelation of Aqueous Solutions.
Macromolecules, 2006, 39, 9429-9434.
Avato P., Rosito I., Papadia P., Fanizzi F. P.
Characterization of seed oil components from Nephelium lappaceum L.
Nat. Prod. Comm., 2006, 1(9), 751-755.
B
Battaini G., Granata A., Monzani E., Gullotti M., Casella L.
Biomimetic oxidations by dinuclear and trinuclear copper complexes.
Adv. Inorg. Chem., 2006, 58, 185-233.
Bagni G., Osella D., Sturchio E., Mascini M.
Deoxyribonucleic acid (DNA) Biosensors for Environmental Risk Assessment and Drug Studies.
Anal. Chim Acta, 2006, 573-574, 81-98.
Bagno A., Bertazzi N., Casella G., Pellerito L., Saielli G., Sciacca I. D.
Structure of D-ribonic acid-dimethyltin(IV) in coordinating solvents: an experimental and DFT
119
Sn NMR study.
J. Phys. Org. Chem., 2006, 19, 874-883.
Bambagiotti-Alberti M., Bruni B., Costantino F., et al.
N-{(2RS)-2-hydroxy- 3-[2-(3-phenylpropanoyl)-phenoxy] propyl} propanaminium chloride.
Acta Crystallographica E- Structure Reports Online. 2006, E62, O1694-O1695.
Bandoli G., Dolmella A., Gioia Lobbia G., Papini G., Pellei M., Santini C.
148
Synthesis and characterization of divalent metal complexes containing the heteroscorpionate
ligand dihydrobis(3-carboxyethyl-5-methylpyrazolyl)borate.
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 4036–4042.
Barba V., Farfán N., Losi S., Zanello P.
Ferrocenylboronates, Crystal Structures and Electrochemical Properties.
Inorg.Chim.Acta, 2006, 359, 1269.
Beghetto E., Gargano N., Ricci S., Garufi G., Peppoloni S., Montagnani F., Oggioni M., Pozzi G.,
Felici F.
Fems Microbiology Letters 2006, 262, 14-21.
Benedetti E.
The Journal of Peptide Science-Special Issue dedicated to the 10th Naples workshop on Bioactive.
Peptides. Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 2006,
12(12), 739.
Benedetti M., Fanizzi F.P., Maresca L., Natile G.
The unexpected reactivity of Zeise's anion in strong basic medium discloses new substitution
patterns at the platinum centre.
Chemical Communications. 2006, pp. 1118-1120.
Benedetto S., Pulito R., Crich S.G., Tarone G., Aime S., Silengo L., Hamm J.
Quantification of the expression level of integrin receptor alpha(v)beta3 in cell lines and MR
imaging with antibody-coated iron oxide particles.
Magn. Reson. Med., 2006, 56(4), 711-6.
Beninati C., Midiri A., Mancuso G., Biondo C., Arigo M., Gerace E., Papasergi S., Gambuzza M.,
Boretti M., Magliani W., Conti S., Polonelli L., Teti G.
Journal of Experimental Medicine 2006, 203, 111-118.
Bergman S. D., Goldberg I., Carfagna C., Mosca L., Kol M., Milani B.
Palladium Complexes Containing Large Fused Aromatic N-N Ligands as Efficient Catalysts for the
CO/Styrene Copolymerization.
Organometallics, 2006, 25, 6014-6018.
Bernardi F., Gaggelli E., Moltenii E., Porciatti E., Valensin D., Valensin G.
1
H And 13C-NMR and Molecular Dynamics Studies of Cyclosporin a Interacting With
Magnesium(II) or Cerium(III) in Acetonitrile. Conformational Changes and Cis-Trans Conversion
of Peptide Bonds.
Biophys.J., 2006, 90, 1350.
Bernini, Spiga O., Ciutti A., Venditti V., Prischi F., Governatori M., Bracci L., Lelli B., Pileri S.,
Botta M., Barge A., Laschi F., Niccolai N.
NMR studies of BPTI aggregation by using paramagnetic relaxation reagents.
Biochim. Biophys. Acta, 2006, 1764, 856-862.
Berti F., Gaggelli E., Guerrini R., Janicka A., Kozlowski H., Legowska A., Miecznikowska H.,
Migliorini C., Pogni R., Remelli M., Rolka K., Valensin D., Valensin G.
Structural and Dynamic Characterization of Copper(II) Binding of the Human Prion Protein Outside
the Octarepeat Region.
Chem.Eur.J., 2006, 13, 434.
149
Bettio F., Baccichetti F., Simonato M., Marzano C., Bordin F.
T4 Phage photoinactivation by linear furocoumarins and angular furoquinolinones.
ChemMedChem, 2006, 1, 1-3.
Bettio F., Canevari M., Marzano C., Bordin F., Guiotto A., Greco F., Duncan R., Veronese F.M.
Synthesis and biological evaluation of novel PEG-psoralen conjugates.
Biomacromolecules, 2006, 7, 3534-41.
Bigoli F., Deplano P., Mercuri M.L., Marchiò L., Pilia L., Serpe A., Concas G., Congiu F., Sanna S.
Structure and characterization of [Pt(Me2pipdt)2][Pt(mnt)2]2 and its unusual magnetic properties
associated with a non-regular one-dimensional [Pt(mnt)2] stack.
Chemical Physics Letters. 2006, 421, 361-366.
Biondo C., Mancuso G., Midiri A., Bombaci M., Messina L., Beninati C., Teti G.
Fems Yeast Research 2006, 6, 645-651.
Biscarini P., Benedetti M., Kuroda R., Ferranti F.
Transfer of chirality in complexes with D3 symmetry: kinetics of the formation reaction of chiral
tris[O,O'-bis(2-methylbutyl)dithiophosphato]chromium(III) complexes (L,D)-[Cr{(+-)-mebdtp}3],
D-(+)589- and L-(-)589-[Cr{(+)-(S)(S)-mebdtp}3].
Eur. J. Inorg. Chem., 2006, 16, 3167-3176.
Boccarelli A., Giordano D., Natile G., Coluccia M.
Differential processing of antitumour-active and antitumour-inactive trans platinum compounds by
SKOV-3 ovarian cancer cells.
Biochemical Pharmacology. 2006, vol. 72(3), pp. 280-292.
Boccarelli A., Intini F.P., Sassanelli R., Sivo M.F., Coluccia M., Natile G.
Synthesis and in vitro antitumor activity of platinum acetonimine complexes.
Journal of Medicinal Chemistry. 2006, vol. 49, pp. 829-837.
Bombieri G., Marchini N., Clattini S., Mortillaro A., Aime S.
The crystallized solvent could influence the lanthanide water bonding.
Inorganica Chimica Acta, 2006, 359, 3405-3411.
Bonelli B., Onida B., Chen J.D., Galarneau A., Di Renzo F., Fajula F., Fubini B., Garrone E.
Characterisation of Al-rich microporous micelle-templated silicates. Part II: Spectroscopic and
microcalorimetric study of the accessibility of exchanged alkali-cations to carbon dioxide.
Microporous And Mesoporous Materials, 2006, 87(3), 170-176.
Bonizzoni M., Fabbrizzi L., Taglietti A., Tiengo F.
(Benzylideneamino)thioureas – chromogenic interactions with anions and N-H deprotonation
Eur. J. Org. Chem. 2006, 3567-3574.
Bonomo R.P., La Mendola D., Pappalardo G., Rizzarelli E., Sovago. I
Coordination features of prion protein domains.
In “Recent Development in Bioinorganic Chemistry: Metal Complexes of Bioactive Molecules”,
2006, 133-160, Ed:Michele Saviano, Transworld Research Network.
Braga D., Grepioni F., Polito M., Chierotti M.R., Ellena S., Gobetto R A.
Solid-gas route to polymorph conversion in crystalline [Fe-II(eta(5)-C5H4COOH)(2)]. A diffraction
and solid-state NMR study.
150
Organometallics, 2006, 25(19), 4627-4633.
Brasun J., Matera A., Oldziej S., Swiatek-Kozlowska J., Messori L., Gabbiani C., Orfei M.,
Ginanneschi M.
The copper(II) coordination abilities of three novel cyclic tetrapeptides with -His-Xaa-His- motif.
J. Inorg. Biochem. 2006, Nov 21.
Bronstein L. M., Khotina I. A., Chernyshov D. M., Valetsky P. M., Timofeeva G. I., Dubrovina L.
V., Stein B., Karlinsey R., Triolo A., Weidenmann A., Lo Celso F., Triolo R., Khokhlov A. R.
Morphology of hybrid polystyrene-block-poly(ethylene oxide) micelles: Analytical
ultracentrifugation and SANS studies.
Journal of Colloid and Interface Science, 2006, 299, 944–952.
Bruni P., Pisani M., Amici A., Marchini C., Montani M., Francescangeli O.
Applied Physics Letters, 2006, 88, 73901-1-3;
Bruno E., Digilio G., Cabella C., De Reggi A., Baroni S., Mainero V., Aime S.
Water exchange across the erythrocyte plasma membrane studied by HR-MAS NMR spectroscopy.
Magn. Reson. Med., 2006, 56(5), 978-85.
Bruno G., Nicoi F., Rotondo A., Risitano F., Grassi G., Foti F.
Helvetica Chimica Acta 2006, 89, 190-200.
Bruno G., Rotondo A., Brancatelli G., Nicolo F., Marino N.
Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications. 2006, 62, O587-O589.
Buchowicz W., Jerzykiewicz L.B., Krasińska A., Losi S., Pietrzykowski A., Zanello P.
Ansa-Nickelocenes by the Ring-Closing Metathesis Route: Syntheses, X-Ray Crystal Structures,
and Physical Properties.
Organometallics, 2006, 25, 5076.
Bussolati, Grange C., Bruno S., Buttiglieri S., Deregibus M. C., Tei L., Aime S., Camussi G.
Neural-cell adhesion molecule (NCAM) is expressed by immature and renal tumour-derived
endothelial cells and favours endothelial cell organization into capillary-like structures.
Experim. Cell Res., 2006, 312, 913-924.
C
Calderone V., Casini A., Mangani S., Messori L., Orioli P.L.
Structural investigation of cisplatin-protein interactions: selective platination of His19 in a
cuprozinc superoxide dismutase.
Angew Chem. Int. Ed. Engl. 2006, 45(8), 1267-9.
Calucci L., Englert U., Grigiotti E., Laschi F., Pampaloni G., Pinzino C., Volpe M., Zanello P.
Synthesis and Characterization of Chromium(I) Bis( 6-Toluene) Derivatives Containing Sterically
Demanding Anions.
J.Organomet. Chem., 2006, 691, 829.
Calvanese L., Saporito A., Marasco D., D'Auria G., Minchiotti G., Pedone C., Paolillo L., Falcigno
L., Ruvo M.
Solution Structure of Mouse Cripto CFC Domain and Its Inactive Variant Trp107Ala.
Journal of Medicinal Chemistry, 2006, 49(24), 7054-7062.
Camporese D., Melendez-Alaford L., Nadali A., Zangoni E., Mazzi U.
151
Lanreotide direct Labelling with Rhenium-188: Stability, biodistribution and preliminary studies
of the chemical structure.
In Technetium,Rhenium and Other Metals, in Chemistry and Nuclear Medicine 7, U.Mazzi Ed.,
SGEditoriali, Padova, Italy, 2006, pp 343-346.
Camporese D., Riondato M., Zampieri A., Marchiò L., Tapparo A., Mazzi U.
Tris(1,2-dimethyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridone)OxoTantalum(V): a new water soluble tantalum
complex containing the [Ta=O]3+ core.
Dalton trans., 2006, 36, 4343-4347.
Canet D., Aroulanda C., Mutzenhardt P., Aime S., Gobetto R., Reineri F.
Para-hydrogen enrichment and hyperpolarization.
Concepts In Magnetic Resonance Part A, 2006, 28A, 321-330.
Canuto H.C., Masic A., Rees N.H., Heyes S.J., Gobetto R., Aime S.
A C-13 CP/MAS NMR study of the structure and dynamics of [(eta(5)-C5H5)(2)Fe-2(CO)(4)]
included in gamma-cyclodextrin: Evidence for terminal-bridging exchange in the cis isomer.
Organometallics, 2006, 25, 2248-2252.
Cappelli A., Matarrese M., Moresco R.M., Valenti S., Anzini M., Vomero S., Turolla E.A., Belloli
S., Simonelli P., Filannino M.A., Lecchi M., Fazio F.
Synthesis, Labeling, and Biological Evaluation of Halogenated Quinoline-2-Carboxamides as
Potential Radioligands for Visualization of Peripheral Benzodiazepine Receptors.
Bioorg.Med.Chem., 2006, 14, 4055.
Cappelli A., Pericot Mohr G., Giuliani G., Galeazzi S., Anzini M., Mennuni L., Ferrari F.,
Makovec F., Kleinrath E.M., Langer T., Valoti M., Giorgi G., Vomero S.
Further Studies on Imidazo[4,5-B]Pyridine AT1 Angiotensin II Receptor Antagonists. Effects of the
Transformation of the 4-Phenylquinoline Backbone into 4-Phenylisoquinolinone or 1-Phenylindene
Scaffolds.
J.Med.Chem., 2006, 49, 6451.
Cappelli A., Travagli V., Zanardi I., Anzini M., Giorgi G., Donati A., Aggravi M., Casolaro M.,
Fresta M., Paccagnini E., Makovec F., Vomero S.
Physicochemical
and
Biopharmaceutical
Characterization
of
Endo-2-(8-Methyl-8Azabicyclo[3.2.1]OCT-3-YL)-2,3-Dihydro-1H-Benz[E]Isoindol-1-One (CR3124) a Novel Potent 5HT3 Receptor Antagonist.
J.Pharm.Sci., 2006, 95, 2706.
Cappiello M., Alterio V., Amodeo P., Del Corso A., Scaloni A., Pedone C., Moschini R., De
Donatis G. M., De Simone G., Mura U.
Metal Ion Substitution in the Catalytic Site Greatly Affects the Binding of Sulfhydryl-Containing
Compounds to Leucyl Aminopeptidase.
Biochemistry, 2006, 45(10), 3226-3234.
Cardiano P., Giuffrè O., Pellerito L., Pettignano A., Sammartano S., Scopelliti M.
Thermodynamic and spectroscopic study of the binding of dimethyltin(IV) by citrate at 25 ◦C.
Appl.Organomet.Chem., 2006, 20, 425-435.
Casanova M., Zangrando E., Munini F., Iengo E., Alessio E.
Fac-[Re(CO)3(dmso-O)3](CF3SO3): a new versatile and efficient Re(I) precursor for the preparation
of mono and polynuclear compounds containing fac-[Re(CO)3]+ fragments.
Dalton Trans., 2006, 5033-5045.
152
Casella L.
Metalloenzymes and chemical biomimetics.
Eur. J. Inorg. Chem., 2006, 3545-3546.
Casella L., Gullotti M., Monzani E., Santagostini L., Zoppellaro G., Sakurai T.
Enzymatic and spectroscopic studies on the activation or inhibition effects by substituted phenolic
compounds in the oxidation of aryldiamines and catechols catalyzed by Rhus vernicifera laccase.
J. Inorg. Biochem., 2006, 100, 2127-2139.
Casellas H., Gamez P., Reedijk J., Massera C.
Solvent control in the synthesis of Zn(II) and Cd(II) supramolecular compounds with N,N'-{2,4-di[(di-pyridin-2-yl)amine]-1,3,5-triazine}ethylenediamine.
Polyhedron. 2006, 25(15), 2959-2966.
Casini A., Cinellu M.A., Minghetti G., Gabbiani C., Coronnello M., Mini E., Messori L.
Structural and solution chemistry, antiproliferative effects, and DNA and protein binding properties
of a series of dinuclear gold(III) compounds with bipyridyl ligands.
J. Med. Chem. 2006, 49(18), 5524-31.
Casini A., Gabbiani C., Mastrobuoni G., Messori L., Moneti G., Pieraccini G.
Exploring metallodrug-protein interactions by ESI mass spectrometry: the reaction of anticancer
platinum drugs with horse heart cytochrome c.
ChemMedChem. 2006, 1(4), 413-7.
Casolaro M., Bottari S., Ito Y.
Vinyl Polymers Based on L-Histidine Residues. Part 2. The Swelling and Electric Behaviour of
Smart Poly(Ampholyte) Hydrogels for Biomedical Applications.
Biomacromolecules, 2006, 7, 1439.
Casolaro M., Casolaro I., Spreafico A., Capperucci C., Frediani B., Marcolongo R., Margiotta N.,
Ostuni R., Mendichi R., Samperi F., Ishii T., Ito Y.
Novel Therapeutic Agents for Bone Resorption. Part 1. Synthesis and Protonation Thermodynamics
of Poly(Amido-Amine)S Containing Bis-Phosphonate Residues.
Biomacromolecules, 2006, 7, 3417.
Castriciano M. A., Romeo A., Angelini N., Micali N., Longo A., Mazzaglia A., Scolaro L. M.
Macromolecules 2006, 39, 5489-5496.
Cerasino L., Natile G.
Platinum complexes with one monodentate ligand (1-methylbenzimidazole or antiviral ribavirin)
flanked by two cis-NMe2 groups: informative models for assessing interligand interactions.
European Journal of Inorganic Chemistry. 2006, pp. 3197-3202.
Chimichi S., Boccalini M., Cravotto G., Rosati O.
A new convenient route to enantiopure 2-coumaryloxypropanals: application to the synthesis of
optically active geiparvarin analogues.
Tetrahedron Lett. 2006, 47 (14), 2405-2408.
Ciaccio C., Gambacurta A., De Sanctis G., Spagnolo D., Sakarikou C., Putrella G., Coletta M.
RhEPO (recombinant human eosinophil peroxidase): expression in Pichia pastoris and biochemical
characterization.
Biochem. J. 2006, 395, 295-301.
Cini R., Cavaglioni A., Corsini M., Defazio S., Tamasi G.
153
Synthesis, X-Ray Structure, and Solution Studies for MER-[RhCl3{Sb(C6H5)3}3], and [Rh(N1,S22-Thiopyrimidinato)2(S2(Rh),N1(Sb)-2-Thiopyrimidinato){Sb(C6H5)3}].
Polyhedron, 2006, 25, 834.
Colletier J.P., Sanson B., Nachon F., Gabellieri E., Fattorusso C., Campiani G., Weik M.
Conformational Flexibility in the Peripheral Site of Torpedo Californica Acetylcholinesterase
Revealed by the Complex Structure with a Bifunctional Inhibitor.
J.Am.Chem.Soc., 2006, 128, 4526.
Colovic M., Campiani G., Butini S., Parabiaghi A., Caccia S.
The 1-(2,3-Dichlorophenyl)-Piperazine-to-Aripiprazole Ratio at Steady State in Rats and
Schizophrenic Patients.
Pharmacologyonline, 2006, 2, 252.
Conti C., Galeazzi R., Giorgini E., Tosi G.
J. Mol. Struct., 2006, 790, 89-93.
Corbini G., Martini S., Bonechi C., Casolaro M., Corti P., Rossi C.
Synthetic Polymers as Biomacromolecular Models for Studying Ligand-Protein Interactions: a
Nuclear Spin Relaxation Approach.
J.Pharm.Biomed.Anal., 2006, 40, 113.
Corsini M., Fabrizi De Biani F., Zanello P.
Mononuclear Metallacarboranes of Groups 6–10 Metals: Analogues of Metallocenes.
Electrochemical and X-Ray Structural Aspects.
Coord. Chem. Rev., 2006, 250, 1351.
Cosma P., Catucci L., Fini P., Dentuto P. L., Agostiano A., Angelini N., Scolaro L. M.
Photochemistry and Photobiology 2006, 82, 563-569.
Costa M. A., Pellerito L., Izzo V., Fiore T., Pellerito C., Melis M., Musmeci M.T., Barbieri G.
Diorganotin(IV) and triorganotin(IV) complexes of meso-tetra(4-sulfonatophenyl)porphine induce
apoptosis in A375
human melanoma cells.
Cancer Lett., 2006, 238, 284–294.
Cravotto G., Boffa L., Bia M., Bonrath W., Curini M., Heropoulos G.A.
An Easy Access to Aromatic Azo Compounds Under US/MW Irradiation.
Synlett., 2006, 16, 2605-2608.
Cravotto G., Cintas P.
Power ultrasound in organic synthesis: moving cavitational chemistry from academia to innovative
and large-scale applications.
Chem. Soc. Rev. 2006, 35 (2), 180-196.
Cravotto G., Binello A., Baranelli E., Carraro P., Trotta F.
Cyclodextrins as food additives and in food processing.
Current Nutrition & Food Science, 2006, 2(4), 343-350.
Cravotto G., Binello A., Boffa L., Chimichi S., Boccalini M.
Regio- and stereoselective reductions of dehydrocholic acid.
Steroids, 2006, 71(6), 469-475.
Cravotto G., Giovenzana G. B., Maspero A., Pilati T., Penoni A., Palmisano G.
Allylindation of 1H-indole-3-carboxaldehyde in the presence of azoles – revisited.
Tetrahedron Lett., 2006, 47 (36) 6439-6443.
154
Cravotto G., Giovenzana G.B., Palmisano G., Penoni A., Pilati T., Sisti M., Stazi F.
Convolutamydine A: the first authenticated absolute configuration and enantioselective synthesis.
Tetrahedron Asymm. 2006, 17, 3070-3074.
Cravotto G., Tagliapietra S., Cappello R., Palmisano G., Curini M., Boccalini M.
Long-Chain 3-Acyl-4-Hydroxycoumarins: Structure and Antibacterial Activity.
Arch. Pharm. Life Sci., 2006, 339, 129-132.
Curini M., Cravotto G., Epifano F., Giannone G.
Chemistry and Biological Activity of Natural and Synthetic Prenyloxycoumarins.
Curr. Med. Chem., 2006, 13, 763-771.
Curini M., Rosati O., Marcotullio M.C., Montanari F., Campagna V., Pace V., Cravotto G.
Preparation of 2-amino-4H-chromene derivatives from coumarins under basic media.
Eur. J. Org. Chem., 2006, 3, 746-751.
Cusumano M., Di Pietro M. L., Giannetto A.
Inorganic Chemistry 2006, 45, 230-235.
D
D’Agati P., Mansueto C., Mansueto V., Pellerito C., Cangialosi M.V., T. Fiore, Pellerito L.
Effects of sublethal levels of tributyltin chloride on a new toxicity test organism, Liza saliens
(Osteichthyes, Mugilidae): a histological study.
Appl.Organomet.Chem., 2006, 20, 357-367.
Daghino S., Turci F., Tomatis M., Favier A., Perotto S., Douki T., Fubini B.
Soil fungi reduce the iron content and the DNA damaging effects of asbestos fibers.
Environmental Science & Technology, 2006, 40(18), 5793-5798.
Dalla Bona A., Formaggio F., Peggion C., Kaptein B., Broxterman Q.B., Galdiero S., Galdiero M.,
Vitiello M., Benedetti E., Toniolo C.
Synthesis, conformation, and bioactivity of novel analogues of the antiviral lipopeptide halovir A.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 2006, 12(12),
748-57.
D'Ambrosio K., Pailot A., Talfournier F., Didierjean C., Benedetti E., Aubry A., Branlant G.,
Corbier C.
The first crystal structure of a thioacylenzyme intermediate in the ALDH family: New coenzyme
conformation and relevance to catalysis.
Biochemistry, 2006, 45(9), 2978-2986.
D'Ambrosio K., Pedone E., Langella E., De Simone G., Rossi M., Pedone C., Bartolucci S.
A novel member of the protein disulfide oxidoreductase family from Aeropyrum pernix K1:
structure, function and electrostatics.
Journal of Molecular Biology, 2006, 362(4), 743-752.
D'Andrea L. D., Del Gatto A., Pedone C., Benedetti E.
Peptide-based molecules in angiogenesis.
Chemical Biology & Drug Design, 2006, 67(2), 115-126.
Danzelsen R., Achsel T., Bederke U., Cozzolino M., Crosio C., Ferri A., Frenzel M., Gralla E.B.,
Huber L., Ludolph A., Nencini M., Rotilio G., Valentine J.S., Carri M.T.
Superoxide dismutase 1 modulates expression of transferrin receptor.
155
J. Biol. Inorg. Chem. 2006, 11, 489-498.
De D. I., Lania A., Bonaccorsi di Patti M.C., Battistoni A., Musci G., Desideri A.
Purification and characterization of recombinant Caulobacter crescentus Cu,Zn superoxide
dismutase.
Biochim. Biophys. Acta 2006, 1764, 105-109.
De Capua A., Goodman M., Amino Y., Saviano M., Benedetti E.
Conformation analysis of aspartame-based sweeteners by NMR spectroscopy, molecular dynamics
simulations, and X-ray diffraction studies.
ChemBioChem, 2006, 7(2), 377-387.
Del Gatto A., D'Andrea L. D., Zaccaro L., Saviano M., Pedone C., Benedetti E.
Engineering peptides in angiogenesis.
Peptide Science, 2006, 43rd, 215-216.
Del Gatto A., Zaccaro L., Grieco P., Novellino E., Zannetti A., Del Vecchio S., Iommelli F.,
Salvatore M., Pedone C., Saviano M.
Novel and Selective v 3 Receptor Peptide Antagonist: Design, Synthesis, and Biological
Behavior.
Journal of Medicinal Chemistry, 2006, 49(11), 3416-3420.
De Lisi R., Gradzielski M., Lazzara G., Milioto S., Muratore N.
Aqueous Block Copolymer-Surfactant Mixtures and their Ability in Solubilizing Chlorinated
Organic Compounds. A Thermodynamic and SANS Study.
J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 25883.
De Lisi R., Lazzara G., Lombardo R., Milioto S., Muratore N., Turco Liveri M. L.
Thermodynamic Behavior of Non-Ionic Tri-block Copolymers in Water at Three Temperatures.
J. Solution Chem., 2006, 35, 659.
De Lisi R., Lazzara G., Milioto S., Muratore N.
A The
-Dichloroalkane/Block Copolymer Mixed Aggregates
Formation. Effect of the Copolymer Architecture.
Journal Coll. Interface Sc., 2006, 300, 368.
De Lisi R., Lazzara G., Milioto S., Muratore N.
Aqueous Nonionic Copolymer-Functionalized Laponite Clay. A Thermodynamic
Spectrophotometric Study To Characterize Its Behavior toward an Organic Material.
Langmuir, 2006, 22, 8056.
and
De Lisi R., Lazzara G., Milioto S., Muratore N.
Volumes of Aqueous Block Copolymers Based on Poly(Propylene Oxides) and Poly(Ethylene
Oxides) in a Large Temperature Range: A Quantitative Description.
J. Chem. Thermodynamics, 2006, 38, 1344.
De Luca G., Pollicino G., Romeo A., Patane S., Scolaro L. M.
Chemistry of Materials 2006, 18, 5429-5436.
De Luca G., Pollicino G., Romeo A., Scolaro L. M.
Chemistry of Materials 2006, 18, 2005-2007.
De Luca G., Romeo A., Scolaro L. M.
Journal of Physical Chemistry B 2006, 110, 7309-7315.
156
De Luca G., Romeo A., Scolaro L. M.
Journal of Physical Chemistry B 2006, 110, 14135-14141.
De Luca S., Morelli G.
Metal-labeled peptides as selective probes in nuclear medicine.
Recent Development in Bioinorganic Chemistry: Metal Complexes of Bioactive Molecules" edited
by M.Saviano, TransWorld Research Network India, 2006, 35-62.
De Luca S., Saviano M., Della Moglie R., Digilio G., Bracco C., Aloj L., Tarallo L., Pedone C.,
Morelli G.
Conformationally constrained CCK8 analogues obtained from a rationally designed peptide library
as ligands for cholecystokinin type B receptor.
ChemMedChem, 2006, 1(9), 997-1006.
De Luca S., Saviano M., Lassiani L., Yannakopoulou K., Stefanidou P., Aloj L., Morelli G.,
Varnavas A.
Anthranilic Acid Based CCK1 Receptor Antagonists and CCK-8 Have a Common Step in Their
"Receptor Desmodynamic Processes".
Journal of Medicinal Chemistry , 2006, 49(8), 2456-2462.
De Pascali S. A., Migoni D., Papadia P., Muscella A., Marsigliante S., Ciccarese A., Fanizzi F. P.
New water-soluble platinum(II) phenanthroline complexes tested as cisplatin analogues: first-time
comparison of cytotoxic activity between analogous four- and five-coordinate species.
Dalton Trans., 2006, 42, 5077-5087.
De Re V., Sansonno D., Simula M.P., Caggiari L., Gasparotto D., Fabris M., Tucci F.A., Racanelli
V., Talamini R., Campagnolo M., Geremia S., Dammacco F., De Vita S.
HCV-NS3 and IgG-Fc crossreactive IgM in patients with type II mixed cryoglobulinemia and Bcell clonal proliferations.
Leukemia, 2006, 20, 1145-1154.
De Sanctis G., Fasciglione G.F., Marini S., Sinibaldi F., Santucci R., Monzani E., Dalla costa C.,
Casella L., Coletta M.
pH-dependent redox and CO binding properties of chelated protoheme-L-histidine and protohemeglycyl-L-histidine complexes.
J. Biol. Inorg. Chem. 11, 2006,153-167.
De Simone G., Vitale R. M., Di Fiore A., Pedone C., Scozzafava A., Montero J. L., Winum J.Y.,
Supuran C. T.
Carbonic anhydrase inhibitors: hypoxia-activatable sulfonamides incorporating disulfide bonds that
target the tumor-associated isoform IX.
Journal of Medicinal Chemistry, 2006, 49(18), 5544-5551.
Di Fiore A., Pedone C., D'Ambrosio K., Scozzafava A., De Simone G., Supuran C. T.
Carbonic anhydrase inhibitors: Valdecoxib binds to a different active site region of the human
isoform II as compared to the structurally related cyclooxygenase II selective' inhibitor celecoxib.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2006, 16(2), 437-442.
Dini L., La Nubile R., Tarantino P., Mandich A., Castaldi E.
Expression of stress proteins 70 in tilapia (Oreochromis mossambicus) durino confinement and
crowding stress.
Ital. J. Zoology, 2006, 73(2), 117-124.
157
Donzello M.P., Bartolino L., Ercolani C., Rizzoli C.
A Heterobimetallic and Heteroleptic µ-Hydroxo Bridged Species. Synthesis, X-Ray Crystal
Structure
and
Properties
of
µ-Hydroxo(tetraphenylporphyrinatomanganese(III))
(phthalocyaninato-(azido)chromium(III)),
[(TPP)Mn-O(H)-Cr(Pc)N3],
Chloronaphthalene
Solvate.
Inorg. Chem., 2006, 45, 6988-6985.
Donzello M.P., Ercolani C., Stuzhin P. A.
Coord. Chem Rev. 2006, 250, 1530-1561.
Dreos R., Mechi L., Randaccio L., Siega P., Zangrando E., Ben Hassen R.
Synthesis and X-ray crystal structure of a new μ-hydroxo dinuclear cobalt complex containing one
cis-β folded and one planar salen moiety.
J. Organometal. Chemistry, 2006, 691, 3305 –3309.
Dreos R., Siega P.
Kinetics and mechanism of metallacyclization in a chloromethylcobalt complex with a salen-type
ligand.
Organometallics, 2006, 25, 5180.
Du C., Moradian-Oldak J., Falini G.
On the formation of amelogenin micro-ribbons.
Eur J Oral Sci., 2006, 114, 115-121.
Durand J., Milani B.
The role of nitrogen-donor ligands in the palladium-catalyzed polyketones synthesis.
Coord. Chem. Rev., 2006, 250, 542-560.
Durand J., Scarel A., Seraglia R., Gladiali S., Carfagna C., Binotti B., Milani B.
Palladium Promoted CO/Ethylene/Styrene Terpolymerisation Reaction: Throwing the Light on the
Different Reactivity of the two Alkenes.
Helv. Chim. Acta, 2006, 89, 1752-1771.
Durand J., Zangrando E., Stener M., Fronzoni G., Carfagna C., Binotti B., Kamer P. C. J., Müller
C., Caporali M., Van Leeuwen P. W. N. M., Vogt D., Milani B.
Long Lived Palladium Catalysts for CO/Vinyl Arene Polyketones Synthesis: A Solution to
Deactivation Problems.
Chem-Eur. J., 2006, 12, 7639-7651.
E
Elias Z., Poirot O., Fenoglio I., Ghiazza M., Daniere M.C., Terzetti F., Darne C., Coulais C.,
Matekovits I., Fubini B.
Surface reactivity, cytotoxic, and morphological transforming effects of diatomaceous earth
products in Syrian hamster embryo cells.
Toxicological Sciences, 2006, 91(2), 510-520.
Esposito L., Pedone C., Vitagliano L.
Molecular dynamics analyses of cross- -spine steric zipper models:
-sheet twisting and
aggregation.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2006, 103(31),
11533-11538.
Esposito S., Baglivo I., Malgieri G., Russo L., Zaccaro L., D'Andrea L.D., Mammucari M., Di
158
Blasio B., Isernia C., Fattorusso R., Pedone P.V.
A Novel Type of Zinc Finger DNA Binding Domain in the Agrobacterium tumefaciens
Transcriptional Regulator Ros.
Biochemistry, 2006, 45, 10394.
F
Falini G., Foresti E., Lesci I. G., Lunelli B. Sabatino P., Roveri N.
Interaction of bovine serum albumin with chrysotile: spectroscopic and morphological studies.
Chemistry--A European Journal, 2006, 12(7), 1968-1974.
Fan H.K., Williams D.L., Breuel K.F., Zingarelli B., Teti G., Tempel G.E., Halushka P.V., Cook J.A.
Frontiers in Bioscience 2006, 11, 2264-2274.
Fan H. K., Williams D. L., Zingarelli B., Breuel K. F., Teti G., Tempel G. E., Spicher K., Boulay
G., Birnbaumer L., Halushka P. V., Cook J. A.
Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular Cell Research 2006, 1763, 1051-1058.
Fattorusso C., Campiani G., Catalanotti B., Persico M., Basilico N., Parapini S., Taramelli D.,
Campagnuolo C., Fattorusso E., Romano A., Taglialatela-Scafati O.
Endoperoxide Derivatives from Marine Organisms: 1,2-Dioxanes of The Plakortin Family as Novel
Antimalarial.
J.Med.Chem., 2006, 49, 7088.
Fenoglio I., Tomatis M., Lison D., Muller J., Fonseca A., Nagy J.B., Fubini B.
Reactivity of carbon nanotubes: Free radical generation or scavenging activity?
Ree Radical Biology And Medicine, 2006, 40(7), 1227-1233.
Ferri A., Cozzolino M., Crosio C., Nencini M., Casciati A., Gralla E.B., Rotilio G., Valentine J.S.,
Carri M.T.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2006,103, 13860-13865.
Fulton D.A., Elemento E.M., Aime S., Chaabane L., Botta M., Parker D.
Glycoconjugates of gadolinium complexes for MRI applications.
Chem. Comm., 2006, 10, 1064-1066.
G
Gabano E., Marengo E., Bobba M., Robotti E., Cassino C., Botta M., Osella D.
195
Pt NMR spectroscopy: a chemometric approach.
Coord. Chem. Rev., 2006, 250, 2158-2174.
Gaberkorn A.A., Donzello M.P., Stuzhin P.A.
Synthesis and spectroscopic study of tert-butyl substituted benzoporphyrazines with annulated
1,2,5-thiadiazole moieties.
Russ. J. Org. Chem., 2006, 42, 929-935.
Gaggelli E., Kozlowski H., Valensin D., Valensin G.
Copper Homeostasis and Neurodegenerative Disorders (Alzheimer, Amyotrophic Lateral Sclerosis,
Prion, Parkinson).
Chem.Rev., 2006, 106, 1995.
Galassi R., Bachechi F., Burini A.
159
Synthesis and crystal structure determination of the bicyclic[bis(μ-P,N-1-benzyl-2-imidazolyldiphenylphosphine)(μ-O,O‟-diperchlorate)dimercury(II)][diperchlorate].
Journal of Molecular Structure, 2006, 791, 82–88.
Galdiero S., Vitiello M., Amodeo P., D'Isanto M., Cantisani M., Pedone C., Galdiero M.
Structural Requirements for Proinflammatory Activity of Porin P2 Loop 7 from Haemophilus
influenzae.
Biochemistry, 2006, 45(14), 4491-4501.
Galdiero S., Vitiello M., D'Isanto M., Falanga A., Collins C., Raieta K., Pedone C., Browne H.,
Galdiero M.
Analysis of synthetic peptides from heptad-repeat domains of herpes simplex virus type 1
glycoproteins H and B.
Journal of General Virology, 2006, 87(5), 1085-1097.
Garino C., Ghiani S., Gobetto R., Nervi C., Salassa L., Croce G., Milanesio M., Rosenberg E.,
Ross J.B.A.
Tricarbonylchlororhenium(I) carboxaldimine derivatives: Synthesis, structure, and NMR
characterization of Z and E isomers.
European Journal Of Inorganic Chemistry, 2006, (14), 2885-2893.
Gemma S., Gabellieri E., Huleatt P., Fattorusso C., Borriello M., Catalanotti B., Butini S., De
Angelis M., Novellino E., Nacci V., Belinskaya T., Saxena Ashima, Campiani G.
Discovery of Huperzine A/Tacrine Hybrids as Potent Inhibitors of Human Cholinesterases
Targeting Their Mid-Gorge Recognition Sites.
J.Med.Chem., 2006, 49, 3421.
Gemma S., Kukreja G., Fattorusso C., Persico M., Romano M.P., Altarelli M., Savini L., Campiani
G., Fattorusso E., Basilico N., Taramelli D.,.Yardley V, Butini S.
Synthesis of N1-Arylidene-N2-Quinolyl- and N2-Acrydinylhydrazones as Potent Antimalarial
Agentsactive Against CQ-Resistant P. Falciparum Strains.
Bioorg.Med.Chem.Lett., 2006, 16, 5384.
Geninatti Crich S., Bussolati B., Tei L., Grange C., Esposito G., Lanzardo S., Camussi G., Aime S.
Magnetic resonance visualization of tumor angiogenesis by targeting neural cell adhesion molecules
with the highly sensitive gadolinium-loaded apoferritin probe.
Cancer. Res., 2006, 66(18), 9196-201.
Geninatti Crich S., Cabella C., Barge A., Belfiore S., Ghirelli C., Lattuada L., Lanzardo S.,
Mortillaro A., Tei L., Visigalli M., Forni G., Aime S.
In vitro and in vivo magnetic resonance detection of tumor cells by targeting glutamine transporters
with Gd-based probes.
J. Med. Chem., 2006, 49(16), 4926-36.
Gennari M., Lanfranchi M., Marchiò L., Pellinghelli M.A., Tegoni M., Cammi R.
Cu(I) dinuclear complexes with tripodal ligands vs monodentate donors: triphenylphosphine,
thiourea and pyridine. A 1H NMR titration study.
Inorganic Chemistry. 2006, 45(8), 3456-3466.
Geremia S., Campagnolo M., Demitri N., Johnson L. N.
Simulation of diffusion time of small molecules in protein crystals.
Structure, 14, 393-400 , 2006
160
Geremia S., Demitri N., Wuerges J., Benedetti F., Berti F., Tell G., Randaccio L.
A new potent HIV protease inhibitor identified in an epimeric mixture by high resolution protein
crystallography.
ChemMedChem, 2006, 1, 186-188.
Giannellini V., Bambagiotti-Alberti M., Bruni B., et al.
Structural and conformational study of two solvates of a fulgenic acid derivative.
New Journal of Chemistry. 2006, 30(4), 647-653.
Giovenzana G.B., Tron G.C., Di Paola S., Menegotto I.G., Pirali T.
Split the Primary Amine in Two: Secondary Amine May Play the Role of the Primary Amine in the
Ugi 4CR.
Angew. Chemie Int. Ed. Engl., 2006, 45(7), 1099-1102.
Giuffrida M.L., Grasso G., Ruvo M., Pedone C., Saporito A., Marasco D., Pignataro B., Cascio C.,
Copani A., Rizzarelli E.
Aβ(25-35) and its C-and/or N-blocked derivatives: copper driver structural features and
neurotoxicity.
J. Neur Res., 2006, 85.
Gobetto R., Caputo G., Garino C., Ghiani S., Nervi C., Salassa L., Rosenberg E., Ross J.B.A.,
Viscardi G., Martra G., Miletto I., Milanesio M.
Synthesis, electrochemical and electrogenerated chemiluminescence studies of Ruthenium(II)
Bis(2,2 '-bipyridyl){2-(4-methylpyridin-2-yl)benzo[d]-X-azole} complexes.
European Journal Of Inorganic Chemistry, 2006, (14), 2839-2849.
Granata A., Monzani E., Bubacco L., Casella L.
Mechanistic insight into the activity of tyrosinase from variable temperature studies in aqueousorganic solvent.
Chem. Eur. J., 2006,12, 2504-2514.
Grasso D., Grasso G., Guantieri V., Impellizzeri G., La Rosa C., Milardi D., Micera G., Osz K.,
Pappalardo G., Rizzarelli E., Sanna D., Sovago I.
Environmental effects on a prion‟s helix II domain: Copper(II) and membrane interactions with
PrP180-193 and its analogues.
Chem. Eur. J., 2006, 12(2), 537-547.
Grasso V., Quattrone T., Silipigni L., De Luca G., Scolaro L. M., Salvato G.
Nuovo Cimento Della Societa Italiana Di Fisica C-Geophysics and Space Physics 2006, 29, 325334.
Greco M., Chiriacò F., Del Boccio P., Tagliaferro L., Menegazzi P., Pinca E., Pignatelli F., Storelli
C., Urbani A., Maffia M.
A proteomic approach in the characterization of the C677T mutation of the human gene methylen
tetrahydrofolate reductase (MTHFR).
Proteomics, 2006, 6, 5350-5361.
Greco S., Storelli C., Marsigliante S.
Protein kinase C (PKC)-delta/-epsilon mediate the PKC/Akt-dependent phosphorylation of
extracellular signal-regulated kinases 1 and 2 in MCF-7 cells stimulated by bradykinin.
J. Endocrinol., 2006 Jan; 188(1), 79-89.
Gulino F.G., De Zorzi R., Di Costanzo L., Geremia S., Lauceri R., Randaccio L., Sciotto D.,
Purrello R.
161
Design, Non-Covalent Syntheses in Aqueous Solution and Crystallographic Characterization of
Multi-Functional Multi-Porphyrins Complexes.
Chem. Eur. J., 2006, 12, 2722-2729.
H
Henn M., Schürmann M., Mahieu B., Zanello P., Cinquantini A., Jurkschat K.
A Ferrocenyl-Bridged Intramolecularly Coordinated Bis(Diorganostannylene): Synthesis,
Molecular Structure and Reactivity Of [4-t-Bu-2,6- P(O)(O-i-Pr)2C6H2Sn C5H4]2Fe.
J.Organomet. Chem., 2006, 691, 1560.
Herber R.H., Kudinov A.R., Zanello P., Nowik I., Perekalin D.S., Meshcheryakov V.I., Lissenko
K.A., Corsini M., Fedi S.
Synthesis, Structure, Electrochemistry, and Metal-Atom Dynamics of Cyclopentadienyl
Ferracarboranes.
Eur.J.Inorg.Chem., 2006, 1786.
Himmelreich U., Aime S., Hieronymus T., Justicia C., Uggeri F., Zenke M., Hoehn M.
A responsive MRI contrast agent to monitor functional cell status.
Neuroimage, 2006, 32 , 1142-1149.
Hughes M.A., Miranda P., Nielsen D., Rosenberg E., Gobetto R., Viale A., Burton S.
Silica polyamine composites: New supramolecular materials for cation and anion recovery and
remediation.
Macromolecular Symposia, 2006, 235, 161-178.
Hughes M.A., Nielsen D., Rosenberg E., Gobetto R., Viale A., Burton S.D., Ferel J.
Structural investigations of silica polyamine composites: Surface coverage, metal ion coordination,
and ligand modification.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 2006, 45(19), 6538-6547.
I
Iengo E., Scandola F., Alessio E.
Metal-mediated multi-porphyrin discrete assemblies and their photoinduced properties.
Struct. Bond., 2006, 121, 105-144.
Iengo E., Zangrando E., Alessio E.
Synthetic Strategies and Structural Aspects of Metal-Mediated Multi-Porphyrin Assemblies.
Acc. Chem. Res., 2006, 39, 841-851.
J
Joszai V., Nagy Z., Osz K., Sanna D., Di Natale G., La Mendola D., Pappalardo G., Rizzarelli E.,
Sovago I.
Transition Metal Complexes of Terminally Protected Peptides ContainingHistidyl residues.
J. Inorg Biochem, 2006, 100(8), 1399-409.
K
Kardjilov N., Fiori F., Giunta G., Hilger A., Rustichelli F., Strobl M., Banhart J., Triolo R.
Neutron tomography for archaeological Investigations.
Journal of Neutron Research, 2006, 14, 29–36.
Kasparkova J., Novakova O., Vrana O., Intini F.P., Natile G., Brabec V.
Biochemical aspects of antitumor effects of a new platinum(IV) drug.
Molecular Pharmacology. 2006, vol. 70, pp. 1708-1719.
162
Kenzel S., Mancuso G., Malley R., Teti G., Golenbock D. T., Henneke P.
Journal of Immunology 2006, 176, 3181-3188.
Kozlowski H., Brown D.R., Valensin G.
Metallochemistry of Neurodegeneration. Biological, Chemical and Genetical Aspects.
R.S.C., Cambridge, Uk, 2006.
Kozlowski H., Luczkowski M., Valensin D., Valensin G.
Metal Ion Binding Properties of Proteins Related to Neurodegeneration.
Neurodegenerative Diseases and Metal Ions in Life Sciences J.Wiley & Sons, Uk, 2006, 61.
Kukreja G., Campiani G., Khurana J., Joshi B., Grover S.
Unexpected Formation of Hydroxybiphenylmethane Derivatives and Some New Observations on
Labat Test.
Nat.Prod.Res., 2006, 20, 1150.
L
La Mendola D., Magrì, A. Milardi D., Pappalardo G., Rizzarelli E.
Environmental effects on conformational diseases. Reactive oxygen species and membrane
interactions with prion, amylin and their peptide fragments.
In “Recent Development in Bioinorganic Chemistry: Metal Complexes of Bioactive Molecules”,
2006, 85-110 Ed:Michele Saviano, Transworld Research Network.
Lampronti I., Bianchi N., Zuccato C., Medici A., Bergamini P., Gambari R.
Effects on erythroid differentiation of platinum(II) complexes of synthetic bile acid derivatives.
Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2006, 14, 5204-5210.
Lattuada L., Demattio S., Vincenzi V., Cabella C., Visigalli M., Aime S., Crich S.G., Gianolio E.
Magnetic resonance imaging of tumor cells by targeting the amino acid transport system.
Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 16(15), 4111-4.
Lazzara G., Milioto S., Gradzielski M.
The Solubilisation Behaviour of Some Dichloroalkanes in Aqueous Solutions of PEO-PPO-PEO
Triblock Copolymers: a Dynamic Light Scattering, Fluorescence Spectroscopy, and SANS Study.
Phys. Chem. Chem. Phys., 2006, 8, 2299
Leese M. P., LeBlond B., Newman S. P., Di Fiore A., De Simone G., Supuran C. T., Purohit A.,
Reed M. J., Potter B. V. L.
2-substituted estradiol bis-sulfamates (bismates), novel multi-targeted anti-cancer agents.
Journal of Medicinal Chemistry, 2006 , 49, 7683.
Lerner H.-W., Margraf G., Kretz T., Schiemann O., Bats J.W., Dürner G., Fabrizi De Biani F.,
Zanello P., Bolte M., Wagner M.
Redox Behaviour of Pyrazolyl-Substituted 1,4-Dihydroxyarenes: Formation of the Corresponding
Semiquinones, Quinhydrones and Quinones.
Z.Naturforsch., 2006, 61b, 252.
Lévêque J.M., Cravotto G.
Microwaves, Power Ultrasound and Ionic Liquids. A new Synergy in Green Organic Synthesis.
Chimia 2006, 60(6), 313-320.
Lévêque J.M., Desset S., Suptil J., Fachinger C., Draye M., Bonrath. W., Cravotto G.
A general ultrasound-assisted access to room temperature ionic liquids.
163
Ultrason. Sonochem., 2006, 13, 189-193.
Lionetto M. G., Caricato R., Erroi E., Giordano M. E., Schettino T.
Potential application of carbonic anhydrase activity in bioassay and biomarker studies.
Chemistry and Ecology, 2006, 22, S119 - S125.
Lionetto M.G., Schettino T.
The Na+-K+-2Cl- cotransporter and the osmotic stress response in a model salt transport epithelium
(review).
Acta Physiologica, 2006, 187,115-124.
Longato B., Montagner D., Bandoli G., Zangrando E.
Platinum(II)-Mediated Coupling Reactions of Acetonitrile with the Exocyclic Nitrogen of 9Methyladenine and 1-Methylcytosine. Synthesis, NMR Characterization, and X-ray Structures of
New Azametallacycle Complexes.
Inorg. Chem., 2006, 45, 1805–1814.
Longato B., Montagner D., Zangrando E.
Mono- and Polynuclear Complexes of the Model Nucleobase 1-Methylcytosine. Synthesis and
Characterization of cis-[(PMe2Ph)2Pt{1-MeCy(-H)}]3(NO3)3 and cis-[(PPh3)2Pt{1-MeCy}]NO3.
Inorg. Chem., 2006, 45, 8179-8187.
Lorusso G., Di Masi N.G., Maresca L., Pacifico C., Natile G.
Markovnikov versus anti-Markovnikov selectivity in the amination of terminal olefins coordinated
to platinum(II).
Inorganic Chemistry Communications. 2006, vol. 9, pp. 500-503.
M
Maheswari P.U., Modec B., Pevec A., Kozlevcar B., Massera C., Gamez P., Reedijk J.
Crystallographic Evidence of Nitrate- Interactions Involving the Electron-Deficient 1,3,5-Triazine
Ring.
Inorg. Chem. 2006, 45(17), 6637-6645.
Mannini R., Rivieccio V., D'Auria S., Tanfani F., Ausili A., Facchiano A., Pedone C., Grimaldi G.
Structure/function of KRAB repression domains: structural properties of KRAB modules inferred
from hydrodynamic, circular dichroism, and FTIR spectroscopic analyses.
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 2006, 62(3), 604-616.
Marasco D., Saporito A., Perretta G., Ruvo M.
Design of redox-active metal-binding peptides.
Recent Development in Bioinorganic Chemistry: Metal Complexes of Bioactive Molecules" edited
by M.Saviano, TransWorld Research Network India, 2006, 63-84.
Marasco D., Saporito A., Ponticelli S., Chambery A., De Falco S., Pedone C., Minchiotti G., Ruvo M.
Chemical synthesis of mouse Cripto CFC variants.
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 2006, 64(3), 779-788.
Marchesi E., Marchi A., Masarati E., Marvelli L., Bertolasi V.
New water soluble complexes of rhenium for radiopharmaceutical preparations
Technetium, rhenium and other metals in chemistry and nuclear medicine. 2006, vol. 7 , 167-170.
164
Marchetti F., Pettinari C., Pettinari R., Cingolani A., Gobetto R., Chierotti M.R., Drozdov A.,
Troyanov S.I.
The imidazole role in strontium beta-diketonate complexes formation.
Inorganic Chemistry, 2006, 45(7), 3074-3085.
Margiotta N., Natile G., Capitelli F., Fanizzi F.P., Boccarelli A., De Rinaldis P., Giordano D.,
Coluccia M.
Sterically hindered complexes of platinum(II) with planar heterocyclic nitrogen donors. A novel
complex with 1-methyl-cytosine has a spectrum of activity different from cisplatin and is able of
overcoming acquired cisplatin resistance.
Journal of Inorganic Biochemistry. 2006, vol. 100, pp. 1849-1857.
Margraf G., Kretz T., Fabrizi De Biani F., Laschi F., Losi S., Zanello P., Bats J.W., Wolf B.,
Remović-Langer K., Lang M., Prokofiev A., Assmus W., Lerner H.-W., Wagner M.
Mono-, Di-, and Oligonuclear Complexes of CuII Ions And p-Hydroquinone Ligands: Syntheses,
Electrochemical Properties, and Magnetic Behavior.
Inorg.Chem., 2006, 45, 1277.
Marzano C., Pellei M., Alidori S., Brossa A., Gioia Lobbia G., Tisato F., Santini C.
New Copper(I) phosphane complexes of dihydridobis(3-nitro-1,2,4-triazolyl)borate ligand showing
cytotoxic activity
J. Inorg. Biochem., 2006, 100, 299-304.
Marzano C., Pellei M., Colavito D., Alidori S., Gioia Lobbia G., Gandin V., Tisato F., Santini C.
Synthesis, Characterization, and in Vitro Antitumor Properties of Tris(hydroxymethyl)phosphine
Copper(I) Complexes Containing the New Bis(1,2,4-triazol-1-yl)acetate Ligand.
J Med. Chem., 2006, 49, 7317-7324.
Martinho P.N., Quintal S., Costa P.J., Losi S., Félix V., Gimeno M.C., Laguna A., Drew M.G.B.,
Zanello P., Calhorda M.J.
New Polynuclear Mo-Fe Complexes with Ferrocenylamido-Benzimidazole Ligands.
Eur.J.Inorg.Chem., 2006, 4096.
Martini S., Bonechi C., Casolaro M., Corbini G., Rossi C.
Drug-Protein Recognition Processes Investigated by NMR Relaxation Data. A Study on
Corticosteroid-Albumin Interactions.
Biochem.Pharm., 2006, 71, 858.
Mascini, Bagni G., Di Pietro M., Ravera M., Baracco S., Osella D.
Electrochemical Biosensor Evaluation of the Interaction Between DNA and Metallo-drugs.
Biometals, 2006, 19, 409-418.
Mazzaglia A., Valerio A., Villari V., Rencurosi A., Lay L., Spadaro S., Scolaro L. M., Micali N.
New Journal of Chemistry 2006, 30, 1662-1668.
Mattioli-Belmonte M., Natali D., Tosi G., Torricelli P., Totano I., Zizzi A., Fini M., Sabbatini S.,
Giavaresi G., Bigini G.
Int. J.Art. Org. 2006, 29, 1000-1011.
Mcgrath L., Onnis V., Campiani G., Wiòlliams D., Zisterer D.M., Mc Gee M.
Caspase-Activated Dnase (CAD)-Independent Oligonucleosomal DNA Fragmentation in Chronic
Myeloid Leukaemia Cells, a Requirement for Serine Protease and Mn(2+)-Dependent Acidic
Endonuclease Activity.
165
Apoptosis, 2006, 27, 2150.
Melendez-Alaford L., Nadali A., Camporese D., Banzato A., Bello M., Uzunov N.M., Boccaccio
P., Antoccia A., Tanzarella C., DeNotaristefani F., Bollini D., Perotta A., Navarria F., Moschini G.,
Rosato A., Mazzi U.
Stability, biodstribution and dosimetry studies of 188Re-Hyaluronic Acid.
In Technetium,Rhenium and Other Metals, in Chemistry and Nuclear Medicine 7, U.Mazzi Ed.,
SGEditoriali, Padova, Italy, 2006, pp 583,588.
Melendez-Alofort L., Riondato M., Nadali A., Banzato A., Camporese D., Boccaccio P., Uzunov
N., Rosato A., Mazzi U.
Bioavailability of 99mTc-Ha-paclitaxel complex [99mTc-ONCOFID-P] in mice using four
different administration routes.
J. Label.Compd & Radiopharm., 2006, 49, 939-950.
Menchise V., De Simone G., Di Fiore A., Scozzafava A., Supuran C. T.
Carbonic anhydrase inhibitors: x-ray crystallographic studies for the binding of 5-amino-1,3,4thiadizole-2-sulfonamide and 5-(4-amino-3-chloro-5-fluorophenylsulfonamido)-1,3,4-thiadiazole-2sulfonamide to human isoform II.
Bioorg Med Chem Lett., 2006, 16, 6204-6208.
Messori L., Gabbiani C., Casini A., Siragusa M., Vincieri F.F., Bilia A.R.
The reaction of artemisinins with hemoglobin: a unified picture.
Bioorg. Med. Chem. 2006,14(9), 2972-7.
Micali N., Villari V., Castriciano M. A., Romeo A., Scolaro L. M.
Journal of Physical Chemistry B 2006, 110, 8289-8295.
Micali N., Villari V., Mazzaglia A., Scolaro L.M., Valerio A., Rencurosi A., Lay L.
Nanotechnology 2006, 17, 3239-3244.
Milacic V., Chen D., Ronconi L., Landis-Piwowar K. R., Fregona D., Dou Q. P.
A Novel Anticancer Gold(III) Dithiocarbamate Complex Inhibits the Activity of a Purified 20S
Proteasome and 26S Proteasome in Human Breast Cancer Cell Cultures and Xenografts.
Cancer Res., 2006, 66, 10478-10486.
Minoura M., Landry V.K., Melnick J.G., Pang K., Marchiò L., Parkin G.
Synthesis and structural characterization of tris(2-seleno-1-mesitylimidazolyl) hydroborato
complexes: A new type of strongly electron donating tripodal selenium ligand.
Chemical Communications. 2006, 38, 3990-3992.
Mohamed A. A., Galassi R., Papa F., Burini A., Fackler J.P.Jr.
Gold(I) and Silver(I) Mixed-Metal Trinuclear Complexes: DimericProducts from the Reaction of
Gold(I) Carbeniates or Benzylimidazolates with Silver(I) 3,5-Diphenylpyrazolate.
Inorganic Chemistry. 2006, 45, 7770-7776.
Monaco S., Sparano V., Gioia M., Sbardella D., Di Pierro D., Marini S., Coletta M.
Enzymatic processing of collagen IV by MMP-2 (gelatinase A) affects neutrophil migration and it
is modulated by extracatalytic domains.
Protein Sci. 2006, 15, 2805-2815.
Mulligan J.M., Greene L., Cloonan S., Mc Gee M., Onnis V., Campiani G., Fattorusso C., Lawler
M., Williams D., Zisterer D.M.
166
Identification of Tubulin as the Molecular Target of Proapoptotic Pyrrolo-1,5-Benzoxazepines.
Mol. Pharmacol., 2006, 70, 60.
Musumeci D., Valente M., Capasso D., Palumbo R., Gorlach M., Schmidtke M., Zell R., Roviello
G. N., Sapio R., Pedone C., Bucci E. M.
A short PNA targeting coxsackievirus B3 5'-nontranslated region prevents virus-induced cytolysis.
Journal of Peptide Science, 2006, 12(3), 161-170.
Mutseneck E.V., Perekalin D.S., Holub J., Starikova Z.A., Petrovskii P.V., Zanello P., Corsini M.,
Štibr B., Kudinov A.R.
(Tetramethylcyclobutadiene)Cobalt Complexes with Phosphacarborane Ligands.
Organometallics, 2006, 25, 2419.
N
Nadali A., Melendez-Alaford L., Pasut G., Camporese D., Zangoni E., Giron M.C., Castagliuolo I.,
Veronese F., Mazzi U.
Indirect 99mTc-labelled UBI using PN2S-PEG Moiety.
In Technetium,Rhenium and Other Metals, in Chemistry and Nuclear Medicine 7, U.Mazzi Ed.,
SGEditoriali, Padova, Italy, 2006, pp 541,542.
Natile G., Marzilli L.G.
Non-covalent interactions in adducts of platinum drugs with nucleobases in nucleotides and DNA
as revealed by using chiral substrates.
Coordination Chemistry Reviews. 2006, vol. 250, pp. 1315-1331.
Nicolis S., Pennati A., Perani E., Monzani E., Sanangelantoni A. M., Casella L.
Easy oxidation and nitration of human myoglobin by nitrite and hydrogen peroxide.
Chem. Eur. J., 2006, 12, 749-757.
P
Pacifico C., Laforgia M., Intini F.P., Padovano G., Natile G.
Two polymorphs of potassium trichloro[diethyl(methylsulfinylmethyl)phosphonate-kS]platinum(II)
with Z'=1 and 3 in the space group P212121.
Acta Crystallographica. Section C, Crystal Structure Communications. 2006, vol. C62, pp. m306m310.
Panzarini E., Ramires P.A., Miccoli M.A., Tenuzzo B., Scordari A., Dini L.
Differentiation of THP-1 and U937 cells in presence of synthetic hydrogels.
Caryologia, 2006, 59(4), 399-407.
Panzarini E., Tenuzzo B., Palazzo F., Chionna A., Dini L.
Apoptosis induction and mitochondria alteration in human HeLa tumor cells by photoproducts of
Rose Bengal acetate.
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2006, 83, 39-47.
Parera E., Ledesma C., Riondato M., Melendez L., Alvarez-Larena A., Bello M., Suades J., Mazzi
U.
Rhenium and Technetium-99m Carbonyl Compounds with Functionalized Phosphines.
In Technetium,Rhenium and Other Metals, in Chemistry and Nuclear Medicine 7, U.Mazzi Ed.,
SGEditoriali, Padova, Italy, 2006, pp 417,418.
Pattacini R., Barbieri L., Stercoli A., Cauzzi D., Graiff C., Lanfranchi M., Tiripicchio A., Elviri L.
167
Zwitterionic Metalates of Group 11 Elements and Their Use as Metalloligands for the Assembly of
Multizwitterionic Clusters.
Journal of the American Chemical Society. 2006, 128(3), 866-876.
Pavoni E., Flego M., Dupuis M. L., Barca S., Petronzelli F., Anastasi A. M., D'Alessio V., Pelliccia
A., Vaccaro P., Monteriu G., Ascione A., De Santis R., Felici F., Cianfriglia M., Minenkova O.
Bmc Cancer 2006, 6.
Pavoni E., Pucci A., Vaccaro P., Monteriu G., Ceratti A. D., Lugini A., Virdis R. A., Cortesi E., De
Gaetano A., Panunzi S., Felici F., Minenkova O.
Cancer Detection and Prevention 2006, 30, 248-256.
Peck O. M., Zingarelli B., Fan H. K., Teti G., Tempel G., Halushka P. V., Cook J. A.
Shock 2006, 26, 31-36.
Pedone C., Morelli G., Tesauro D., Saviano M.
Peptide structure and analysis.
Radionuclide Peptide Cancer Therapy (2006), 1-30.
Pedone E., D'Ambrosio K., De Simone G., Rossi M., Pedone C., Bartolucci S.
Insights on a New PDI-like Family: Structural and Functional Analysis of a Protein Disulfide
Oxidoreductase from the Bacterium Aquifex aeolicus.
Journal of Molecular Biology, 2006, 356(1), 155-164.
Pellei M., Gioia Lobbia G., Mancini M., Spagna R., Santini C.
Synthesis and characterization of new organotin(IV) complexes with polyfunctional ligands.
J. Organomet. Chem., 2006, 691,1615-1621.
Pellerito C., Nagy L., Pellerito L. Szorcsikc A.
Biological activity studies on organotin(IV)n+ complexes and parent Compounds.
J. Organometal. Chem., 2006, 691, 1733–1747.
Pellerito C., Scopelliti M., Fiore T., Nagy L., Barone G., Abbate M., Stocco G.C., Pellerito L.
Structural investigations on diorgano- and trior ganotin(IV) derivatives of [meso-tetra(4sulfonatophenyl)porphine] metal chlorides.
J. Organometal Chem., 2006, 691, 1573-1583.
Pellicani R.Z., Intini F.P., Maresca L., Mesto E., Pacifico C., Natile G.
The first example of a dinuclear platinum(III) complex with three bridging ligands.
European Journal of Inorganic Chemistry. 2006, pp. 1635-1642.
Pelosi G., Belicchi Ferrari M., Rodríguez-Argüelles M.C., Mosquera-Vazquez S., Sanmartín J.
Sodium 2-oxo-3-semicarbazono-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonate dihydrate.
Acta Crystallogr. 2006, C62, m241-m242.
Pierre V. C., Botta M., Aime S., Raymond K. N.
Fe(III)-templated Gd(III) self-assemblies – a new route toward macromolecular MRI contrast
agents.
J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 9272-9273.
Pierre V. C., Botta M., Aime S., Raymond K. N.
168
Substituent effects on Gd(III)-based MRI contrast agents: optimizing the stability and selectivity
of the complex and the number of coordinated water molecules.
Inorg. Chem., 2006, 45,8355-8364.
Pierre V. C., Botta M., Aime S., Raymond K. N.
Tuning the coordination number of hydroxypyridonate-based gadolinium complexes: implications
for MRI contrast agents.
J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 5344-5345
Pilloni G., Toffoletti A., Bandoli G., Longato B.
Homoleptic Complexes of Cobalt(0) and Nickel(0,I) with 1,1‟-Bis(diphenylphosphino)ferrocene
(dppf): Synthesis and Characterization.
Inorg. Chem. 2006, 45, 10321.
Pisani M., Bruni P., Caracciolo G., Caminiti R., Francescangeli O.
J.Phys. Chem. B, 2006, 110,13203-13211;
Platts J. A., Oldfield S. P., Reif M. M., Palmucci A., Gabano E., Osella D.
The RP-HPLC measurement and QSPR analysis of log Po/w values of several Pt(II) complexes.
J. Inorg Biochem., 2006, 100, 1199-1207.
Porchia M., Papini G., Santini C., Gioia Lobbia G., Pellei M., Tisato F., Bandoli G., Dolmella A.
Rhenium oxo compounds containing tripodal bis(3,5-dimethylpyrazol-1-yl)acetate scorpionate
ligands.
Inorganica Chimica Acta 2006, 359, 2501–2508.
Prodi A., Chiorboli C., Scandola F., Iengo E., Alessio E.
Electronic Energy Transfer in a Multiporphyrin-based Molecular Box.
ChemPhysChem, 2006, 7, 1514-1519.
Puerta D. T., Botta M., Jocher C. J., Werner E. J., Avedano S., Raymond K. N., Cohen S.
Tris(pyrone) chelates of Gd(III) as high solubility MRI-CA.
J. Am. Chem. Soc., 2006, 128, 2222-2223.
Q
Quagliotto P., Montoneri E., Tambone F., Adani F., Gobetto R., Viscardi G.
Chemicals from wastes: Compost-derived humic acid-like matter as surfactant.
Environmental Science & Technology, 2006, 40(5), 1686-1692.
Quesada M., de Hoog P., Gamez P., Roubeau O., Aromi G., Donnadieu B., Massera C., Lutz M.,
Spek A., Reedijk J.
Coordination Dependence of Magnetic Properties within a Family of [FeII2] Related Complexes of a
Triazine-based Ligand.
Eur. J. Inorg. Chem. 2006, 7, 1353-1361.
R
Randaccio L., Geremia S., Nardin G., Wuergess J.
X-ray structural chemistry of cobalamins.
Cord. Chem. Rev., 2006, 250, 1332-1350.
169
Ravera M., Cassino C., Baracco S., Osella D.
New insights into the redox chemistry of ruthenium metallopharmaceuticals: the electrochemical
behaviour of [LH][trans-RuIIICl4L2] (L = imidazole or indazole) complexes.
Eur. J. Inorg. Chem., 2006, 740-746.
Ravera M., Ciccarelli C., Gastaldi D., Rinaudo C., Castelli C., Osella D.
An Electrokinetic Removal Experiment of Copper from Soil Contaminated by Brass Industry.
Chemospere, 2006, 63, 950-955.
Ricelli A., Baruzzi F., Solfrizzo M., Morea M., Fanizzi F. P.
Biotransformation of patulin by Gluconobacter oxydans.
Appl. Environ. Microbiol., 2006. Advance paper. DOI:10.1128/AEM.02032-06.
Rinaudo C., Cairo S., Gastaldi D., Gianfagna A., Mazziotti Tagliani S., Tosi G., Conti C.
Mineralogical Magazine 2006, 70(3), 291-298.
Rodriguez J., Di Pierro D., Gioia M., Monaco S., Delgado R., Coletta M., Marini S.
Effects of a natural extract from Mangifera indica L, and its active compound mangiferin on energy
state and lipid peroxidation of red blood cells.
Biochim. Biophys. Acta 2006, 1760, 1333-1342.
Romano S., Muscella A., Storelli C., Marsigliante S.
Angiotensin II does not stimulate proliferation of rat thyroid PC Cl3 cell line.
J. Endocrinol., 2006 Dec;191(3), 727-35.
Romeo R., Carnabuci S., Fenech L., Plutino M. R., Albinati A.
Angewandte Chemie-International Edition 2006, 45, 4494-4498.
Romeo R., D'Amico G.
Organometallics 2006, 25, 3435-3446.
Roncone R., Barbieri M., Monzani E., Casella L.
Reactive nitrogen species of physiological relevance: mechanism of formation and biological
targets.
Coord. Chem. Rev., 2006, 250, 1286-1293.
Ronconi L., Marzano C., Zanello P., Corsini M., Miolo G., Maccà C., Trevisan A., Fregona D.
Gold(III) dithiocarbamate derivatives for the treatment of cancer solution chemistry, DNA binding
and haemolytic properties.
J. Med. Chem., 2006, 49, 1648-1657.
Ronga L., Palladino P., Tizzano B., Marasco D., Benedetti E., Ragone R., Rossi F.
Effect of salts on the structural behavior of hPrP alpha2-helix-derived analogues: the counterion
perspective.
Journal of peptide science : an official publication of the European Peptide Society, 2006, 12(12),
790-5.
Ronga L., Tizzano B., Palladino P., Ragone R., Urso E., Maffia M., Ruvo M., Benedetti E., Rossi F.
The prion protein: structural features and related toxic peptides.
Chemical Biology & Drug Design, 2006, 68(3), 139-47.
170
Rotondo A.
Acta Crystallographica Section C-Crystal Structure Communications 2006, 62, M19-M21.
Roveri N., Falini G., Foresti E., Fracasso G., Lesci I. G., Sabatino P.
GeoinspiredSynthetic Chrysotile Nanotubes.
J. Mat. Research, 2006, 21(11), 2711-2725.
Roveri N., Palazzo B.
Hydroxyapatite nanocrystals as bone substitutes.
Nanotechnologies for the Lifesciences “Nanomaterials and Technologies for Tissue Engineering”
Kumar (ed.) Wiley - 2006, 8, 283-307
Rudovský J., Botta M., Hermann P., Hardcastle K. I., Lukeš I., Aime S.
PAMAM dendrimeric conjugates with a Gd-DOTA phosphinate derivative and their adducts with
polyaminoacids: the interplay of global motion, internal rotation, and fast water exchange.
Bioconjugate Chem., 2006, 17, 975-987.
Rudovský J., Botta M., Hermann P., Koridze A., Aime S.
Relaxometric and solution NMR strucural studies on ditopic lanthanide(III) complexes of a
phosphinate analogue of DOTA with a fast rate of water exchange.
Dalton Trans., 2006, 2323-2333.
S
Salmar S., Cravotto G., Tuulmets A., Hagu H.
Effect of Ultrasound on the Base-Catalyzed Hydrolysis of 4-Nitrophenyl Acetate in Aqueous
Ethanol.
J. Phys. Chem., B. 2006, 110 (11), 5817-5821.
Sannino A., Madaghiele M., Lionetto M.G., Schettino T., Maffezzoli A.
A cellulose-based hydrogel as a potential bulking agent for hypocaloric diets: an in vitro
biocompatibility study on rat intestine.
Journal of Applied Polymer Science, 2006, 102, 1524-1530.
Saporito A., Marasco D., Chambery A., Botti P., Monti S. M., Pedone C., Ruvo M.
The chemical synthesis of the GstI protein by NCL on a x-met site.
Biopolymers, (2006, 83(5), 508-518.
Saviano M.
Recent Development in Bioinorganic Chemistry: Metal Complexes of Bioactive Molecules.
TransWorld Research Network India, 2006.
Schätz A., Scarel A., Zangrando E., Mosca L., Carfagna C., Gissibl A., Milani B., Reiser O.
High Stereocontrol and Efficiency in CO/Styrene Polyketones Synthesis Promoted by
Azabis(oxazoline)-Palladium Complexes.
Organometallics, 2006, 25, 4065-4068.
Scolaro L. M., Castriciano M. A., Romeo A., Micali N., Angelini N., Lo Passo C., Felici F.
Journal of the American Chemical Society, 2006, 128, 7446-7447.
Scolaro L. M., Plutino M. R., Romeo A., Romeo R., Ricciardi G., Belviso S., Albinati
A. Dalton Transactions 2006, 2551-2559.
171
Senanayake K., Thompson A. L., Howard J. A. K., Botta M., Parker D.
Synthesis and characterization of dimeric eight-coordinate lanthanide(III) complexes of a
macrocyclic tribenzylphosphinate ligand.
Dalton Trans., 2006, 5423-5428.
Shaheen F., Marchiò L., Badshah A., Khosa M. K.
(Z)-4-Anilinopent-3-en-2-one.
Acta Crystallographica, Section E: Structure Reports Online. 2006, E62(3), o873-o874.
Siega P., Randaccio L., Marzilli P. A., Marzilli L. G.
Metal Coordination by Sterically Hindered Heterocyclic Ligands, Including 2-Vinylpyridine,
Assessed by Investigation of Cobaloximes.
Inorg. Chem., 2006, 45, 3359-3368.
Silipigni L., De Luca G., Quattrone Q., Scolaro L. M., Salvato G., Grasso V.
Journal of Physics-Condensed Matter 2006, 18, 5759-5772.
Sinibaldi F., Howes B.D., Piro M.C., Caroppi P., Mei G., Ascoli F., Smulevich G., Santucci R.
Insights into the role of the histidines in the structure and stability of cytochrome c.
J. Biol. Inorg. Chem. 2006, 11, 52-62.
Sinibaldi F., Piro M.C., Coletta M., Santucci R.
Salt-induced formation of the A-state of ferricytochrome c. Effect of the anion charge on protein
structure.
FEBS J. 2006, 273, 5347-5357.
Song L.-C., -H.Su F., -M.Hu Q., Grigiotti E., Zanello P.
Synthesis, Characterization, and Electrochemical Properties of Novel Transition Metal-Fullerene
Complexes Containing Di- And Tetraphosphane Ligands.
Eur.J.Inorg.Chem., 2006, 422.
Sortino S., Mazzaglia A., Scolaro L. M., Merlo F. M., Valveri V., Sciortino M. T.
Biomaterials 2006, 27, 4256-4265.
Stanczak P., Valensin D., Porciatti E., Jankowska E., Grzonka Z., Molteni E., Gaggelli E.,
Valensin G., Kozlowski H.
Tandem Repeat-Like Domain of "Similar To Prion Protein" (STPRP) of Japanese Pufferfish Binds
Cu(II) as Effectively as the Mammalian Protein.
Biochemistry, 2006, 45, 12227.
Szorcsik A., Nagy L., Scopelliti M., Deák A., Pellerito L., Galbács G., Hered M.
Preparation and structural characterization of Ph3Sn(IV)+ complexes with pyridinecarboxylic acids
or hydroxypyridene, -pyrimidine and –quinoline.
J. Organometal.Chem., 2006, 691, 1622-1630.
Szorcsik A., Nagy L., Sipos P., Berenji P., Scopelliti M., Pellerito L.
FT-IR and Mössbauer Investigations of Complexes Formed between [Me2Sn(IV)]2+ and
Carboxymethyl-Celluloses with Various Degrees of Carboxymethylation.
Carb. Res., 2006, 341, 2083–2089.
T
172
Taddia M.
Il segreto della soda artificiale.
Kos, Nuova serie, 2006, n. 248, pp. 40-47.
Taddia M.
La storia insegna…anche la stechiometria.
CnS-La Chimica nella Scuola, anno XXVIII, 2006, n.3, pp. 149-153.
Taddia M.
Storia della scienza e integrazione europea.
La Chimica e l'Industria, 2006, 88(9), p. 36-37.
Taddia M.
Un ritratto di Robert Boyle inciso da un'artista francescana del '600.
La Chimica e l'Industria, 2006, 88(4), pp. 80-81.
Tardito S., Bussolati O., Gaccioli F., Gatti R., Guizzardi S., Uggeri J., Marchiò L., Lanfranchi M.,
Franchi-Gazzola R.
Non-apoptotic programmed cell death induced by a copper(II) complex in human fibrosarcoma
cells.
Histochemistry and Cell Biology. 2006, 126(4), 473-482.
Tamasi G., Botta F., Cini R.
Dft-Molecular Modeling Analysis Of C-H…N And C-H…S Hydrogen Bond Type Interactions in
Selected Platinum-Purine/Pyrimidine Complexes.
J. Mol. Struct. Theochem, 2006, 766, 61.
Tamasi G., Cini R.
Technetium And Rhenium Complexes as Possible Radio-Pharmaceuticals and other Metal
Complexes of Interest for Medicinal Inorganic Chemistry.
Science And Supercomputing At Cineca 2005 Report, 2006, 199.
Tebben L., Neumann M., Kehr G., Fröhlich R., Erker G., Losi S., Zanello P.
Development of a Convenient New Synthetic Route To [3]Ferrocenophanones.
Dalton Trans., 2006,1715.
Tenuzzo B., Chionna A., Panzarini E., Lanubile R., Tarantino P., Di Jeso B., Dwikat M., Dini L.
Biological effects of 6 mT Static Magnetic Fields: a comparative study in different cell types.
Bioelectromagnetics, 2006, 27(7), 560-577.
Tenuzzo B., Zatta L., Dini L.
Phagocytosis of apoptotic cells during liver development.
Caryologia, 2006, 59(4), 384-391.
Terreno E., Botta M., Dastrù W., Aime S.
Gd-enhanced MR images of substrates other than water.
Contrast Med. Mol. Imaging. 2006, 1, 101-105.
Terreno E., Crich S.G., Belfiore S., Biancone L., Cabella C., Esposito G., Manazza A.D., Aime S.
Effect of the intracellular localization of a Gd-based imaging probe on the relaxation enhancement
of water protons.
Magn. Reson. Med., 2006, 55(3), 491-497.
173
Thompson L., Parker D., Fulton D. A., Howard J. A. K., Pandya S. U., Puschmann H.,
Senanayake K., Stenson P. A., Badari A., Botta M., Avedano S., Aime S.
On the role of the counter-ion in defining water structure and dynamics: order, structure and
dynamics in hydrophilic and hydrophobic gadolinium salt complexes.
Dalton Trans., 2006, 21(47), 5605-5616.
Triolo R., Lo Celso F., Gorgoni C., Pallante P., Schwann D., Baron M.
Mesoscopic structure of marble determined by combined USANS and SANS.
Journal of Neutron Research, 2006, 14, 59–67.
Trost P., Fermani S., Marri L., Zaffagnini M., Falini G., Scagliarini S., Pupillo P., Sparla F.
Thioredoxin-dependent regulation of photosynthetic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase:
Autonomous vs. CP12-dependent mechanisms.
Photosynthesis Research, 2006, 89(2-3), 263-275.
U
Ulianich L., Elia M.G., Treglia A.S., Muscella A., Di Jeso B., Storelli C., Marsigliante S.
The sarcoplasmic-endoplasmic reticulum Ca2+ ATPase 2b regulates the Ca2+ transients elicited by
P2Y2 activation in PC Cl3 thyroid cells.
J. Endocrinol., 2006 Sep;190(3), 641-9.
V
Vaccaro M., Accardo A., Tesauro D., Mangiapia G., Loef D., Schillen K., Soederman O., Morelli
G., Paduano L.
Supramolecular Aggregates of Amphiphilic Gadolinium Complexes as Blood Pool MRI/MRA
Contrast Agents: Physicochemical Characterization.
Langmuir, 2006, 22(15), 6635-6643.
Vaccaro P., Pavoni E., Monteriu G., Andrea P., Felici F., Minenkova O.
Journal of Immunological Methods 2006, 310, 149-158.
Vasalatiy O., Zhao P., Zhang S., Aime S., Sherry A.D.
Catalytic effects of apoferritin interior surface residues on water proton exchange in lanthanide
complexes.
Contrast Media Mol. Imaging., 2006, 1(1), 10-4.
Villano M., Amendola V., Sandonà G., Donzello M.P., Meneghetti M., Ercolani C.
A Pyrazinoporphyrazine Macrocycle Carrying Externally Appended Pyridine Rings: Excited
States Dynamic and Nonlinear Absorption of Its Mg(II) Derivative.
J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 24354-24360.
W
Wuerges J., Garau G., Geremia S., Fedosov S. N., Petersen T. E., Randaccio L.
Structural basis for mammalian vitamin B12-transport by transcobalamin.
PNAS, 2006, 103, 4386 – 4391.
Z
174
Zanello P., Corsini M.
Homoleptic, Mononuclear Transition Metal Complexes Of 1,2-Dioxolenes: Updating Their
Electrochemical-to-Structural (X-Ray) Properties.
Coord. Chem. Rev., 2006, 250, 2000.
BREVETTI
Accardo A., Tesauro D., Paduano L., Pedone C., Aloj L., Morelli G.
Supramolecular aggregates containing chelating agents and bioactive peptides for delivery of
antitumor drugs and contrast agents in MRI or nuclear medicine.
PCT Int. Appl. (2006), 50pp. CODEN: PIXXD2 WO 2006 128643
Bucci E., Moccia M., Musumeci D., Pedone C., Roviello G., Sapio R., Valente M.
Method for sequencing nucleic acids and analogues thereof.
PCT Int. Appl. (2006), 20pp. CODEN: PIXXD2 WO 2006 131249
Butini S., Campiani G., De Angelis M., Franceschini S., Trotta F.
Novel Aryl Piperazine Derivatives With Medical Utility. 2006.
Campiani G., Butini S., Fattorusso C.
Aryl Piperazine Derivatives for the Treatment of Neuro-Phsychiatric Disorders. 2006.
Campiani G., De Angelis M., Fattorusso C., Fattorusso E., Gemma S., Joshi B., Kukreja G.
Antimalarial Agents Having Polyaromatic Structure. 2006.
Campiani G., Fattorusso C., Butini S., Gemma S.
Composti Attivi sui Recettori Glutammatergici. 2006.
Campiani G., Gemma S., De Angelis M., Gagan B., Savini L., Fattorusso E., Taglialatela M.,
Fattorusso C.
Novel Polycyclic Compounds as Antimalarial Agents. 2006.
D'Andrea L., Pedone C., Abrescia P.
Methods for identifying agents modulating reverse cholesterol transport or metabolism of steroid
for treatment of cardiovascular disease, ovarian follicle dysfunction and other metabolic diseases.
PCT Int. Appl. (2006), 28 pp. CODEN: PIXXD2 WO 2006 008775.
Del Gatto A., Zaccaro L., Pedone C., Saviano M.
Selective, alfav beta3 receptor peptide antagonist for therapeutic and diagnostic
applications”PCT/EP2006/009733 (2006)
Palazzo B., Roveri N., Iafisco M., Rimondini L., Gazzaniga G., Gualandi P.
Biologically active nanoparticles of a carbonate-substituted hydroxyapatite, process for their
preparation and composition incorporating the same.
International patent. Deposited PCT 12/05/2006 Gua/CB.
Verdoliva A., Bellofiore P., Cassani G., Marasco D., Pedone C., Monti S., Ruvo M.
Peptide ligands specific to immunoglobulins.
Eur. Pat. Appl. (2006), 17 pp. CODEN: EPXXDW EP 1621546
175
176
PERSONALE AFFERENTE
177
178
UNITA’ LOCALE DI BARI
Personale
Agostiano Angela
Gallerani Raffaele
Giordano Domenico
Landriscina Clemente
Marcotrigiano Giuseppe
Maresca Luciana
Natile Giovanni
Catucci Lucia
Coluccia Mauro
Pacifico Concetta
Arnesano Fabio
Boccarelli Angelina
Casalino Elisabetta
Ceci Luigi Ruggiero
Di Benedetto Angela
Garofalo Rita
Intini Francesco Paolo
Margiotta Nicola
Storelli Maria Maddalena
Trotta Massimo
Barone Carmen
Cornacchia Daniele
Ostuni Rosa
Pellicani Zoe Raffaella
Ranaldo Rosa
Sasanelli Rossella
Scintilla Simone
Cerasino Leonardo
Busco Vito Pietro
Di Masi Nicola Giovanni
Dompietro Maria Teresa
Giampietro Antonio
Sblano Cesare
Storelli Arianna
Cannito Francesco
Racaniello Francesco
Bottalico Simona
Losacco Maurizio
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Primo Ricercatore
Ricercatrice
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Dottoranda
Dottorando
Dottoranda
Dottoranda
Dottoranda
Dottoranda
Dottorando
Assegnista di ricerca
Tecnico
Tecnico
Tecnico a Contratto
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Tecnico laureato
Responsabile Amministrativo
Coll.re d‟Amm.ne
Borsiata
Dipartimento
Dip. di Chimica
Dip. di Biochim. e Biol. Molecolare
Dip. Scienze Biomed. E Oncol.
Ist. Chimica MED. VET.
Ist. Chimica MED. VET
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Farmaco-chimico
Dip. di Chimica
Dip. Scienze Biomed. E Oncol.
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Scienze Biomed. E Oncol.
Ist. Chimica MED. VET
CNR
Dip. di Chimica
Ist. Chimica MED. VET
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Farmaco-chimico
Ist. Chimica MED. VET
CNR
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Scienze Biomed. E Oncol.
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Farmaco-chimico
Ist. Chimica MED. VET
Dip. Farmaco-chimico
Dip. Farmaco-chimico
Ist. Chimica MED. VET
Ist. Chimica MED. VET
Ist. Chimica MED. VET
C.I.R.C.M.S.B.
C.I.R.C.M.S.B.
C.I.R.C.M.S.B.
-
UNITÀ LOCALE DI BOLOGNA
Personale
Qualifica
Dipartimento
Ripamonti Alberto
Roveri Norberto
Fabbri Daniele
Foresti Elisabetta
Rimondini Lia
Sabatino Piera
Prof. Emerito
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
179
Taddia Marco
Falini Giuseppe
Iafisco Michele
Tosi Giovanna
Fermani Simona
Lesci Giorgio Isidoro
Palazzo Barbara
Zuccheri Tommaso
Manara Silvia
Caroselli Alessio
Corallo Antonio
Occhi Emiliano
Paoli Federica
Molinas Maria
Fracasso Guido
Modelli Stefano
Morselli Silvana
Prof. Associato
Ricercatore
Dottorando
Dottoranda
Assegnista
Assegnista
Assegnista
Assegnista
Contrattista
Borsista
Borsista
Borsista
Borsista
Segr.Amministrativo
Tecnico
Tecnico
Tecnico
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
Dip. Chimica “Ciamician”
UNITA’ LOCALE DI CAMERINO
Personale
Cingolani Augusto
Gioia Lobbia Giancarlo
Fioretti Evandro
Angeletti Mauro
Burini Alfredo
Lupidi Giulio
Lorenzotti Adriana
Marchetti Fabio
Pettinari Claudio
Santini Carlo
Galassi Rossana
Pellei Maura
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Tecnico
Dipartimento
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
B.M.C.A.
B.M.C.A.
Scienze Chimiche
B.M.C.A.
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
B.M.C.A.= Biologia Molecolare cellulare e animale
UNITÀ LOCALE DI CATANIA
Personale Docente
Arena Giuseppe
Bonomo Raffaele
Cucinotta Vincenzo
Purrello Roberto
Rizzarelli Enrico
D‟Alessandro Franca
De Guidi Guido
Giuffrida Salvatore
Impellizzeri Giuseppe
Maccarone Giuseppe
Sortino Salvatore
Spoto Giuseppe
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Dipartimento
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
Scienze Chimiche
180
Vecchio Graziella
Attanasio Francesco
Grasso Giulia
La Mendola Diego
Laceri Rosaria
Magrì Antonio
Miliardi Danilo
Pappalardo Giuseppe
Santoro Anna Maria
Tabbì Giovanni
Vagliasindi Laura Irene
D‟Urso Alessandro
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Dottorando
Borsista
Scienze Chimiche
IBB CNR – Sezione di Catania
IBB CNR – Sezione di Catania
IBB CNR – Sezione di Catania
IBB CNR – Sezione di Catania
IBB CNR – Sezione di Catania
IBB CNR – Sezione di Catania
IBB CNR – Sezione di Catania
IBB CNR – Sezione di Catania
IBB CNR – Sezione di Catania
Scienze Chimiche
CIRCMSB
Grasso Giuseppe
Borsista FIRB
Scienze Chimiche
UNITÀ LOCALE DI FERRARA
Personale Docente
Medici Alessandro
Maldotti Andrea
Marchi Andrea
Remelli Maurizio
Bergamini Paola
Marvelli Lorenza
Masarati Enrico
Fratta Marcello
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Dottorando
Tecnico
Dipartimento
Dip. Risorse Naturali e Culturali
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
UNITA’ LOCALE DI FIRENZE
Personale
Marzocchi Mario
Scozzafava Andrea
Smulevich Giulietta
Vincieri Francesco Franco
Bilia Anna Rita
Briganti Fabrizio
Messori Luigi
Gianneschi Mauro
Feis Alessandro
Ferraroni Marta
Supuran Claudio
Barbaro Pierluigi
Bianchini Claudio
Casini Angela
Temperini Claudia
Vullo Daniela
Gabbiani Chiara
Innocenti Alessio
Bruni Bruno
Monnanni Roberto
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Borsista
Borsista
Borsista
Borsista
Assegnista
Tecnico
Tecnico
Dipartimento
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. Scienze Farmaceutiche
Dip. Scienze Farmaceutiche
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica Organica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
CNR Firenze
CNR Firenze
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
CIRCMSB
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
Dip. di Chimica
181
UNITA’ LOCALE DELL’INSUBRIA
Personale
Palmisano Giovanni
Sisti Massimo
Fumagalli Alessandro
Banfi Stefano
Tollari Stefano
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Dipartimento
Dip. Scienze Chimiche e Ambientali
Dip. Scienze Chimiche e Ambientali
Dip. di Biologia Strutturale e Funz.
Dip.di Biologia Strutturale e Funz.
Dip. Scienze Chimiche e Ambientali
UNITA’ LOCALE DI LECCE
Personale
Dini Luciana
Fanizzi Francesco Paolo
Schettino Trifone
Ciccarese Antonella
Di Jeso Bruno
Maffia Michele
Marsigliante Santo
Benedetti Michele
Lionetto Maria Giulia
Muscella Antonella
Rizzello Antonia
Calabriso Nadia
Calisi Antonio
Capoccia Serena
Del Coco Laura
Durante Cosimo
Erroi Elisa
Panzarini Elisa
Scordari Alessandra
Urso Loredana
Vecchio Vita Mariagrazia
Caricato Roberto
De Pascali Sandra Angelica
Tarantino Patrizia
Tenuzzo Bernadetta
Zazza Laura
Migoni Danilo
Papadia Paride
Urso Emanuela
Acierno Raffaele
Giordano Maria Elena
Treglia Sonia Antonella
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatrice
Ricercatrice
Giov. Ricercatrice (co.co.pro.)
Dottorando
Dottorando
Dottorando
Dottorando
Dottorando
Dottorando
Dottorando
Dottorando
Dottorando
Dottorando
Contrattista
Contrattista
Contrattista
Contrattista
Contrattista
Assegnista
Assegnista
Assegnista
Tecnico Laureato
Tecnico Laureato
Tecnico Laureato
Dipartimento
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A.
D.I.S.T.E.B.A. = Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali
UNITA’ LOCALE DI MESSINA
Personale
Bruno Giuseppe
Cusumano Matteo
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Dipartimento
C.I.C.A.F.
C.I.C.A.F.
182
Felici Francesco
Prof. Ordinario
S.G.M.
Monsù Scolaro Luigi
Prof. Ordinario
C.I.C.A.F.
Romeo Raffaello
Prof. Ordinario
C.I.C.A.F.
Rotondo Enrico
Prof. Ordinario
C.I.C.A.F.
Teti Giuseppe
Prof. Ordinario
P.M.S.
Giannetto Antonino
Prof. Associato
C.I.C.A.F.
Nicolò Francesco
Prof. Associato
C.I.C.A.F.
Di Pietro Letizia
Ricercatrice
C.I.C.A.F.
Lo Passo Carla
Ricercatrice
S.G.M.
Romeo Andrea
Ricercatore
C.I.C.A.F.
Rotondo Archimede
Dottorando
C.I.C.A.F.
Castriciano Maria Angela Assegnista
C.I.R.C.M.S.B.
C.I.C.A.F. = Dipartimento di Chimica Inorganica, Chimica Analitica e Chimica Fisica
S.G.M. = Dip. Scienze Microbiologiche Genetiche e Molecolari
P.M.S. = Dip. Patologia e Microbiologia Sperimentale
UNITA’ LOCALE DI NAPOLI
Personale
Busico Vincenzo
Abbrescia Paolo
Benedetti Ettore
Di Blasio Benedetto
Paolillo Livio
Pavone Vincenzo
Pedone Carlo
Vitagliano Aldo
D‟Auria Gabriella
Fattorusso Roberto
Galdiero Massimiliano
Isernia Carla
Lombardi Angela
Morelli Giancarlo
Pedone Paolo Vincenzo
Rossi Filomena
Ruffo Francesco
Bucci Enrico
Ruvo Menotti
Saviano Michele
Vitagliano Luigi
D‟Andrea Luca Domenico
De Simone Giuseppina
Di Gaetano Sonia
Improta Roberto
Luongo Delia
Menchise Valeria
Monti Simona Maria
Palumbo Rosanna
Zaccaro Laura
Aloj Luigi
Cipullo Roberta
Qualifica
Prof. Straordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Primo Ricercatore CNR
Primo Ricercatore CNR
Primo Ricercatore CNR
Primo Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Ricercatore CNR
Ricercatore Univ.
Ricercatore Univ.
183
Dipartimento
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
Cucciolito Maria Elena
Falcigno Lucia
Galdiero Stefania
Messere Anna
Tesauro Diego
Trifuoggi Marco
Talarico Giovanni
Ricercatore Univ.
Ricercatore Univ.
Ricercatore Univ.
Ricercatore Univ.
Ricercatore Univ.
Ricercatore Univ.
Assegnista di Ricerca
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B.
C.I.R.P.B. = Centro Interuniversitario di Ricerca su Peptidi Bioattivi
UNITA’ LOCALE DI PADOVA
Personale
Bandoli Giuliano
Vidali Maurizio
Faraglia Giuseppina
Longato Bruno
Marzotto Armando
Mazzi Ulderico
Pilloni Giuseppe
Tallandini Laura
Dolmella Alessandro
Fregona Dolores
Guantieri Valeria
Gandin Valentina
Marzano Cristina
Montagner Diego
Zangoni Elena
Giovagnini Lorena
Melendez Laura
Camporese Davide
Nadali Anna
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Dottoranda
Dottorando
Dottorando
Dottoranda
Assegnista
Assegnista
Borsista Postdoc
Borsista
Dipartimento
Dip. Scienze Farm.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Scienze Farm.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Scienze Farm.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
Dip. Chim. Inorg. Metal. Anal.
CIRCMSB
UNITA’ LOCALE DI PALERMO
Personale
Bertazzi Nuccio
De Lisi Rosario
Gianguzza Antonio
Gianguzza Mario
Milioto Stefania
Pellerito Lorenzo
Stocco Giancarlo
Triolo Roberto
Casella Girolamo
Fiore Tiziana
Pellerito Claudia
Piazzese Daniela
Scopelliti Michelangelo
Abbate Michele
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Borsista
Dipartimento
Dip. Chimica Inorganica
Dip. Chimica Fisica
Dip. Chimica Inorganica
Dip. Biologia-Medicina
Dip. Chimico Fisica
Dip. Chimica Inorganica
Dip. Chimica Inorganica
Chimica Fisica
Dip. Chimica Inorganica
Dip. Chimica Inorganica
Dip. Chimica Inorganica
Dip. Chimica Inorganica
Dip. Chimica Inorganica
CIRCMSB
184
Di Prima Filippa
Di Prima Maria
Uccello Maria
Segretario Amministrativo
Segretario Amministrativo
Segretario Amministrativo
Dip. Chimica Inorganica
Dip. Chimica Inorganica
Dip. Chimica Inorganica
UNITÀ LOCALE DI PARMA
Personale
Lanfranchi Maurizio
Pellinghelli Maria Angela
Ugozzoli Franco
Dallavalle Francesco
Ferrari-Belicchi Marisa
Franchi Gazzola Renata
Pelosi Giorgio
Tarasconi Pieralberto
Bisceglie Franco
Buschini Annamaria
Marchiò Luciano
Massera Chiara
Tegoni Matteo
Tardito saverio
Pinelli Silvana
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Dottorando
Assistente tecnico
Dipartimento
CGICACF
CGICACF
CGICACF
CGICACF
CGICACF
DMS-PGC
CGICACF
CGICACF
CGICACF
GBMAE
CGIACF
CGIACF
CGIACF
DMS-PGC
CMNSP
CMNSP = Dipartimento di Clinica Medica, Nefrologia e Scienze della Prevenzione
CGICACF = Dipartimento di Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Analitica, Chimica Fisica
GBMAE = Dipartimento di Genetica, Biologia dei Microrganismi, Antropologia,Evoluzione
DMS-PGC = Dip. di Medicina Sperimentale sez. Patologia Generale e Clinica
UNITA’ LOCALE DI PAVIA
Personale
Casella Luigi
Fabbrizzi Luigi
Licchelli Maurizio
Poggi Antonio
Monzani Enrico
Pallavicini Piersandro
Taglietti Angelo
Amendola Valeria
Palavicini Sara
Patroni Stefano
Barbieri Marica
Bonizzoni Marco
Cacchione Giovanni
Colucci Guido
Nicolis Stefania
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Dottorando
Dottorando
Borsista
Borsista
Borsista
Borsista
Assegnista
Dipartimento
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
CIRCMSB
Dip. Chimica Generale
Dip. Chimica Generale
UNITA’ LOCALE DEL PIEMONTE ORIENTALE
Personale
Osella Domenico
Viano Ilario
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Dipartimento
DiSAV
DiSM
185
Botta Mauro
Ravera Mauro
Colangelo Donato
Giovenzana Giovanni B.
Tei Lorenzo
Cassino Claudio
Musso Davide
Gabano Elisabetta
Lovazzano Clara
Bonetti Samuele
Avedano Stefano
Buico Alessandra
Morgese Francesca
Prof. Straordinario
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Tecnico D
Tecnico D
Assegnista di Ricerca
Assegnista di Ricerca
Dottorando
Dottorando
Dottorando
Borsista
DiSAV
DiSAV
DiSM
DiSCAFF
DiSAV
DiSAV
DiSAV
DiSAV
DiSAV
DiSAV
DiSAV
DiSAV
DiSAV
DiSAV: Dipartimento di Scienze dell‟Ambiente e della Vita
DiSM: Dipartimento di Scienze Mediche
DiSCAFF: Dipartimento di Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e Farmacologiche
UNITA’ LOCALE POLITECNICA DELLE MARCHE
Personale
Bruni Paolo
Tosi Giorgio
Giorgini Elisabetta
Conti Carla
Sabbatini Simona
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Ricercatore
Tecnico
-
Dipartimento
Dip. di Scienz. Mat. e Terra
Dip. di Scienz. Mat. e Terra
Dip. di Scienz. Mat. e Terra
Dip. di Scienz. Mat. e Terra
Dip. di Scienz. Mat. e Terra
UNITA’ LOCALE DI ROMA “LA SAPIENZA”
Personale
Ercolani Claudio
Monacelli Fabrizio
Borghi Elena
Donzello Maria Pia
Dragone Roberto
Viola Elisa
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Dottoranda
Dipartimento
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Chimica
Dipartimento di Chimica
UNITA’ LOCALE DI ROMA “TOR VERGATA”
Personale
Coletta Massimo
Rotilio Giuseppe
Battistoni Andrea
Fiorucci Laura
Marini Stefano
Rossi Luisa
Santucci Roberto
Gambacurta Alessandra
Piro Maria Cristina
Monaco Susanna
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Dottoranda
Dipartimento
Fac. Medicina e Chirurgia
Fac. SS.MM.FF.NN.
Fac. SS.MM.FF.NN.
Fac. Medicina e Chirurgia
Fac. Medicina e Chirurgia
Fac. SS.MM.FF.NN.
Fac. Medicina e Chirurgia
Fac. Medicina e Chirurgia
Fac. Medicina e Chirurgia
Fac. Medicina e Chirurgia
186
Gioia Magda
Di Pierro Donato
Fasciglione Giovanni F.
Ciaccio Chiara
Sinibaldi Federica
Funz. Tecnico
Funz. Tecnico
Assist. Tecnico
Borsista
Borsista
Fac. Medicina e Chirurgia
Fac. Medicina e Chirurgia
Fac. Medicina e Chirurgia
C.I.R.C.M.S.B.
Fac. Medicina e Chirurgia
UNITA’ LOCALE DI SIENA
Personle
Campiani Giuseppe
Nacci Vito
Valensin Gianni
Vomero Salvatore
Zanello Piero
Anzini Maurizio
Cappelli Andrea
Cini Renzo
Cinquantini Arnaldo
Ferrali Marco
Fiorini Isabella
Laschi Franco
Savini Luisa
Butini Stefania
Casolaro Mario
Fabrizi de Biani Fabrizia
Gemma Sandra
Rosani Claudia
Gaggelli Nicola
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatrice
Ricercatore
Borsista
Tecnico
Struttura locale
Dip. Farmaco-Chimico-Tecnologico
Dip. Farmaco-Chimico-Tecnologico
Dip. di Chimica
Dip. Farmaco-Chimico-Tecnologico
Dip. di Chimica
Dip. Farmaco-Chimico-Tecnologico
Dip. Farmaco-Chimico-Tecnologico
Dip. di Scienze e Tecn. Chim. Bios.
Dip. di Chimica
Dip. di Fisiopatologia e Med. Sperim.
Dip. Farmaco-Chimico-Tecnologico
Dip. di Chimica
Dip. Farmaco-Chimico-Tecnologico
Dip. Farmaco-Chimico-Tecnologico
Dip. di Scienze e Tecn.Chim.Bios.
Dip. di Chimica
Dip. Farmaco-Chimico-Tecnologico
C.I.R.C.M.S.B.
Dip. di Chimica
UNITA’ LOCALE DI TORINO
Personale
Aime Silvio
Fubini Bice
Gobetto Roberto
Cravotto Giancarlo
Barge Alessandro
Dastrù Walter
Nervi Carlo
Terreno Enzo
Baroni Simona
Chierotti Michele
Delli Castelli Daniela
Garino Claudio
Reineri Francesca
Belfiore Simona
Carrera Carla
Consol Simona
Esposito Giovanna
Ghiani Simona
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Ricercatore
Post-Doc
Post-Doc
Post-Doc
Post-Doc
Post-Doc
Dottoranda
Dottoranda
Dottoranda
Dottoranda
Dottoranda
Dipartimento
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
187
Lanzardo Stefania
Longo Dario
Stefania Rachele
Geninatti Crich Simonetta
Gianolio Eliana
Viale Alessandra
Dottoranda
Dottorando
Dottoranda
Tecnico Laureato
Tecnico Laureato
Tecnico Laureato
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
Dip. di Chimica IFM
UNITA’ LOCALE DI TRIESTE
Personale
Randaccio Lucio
Alessio Enzo
Dreos Renata
Geremia Silvano
Vlaic Gilberto
Zangrando Ennio
Milani Barbara
Tavagnacco Claudio
Bratsos Jannis
Wuerges Jochen
Casanova Massimo
De Zorzi Rita
Siega Patrizia
De Baseggio Paolo
Qualifica
Prof. Ordinario
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Prof. Associato
Ricercatore
Ricercatore
Assegnista
Assegnista
Dottorando
Dottorando
Borsista
Tecnico
Dipartimento
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
Dip. Scienze Chimiche
188