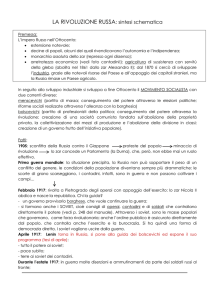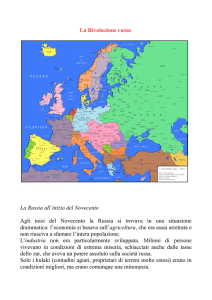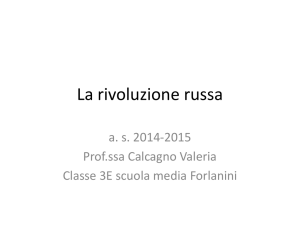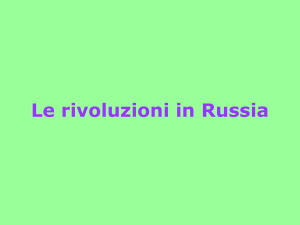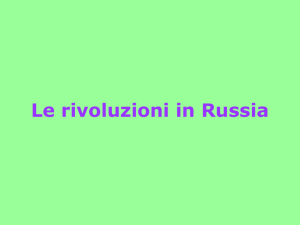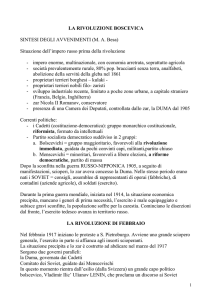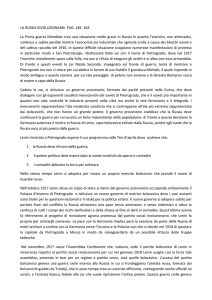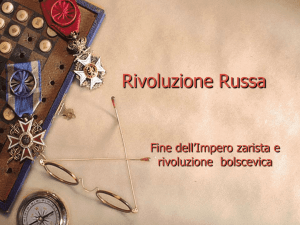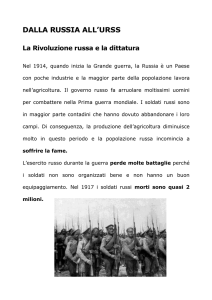LA RIVOLUZIONE RUSSA.
“Era convinzione di Marx chela rivoluzione per il socialismo sarebbe scoppiata nei paesi di ‘capitalismo
progredito’, non in Russia –il paese più arretrato d’Europa dal punto di vista capitalistico-industriale, […] con strutture
economiche e sociali ancora semi-feudali” (Antonio Desideri). Ma non fu così.
LA SOCIETA’ RUSSA E I PARITI POLITICI ALL’ALBA DELLA RIVOLUZIONE
Morto lo zar Alessandro II (il sovrano che aveva abolito la servitù della gleba nel 1861) a seguito di un attentato nel
1881, il regime zarista perseguì per più di 20 anni una politica interna puramente repressiva contro i gruppi dissidenti,
tra i quali spiccavano i NICHILISTI (Cernysevskij e altri: negatori dei valori etici e religiosi della società russa),
sostenitori del terrorismo politico contro il regime ‘feudale’ e assolutista russo. Gli zar si servirono della loro polizia
segreta, la Okrana (o ‘Ochrana’ o ‘Okhrana’) per colpire i dissidenti e spingere la popolazione ad atteggiamenti
antisemiti (numerosi i pogrom). Come già sappiamo, la politica estera zarista subì un duro colpo con la sconfitta del
1904-1905 nella guerra contro i giapponesi per la Manciuria. La crisi militare, la politica interna repressiva, la
debolezza economica della Russia rendevano fragile il potere autocratico della monarchia russa, guidata da Alessandro
III e infine, dal 1894, da Nicola II (l’ultimo degli zar).
La società russa agli inizi del Novecento era ancora una società sostanzialmente agricola e semi-feudale: al
vertice della piramide sociale v’era lo zar, poi la nobiltà latifondista (i boiari) e la chiesa ortodossa (i ‘pope’). La
borghesia delle professioni e industriale era ancora debole. A partire dal 1906/7 il governo zarista guidato dal ministro
Stolypin diede avvio a una serie di riforme per rendere più stabile l'ordine sociale: l'intenzione era quella di facilitare la
distribuzione delle terre appartenenti alle comunità di villaggio (=le obscina ) ai contadini, abolendo il mir (l’assemblea
dei villaggi contadini, che ripartiva in uso le terre, di proprietà collettiva, alle varie famiglie del villaggio). I contadini
già liberati dalla condizione di servi della gleba, ora sarebbero diventati piccoli proprietari terrieri. Ma la riforma
Stolypin non riuscì se non in parte. Si formò un ceto di contadini agiati, i kulaki. Decine di milioni di contadini
continuavano a vivere nella miseria. Erano i mugiki, i contadini poveri, che lavoravano le terre del villaggio o facevano
i braccianti sulle terre dei nobili.
30.000 famiglie di nobili e kulaki controllavano 1/3 del suolo nazionale; gli altri 2/3 erano suddivisi tra 14
milioni di famiglie di piccolissimi proprietari o braccianti.
Lo sviluppo industriale, sostenuto da finanziamenti statali
e capitali stranieri, era avvenuto ‘dall’alto’, ed era estremamente concentrato: 6 aree attorno alle grandi città, isole
industriali in un mare agricolo.
Nel 1905, a seguito della sconfitta militare con il Giappone, la Russia zarista fu teatro di una rivoluzione
con la quale la borghesia voleva creare un regime liberal-costituzionale, limitando i poteri dello zar. La borghesia era
molto debole, e nel 1905 si era organizzata nel partito costituzionale-democratico, (il PARTITO CADETTO). La
sconfitta con il Giappone fece traboccare il vaso: a Pietroburgo nel gennaio 1905 si ebbe la ‘domenica di sangue’: la
guardia imperiale sparò sui manifestanti che chiedevano aumenti salariali e assemblea costituente eletta a suffragio
universale. Vi furono 1000 morti. A Odessa i marinai della corazzata Potemkin si rivoltarono. Lo zar, preoccupato per
l’estendersi dei moti, concesse la costituzione e l’elezione di una DUMA (=parlamento). Ma si trattava di concessioni
estremamente limitate. La Duma era eletta con un sistema che favoriva il peso politico dei nobili.. I poteri della Duma,
poi, finirono per essere puramente consultivi (= la Duma si limitava a offrire consigli allo zar, o a venire consultata
dallo zar, senza poter imporre decisioni vincolanti allo stesso zar). Così la rivoluzione del 1905 terminò in un nulla di
fatto. Nicola II e il ministro Stolypin non riuscirono in ogni caso a eliminare le ragioni del malcontento. I mugiki e gli
operai industriali avevano fame ed erano sottoposti a uno sfruttamento bestiale. Lo scontro definitivo era stato solo
rimandato.
Oltre al partito cadetto, si erano formati (nella clandestinità) altri gruppi politici.
C’era dal 1901 il partito socialista rivoluzionario (gli S.R.), che aveva una forte presa nelle campagne, tra i contadini.
Gli S.R. erano gli eredi della tradizione ottocentesca dei populisti (=i ‘narodniki’, gli ‘amici del popolo’, dal russo
narodna = popolo). Si trattava di un partito non marxista: secondo gli S.R. si doveva e poteva passare direttamente
dalle obscina (le comunità di villaggio con proprietà comune della terra) al socialismo, senza dover attraversare la fase
dello sviluppo del capitalismo in Russia. Come dire che, secondo i socialisti rivoluzionari populisti, si poteva passare
direttamente da una fase ancora agricola e semi-feudale alla fase della società socialista, giusta, ‘umana’. Il soggetto
della rivoluzione era rappresentato –nella loro ottica (affine a quella di Bakunin)- dai contadini.
Nel 1912 il partito socialdemocratico russo ( partito marxista, nato sul finire dell’Ottocento) si era diviso in due:
i bolscevichi (la parte di maggioranza) e i menscevichi (la minoranza). Entrambi i partiti si professavano marxisti e
attribuivano al proletariato industriale il compito di realizzare il socialismo. Ma vi erano profonde divergenze sul modo
di procedere in concreto. I menscevichi, marxisti ortodossi vicini al modo di pensare di Kautsky e guidati da uomini
come Plechanov e Martov, erano convinti della necessità di giungere al comunismo (socialismo) solo in un momento
successivo, dopo che una lunga fase di alleanza tra mondo operaio e forze borghesi avesse consolidato il capitalismo in
Russia. Fedeli allo schema di sviluppo storico elaborato da Marx (secondo il quale è possibile passare al socialismo solo
in Paesi a capitalismo avanzato, dove sia presente un numeroso e organizzato proletariato industriale), i menscevichi
ritenevano che il sistema capitalistico fosse già presente in Russia, ma fosse ancora troppo debole, e non avesse ancora
prodotto una solida classe di proletari. Secondo Martov e compagni, bisognava aspettare. Bisognava prima allearsi al
mondo borghese e collaborare alla costruzione di un regime politico liberale-democratico borghese, per consolidare il
capitalismo e solo poi (in un futuro remoto, lontano) passare al socialismo.
I bolscevichi guidati da Vladimir Ulianovic Lenin, svilupparono un marxismo volontaristico e attivistico che rifiutava
l’idea dell’alleanza con le forze borghesi cadette e propendeva per il passaggio immediato alla rivoluzione socialista.
Per Lenin gli S.R. populisti avevano torto: non era più possibile passare dal sistema delle obscina al socialismo, perché
il capitalismo in Russia c’era già (“Lo sviluppo del capitalismo in Russia”, opera di Lenin, 1899). Avevano torto anche i
menscevichi: non c’era bisogno di aspettare oltre; il proletariato industriale c’era già ed era sufficiente a condurre la
battaglia contro capitalisti, nobili e regime zarista. Lenin non voleva una politica di roforma democratico-liberaleborghese che rinviasse il trapasso al socialismo ad un futuro lontano.
I menscevichi accusarono Lenin di tradire il marxismo, di essere un ‘bonapartista’ (cioè di avere volontà dittatoriali,
come Napoleone III): secondo Martov e i menscevichi, il programma di Lenin avrebbe portato ad una dittatura sul
proletariato, non alla dittatura del proletariato.
LE RIVOLUZIONI DEL 1917
Come già detto, la partecipazione della Russia alla prima guerra mondiale accelerò la crisi del sistema zarista. Le
sconfitte militari, l’insufficienza della produzione agricola, privata del lavoro degli uomini chiamati alle armi, il
conseguente, enorme aumento del costo della vita ( nel 1917, sette volte rispetto al 1914 –dati Carocci) generarono una
situazione sociale esplosiva. In questo clima maturarono le due rivoluzioni del 1917 in Russia.
La prima avvenne in febbraio (corrispondente, nel calendario occidentale gregoriano, a marzo: ricordo che in Russia
era ancora in vigore il vecchio calendario giuliano, che contava uno scarto di 13 giorni in meno rispetto a quello
occidentale), e fu una ‘rivoluzione borghese’. La seconda avvenne nei giorni 24-25 ottobre (corrispondenti al 6-7
novembre), e fu una rivoluzione socialista: con essa il partito bolscevico comunista si impadronì del potere.
La rivoluzione di febbraio avvenne in modo spontaneo, senza essere promossa e guidata dai partiti contrari allo
zarismo. Le proteste e gli scioperi spontanei degli operai di Pietrogrado aumentarono sempre più, sino a dar vita a uno
sciopero generale che spinse il governo zarista a dimettersi. Nel vuoto di potere creatosi sorsero due organismi destinati
nei mesi successivi a diventare antagonisti: il Soviet (consiglio di operai e soldati) di Pietrogrado e il governo
provvisorio. Anche nelle altre grandi città russe si formarono dei soviet. Nei soviet ebbero la maggioranza i socialisti
rivoluzionari (S.R.) e i menscevichi, che chiesero l’elezione a suffragio universale di una assemblea costituente. Ai
soviet, espressione degli operai e dei soldati-contadini, si contrappose il governo provvisorio, espressione della
borghesia e dall’inizio composto nella gran maggioranza da cadetti. Il governo provvisorio indusse lo zar Nicola ad
abdicare. Il governo intendeva proseguire la guerra a fianco delle potenze dell’Intesa, contro i tedeschi. Ma il popolo
non ne voleva più sapere. In estate il governo provvisorio si aprì anche a elementi menscevichi (che, come sappiamo,
predicavano l’alleanza tattica tra operai e borghesia contro le forze ‘feudali’ della Russia) e a membri moderati del
partito S.R. Da luglio il governo provvisorio fu addirittura presieduto da un socialista rivoluzionario, Kerenskij.
La storia della Russia tra le due rivoluzioni del 1917 è la storia del progressivo affermarsi delle tesi di Lenin nelle fila
dei bolscevichi, dei bolscevichi nei maggiori soviet russi e infine dei soviet sul governo provvisorio. Nessun bolscevico
entrò nel governo provvisorio, e dunque il partito di Lenin fu l’unico a non compromettersi con un sistema politico che
voleva continuare la guerra. Ciò giocò indubbiamente a favore dei bolscevichi, che divennero via via più popolari anche
nelle campagne (dove erano fortissimi i socialisti rivoluzionari). I bolscevichi volevano la pace subito, senza condizioni,
con la Germania, e propagandavano tra i soldati il ‘disfattismo nazionale’. Del resto i soldati-contadini non ne potevano
più degli orrori della guerra, e già da alcuni mesi ‘votavano con i tacchi’ (=disertavano) il loro rifiuto della guerra.
Le offensive lanciate dal governo provvisorio in giugno-luglio contro i tedeschi fallirono, ed ebbero come effetto quello
di allontanare sempre più la gran parte del popolo russo dal governo e dai partiti che vi erano rappresentati.
Intanto, già in aprile Lenin era tornato in Russia dalla Svizzera, dove si trovava in esilio. Il viaggio era stato
organizzato dal governo tedesco, nella speranza (come poi accadde) che Lenin spingesse la Russia fuori dalla guerra.
Appena arrivato, Lenin espose le sue famose tesi di aprile. Dalla rivoluzione borghese si doveva passare subito alla
rivoluzione socialista. Le tesi vennero riassunte in una serie di slogan politici: tutto il potere ai soviet; la pace subito;
la terra ai contadini; il controllo della produzione da parte dei soviet.
In luglio alcuni dirigenti bolscevichi furono arrestati, e lo stesso Lenin fu costretto a fuggire in Finlandia. Ma tra
settembre e ottobre i bolscevichi conquistarono la maggioranza nel soviet di Pietrogrado e in quello di Mosca, i più
importanti. Il partito bolscevico cambiò il nome in quello di partito comunista. Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre (6-7
novembre) Trotzki, il fedele braccio destro di Lenin (Lev Trotzki era stato inizialmente menscevico, per poi avvicinarsi
a Lenin), guidò l’insurrezione a Pietrogrado. Fu assalito il Palazzo d’Inverno, sede del governo provvisorio. Con scarso
spargimento di sangue, i bolscevichi conquistarono il potere. Il governo di Kerenskij venne dichiarato decaduto.
LA GUERRA CIVILE E IL ‘COMUNISMO DI GUERRA’. (1918 – 1921)
Si formò un nuovo governo, chiamato Consiglio dei commissari del popolo, guidato da Lenin. Subito furono varati i
famosi decreti di novembre: si stabilì di firmare la pace con la Germania (sappiamo che la pace fu firmata nel marzo
1918 a Brest-Litovsk – vedi appunti su prima g. m.); i latifondi nobiliari vennero confiscati e spartiti tra i contadini,
distribuiti (anche ai kulaki) in godimento d’uso, non in proprietà. Vennero nazionalizzate le banche, ma non le
fabbriche (lasciate sotto il duplice controllo degli operai e dei padroni). Per il momento Lenin non riteneva ancora
opportuno introdurre provvedimenti specificamente comunisti (come l’abolizione della proprietà privata).
Nel contempo, fermenti di libertà civile e culturale trovarono il modo di realizzarsi: le donne ottennero il diritto di
voto; furono legalizzati il divorzio e l’aborto, e fu stabilita l’eguaglianza giuridica tra i figli legittimi e quelli nati da
libere unioni.
Molti scrittori e artisti aderirono con entusiasmo (iniziale) alla rivoluzione, prima di scoprire il volto autoritario che si
nascondeva nel cuore del nuovo regime: è da ricordare Vladimir Majakovskij, il leader del futurismo russo. Altre
importanti personalità furono Blok e Isaac Babel, e poi il grande regista cinematografico Eisenstein.
Tuttavia, dietro questi fermenti di libertà, andava delineandosi una diversa realtà.
Lenin non dubitò mai che per ‘dittatura del proletariato’ dovesse intendersi la dittatura del partito comunista (o
‘bolscevico’), ricorda G. Carocci. Per Lenin il partito doveva essere una organizzazione di ‘rivoluzionari di
professione’, capace di guidare il proletariato e di spronarlo all’azione anche contro la sua volontà (secondo Lenin, il
mondo operaio aveva una naturale tendenza a limitarsi a chiedere riforme salariali, e doveva essere costantemente
stimolato dal partito); il partito doveva essere una struttura rigidamente gerarchica e disciplinatissima, e pronta a
intervenire con estrema durezza per realizzare l’obiettivo finale: una società comunista basata sulla giustizia sociale e
l’abolizione dello sfruttamento. Ma –come ha affermato Gaetano Salvemini, riferendosi alle dittature nate in nome
della Volontà Generale e per realizzare il bene del popolo- “chi è convinto di possedere il segreto infallibile per rendere
felici gli uomini, è sempre pronto ad ammazzarli” (Salvemini, già membro del P.S.I, uscito dal partito nel 1911,
democratico e meridionalista, antigiolittiano e antifascista, ma anche estremamente duro nei confronti dell’esperienza
sovietica). Oggi come allora, ancora si discute sull’ipotesi se gli orrori prodotti dal totalitarismo stalinista (milioni di
vittime ammazzate in nome del comunismo) siano o non siano una conseguenza inevitabile della logica estremista
implicita nel pensiero e nell’azione dello stesso Lenin.
Secondo alcuni, Stalin e lo stalinismo sarebbero solo una aberrante e patologica deviazione da un tronco di sani ideali
politici, quelli del marxismo-leninismo. E l’azione e il pensiero di Lenin non dovrebbero mai essere confusi con quelli
di uno psicopatico sanguinario e rozzo come Stalin. Sono di questo parere tutti quelli che ancora oggi si dichiarano
comunisti (Bertinotti compreso), e in generale gli studiosi trotzkisti.
Secondo altri, e non solo i liberal-democratici, come è ovvio pensare, ma anche quei socialisti (i socialisti moderati o
‘socialdemocratici’) eredi della tradizione di pensiero che si richiama a Bernstein, Turati, Kautsky, l’orrore del
totalitarismo sovietico è già tutto implicito nell’utopismo estremistico di Lenin. Insomma, la ‘mela’ sarebbe stata marcia
già nel suo ‘seme’, per capirci. E Lenin, come dicevano i menscevichi, realizzò non la dittatura del proletariato, ma la
‘dittatura sul proletariato’, quello stesso che intendeva liberare dall’oppressione.
Se stiamo ai fatti, è certo che sotto la guida di Lenin c’era almeno , all’interno dei vertici del partito comunista, la
possibilità di discutere e contestare e criticare; tutto questo spirito di discussione sarebbe sparito con Stalin. E questo è
indiscutibile: Stalin fece ‘epurare’, liquidare migliaia e migliaia di membri dello stesso partito comunista sovietico. Ma
i detrattori del leninismo sottolineano che
1) già nel dicembre 1917, quindi sotto il controllo di Lenin, fu istituita la Ceka (la polizia politica segreta, il cui
compito fu quello di reprimere la dissidenza politica. Ricordo che la Ceka assunse nel tempo altri e forse più noti
nomi: G.P.U, N.K.V.D., K.G.B.). Lo stato dei soviet, anziché ‘estinguersi’ –come aveva teorizzato Leninsembrava sul punto di rafforzarsi sempre più.
2) L’assemblea costituente voluta da tutti i gruppi politici si riunì nel gennaio del 1918, ma poiché era composta in
maggioranza da S.R. e menscevichi, Lenin non esitò a sopprimerla con la forza!
3) Nel 1921 i marinai e gli operai rivoluzionari della base navale di Kronstadt, molti dei quali aderivano a dottrine
anarchiche, diedero vita a una rivolta contro il governo comunista, accusato di essere autoritario e repressivo. In
quella occasione, alcune migliaia di ‘figli del popolo’ vennero uccisi dalle forze bolsceviche.
La discussione è comunque ancora aperta.
Intanto, vari generali erano rimasti fedeli allo zar, e organizzarono le loro truppe (le armate bianche), aiutate e
finanziate anche dalle potenze dell’Intesa (francesi, inglesi, americani), interessate a bloccare l’espansione del
bolscevismo. Scoppiò la GUERRA CIVILE: le armate bianche contro l’armata rossa, organizzata da Trotzki. La
guerra civile insanguinò il paese dal 1918 al 1921. Alla fine i bolscevichi riuscirono ad affermarsi, ma la prova fu
terribile. Ricordo che in questo clima si colloca il massacro della famiglia dello zar, nel 1918, perpetrato per eliminare il
simbolo della controrivoluzione bianca. L’armata rossa combatté non solo i bianchi, ma anche gruppi di menscevichi e
S.R. La guerra civile riportò la Russia a condizioni di vita medievali. Essa provocò circa 9 milioni di morti (molti per
carestia ed epidemie). Per vincere, i bolscevichi (i comunisti) dovettero instaurare il cosiddetto comunismo di guerra,
cioè una politica economica basata sull’intervento autoritario dello Stato dei soviet nel campo della produzione agricola
e industriale. Si instaurò una sorta di dirigismo economico integrale: il Consiglio dei commissari decretò la requisizione
forzata di vettovaglie per sostenere l’armata rossa (i contadini spesso si rivoltarono), impose calmieri sul prezzo del
pane, fissò i salari e gestì direttamente le industrie. In questa circostanza i comunisti attuarono misure radicali: la
nazionalizzazione delle terre (legge agraria del 1918) e delle fabbriche: decretarono, cioè, la fine delle proprietà privata
dei mezzi di produzione. Tutto questo era reso necessario dalla guerra civile in corso, ma rispondeva anche alla
ideologia politica di Lenin. Si andava nel frattempo consolidando una nuova burocrazia statale che rischiava di
riprodurre quelle differenze sociali per combattere le quali era sorto il bolscevismo.
La NEP. (1921 – 1928)
La guerra mondiale, la rivoluzione e la successiva guerra civile avevano avuto effetti catastrofici sull’economia russa.
Gli indici di produzione erano crollati: fra il 1914 e il 1921 la produzione industriale era diminuita di ¾, quella
cerealicola della metà. (dati Carocci). L’80% dei quadri dirigenti del paese (imprenditori, professionisti, professori etc.)
e la quasi totalità dei nobili erano fuggiti all’estero.
Per rimediare a questo quadro catastrofico e placare il malcontento popolare di cui la rivolta di Kronstadt era stata
sintomo eloquente, Lenin decise nel 1921 di abolire il comunismo di guerra e di introdurre una Nuova Politica
Economica (N.E.P.). La NEP diminuì gli interventi diretti dello Stato sulla società e rimise in vigore alcuni aspetti del
capitalismo. Si ricostituì la piccola proprietà privata. Si invitarono i kulaki ad arricchirsi, purché garantissero l’aumento
della produzione. I contadini poterono vendere liberamente i loro prodotti. Fu autorizzata l’attività di piccole industrie
private con meno di venti dipendenti (ma lo Stato manteneva nelle sue mani la grande industria e il commercio
all’ingrosso e con l’estero). In questo modo, lentamente, l’economia russa trovò nuovo ossigeno e si rimise in moto.
Nel 1922 la Russia assunse il nome di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (U.R.S.S.). Già dal 1918 la
capitale era stata spostata da Pietrogrado a Mosca. Nel 1924 fu introdotta una costituzione. La costituzione dell’Urss
affermava formalmente che la fonte del potere era costituita dai soviet, riuniti nel Congresso dei Soviet dell’Unione (il
parlamento federale), ma di fatto la vera fonte del potere era il partito comunista (l’unico partito), o meglio il Politburò,
l’ufficio politico (il direttivo) del partito comunista e il suo segretario.
Nel 1923 Lenin si ammalò gravemente e all’inizio del 1924 morì. Subito si scatenò la lotta per il potere tra i suoi excollaboratori. Segretario del PCUS (partito comunista dell’unione sovietica) era dal 1922 Iosif Dzugasvili STALIN
(=acciaio), un astuto, brutale e intollerante georgiano. Un anno prima di morire, Lenin aveva messo in guardia i suoi
compagni per i modi brutali di Stalin (ma è anche vero che Stalin divenne segretario del partito quando ancora Lenin
dominava!). La lotta per la successione coinvolse Stalin e Trotzki (la personalità più autorevole tra i vecchi compagni di
Lenin). Il dissenso più grave tra i due riguardava la politica estera dell’Urss. Per capire quello che successe è necessario
fare un passo indietro ed esaminare brevemente i rapporti tra l’Urss e gli altri paesi d’Europa.
LA TERZA INTERNAZIONALE.
Lenin riteneva che per assicurare il socialismo in Russia, questo dovesse affermarsi anche in Europa. “Lenin
ripose tutte le sue speranze nel successo della rivoluzione in Europa” (Carocci). Solo se si fosse diffusa anche nei
paesi più avanzati d’Europa, la rivoluzione avrebbe acquistato in modo compiuto i suoi caratteri socialisti. Ma, come
vedremo, in Europa la rivoluzione socialista fallì. La borghesia rimase ovunque al potere e in Russia, con Stalin, la
rivoluzione assunse un carattere dittatoriale e totalitario.
Per Lenin la rivoluzione dei soviet era solo la fase iniziale della imminente rivoluzione mondiale. Egli riteneva che nel
giro di una decina d’anni il socialismo marxista avrebbe trionfato ovunque. Non visse abbastanza per veder
completamente fallite le sue speranze. Comunque, al fine di creare un nuovo organismo che riaffermasse, sulle ceneri
della II Internazionale dissoltasi nel 1914, l’unione dei proletari di tutto il mondo, nel 1919 fu convocata a Mosca la
TERZA INTERNAZIONALE, il cui compito era di organizzare la lotta dei proletari a livello mondiale. La Terza
Internazionale (la KOMINTERN = Internazionale comunista) fu un organismo fortemente accentrato: tutti i partiti
aderenti, provenienti dai più diversi Paesi, erano tenuti ad eseguire le decisioni del suo direttivo (di fatto monopolizzato
da uomini del PCUS). La Terza Int si caratterizzava per il rifiuto del metodo gradualistico, riformista e moderato e
democratico-parlamentare dei ‘falsi socialisti’, disposti a patteggiare con il nemico borghese. Nella sua celebrazione del
metodo rivoluzionario, Lenin accusava Bernstein (il padre del revisionismo marxista, membro dell’S.P.D tedesco) di
essere un ‘volgare liberale’, e attaccava Kautsky (teorico del marxismo ortodosso dell’S.P.D., sostenitore di un
massimalismo puramente verbale e in realtà incline al metodo riformistico-parlamentare) accusandolo di essere un
‘rinnegato’. La condizione necessaria per essere ammessi nella Komintern era quella di allontanare tutti i riformisti dai
partiti, tutti i bernsteiniani, i lassalliani, i turatiani etc.
Si giunse così alla tragica frattura tra le forze della sinistra (i socialisti comunisti rivoluzionari contrapposti ai
socialisti riformisti, i cosiddetti ‘socialdemocratici’) proprio nel momento in cui le forze della destra radicale
stavano tentando di dare la scalata al potere (i fascisti e poi i nazisti). La prospettiva di Lenin e poi di Stalin si
basava su un gravissimo errore di giudizio che favorì oggettivamente il formarsi delle dittature di destra.
Nacquero allora (primi anni venti) i partiti comunisti (in Francia, in Italia etc.), che si ispiravano anche nel nome al
modello sovietico-boscevico. E questi partiti furono ferocemente ostili ai partiti socialdemocratici: le forze della sinistra
litigavano tra di loro anziché far fronte unito contro la marea montante delle nuove destre radicali! Addirittura, nel
1929, Stalin finì per equiparare socialdemocrazia e fascismo lanciando la parola d’ordine del socialfascismo:
socialismo moderato e fascismo erano “due facce di un medesimo strumento della dittatura capitalistica”! Follia! Solo
dopo l’ascesa al potere di Hitler (1933), la Komintern cambiò strategia politica, vedendo nel nazi-fascismo il principale
nemico da combattere e lanciando la politica dei fronti popolari nel 1935: tutte le forze anti-fasciste, comunisti,
socialdemocratici, liberal-democratici borghesi dovevano collaborare e lottare assieme contro il nemico comune. Ma era
ormai troppo tardi. Troppo tardi per fermare Hitler e Mussolini, e per impedire la seconda guerra mondiale. Ricordo,
per finire, che la Komintern fu sciolta nel 1943, nel pieno della seconda g. m., per non irritare gli alleati occidentali
(Usa e Inghilterra) che sostenevano l’Urss nella lotta contro le potenze nazi-fasciste.
LA MANCATA RIVOLUZIONE IN EUROPA.
Finita la Grande Guerra, tutti i popoli europei attraversarono un periodo di grande agitazione (1919-1920), e in alcuni
paesi (in Germania e in Italia) si formò il movimento dei consigli che, ispirandosi ai soviet russi, intendevano ‘fare
come in Russia’. Molti borghesi temevano la possibilità della rivoluzione comunista, alimentata da povertà e inflazione.
In generale, nei paesi usciti vittoriosi dalla guerra il fermento rivoluzionario fu meno intenso e venne tenuto sotto
controllo dalle istituzioni liberal-democratiche tradizionali, grazie anche a una saggia politica di aumenti salariali e
riduzione delle ore di lavoro (ridotte a 8 al giorno).
Fece eccezione l’Italia –come vedremo meglio più avanti- nella quale le spinte rivoluzionarie furono molto forti ma
fallirono e si conclusero con la vittoria del fascismo. In Italia il periodo 1919-1920 , il biennio rosso, fu caratterizzato
da ondate di scioperi, occupazione di terre e di fabbriche (soprattutto a Torino nel settembre 1920). Ma la rivoluzione
non venne, anche per le indecisioni del Psi e del sindacato operaio. Il gruppo di giovani intellettuali rivoluzionari
(Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti e altri) che a Torino aveva fondato il periodico L’ORDINE NUOVO ed esaltava il
marxismo volontaristico di Lenin, aveva altresì dato vita al movimento dei consigli di fabbrica: consigli di operai che
dovevano dirigere la produzione e prendere il potere, come in Russia. Nel 1920, come già detto, il movimento fallì.
Dopo il 1920 la spinta rivoluzionaria declinò, ma Gramsci e i suoi uscirono dal Psi, disgustati, e fondarono nel 1921 il
partito comunista italiano, a Livorno.
In Ungheria, il tentativo del comunista Bela Kun fallì, schiacciato da una violenta controrivoluzione (v. appunti I g.
m.).
In Germania, paese sconfitto ed economicamente afflitto da una gravissima crisi, la rivoluzione sembrò poter riuscire.
Nel novembre 1918, cacciato il Kaiser, era sorta una repubblica in cui gran peso avevano i consigli degli operai, che
controllavano le fabbriche. Ma nello stesso novembre, i padroni stipularono con i sindacati degli accordi (le 8 ore di
lavoro e aumenti salariali, come in altri paesi occidentali): in questo modo la gran parte dei leader operai e sindacali
rinunciava alla rivoluzione e accettava la prospettiva socialista riformista. Intanto le forze di estrema destra si
organizzarono in corpi paramilitari (i corpi franchi) con la protezione del governo, guidato dal socialdemocratico
Ebert.
I comunisti tedeschi (una minoranza) che si chiamavano spartachisti e che erano guidati da Rosa Rosa Luxemburg e
Karl Liebknecht, tentarono di sollevare la popolazione nel gennaio 1919. Ma i corpi franchi intervennero, e
l’insurrezione si spense nel sangue. Rosa Luxemburg e Liebknecht furono assassinati. La rivoluzione socialista tedesca
era fallita. Sulle sue rovine nacque un regime borghese democratico assai fragile e minacciato da continui tentativi di
colpi di Stato da destra e da sinistra: la Repubblica di Weimar. Ma la speranza della rivoluzione era sostanzialmente
fallita. E nel 1933 salì al potere il nazismo di Adolf Hitler.
LO SCONTRO TRA STALIN E TROTZKI E L’AFFERMAZIONE DELLO STALINISMO.
E finalmente torniamo alle questioni politiche interne alla Russia del dopo-Lenin. Nonostante la delusione per la
mancata rivoluzione in Europa, Trotzki continuava a pensare che il compito dei comunisti russi fosse quello di
continuare a sostenere e diffondere ed espandere la rivoluzione in Europa e nel mondo. Era, quella di Trotzki, la tesi
della rivoluzione permanente. Stalin, invece, più realisticamente, pensava che la Russia fosse ancora troppo debole per
tentare pericolose avventure militari all’estero e/o fomentare tentativi rivoluzionari: le grandi potenze occidentali
capitalistiche si sarebbero unite in una crociata anticomunista e avrebbero distrutto la Russia sovietica. Stalin dunque
affermò che per il momento bisognava limitarsi a consolidare il socialismo in Russia. Era, questa, la tesi del socialismo
in un solo paese.
Stalin riuscì ad avere il sopravvento e a controllare il partito e lo Stato. Nel 1929 Trotzki fu espulso dal paese e andò in
esilio. Nel 1940 i sicari di Stalin lo rintracciarono a Città del Messico e lo ammazzarono. Stalin aveva trionfato:
controllava il partito e il paese, e attraverso la Komintern, controllava anche i partiti comunisti d’Europa. La Russia era
ormai alla vigilia dello stalinismo, il potere personale, terroristico e totalitario di Stalin.
LO STALINISMO.
1) Industrializzazione e collettivizzazione delle campagne. La fine della NEP. (1929 – 1937)
Fra il 1928 e il 1929 Stalin, ormai padrone della situazione, decise di abbandonare la NEP, di abolire ogni residuo di
proprietà privata e tutti quegli aspetti capitalistici presenti nella NEP. Nel contempo, egli puntò sulla modernizzazione e
sulla industrializzazione forzata del paese, anche per metterlo in grado di resistere a eventuali ‘aggressioni
capitalistiche’. L’economia della nazione fu nuovamente sottoposta a un rigidissimo controllo statale. Una
commissione, il GOSPLAN, aveva il compito di preparare i piani quinquennali per lo sviluppo economico industriale
e agricolo del paese. Si passò dunque dalla NEP alla politica della pianificazione economica. Un primo piano
quinquennale venne realizzato nel 1929-1932.
La collettivizzazione delle campagne (e dunque l’abolizione della proprietà privata delle terre) costò milioni di morti.
Fu -come ha sostenuto Alan Bullock in HITLER E STALIN (1991)- “la più grande guerra contro i contadini che uno
Stato abbia mai effettuato”. I kulaki (i contadini agiati) ma anche moltissimi contadini che avevano solo quantità di terra
appena sufficienti per vivere, furono sterminati fisicamente (si calcola che circa 3 milioni di kulaki furono liquidati). E
spesso con modi barbari, meno ‘scientifici’ di quelli nazisti. Spesso venivano costretti ad inoltrarsi in piena steppa e lì
abbandonati a morire; altre volte li si caricava su barconi che poi venivano fatti affondare. Né si deve dimenticare la
Grande Carestia indotta dal governo sovietico in Ucraina (6 milioni di morti tra il 1931 e il 1933) per spezzare la
volontà autonomistica di quel popolo: in questo caso il governo chiese quote sempre più alte del raccolto ucraino, fino a
privare i contadini delle sementi necessarie per coltivare la terra. Mentre i bambini morivano di fame (ci sono
descrizioni terrificanti), il governo sovietico vendeva le eccedenze di grano all’estero, per ottenere i capitali necessari a
procedere sulla strada dell’industrializzazione.
La terra fu nazionalizzata e distribuita ai contadini riuniti in cooperative (kolchoz). Vennero anche istituite aziende
agricole direttamente gestite da funzionari statali (i sovchoz). Nel 1934, ormai quasi tutta la terra russa era stata
colettivizzata, nonostante le tante rivolte contadine (non solo in Ucraina).
La pianificazione permise inoltre un formidabile sviluppo industriale in tempi brevissimi. Il governo puntò sullo
sviluppo dell’industria pesante (produttrice di beni strumentali: trattori, trebbiatrici, cannoni, macchine utensili varie,
non di beni di consumo= industria leggera). Nel 1941, l’Urss era diventata il 2° produttore mondiale di petrolio, il 3° di
acciaio. Già dal 1932 la disoccupazione era scomparsa, proprio quando l’Occidente era colpito –come vedremo dalla
gravissima crisi economica iniziata nel 1929. Il relativo isolamento dell’Urss le impedì di venir colpita dalla crisi
suddetta, e ciò parve dimostrare a molti intellettuali filosovietici la superiorità del sistema sovietico su quello
capitalistico occidentale.
Numerosi furono poi i successi realizzati in campo medico e in quello dell’istruzione. Nel 1939, tutti i cittadini
sovietici sotto i 50 anni erano alfabetizzati.
Ma questi successi non devono far dimenticare i tanti orrori del regime stalinista. Il tenore di vita della popolazione
era bassissimo. Nel 1940, il 25% degli abitanti di Mosca viveva in dormitori. Delle condizioni bestiali dei contadini si è
già detto.
Il regime totalitario di Stalin cantava le lodi del grande popolo russo e offriva premi per i lavoratori più produttivi.
Molti, bisogna anche dire, credevano davvero di lottare per creare una società migliore, e si sacrificavano sul lavoro:
come il mitico compagno Stakanov, capace di lavorare senza soste per ore e ore (da lui il termine stakanovismo per
indicare la dedizione assoluta al proprio lavoro). Ma il regime stalinista non era certo una società socialista nel senso
che Marx ed Engels avevano dato a tale termine: la liberazione dell’uomo dallo sfruttamento, la giustizia sociale erano
solo parole vuote. Piuttosto, dice Carocci, si trattava di “un regime modernizzatore autoritario e burocratico”, o forse si
dovrebbe dire: si trattava di un regime totalitario, proprio nel senso in cui la parola è usata dalla Arendt.
2) IL TERRORE STALINISTA.
Dopo il 1928 Stalin impose alla Russia una dittatura spietata, basata sul regime a partito unico, sul controllo dei mezzi
di comunicazione e sul terrore. L’arresto e l’invio arbitrario (e spesso senza processo) nei campi di lavoro di milioni di
persone erano diventati la norma. Si costituì un enorme universo concentrazionario, fatto di centinaia e centinaia di
campi di concentramento sparsi per tutta la Siberia e le repubbliche più orientali: il GULAG. Tra i campi più terribili
ricordo quello di Kolyma (in prossimità di un fiume del nord-est della Siberia), in cui si lavorava in condizioni
disumane all’estrazione dell’oro; e poi le isole Soloveckie (nel mar Bianco), dove uomini ridotti alla condizione di veri
e propri schiavi del regime lavoravano al taglio del legname. Il Gulag era diventato un enorme serbatoio di forza lavoro
schiavile. E nel Gulag si poteva finire per un nonnulla. Pochissimi sapevano davvero cosa succedesse nel Gulag, ma
tutti sapevano che la gente spariva d’un tratto, senza un perché. Molti erano oppositori politici, ma molti di più erano
persone che magari avevano falciato un po’ d’erba per nutrire la mucca. L’orrore del Gulag fu rivelato in Occidente
dall’ex prigioniero A. Solzenicyn con i suoi libri, in particolare ARCIPELAGO GULAG (1973), ma molti intellettuali
comunisti in Occidente accusarono l’autore di essere un ‘servo del capitalismo’. Oggi, finita la guerra fredda e crollata
l’Urss, sappiamo che quello che Solzenicyn ha scritto è vero. Il regime stalinista elaborò il concetto mostruoso di
‘nemico oggettivo’: una persona, figlio di un borghese, di un kulako o di un menscevico etc., può essere arrestato e
liquidato. E non per qualche colpa personale (può essere del tutto innocente!) ma perché egli è oggettivamente un
pericolo sociale, un ‘nemico oggettivo’. Come se attraverso il sangue venisse veicolato qualche virus sociale che rende
potenzialmente nemico e dunque sospetto l’individuo in questione!
Per capire cosa fosse il terrore stalinista, voglio ricordare un episodio raccontato da Solzenicyn in ARCIPELAGO
GULAG.
“Ecco una scenetta di quegli anni. Si sta svolgendo (nella regione di Mosca) una conferenza regionale di partito … alla
fine della conferenza viene approvato un messaggio di fedeltà a Stalin. Naturalmente tutti si alzano in piedi … gli
applausi diventano ovazione. Tre minuti, quattro minuti, cinque minuti … già gli anziani hanno l’affanno… ma chi
oserà smettere per primo?… Infatti vi sono in sala quelli dell’NKVD, in piedi ad applaudire, e osservano chi smetterà
per primo. E gli applausi … continuano. Sei, sette, otto minuti! … Non possono più fermarsi fino a quando non saranno
caduti colti da infarto … Follia! Follia collettiva! … All’undicesimo minuto il direttore della cartiera assume un’aria
indaffarata e si siede… La notte stessa il direttore della cartiera è arrestato.” ( Mondadori, 1974, pp. 84-85)
Nel 1929-1933 i metodi terroristici furono impiegati contro i contadini, kulaki e no; negli anni successivi il terrore fu
impiegato indiscriminatamente contro tutti, e anche per eliminare gli altri dirigenti di rilievo del partito e i loro seguaci,
dopo aversi torturati perché ‘confessassero’ crimini inesistenti. Il culmine di queste pratiche fu raggiunto nel periodo
1937-1938, all’epoca delle cosiddette grandi purghe (più o meno nella stessa epoca in cui i nazisti iniziavano a dar
sfogo alla loro bestiale rabbia antisemita in Germania). Nel 1938 il grande leader comunista Bucharin venne accusato
di ‘deviazionismo di destra’ (cioè di voler reintrodurre la NEP) e di trotzkismo, e condannato a morte. La stessa accusa
era spesso mossa a tutti coloro di cui Stalin intendeva sbarazzarsi. I sospetti paranoici e criminali di Stalin costarono la
vita, nel periodo delle grandi purghe, a circa 600.000-700.000 membri dello stesso partito comunista sovietico.
La Lubianka, la prigione politica nei cui sotterranei a Mosca trovarono la morte migliaia di oppositori, divenne il
simbolo feroce del totalitarismo stalinista. Solo nel 1956, al XX congresso del PCUS il nuovo segretario Kruscev
avrebbe dato inizio alla destalinizzazione (Stalin era morto nel 1953) riconoscendo pubblicamente i crimini compiuti
dal dittatore sovietico (anche se solo quelli contro i membri di partito).
Scomparso ogni residuo di democrazia, la persona di Stalin fu fatta oggetto di culto quasi religioso. La libera
creatività degli artisti fu soffocata e sostituita da una nuova ‘arte’: quella del realismo socialista, falsa e asservita al
regime. Nel 1936 fu vietato l’aborto e severamente limitato il divorzio.
Intanto, mentre all’interno stava sviluppandosi sempre di più una nuova casta sociale privilegiata, quella della
burocrazia di Stato (la ‘nomenklatura’), Stalin lanciava attraverso la Komintern la politica estera del fronte popolare:
ormai anche il dittatore si rendeva contro che il mondo stava pian piano scivolando verso una nuova guerra, e che la
aggressività nazi-fascista avrebbe ben presto dato fuoco alle polveri.