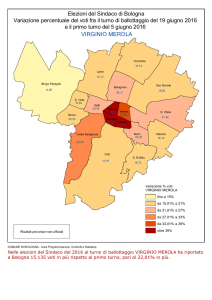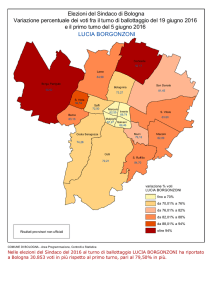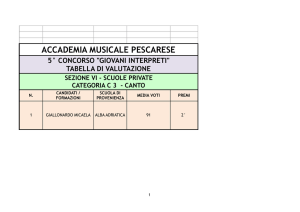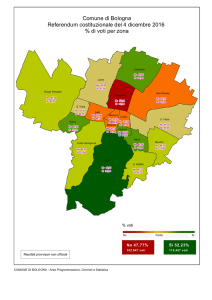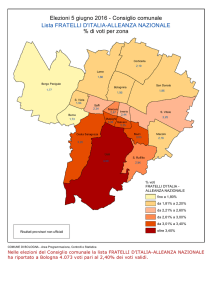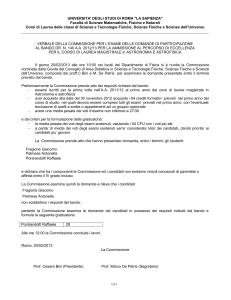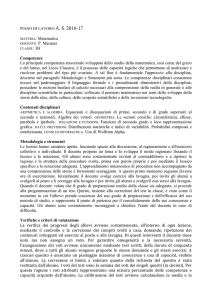Luca Tentoni
Le elezioni comunali del 2016
nei capoluoghi di regione
Nota introduttiva
Questo e-book raccoglie alcuni testi che Mentepolitica
ha pubblicato sulle elezioni comunali del 2016, con
qualche “divagazione” sul referendum abrogativo di
aprile e quello, prossimo, di ottobre sulla riforma
costituzionale. Sono preceduti da un testo che chiudeva
il precedente Quaderno, in modo da formare un
raccordo col volume già pubblicato. Qui si ripercorre la
campagna elettorale puntando però più sull’analisi dei
dati e del contesto sociale, politico e istituzionale che
sulla dialettica corrente. La seconda parte del volume
analizza invece i risultati del primo e del secondo turno
delle elezioni comunali del 5-19 giugno. Come per i due
precedenti quaderni di Mentepolitica, riproponiamo i
testi con un leggero editing. In attesa del referendum
costituzionale, il cui esito a nostro avviso influenzerà
comunque il futuro del sistema politico italiano,
proponiamo ai lettori questa raccolta, con lo scopo, più
volte ribadito su Mentepolitica, di rendere il dibattito
sociale, politico e culturale sempre più ampio e ricco.
1
Indice
Parte Prima
-
Le elezioni comunali e il “voto degli esclusi” (19 marzo
2016) – pagina 3
Partiti “del leader” ed elezioni locali (2 aprile 2016) –
pagina 10
L'Italia dei "sette campanili" (9 aprile 2016) – pagina 19
Referendum, note a margine (23 aprile 2016) – pagina 25
Referendum costituzionale, la partita è aperta (30 aprile
2016) – pagina 33
La battaglia di Roma (7 maggio 2016) – pagina 40
Il "bipolarismo comunale"(14 maggio 2016) – pagina 49
Le comunali "arcobaleno" (21 maggio 2016) – pagina 59
Comunali, l'importanza dei candidati sindaci (28 maggio
2016) – pagina 65
Parte Seconda
-
Il voto nelle “sette capitali”: un primo bilancio (11 giugno
2016) – pagina 73
Comunali: il rendimento dei candidati sindaci (15 giugno
2016) – pagina 82
-
Bilancio dei ballottaggi (25 giugno 2016) – pagina 89
-
Comunali, i voti ai partiti nei sette capoluoghi (tabella) –
pagina 99
2
Parte Prima
Le elezioni comunali e il “voto degli esclusi”
19.3.2016
Mentre i partiti definiscono, fra mille difficoltà, le
candidature alle elezioni comunali, c'è già chi si
prepara a dare al voto nei grandi centri urbani un
valore politico nazionale. Si tratta di comparazioni
da effettuare con cautela, trattandosi di
consultazioni di diverso genere. In primo luogo,
l'affluenza alle comunali è solitamente più bassa di
circa il 15-20% rispetto a quella delle politiche. Se
ci riferiamo ai soli dati aggregati relativi alle sette
maggiori città dove si voterà fra un paio di mesi
(Torino, Milano, Bologna, Trieste, Roma, Napoli,
Cagliari) abbiamo un'affluenza oscillante fra il
54,1% delle europee e il 62% delle regionali (59,6%
comunali) che sale però al 74,6% alle politiche (il
periodo considerato va dal 2011 al 2015). La
"platea" di riferimento, insomma, sarà stavolta
meno ampia che nel 2013. Inoltre, ci sono
3
appuntamenti nei quali i partiti e le coalizioni
ottengono rendimenti diversi: più il voto è politico,
ad esempio, più il M5S ha possibilità di conseguire
una percentuale elevata. Non si spiegherebbe
diversamente il 24,3% avuto alle politiche 2013 dai
Cinquestelle contro il 21,7% delle europee e il
16,4% delle regionali 2013-2015. Senza contare,
inoltre, che a Roma a poca distanza di tempo, nel
2013, per comunali, regionali e politiche, con questi
risultati: M5S 12,8% comunali, 27,3% politiche,
16,8% regionali. In quella occasione il centrodestra
ottenne invece il 31,7% per il Campidoglio, il 28,3%
per la Regione ma solo il 23,7% per la Camera.
Anche il centrosinistra ebbe un maggior risultato
alle comunali romane rispetto alle politiche e alle
regionali. Inoltre, bisogna considerare che alle
amministrative una percentuale media di voti
variabile fra il 7,3% e il 7,7% degli aventi diritto è
costituita da schede dove il votante non ha optato
per un partito ma ha scelto solo il candidato
sindaco o "governatore". Quindi, i raffronti
andranno fatti con molto giudizio. Ad ogni buon
conto, però, queste comunali possono dirci molto
4
più di quanto crediamo: basta cercare altrove i
segnali più significativi. Per ottenere qualche
indicazione potremmo prendere in considerazione
due fattori: la "filosofia di fondo" del sistema di
voto e il comportamento degli elettori. Per quanto
riguarda il primo, è ben noto che fra il meccanismo
per l'elezione dei sindaci e l'Italicum per la Camera
esistono alcune affinità: il doppio turno se nessuno
supera una certa percentuale (il 50% nei comuni, il
40% per Montecitorio) e il ballottaggio "chiuso" (a
due). Restano, ovviamente, molte differenze, fra le
quali la possibilità di apparentamenti fra il primo e
il secondo turno (possibili nei comuni ma non - o
non ancora - per l'Italicum) e il premio di
maggioranza che in un caso è riservato alla
persona (comunali: contano i voti dei candidati
sindaci, non quelli delle liste) e nell'altro al partito
(Camera dei deputati). Questo "patrimonio
comune" ai due sistemi (il premio e il ballottaggio
chiuso) ci permette di fare un passo ulteriore:
cercare di comprendere come si comportano gli
elettori dei partiti e dei candidati esclusi dal
ballottaggio. Si tratta, com'è evidente, di dati che
5
anche in tal caso vanno presi con molta cautela,
perchè
conta
parecchio
la
personalità
dell’aspirante sindaco “bocciato” al primo turno.
Quello più vicino ideologicamente - in teoria - ad
uno dei promossi al ballottaggio potrebbe – per
esempio - essere un suo acerrimo avversario
politico, quindi non necessariamente gli elettori
rimasti "orfani" sarebbero disposti a tornare alle
urne per sostenere il candidato "meno distante"
(alcuni, piuttosto, potrebbero preferirgli lo
sfidante). Fatte perciò le dovute distinzioni, resta
però l'interesse che il comportamento di voto degli
esclusi riveste in funzione di una possibile futura
scelta analoga che potrebbe presentarsi loro in
occasione del ballottaggio con l'Italicum. Poichè,
secondo tutte le rilevazioni e i sondaggi, nella
battaglia per la conquista del premio di
maggioranza alla Camera i competitori in lizza
sarebbero il Pd e il M5S, resta da vedere come si
comporterebbe l'elettorato di centrodestra (sia nel
caso che l’area di Berlusconi e Salvini tornasse
unita e competitiva con gli altri due soggetti
politici, sia nell’ipotesi di “corsa separata”). Sarà
6
dunque importante confrontare i dati delle ultime
elezioni politiche, europee e regionali con quelli
delle comunali per capire se il centrodestra ottiene
più voti andando diviso o unito e se - arrivato
eventualmente al ballottaggio - è in grado di
attrarre voti e da quale direzione. A Bologna sarà
interessante assistere alla lotta fra M5S e Lega.
Altrove, invece (per esempio in qualche città non
capoluogo di regione) potrebbero trovarsi a lottare
per il secondo posto i Cinquestelle e il
centrodestra: chi avrebbe la meglio (con nuovi o
confermati rapporti di forza)? In situazioni del
genere, come si comporterebbe l'elettorato escluso?
I votanti di centrodestra appoggerebbero il M5S, si
asterrebbero o darebbero un (poco probabile)
sostegno al candidato di centrosinistra? Inoltre: in
realtà come Torino, invece, la sinistra radicale
accorrerebbe in massa per sostenere Fassino (nello
specifico, ma si potrebbe fare anche il caso di
Giachetti a Roma) in un possibile secondo turno?
A Milano e Trieste, dove i favoriti appaiono i
candidati di centrosinistra e centrodestra, a chi
finirebbero i voti “grillini”? E nella Capitale, con la
7
Raggi (M5S) favorita, come si comporterebbero gli
elettori di un centrodestra che potremmo
eufemisticamente definire "plurale"? C'è poi il caso
di Napoli, dove ogni combinazione è possibile e
dove i concorrenti competitivi sono almeno
quattro (quindi due o più verranno "eliminati" al
primo turno, lasciando elettorati più o meno
cospicui a fare da arbitri). Insomma, mentre i
ballottaggi con l'Italicum che i sondaggi presentati
da Mentana il lunedì al Tgla7 sono "esercitazioni",
nelle città italiane potrebbero andare in scena
davvero tutte le combinazioni possibili: Pd contro
M5S; Pd contro centrodestra; centrodestra contro
M5S. Senza contare gli outsider e De Magistris a
Napoli. Si tratta, nelle città come a livello
nazionale, di sfide fra partiti o “cartelli elettorali”
che possono portare al ballottaggio soggetti politici
con un consenso complessivo (come sembra
verosimile) di circa il 50-60% dei votanti del primo
turno. La questione del “voto degli esclusi”,
dunque, diventa cruciale. Inoltre, sarà importante
leggere con attenzione i dati delle elezioni nei
capoluoghi di regione tenendo presente che in
8
questa classe di comuni (in particolare, nelle sette
città
al
voto)
la
Lega
è
fortemente
sottorappresentata (abbassando così il dato
complessivo del centrodestra) mentre il Pd è
sovrarappresentato. Andranno infine valutati i
rapporti di forza fra Pd e sinistra radicale (di solito,
Democratici e altri di area hanno fra il 70 e l'85%
dei voti dell'intero centrosinistra allargato) e quelli
fra Forza Italia e Lega (nei sette comuni considerati
il Carroccio ha ottenuto, nel periodo 2011-2015, fra
il 2 e il 4% dei voti mentre gli azzurri hanno
oscillato fra il 14 e il 21%). Una volta depurati i dati
dalle tendenze locali e isolati i casi più significativi,
anche questo turno amministrativo potrà insomma
darci qualche indicazione tendenziale. Il che, lo
ripetiamo, non sarà un pronostico sulle "politiche"
ma aiuterà partiti e analisti ad orientarsi circa
l'andamento
dell'offerta
elettorale
e
del
comportamento dei (pochi, si suppone) votanti.
9
Partiti "del leader" ed elezioni locali
2.4.2016
In un'epoca nella quale i partiti tendono a perdere
spazio e consenso mentre i leader divengono non
solo centrali ma trainanti e decisivi per il risultato
elettorale e per la stessa esistenza di molti soggetti
politici, il voto per il rinnovo dei consigli comunali
previsto per la fine della primavera rappresenta un
banco di prova fondamentale. Poichè la politica è
sempre più un fatto mediatico e personalizzato, i
partiti e i movimenti hanno la necessità di agire su
due fronti: da un lato, quello nazionale, dove la
comunicazione non può che passare attraverso
internet ma anche per i mezzi di comunicazione
"tradizionali" (giornali, televisione); dall'altro, c'è la
dimensione locale del rapporto "porta a porta" con
gli elettori e con le loro esigenze quotidiane,
variabili a seconda del tipo di comune e del
contesto sociale ed economico. Nei soggetti politici
di un tempo il livello nazionale e quello locale non
erano poi così disgiunti, anche se potevano
apparire distanti: l'organizzazione capillare
10
tradizionale (la sezione aperta e funzionante anche
nei comuni più piccoli) e alcuni fattori unificanti
(l'ideologia, la prevalenza della classe dirigente sul
leader, il peso nazionale dei notabili locali)
facevano sentire la "presenza" del Partito anche in
ambiti territoriali minori. La "spettacolarizzazione
della leadership", com'è stata definita, comporta
che i soggetti politici affidino le loro fortune ad
una personalità di spicco, la quale non può che
perseguire politiche nazionali e avere un'agenda
più orientata sui grandi temi di facile presa
sull'opinione pubblica che su argomenti di
interesse locale. A livello periferico, tuttavia, la
situazione va gestita in modo diverso: se il
franchising del leader nazionale e il brand del
partito possono essere utilizzati, è però vero che da
soli non bastano per conquistare consensi e
arrivare ad amministrare realtà peculiari. Serve
una classe dirigente che sia direttamente in
contatto con i cittadini: una sorta di "secondo
canale" rispetto alla comunicazione e al "formato"
del partito del leader. Come dimostra la storia
della Seconda Repubblica, la competizione locale è
11
sempre stata più favorevole ai partiti radicati sul
territorio, laddove quella di livello nazionale ha
avvantaggiato i soggetti politici più abili a
dominare il panorama mediatico globale. Il
centrosinistra e la Lega hanno saputo affermarsi a
livello comunale, provinciale e regionale mentre
Forza Italia ha sempre avuto i suoi migliori
risultati alle elezioni parlamentari nazionali ed
europee. Il centrodestra è riuscito ad aggiudicarsi
importanti amministrazioni del Nord grazie (in
realtà come il Veneto si potrebbe dire soprattutto)
al radicamento del Carroccio. Il partito di
Berlusconi e quello che oggi è di Salvini (ma per
lungo tempo è stato di Bossi) rappresentano gli
opposti modelli organizzativi: "leggero" quello del
Cavaliere, "pesante" e capillare quello del "senatùr"
e del suo successore. Il rendimento elettorale
spiega molto, se si confrontano i consensi delle
politiche con quelli delle amministrative, ma se ci
si limita ad osservare il voto per classi di comuni
alle elezioni parlamentari si falsa la prospettiva,
perchè non si coglie la differenza che c'è fra Forza
Italia e la Lega: entrambe, infatti, ottengono
12
percentuali più alte nei comuni più piccoli, mentre
nelle grandi città non catturano o catturano meno
un voto che è sfaccettato e - per certi versi - "di
opinione". Il "partito del leader" berlusconiano è
stato in grado, nei momenti migliori, di trainare il
centrodestra e di portarlo quasi sempre a ridosso
del 50% dei voti nazionali, alle elezioni per Camera
e Senato (la defezione della Lega nel 1996 e
l’esclusione dell'Udc nel 2008 hanno ovviamente
ricondotto il risultato del centrodestra più vicino al
45%): la Cdl ha complessivamente ottenuto il
52,1% nel 1996 (centrodestra 42%; Lega 10,1%), il
49,6% nel 2001, il 49,2% nel 2006, il 52% (46,3%
centrodestra, 5,7% Udc) nel 2008. Tuttavia, quella
Forza Italia che alle politiche e alle europee era uno
schiacciasassi (tale da comprimere l'espansione
leghista,
ad
esempio
nell'elezione
"europarlamentare" del 1994, a vantaggio del
partito "azzurro"), alle elezioni locali era invece,
soprattutto al Nord e al Centro (dove però il
centrodestra è strutturalmente più debole del
centrosinistra, in particolare nelle "zone rosse")
notevolmente svantaggiata. In alcune aree del Sud,
13
però, si poteva osservare un buon rendimento del
centrodestra alle amministrative, dovuto a
dinamiche di carattere locale e alla presenza di un
personale politico (in gran parte proveniente
dall'esperienza della Prima Repubblica) molto
radicato sul territorio. Riportando il discorso su un
livello più generale, è importante fissare un
concetto: i partiti "del leader" sono fatti per
affrontare competizioni a carattere nazionale.
Vincono a livello locale se hanno una storia
"ideologicamente favorevole" (cioè una tendenza
costante a un voto orientato verso quella famiglia
politica) o se reclutano personale politico che ha un
contatto col territorio. Diversamente, i partiti
"tradizionali" hanno una forte base di
simpatizzanti e una rete orientata all'ascolto dei
territori ma non sempre hanno avuto leader capaci
di catturare consensi supplementari a livello
nazionale. Nella transizione che stiamo vivendo,
tuttavia, non esistono più partiti di questo genere.
La Lega, per esempio, aveva un leader forte (Bossi)
ma che non riusciva ad ottenere consensi oltre i
confini territoriali d'insediamento naturale, mentre
14
oggi Salvini sembra in grado - con un approccio
comunicativo molto orientato all'uso dei mezzi di
comunicazione di massa: televisione, internet - di
raggiungere un pubblico più vasto, sia per
numerosità sia per collocazione geografica. Il Pd
ha compiuto un percorso diverso: aveva leadership
meno durature e "incontestate" della Lega, mentre
ora ha Renzi che è una sorta di "dominus" del
partito; l'articolazione locale si è andata
indebolendo (anche parecchio, in alcune realtà)
pur se - sul piano dei risultati elettorali - è riuscita
fin qui a mantenere il governo della grande
maggioranza delle amministrazioni regionali e
comunali; oggi il partito è più forte sul piano
mediatico ma più "leggero", o, meglio, gli ambiti
nazionale e locale appaiono più scollegati e
lontani. In quanto al M5S, sebbene le prime
affermazioni siano arrivate in “periferia” (le
comunali a Parma, le regionali del 2010 in EmiliaRomagna), il movimento non ha roccaforti, ma un
livello di consenso molto omogeneo che sembra
non essere sostanzialmente intaccato in modo
incisivo dalla presenza, in alcune regioni, di "poli
15
dominanti" (la zona rossa, il lombardo-veneto
leghista). La comunicazione del M5S si è basata
inizialmente su un leader nazionale (Grillo) e sulla
"Rete" (internet, i social network): a livello di
risultati, il riscontro maggiore si è avuto in ambito
nazionale (dove i Cinquestelle hanno assunto
posizioni radicali sull'euro, ad esempio) mentre sul
piano locale il Movimento non è mai riuscito a
conquistare una regione o (finora, almeno) il posto
di sindaco in una città capoluogo di regione. I tre
maggiori soggetti politici del Paese (più Forza
Italia, che molti danno per quarta classificata) sono
ormai "partiti del leader", anche se nel M5S si
assiste ad una tendenza opposta a quella degli altri
soggetti politici, con la scelta di un progressivo
passaggio di testimone da Grillo ad una dirigenza
nazionale "plurale". Tutti usano forme di
comunicazione moderna (solo Forza Italia non ha
una presenza su internet e sui social network
paragonabile a quella della concorrenza) ma
ognuno ha articolazioni locali di diverso tipo e diciamo così - "intensità". La Lega è di gran lunga
la più radicata, seguita da Pd, M5S e, buona
16
ultima, Forza Italia. In occasione di queste elezioni
comunali, però, figurano pochi candidati sindaci
leghisti nelle città capoluogo di regione (il che,
tuttavia, non esclude affatto che il partito di Salvini
possa ottenere un buon risultato elettorale) mentre
quelli
"azzurri" sono generalmente
poco
"supportati" (tranne il caso di Milano, che tuttavia
ci sembra molto peculiare) dal consenso degli altri
gruppi di centrodestra. Le difficoltà del "partito
leggero" berlusconiano, perciò, potrebbero essere
accentuate da questa situazione, soprattutto in
realtà come quella romana, dove il candidato di
Berlusconi dovrà vedersela con Giorgia Meloni,
leader di un partito - FdI - molto radicato nella
Capitale.
L'incognita
di
questo
turno
amministrativo è dunque rappresentata, nelle
grandi città, da Pd e M5S e dalla loro capacità (non
potendo contare su "traini nazionali" poco efficaci
in elezioni locali) di "sintonizzarsi" con un tipo di
competizione che richiede un grande radicamento
territoriale. Senza Renzi, Salvini, Grillo e
Berlusconi, i candidati dovranno vedersela con i
cittadini e con esigenze diverse da quelle che sono
17
oggetto di dibattito sui grandi mezzi di
comunicazione di massa. In fondo, è un po' una
sorta di nemesi: ora che i partiti debbono la
propria fortuna ai leader e alla capacità di
personalizzare e nazionalizzare il confronto
politico, sono costretti a misurarsi anche con una
dimensione lontanissima e periferica. Ecco perchè
ogni esito delle “comunali” appare oggi possibile.
18
L'Italia dei "sette campanili"
9.4.2016
Fra due mesi, quando saranno aperte le urne delle
elezioni comunali, i partiti non potranno fare a
meno di dare ai responsi delle "amministrative" un
valore politico. O, meglio, lo faranno soprattutto i
vincitori. In ogni caso, se ci sarà un dibattito sui
risvolti del voto sul quadro politico nazionale si
terrà conto non delle centinaia di comuni che pure
rappresentano una parte non trascurabile
dell'elettorato, ma dei sette capoluoghi di regione
dove avranno luogo le sfide principali,
probabilmente le più incerte e appassionanti.
Come nella storica trasmissione radiofonica "Tutto
il calcio minuto per minuto", insomma, saranno le
notizie provenienti dai "campi principali" ad
occupare in modo pressochè totalizzante
l'attenzione degli appassionati. Eppure quelle sette
città, come del resto i ventuno capoluoghi di
regione italiani (per il Trentino-Alto Adige si
considerano Trento e Bolzano) hanno un
comportamento elettorale molto diverso rispetto al
19
resto del Paese. Per accorgersene, basta elaborare i
dati relativi alle consultazioni dal 2006 in poi. In
tutte le occasioni il centrosinistra avrebbe vinto le
elezioni: non solo come Unione nel 2006 (51,9%
contro il 41,6% nazionale) ma anche come "piccolo
centrosinistra" nel 2008 (politiche: Pd e Idv
avrebbero portato Veltroni a Palazzo Chigi col
43,6% dei voti contro il 37,6% nazionale; il
centrodestra si sarebbe fermato al 41,7%, contro il
46,8% nazionale) e nel 2009 (europee). Alle
politiche 2013 la coalizione di Bersani ha ottenuto
nei comuni capoluogo di regione il 33,7% contro il
29,6% nazionale e il rispettivo 24,4%/29,2% del
centrodestra). Alle europee 2014, inoltre, il solo Pd
ha avuto il 43,5% a fronte del 40,8% nazionale,
mentre il centrodestra si è fermato al 21,2% (molto
al di sotto del 26,7% ottenuto in tutta Italia) e il
M5S al 22,1% (meglio del 21,2% nazionale). I
capoluoghi di regione pesano molto sul piano
politico, ma non troppo su quello numerico: i loro
elettori, infatti, sono poco meno di otto milioni,
circa un sesto del corpo elettorale italiano. I sette
capoluoghi dove si andrà alle urne il 5 giugno
20
hanno però, da soli, circa il 70% degli aventi diritto
al voto di questa categoria di comuni, contro il 30%
(circa 2,4 milioni di italiani) degli altri 14 centri.
Roma, Napoli, Milano, Torino, Bologna, Cagliari e
Trieste, insomma, pesano parecchio sul complesso
dei capoluoghi regionali e, politicamente, contano
ancora di più. Sul piano del rendimento dei
principali partiti c'è poca differenza fra il dato
delle sette città al voto rispetto a quello delle altre
quattordici. La caratteristica dei capoluoghi di
regione in generale e, in particolare, di quelli dove
si eleggeranno i sindaci nel prossimo giugno, è la
minore affluenza alle urne rispetto al dato
nazionale (-0,8% alle politiche 2008, -3,5% alle
europee 2009, -0,6% alle politiche 2013, -4,6% alle
europee 2014). In compenso, il dato delle schede
bianche e nulle è più basso che altrove. Quella
nelle sette città, insomma, sarà una competizione
che è già strutturalmente diversa per i rapporti di
forza più sbilanciati verso il centrosinistra e a
sfavore del centrodestra rispetto al quadro
nazionale, ma sarà ancora più complessa perchè la
moltiplicazione delle candidature e le diverse
21
combinazioni e alleanze nelle città renderanno
difficile tracciare una sintesi che non risenta troppo
dell'eterogeneità di domanda e offerta politica. Di
sicuro il dato del M5S sarà omogeneo, perchè i
Cinquestelle si presentano senza liste civiche e
alleanze: i loro punti di partenza sono - nelle sette
città capoluogo di regione - il 24,3% delle politiche
2013, il 21,7% delle europee 2014, il 16,4% delle
regionali 2013-2015, il 7,4% delle scorse comunali
(quasi tutte risalenti al 2011, quando il Movimento
di Grillo era agli albori). Oscillante fra il 6 e il 9%,
invece, è l'area della "sinistra radicale", mentre la
"destra radicale" e la Lega hanno ottenuto, nel
periodo 2011-2015, fra il 7 e il 10% dei voti (solo il
5% alle politiche, però). Molto variabili, inoltre,
sono i dati riguardanti Pd e Forza Italia, che hanno
oscillato parecchio negli ultimi anni, anche
tenendo conto delle liste "di area" che si sono
presentate alle regionali e alle comunali per
sostenere i candidati sindaci o governatori. Va
però tenuto conto, per un'indicazione di massima,
che le liste di Forza Italia-Pdl hanno
rispettivamente ottenuto il 21,7% alle comunali
22
2011 (liste di area: 7%), il 19,4% alle politiche, il
14,4% alle europee, il 15,8% alle regionali (liste del
governatore: 3,3%) mentre quelle del Pd sono
passate dal 27,2% delle comunali (liste del sindaco
o "di area": 4,8%) al 28,9% delle politiche, al 44,1%
delle europee e al 30,5% delle regionali (liste "del
presidente": 7,1%). Questi dati - e la configurazione
dell'elettorato delle sette città capoluogo - spiegano
il successo del centrosinistra e della sinistra alle
scorse “amministrative” (in sei comuni col Pd, in
uno - Napoli - senza). In una "roccaforte rossa"
come Bologna, ad esempio, la sola lista del Pd non
ha mai ottenuto meno del 38-40% dei voti, mentre
la seconda classificata non è mai arrivata al 20%
(16,6% Pdl alle comunali 2011; 19,1% M5S alle
politiche 2013, 15,3% M5S alle europee 2014; 14,5%
Lega alle regionali 2014). In altre parole, in realtà
del genere molto dipende dal rendimento dei
Democratici, mentre in città come Roma e Napoli
le distanze fra i possibili "poli" (e fra i candidati in
lizza) sono meno nette, almeno stando ai
precedenti più prossimi. In questa "Italia
metropolitana" dei sette capoluoghi, insomma, che
23
è un po' più astensionista e un po' più di
centrosinistra rispetto al resto del Paese si gioca
una partita che non è affatto scontata e che
probabilmente sarà decisa, fra due mesi (al
ballottaggio quasi ovunque, si suppone) dalla
capacità o meno delle "famiglie politiche" di restare
coese. Questo è però il vero vulnus delle elezioni
2016: in molte realtà nei poli si giocano partite
"tutti contro tutti", quindi i risultati complessivi
delle liste di un'area potrebbero risultare in linea
con i precedenti, ma l'esito della competizione
potrebbe invece riservare più di qualche sorpresa.
24
Referendum, note a margine
23.4.2016
Il referendum del 17 aprile è giunto a 42 anni di
distanza da quello sul divorzio (12-13 maggio
1974) e a 21 anni dall'ultima consultazione che
superò comodamente il quorum (quella dell'11
giugno 1995). In questa storia in due atti
dell'istituto referendario ci sono altrettante
eccezioni che confermano la regola: il mancato
quorum del 1990, il quorum scattato nel 2011. Per
il resto, fra i primi e i secondi 21 anni di
referendum c'è un abisso. Il primo è stato il
periodo della battaglia sul merito e nelle urne; il
secondo, quello dell'astensionismo di supporto al
"no". Che la tendenza ad abrogare le leggi fosse
ormai diffusa era già chiaro alla fine degli anni
Ottanta. Nelle consultazioni del 1974 (divorzio),
1978 (finanziamento partiti, legge Reale), 1981
(aborto - 2 quesiti - abolizione dell'ergastolo,
ordine pubblico, porto d'armi), 1985 (scala mobile)
il "no" vinceva sempre e comunque, anche con
scarti minimi come nell'ultimo referendum della
25
serie, caratterizzato da una contrapposizione fra
Craxi e Pci-Cgil che chiuse forse definitivamente le
porte ad una possibile futura "alternativa di
sinistra". Nel primo quarto di storia referendaria,
dunque, prevalsero l'alta affluenza (sempre minore
rispetto alle politiche, però) e la tendenza
dell'elettorato a confermare le leggi dello Stato,
anche le più sgradite (quella sul finanziamento
ebbe il 43,6% di sì: un campanello d'allarme per la
Prima Repubblica; del resto, in quel drammatico
1978 l'elettorato italiano non era ancora pronto,
come sarebbe stato nel 1991-'93, per dare una
"spallata" al sistema). Dal 1987 in poi, tuttavia, i
"sì" partono quasi sempre in vantaggio: su 58
quesiti, in 51 casi (con quorum o meno) hanno
prevalso i favorevoli all'abrogazione contro i 7 nei
quali (tutti nel 1995: altra eccezione che conferma
la regola) ha vinto il "no". Da quasi trenta anni a
questa parte, insomma, i difensori di una legge
hanno sempre meno speranze che il popolo voti
per confermarla. Da un lato perchè i comitati per il
sì sono più agguerriti e mobilitati (trattandosi,
peraltro, per la maggior parte, di questioni in
26
genere meno note al grande pubblico ma capaci di
sollecitare
la
partecipazione
dei
settori
dell'elettorato più sensibili a determinati temi) e da
un altro lato perché il “fronte del no” comprende,
fra il 1987 e il 1995, che le partite "a viso aperto"
stanno premiando gli sfidanti e decide dunque
(grazie all'"azzardo astensionista" tentato con
successo, nel '90, dai partiti desiderosi di non
inimicarsi i cacciatori, contrari ai quesiti
ambientalisti) di dar vita al "secondo tempo" della
storia referendaria: quello del "non voto". Dal 1997
in poi, infatti (tranne l'eccezione del 2011) si
dispiega la seconda parte della storia referendaria,
caratterizzata dall'alleanza fra un astensionismo
strutturale di solito più forte di quello fatto
registrare per tutti i tipi di elezioni (europee,
politiche, regionali ed amministrative) e i partiti
schierati per il "no". La percentuale media dei
votanti ai referendum, che negli anni '70 era stata
dell'84,4% e nel decennio successivo era scesa ad
un pur sempre ragguardevole 74,1%, era
sicuramente destinata ad erodersi, ma non a
crollare. Seguendo il declino della partecipazione
27
elettorale per altri tipi di consultazione, si sarebbe
potuto scendere verso una quota intorno al 50%,
ma sarebbe rimasto possibile mantenere in primo
piano la battaglia fra il sì e il no, lasciando sullo
sfondo quella sul quorum. Invece l'idea del “fronte
del no” di disertare le urne ha fatto precipitare
l'affluenza media: 53,2% negli anni '90 (durante i
quali il periodo 1991-'95 è stato ancora all'insegna
della mobilitazione, soprattutto in chiave
antisistema, mentre nel '97-'99 si è affermato il
partito "del no astensionista") fino al 32,1% fatto
registrare nel periodo dal 2000 ad oggi. Per
curiosità va rilevato che quel 32,1% corrisponde
quasi perfettamente all'affluenza del primo
appuntamento della serie (21 maggio 2000, 32,2%)
ed è molto vicino al 31,2% di domenica 17 aprile
2016. Nel frattempo, abbiamo avuto tre
consultazioni con un'affluenza fra il 23 e il 26%
(2003, 2005, 2009) e una col quorum raggiunto
(2011, 12-13 giugno, anche in questo caso in un
periodo di fermenti sociali e politici, quasi come
venti anni prima). Non è difficile ipotizzare che,
senza la mobilitazione delle ultime settimane sul
28
quesito relativo alla trivellazione in mare, anche il
referendum del 2016 avrebbe fatto registrare una
partecipazione al voto inferiore al 25%. Da un lato,
insomma, abbiamo avuto stavolta un probabile
surplus di affluenza dovuto all'aumentare della
tensione politica intorno alla consultazione, ma come al solito - abbiamo avuto almeno un 15-20%
di elettori che avrebbero potuto optare per il no ma
sono stati orientati verso l'astensione. Ad oggi non
è dato sapere se, in presenza di uno scheramento
di tutti i partiti per il sì o per il no (ma comunque
per il voto) si sarebbe raggiunto il quorum (data
l'affluenza di regionali ed europee recenti,
solitamente più alta che nei referendum, il dubbio
è legittimo). In qualche modo, sembra esserci quasi
un'eterogenesi dei fini: la mancanza del quorum a
fronte dell'impegno di tutti i partiti per il voto
sarebbe stato un atto di sfiducia e rifiuto dell'intero
sistema politico. La scelta di taluni soggetti
(diversi, in questi ultimi 16 anni) di defilarsi per
rivendicare la "vittoria anti abrogazionista"
utilizzando i "non voti" del "partito dell'astensione"
ha dato forza a chi ha usato questo espediente, ma
29
in realtà ha ottenuto probabilmente l'involontario
risultato di riuscire a mascherare una più generale
debolezza e perdita di credibilità dell'intera classe
dirigente politica. In altre occasioni, infatti, nelle
quali l'astensionismo non poteva essere utilizzato
(alle elezioni amministrative in particolare) si è
assistito a consultazioni con un'affluenza vicina se
non inferiore al 50% (regionali 2015: 53,9%;
regionali Emilia-Romagna 2014: 37,7%; regionali
Calabria 2014: 43,8%; comunali Roma 2013: 52,8%).
Al di là, dunque, delle polemiche politiche che
hanno accompagnato le scelte di schieramento
("nel voto" o "fuori dalle urne") dei diversi partiti e
leader, resta il problema della partecipazione
popolare. Lo scarso interesse per un quesito può
avere un peso, ma limitato a pochi punti
percentuali. Lo dimostra il fatto che molti cittadini
- in numero sempre maggiore - non si mobilitano
per esercitare il loro diritto di voto neanche per
scegliere da chi far governare il proprio comune, la
propria regione, il Paese. È opportuno tenere conto
di questo fattore, non solo per le imminenti
comunali del 5-19 giugno ma soprattutto per il
30
referendum costituzionale di ottobre. È bene
ricordare, infatti, che se l’ampia riforma voluta dal
centrodestra nel 2005 e sottoposta al voto del 2006
è stata bloccata col "no" popolare in una
consultazione nel corso della quale ha votato il
52% degli aventi diritto, nel 2001 la più circoscritta
riforma del Titolo V della Costituzione è stata
approvata dall'elettorato, ma con un'affluenza
molto modesta (il 34,1%). Com'è noto, il
referendum costituzionale non ha quorum, ma fin
qui è stato utilizzato per sottoporre al giudizio
popolare progetti vasti e di elevata eterogeneità e
complessità, non per singoli articoli o istituti. Nei
referendum del 2001 e del 2006, come in quello di
fine 2016, si è sempre deciso su importanti
variazioni
della
Carta
Repubblicana.
Verosimilmente, a ottobre tutti i partiti
cercheranno di mobilitare l'elettorato per ottenere
una partecipazione alta, perciò - su un banco di
prova importante come la modifica della Seconda
Parte della Costituzione - si capirà se le forze
politiche saranno in grado di coinvolgere la
maggioranza assoluta degli italiani a pronunciarsi
31
per il “sì” o per il “no”. Se neppure in un clima che
si presuppone di scontro e di alta tensione politica,
con un cambio istituzionale in gioco, il "quorum
morale" del 50% più uno sarà raggiunto, la Terza
Repubblica nascerà (con o senza la riforma) sotto il
peggiore degli auspici.
32
Referendum costituzionale, la partita è aperta
30.4.2016
Ogni
sondaggio
relativo
al
referendum
costituzionale di ottobre è attualmente poco più
d'un embrionale tentativo di "saggiare il terreno".
Abbiamo ancora quasi sei mesi di campagna
elettorale (compresa quella per le comunali, che si
concluderà col voto del 5 e 19 giugno) quindi non
stupisce che - su cento intervistati da Euromedia
Research per “Ballarò” del 19 aprile scorso - ben 46
(il 45,9%, per l'esattezza) non sappiano se
andranno a votare o, per ora, non siano
intenzionati a farlo. Lo stesso risultato del
sondaggio, relativamente alla preferenza di chi
invece andrebbe ai seggi, è poco significativo: il
26% degli interpellati approverebbe la riforma,
mentre il 28,1% la respingerebbe. Non è solo un
dato rientrante nel margine d'errore statistico, ma è
anche suscettibile di variazione nel corso dei mesi.
Detto questo, però, il sondaggio della Ghisleri non
è affatto inutile, perchè delinea alcune tendenze
già molto chiare. Secondo la rilevazione, la
33
consultazione sulla riforma costituzionale sembra
già una sorta di referendum pro o contro Renzi:
voterebbe “sì” il 69% degli elettori centristi di
governo (Ncd-Udc) e il 65,2% di quelli del Pd (il
“no” si fermerebbe rispettivamente al 6 e al 5%,
con un tasso di indecisi o non votanti fra il 25 e il
30%). Solo gli elettori di Sel avrebbero una
marginale propensione al "sì" maggiore rispetto a
quella di altri partiti d'opposizione: 26,6% contro
l'11% di FI e Lega, il 7% di FdI e l'8,5% del M5S.
Tuttavia, anche in Sel il “no” arriverebbe oltre il
40% (42,2%) in linea col 42,9% di FI, il 46% della
Lega, il 46,5% di FdI e il 51,4% del M5S. Tutto
scontato, dunque? Alcuni indicatori ci dicono che
non è così. Certo, l'elettorato di centristi, Pd e Sel
sembra già schierato (solo il 25-31% è indeciso o
non voterebbe: una quota fisiologica). Oscilla fra il
40 e il 46,5%, invece, il tasso di indecisione
nell'opposizione di centrodestra e nel M5S. Quel
28,1% di "no" alla revisione costituzionale, inoltre,
somiglia molto al 27,4% (sul totale degli aventi
diritto al voto nel territorio nazionale) dei “sì” al
referendum sulla trivellazione in mare. In altre
34
parole, non è difficile credere che le posizioni degli
elettori sul “sì” al referendum del 17 aprile e sul
“no” a quello del prossimo ottobre siano in gran
parte sovrapponibili. Anche aggiungendo a questi
dati quelli di un sondaggio Ixè per “Agorà” del 22
aprile, secondo i quali i “sì” prevarrebbero con
circa il 53% dei voti contro il 47% dei “no”, le cose
non cambierebbero molto (pur se Ixè prevede
un’affluenza referendaria del 69% che ad oggi
sembra spropositata e che in parte contrasta col
60% di votanti alle politiche stimato dallo stesso
istituto). In termini di rapporto fra espressioni di
voto nel sondaggio Euromedia la differenza (che
abbiamo ricavato noi) fra “sì” (48,1%) e “no”
(51,9%) rientrerebbe ugualmente nel margine
d’errore statistico intorno al valore del 50%.
Avremmo – comparando “Euromedia” e “Ixè” una “forchetta” del 48-53% per il “sì” e del 47-52%
per il “no”, dunque un esito del tutto incerto. Se
queste sono le posizioni di partenza, con un 28%
già mobilitato per il “no” e un 26% mobilitabile per
il “sì”, o viceversa (ci permettiamo di prendere
come punto di partenza l’affluenza del 54%
35
prevista da Euromedia anziché il meno probabile
69% di Ixè) si possono già trarre alcune
conclusioni. La prima è che per vincere la
consultazione di ottobre Renzi avrà bisogno di
disporre di tutte le forze del suo partito e degli
alleati centristi, se gli italiani al voto saranno 26-27
milioni. La seconda è che buona parte della
competizione si gioca sul grosso di quegli elettori
che oggi – se si votasse per le politiche - non
sceglierebbero alcun partito e che non sanno se e
come si esprimerebbero in occasione della
consultazione di ottobre. Fra costoro, solo 15,5 su
cento direbbero “sì” alla riforma, contro il 12,1%
che voterebbe “no”. La mobilitazione dei due
fronti potrebbe verosimilmente portare l’affluenza
sopra il 50% degli aventi diritto, nonostante il fatto
che per il referendum costituzionale non ci sia
bisogno di un quorum minimo di validità. Questo
sondaggio, dunque, non ci permette di prevedere
un vincitore, ma ci indica tre possibili direttrici
della campagna elettorale referendaria autunnale.
La prima, interna alla maggioranza di governo,
sarà la massima mobilitazione possibile dei votanti
36
di Pd e centristi (ampiamente minoritari rispetto al
complesso del sostegno che i sondaggi accordano
ai partiti di opposizione). Quel 30% circa di
simpatizzanti del partito di Renzi che non sa se e
come votare è probabilmente composto da elettori
che non condividono appieno la posizione del
premier e che forse si ritrovano di più in quella
della minoranza del Pd. Si tratta di una massa di
voti che potrebbe – se spinta verso il sì o il no spostare l'ago della bilancia in maniera sensibile. In
altre parole, Renzi non solo deve portare alle urne
il grosso del suo partito che è già favorevole alla
riforma, ma deve conquistare almeno la "non
belligeranza" dei suoi oppositori interni (anche per
questo sta cercando di "arruolarne" alcuni nei
comitati per il “sì”). La seconda direttrice lungo la
quale si snoderà la campagna elettorale riguarderà
invece i partiti di opposizione. Quel 27-28% di
elettorato che si è già manifestato (con i “sì” antitrivellazione) al referendum di aprile sembra
intenzionato a tornare alle urne, anche perchè
l'appuntamento di ottobre è molto più importante.
Ma c'è quel 45,7% di elettorato indeciso di Forza
37
Italia che potrebbe andare ovunque, anche verso il
fronte del sì. La (per ora improbabile)
ricomposizione del centrodestra può influenzare
l'esito del referendum costituzionale, accelerando
processi di riaggregazione o di dispersione
dell'elettorato "moderato". L'area a destra del Ncd,
infatti, rappresenta pur sempre, in tutti i sondaggi,
poco meno di un terzo dei potenziali votanti.
Quindi, le dinamiche di leadership, programmi,
posizionamenti di questa area molto eterogenea
sono suscettibili di produrre effetti molto marcati
non solo sull'esito della consultazione ma anche
sulla futura struttura del (per ora scontato)
ballottaggio (con l'Italicum) per la conquista del
premio di maggioranza alla Camera dei deputati
nel 2017 o 2018. Infine, la terza direttrice riguarda
il "voto di chi non vota". La prova generale per
comprendere se la quota elevata di elettori che
oggi non andrebbe alle urne per il referendum
costituzionale è un blocco granitico o se può invece
essere scalfito da "stimoli politici" è costituita dalle
prossime elezioni amministrative. Se l'affluenza
resterà al massimo sul 55-60%, probabilmente il
38
"partito astensionista" non si “scongelerà” neppure
per il referendum. Un conto infatti è scegliere da
chi far governare la propria città (un tema molto
concreto e percepito come vicino dai cittadini), un
altro conto è esprimersi su una vasta e complessa
modifica della Costituzione (per di più, in pieno
autunno). Mobilitare i propri elettori, sperare nelle
incertezze nel fronte avverso, cercare di catturare
un po' di "astensionisti cronici": questo è il filo
conduttore di una battaglia appena iniziata e il cui
esito è completamente imprevedibile e aperto.
39
La battaglia di Roma
7.5.2016
La decisione di Berlusconi di sostenere, alle
comunali romane, il candidato centrista Alfio
Marchini anzichè la candidata di FdI e Lega
Giorgia Meloni, è la prova che nel centrodestra è in
corso una resa dei conti. Si tratta di un
appuntamento rinviato troppo a lungo e ormai
necessario, perchè nulla esclude con certezza che si
possa tornare ad elezioni politiche (anticipate) già
nella primavera del 2017. Col vecchio "Porcellum"
(il sistema elettorale utilizzato per eleggere i
parlamentari nel 2006, 2008 e 2013) bisognava
formare una coalizione per sperare di aggiudicarsi
il premio di maggioranza alla Camera. Tre anni fa
l'alleanza fra Pdl, Lega e destra si fece: anche se il
centrodestra era in fase calante, Berlusconi mancò
per poco il sorpasso nei confronti del centrosinistra
di Bersani (pur restando sotto quota 30%, tuttavia).
Il partito del Cavaliere e il Carroccio
attraversavano una fase critica, che per Berlusconi
si è aggravata mentre per la Lega si è mutata in
40
una contingenza positiva: il nuovo leader Salvini,
infatti, ha riportato il suo partito verso percentuali
di rilievo. Da una situazione nella quale la
leadership di Berlusconi e il peso elettorale della
componente vicina al PPE era preponderante
rispetto alla destra si è passati ad una fase di
debolezza reciprioca (2012-2013) delle due "anime"
della coalizione e, infine, alla situazione attuale.
Oggi la componente dell'ex Cdl che a Roma si
riunisce intorno a Marchini parte da una base
elettorale che alle ultime europee era intorno al
17% in città e al 21% nazionale (FI-Ncd-Udc),
contro il 7% ottenuto da Lega-FdI nella Capitale
(9,9% nazionale). In teoria, se ci fossero le
condizioni politiche per un'intesa coalizionale,
l'anima "popolare" del centrodestra e quella
"lepenista" potrebbero contare su un 24% a Roma e
un 31% nazionale (europee 2014) che però,
secondo i sondaggi, potrebbe arrivare oltre, al 3234%. In realtà, a Roma Marchini e Meloni
resteranno in campo mentre, su scala più ampia, la
scelta finale sarà fra il centrodestra "classico"
guidato (anche non personalmente, ma comunque
41
dominato) da Berlusconi e una coalizione a
trazione leghista e di destra, nella quale gli
"azzurri" avrebbero un ruolo marginale e quasi
"servente". Nella fase politica nella quale ci
troviamo, Pd e M5S possono giovarsi delle
divisioni nell'ex Cdl. A Roma, perchè c'è il rischio
che nessuno dei due candidati di centrodestra
vada al ballottaggio e a livello nazionale perchè
l'Italicum premia una sola lista: se per Berlusconi e
Salvini è difficile trovare un accordo per le
comunali ed è quasi impossibile costituire una
coalizione per le politiche, si può ben immaginare
che il "listone" comune per la Camera dei deputati
è ad oggi una pura utopia. Non si arriverà
facilmente ad un'intesa nel centrodestra; è più
facile che si vada alla conta, soprattutto per
stabilire se i rapporti di forza dell'ultimo
appuntamento elettorale importante (le europee
del 2014) sono ancora validi o se, invece, la destra
prevale - sia pur di poco - sulla componente che in
Europa si riconduce al PPE. Il terreno migliore per
una gara senza esclusione di colpi è Roma. Più a
sud, la Lega non ha molta forza e la destra di FdI
42
non riesce a contrastare i centristi. Più a nord,
invece, il Carroccio sembra aver preso un
vantaggio cospicuo sugli "azzurri". La Capitale è
tradizionalmente una città generosa verso la
destra: alle comunali del 1993, quando Berlusconi
disse che se fosse stato romano avrebbe votato Fini
(dando così il via alla stagione ventennale della
Cdl) il Msi ebbe il 31%. Il risultato fu il frutto del
crollo della Dc e dei liberali (cioè dell’area
popolare-liberale che poi Berlusconi avrebbe
voluto “incarnare”), ma va ricordato che
monarchici, missini e altri di destra avevano
comunque sempre avuto numerosi consensi. Nel
1946, alle comunali, la Dc e il Pli ebbero il 25,3%
contro il 27,7% di qualunquisti e monarchici; nel
1952 (sempre alle comunali, come in tutti gli
esempi che seguono) il risultato fu di 35,5% per la
Dc e il Pli contro il 19,7% di Uq-Pnm-Msi; nel 1956,
Dc-Pli 36,4%, Pnm-Pmp-Msi 20,9%; nel 1960, DcPli 38%, Msi-Pdium 17,9%; nel 1962, Dc-Pli 37,5%,
Msi-Pdium 18,6%; nel 1966, Dc-Pli 41,4%, MsiPdium 11,6%; nel 1971, Dc-Pli 32,2%, Msi-Pdium
17,4%; nel 1976, Dc-Pli 34,8%, Msi 10,6%; nel 1981
43
Dc-Pli 32,6%, Msi 8,7%; nel 1985 Dc-Pli 35,6%, Msi
9,3%; nel 1989, infine, Dc-Pli 33,8%, Msi 6,9%. Quel
41-44% dei voti democristiani, liberali e missini del
periodo 1976-'89 non è poi troppo distante dal 44%
ottenuto da Msi, Dc e Unione di centro nel 1993 a
Roma (47% complessivo per i candidati Fini e
Caruso). In altre parole, nella Capitale il confronto
fra i centristi moderati (Pli e Dc prima, Udc e Forza
Italia poi) e la destra è sempre stato un elemento
importante della competizione. I democristiani, a
Roma, erano dominanti sul piano numerico ma
non riuscivano sempre a fare come sul piano
nazionale: servirsi, cioè, del voto missino e di
destra in casi di emergenza (come la mobilitazione
del 1976 contro il sorpasso del Pci, che vide la Dc
resistere grazie al "ritorno a casa" di molti voti
persi a destra nel biennio 1971-'72). Nella Capitale,
infatti, la destra riusciva non di rado a erodere
elettorato "di confine" con la Dc e il Pli. Durante la
Seconda Repubblica, questo confronto fra centro
moderato e destra si è svolto talvolta, a Roma, su
un piano di quasi parità: alle europee del 1994, FI e
alleati centristi hanno avuto il 24,5% dei voti
44
contro il 25,3% di An e altri di destra. Forza Italia
ha sofferto molto, nei primi anni, la difficoltà di
radicarsi sul territorio, soprattutto alle comunali
1997 (25,9% della destra contro il 13,8% di "azzurri"
e CCD), ma molto meno in elezioni nazionali come
le europee del 1999 (25,2% a 20,7% per la destra) e
persino alle comunali, nel 2001 (22,3% destra,
25,1% FI-Ccd-Cdu-altri). Così, si è avuto equilibrio
alle europee 2004 (20,4% destra, 19,6% azzurri e
altri), alle politiche 2006 (21,2% a 24,8%) e alle
comunali dello stesso anno (20% contro 15,1%).
L'unificazione di An e FI nel Pdl ha reso
impossibile, nel periodo fra il 2008 e il 2013,
quantificare la forza delle due anime della vecchia
Cdl. Ma alle europee del 2014 si è avuto di nuovo
un primo risultato “disaggregato” (6,74% per Lega
e FdI contro il 17,14% di FI e Ncd-Udc). Nel
frattempo, tuttavia, il contesto politico è cambiato:
al posto della "destra che andava verso il centro",
quella di Fini, ce n'è una che se ne allontana in
modo molto marcato. A ben vedere ci sono
divaricazioni e differenze persino all'interno delle
due "anime": pur essendo entrambi all'opposizione
45
di tutti i governi e dell'euro dal 2011, Meloni e
Salvini hanno però concezioni non perfettamente
coincidenti (oltre a storie politiche molto diverse);
sul fronte "del PPE", c'è una certa distanza fra chi è
ora al governo con Renzi (Udc-Ncd) e voterebbe sì
al referendum costituzionale e chi, invece, è
all'opposizione e si schiererebbe per il no (Forza
Italia). Oltre a euro e governo, il discrimine è
dunque sulla posizione circa le riforme
istituzionali: gli "azzurri" hanno fatto parte della
"coalizione ampia" che ha - per un certo periodo,
durante i mesi del "patto del Nazareno" - sostenuto
il progetto di revisione costituzionale voluto dal
Pd. Oggi, il "centro popolare" (vicino al PPE della
Merkel e dei conservatori britannici) è dato dai
sondaggi intorno al 14-15% nazionale (secondo
l'Emg, Forza Italia è circa al 12%, Ncd-Udc al 3%;
per Ixè FI avrebbe l'11%, Ncd-Udc il 3,4%) mentre
la "destra lepenista" (vicina alle destre europee e,
per quanto riguarda la Lega, anche al candidato
repubblicano statunitense Donald Trump) è
quotata intorno al 18-20% (15% Lega e 4,5% FdI-An
per Emg, 15% Lega e 3,6% FdI-An per Ixè). In
46
pratica, la partita si gioca per pochi punti
percentuali a livello nazionale e forse anche nel
comune di Roma. A Milano la coalizione è coesa
perchè ci sono equilibri locali da rispettare, anche
regionali, ma certamente sarà interessante vedere
se il Carroccio riuscirà ad avere la meglio su FI in
una città che spesso è stata molto più favorevole
agli "azzurri" che ai leghisti. A Napoli, invece, c'è
solo Forza Italia o poco più: la destra ha un peso
minore rispetto a Roma. Ecco perchè - se c'era
bisogno di uno "strappo" e di un confronto diretto,
di una sfida che anticipasse la lotta per la
conquista dell'intero centrodestra - non esisteva
posto migliore della Capitale. Se uno fra Marchini
e Meloni andrà al ballottaggio, sarà interessante
studiare quanti dei voti dell'avversario escluso
andranno al restante "campione" del centrodestra.
Il fossato fra le due "anime", infatti, è sempre più
ampio, senza contare la concorrenza: per i
"popolari", il "partito della Nazione" di Renzi; per
la destra anti-euro, il M5S. Oltre a lottare fra loro
per il predominio, insomma, le due anime del
centrodestra dovranno evitare di farsi logorare e
47
stringere nella morsa Pd-M5S. Democratici e
Cinquestelle, infatti, sembrano prepararsi ad essere
i protagonisti del ballottaggio con l'Italicum del
2018 (o, più probabilmente, del 2017) e hanno tutto
l'interesse a indebolire e mantenere divisa un'area,
quella di centrodestra, che se unita sarebbe
potenzialmente competitiva, dunque "pericolosa"
per loro.
48
Il "bipolarismo comunale"
14.5.2016
Con le elezioni amministrative del 5-19 giugno
anche il sistema politico dei grandi comuni italiani
sembra destinato ad abbandonare la lunga
stagione del bipolarismo. Come abbiamo
accennato nello scorso capitolo, la pluralità di
candidature competitive rende più che probabile la
dispersione del voto e l'arrivo al ballottaggio di
personalità che forse insieme rappresenteranno
poco più della metà degli elettori votanti al primo
turno. In questo modo potrebbe essere certificata la
fine, anche a livello locale, della ventennale
stagione del confronto fra due coalizioni che aveva
caratterizzato la Seconda Repubblica fino alla
svolta rappresentata dalle “politiche” del 2013. Se
ci si riflette, è proprio dall'introduzione del nuovo
sistema per l'elezione diretta dei sindaci che si
afferma, all'inizio degli anni Novanta, l'epoca della
politica fondata sul successo dei leader e sulla
necessità di costruire alleanze e coalizioni
competitive. La caratteristica dei sistemi elettorali
49
comunali e di quelli nazionali era, fino al '92, la
rappresentazione proporzionale delle preferenze
politiche dei cittadini. Le maggioranze in
Parlamento e nei comuni - anche se ampiamente
annunciate in precedenza - si concretizzavano al
momento di scegliere, in assemblea, la giunta
(locale) o il governo (nazionale). I partiti, che
prima negoziavano sulla base dei risultati elettorali
e dei rapporti di forza, si sono invece trovati – dal
’93 - ad allearsi per superare la prova del voto.
Mentre il Presidente del Consiglio, però, non è mai
stato formalmente eletto dal popolo (persino il
Porcellum indicava il "capo della coalizione",
perchè il ruolo del Presidente della Repubblica e
del Parlamento non sono stati modificati, neppure
in occasione della riforma costituzionale che sarà
sottoposta al giudizio degli italiani nel prossimo
ottobre), il sindaco lo è sempre stato, dal 1993 in
poi. L'elemento maggioritario e personalizzante
della competizione è stato accentuato sia dalla
necessità - nei comuni - di raggiungere e superare
il 50% dei voti validi per conseguire l'elezione al
primo turno, sia dall'eventuale ballottaggio
50
"chiuso" (cioè riservato ai primi due, in modo da
bipolarizzare la competizione). Poi il Mattarellum,
nelle differenti versioni per Camera e Senato, ha
spinto il sistema dei partiti a riaggregarsi intorno a
due schieramenti contrapposti. Persino il
Porcellum ha continuato ad avere effetti
bipolarizzanti, consentendo però ai partiti
maggiori (Pd e Pdl) di competere senza la necessità
di costituire coalizioni omnibus: rispetto al 2006,
infatti, nel 2008 l'Udc "ha corso" fuori dal
centrodestra (Pdl-Lega-Mpa) e la sinistra radicale
(Arcobaleno) è restata fuori dal centrosinistra (PdIdv). Si sono formate "coalizioni minime vincenti"
ma l'impianto è rimasto bipolare, finchè l'elettorato
ha scardinato il sistema e imposto un assetto
diverso. Pur riuniti in due poli competitivi,
centrosinistra di Bersani e centrodestra di
Berlusconi hanno avuto insieme solo il 58,73% dei
voti per la Camera dei deputati, nel 2013. L'indice
di bipolarismo, cioè la percentuale dei voti
ottenuta dalle due coalizioni meglio classificate
alle elezioni politiche (in particolare, alla Camera e,
per quanto riguarda il periodo 1994-2001,
51
limitatamente al voto per la parte proporzionale) è
salito dal 77,18 del 1994 (abbiamo considerato
però, come avversaria dei Progressisti, l'alleanza
fra i due "tronconi" del centrodestra: al nord Forza
Italia con la Lega, al sud FI-AN; in realtà vanno
conteggiati nel polo di centrodestra i voti di tutti i
partiti di quella che subito dopo le elezioni sarebbe
diventata l'alleanza sostenitrice del primo governo
Berlusconi) all'85,46 del 1996 (Lega fuori dai poli)
per attestarsi all'84,64 del 2001 (Rifondazione e Di
Pietro fuori dal centrosinistra), riprendere quota
fino al 98,92 del 2006 (il vero trionfo del
bipolarismo, con tutte le forze politiche schierate
con l'Unione o con la CDL), discendere all'83,83 del
2008 (Udc e sinistra radicale autonomi) e infine
crollare al 58,73 del 2013 (con la comparsa del M5S
e di Scelta Civica). La storia, insomma, ci racconta
di un sistema dei partiti che a livello nazionale
parte da un indice di bipolarismo già molto alto
nel 1994 (77%), si assesta sull'85% circa nel periodo
1996-2001 e che sfiora il 90% nella media delle
prime tre elezioni del secolo (2001-2006-2008:
89,13%) prima del crollo del 2013. Un sistema
52
politico e partitico completamente diverso - anche
per modalità comunicative e per la presenza di
alleanze elettorali e non post-elettorali come in
precedenza - da quello della Prima Repubblica. Un
bipolarismo che poteva concedersi defezioni di
forze più o meno marginali ma che restava saldo e
connotava il sistema dei partiti della Seconda
Repubblica. Questo bipolarismo esisteva anche
nelle elezioni per i comuni maggiori. Se prendiamo
in considerazione le sette città dove si voterà il 5 e
forse anche il 19 giugno (Roma, Milano, Napoli,
Torino, Bologna, Cagliari, Trieste) notiamo che la
percentuale di voto ai primi due candidati
classificati alle elezioni comunali è stata in media
dell'82,58% nel periodo 1993-2013 contro l'81,46%
ottenuto alle politiche dalle prime due coalizioni
nazionali nello stesso periodo. Il "bipolarismo
comunale", però, ha avuto un esordio meno
brillante di quello nazionale: in alcune città come
Torino la lotta non è stata fra due coalizioni
strutturate e identificate in candidati comuni
espressioni di accordi più ampi, ma fra due
candidati di sinistra (a Milano fra la sola Lega e la
53
sinistra, a Bologna fra centrosinistra e AN, a Roma
e Napoli fra sinistra e MSI). Il passaggio fra
vecchio e nuovo sistema dei partiti non era ancora
compiuto, nel periodo 1993-'95. Tuttavia, i due più
votati nei sette comuni avevano in media il 67,6%
dei
consensi
popolari:
una
percentuale
ragguardevole in valore assoluto, anche se
inferiore di circa dieci punti rispetto al 77,18%
conquistato da centrodestra e Progressisti alle
politiche 1994. Mentre nella seconda metà degli
anni Novanta il bipolarismo comunale si va
affermando (nel periodo del "partito dei sindaci")
l'indice di bipolarismo sale di 14,6 punti (quello
nazionale, invece, ne guadagna "solo" otto) anche
se resta inferiore (82,28 contro l'85% delle politiche
1996 e 2001) a quello per la Camera dei deputati.
Già in alcune realtà come Bologna (88,15%), Roma
(96,39), Napoli (98,2) la concentrazione attorno a
due candidati e la formazione di coalizioni di
centrosinistra e di centrodestra è forte nel periodo
1997-'99. È però negli anni Duemila che il
bipolarismo comunale prende - per così dire - il
sopravvento su quello nazionale. A parte il 2006,
54
l'anno nel quale fuori dai due competitori per la
Camera (Unione e CDL) ci sono solo partiti
pulviscolari, fra il 2001 e il 2008 i poli si presentano
all'elettore italiano in "formazione ridotta", mentre
molto spesso nei comuni non è nè possibile nè
auspicabile puntare su "coalizioni minime". Sia
nella tornata elettorale comunale del 2001-'04 che
in quella del 2006-'09 l'indice di bipolarismo nelle
sette città si attesta al 92,2%, con punte fino al 98%
a Milano (2006: 98,95%) e Roma (2006: 98,51%).
Non
considerando
l'astensionismo
(che
meriterebbe un discorso a parte) ma solo i voti
validi, si può dire che la configurazione bipolare
del sistema, nata con i ballottaggi delle comunali
1993 e affermatasi a livello nazionale con le leggi
elettorali che premiavano coloro i quali erano più
capaci nel coalizzarsi, si sia radicata più nelle città
che nella "grande politica". L'ultima tornata
elettorale,
quella
del
2011-2013,
risente
probabilmente ancora poco della comparsa del
M5S e dell'evoluzione del sistema politico, ma è
pur sempre vero che i candidati di centrodestra e
centrosinistra, a Roma, nel 2013, ottengono il
55
72,87% mentre le due coalizioni nazionali più
votate (quella di Bersani e quella di Berlusconi)
avevano riscosso pochi mesi prima, nella Capitale,
solo il 67,12% dei suffragi. La polarizzazione del
voto comunale, dunque, resta più elevata, sia forse
per caratteristiche della "concorrenza", sia soprattutto - perchè la natura bipolare della
competizione locale appare ancora attrattiva per
l'elettore e per i partiti “di area”. E se è vero che a
Roma, nel giro di pochi mesi, l'affluenza è crollata
dal 77,35% delle politiche al 52,81% del primo
turno delle comunali (-24,54%), è però vero che i
voti assoluti delle due principali coalizioni sono
diminuiti soltanto del 4,1% da 913.970 a 876.057
(risalendo a 1.039.373 in occasione del
ballottaggio). Sintomo di una mobilitazione che almeno a livello dei poli in lizza - si è dimostrata
costante. Resta, dunque, un interrogativo da porsi:
se quel 5-6% in più del "bipolarismo comunale"
romano (che diventa 21% in più nelle sette città 79,75 a 58,73 - sia pure con l'avvertenza che le
politiche si sono svolte nel 2013 e le amministrative
nel 2011 tranne che nella Capitale) sia un dato che
56
possa restare nel tempo e caratterizzare anche
questa competizione oppure no. La nostra
impressione è che la smobilitazione, che nel 2011
era in potenza e che nel 2013 si è palesata con forza
alle elezioni politiche più che alle comunali, sia
oggi in stato avanzato. Esaminando l'offerta
politica "plurale" di parecchie città si può
considerare verosimile registrare un valore
dell'indice di bipolarismo intermedio fra quello
delle politiche 2013 (58,73%) e il 79,75% delle
comunali 2011-2013. Ciò che è ancor più
importante, però, è che mai, in tutte le 36
consultazioni amministrative che si sono svolte
nelle sette città durante la Seconda Repubblica,
l'indice di bipolarismo è sceso sotto il 50%: è
rimasto sotto il 60% solo in tre casi (Cagliari e
Torino 1994, Roma 2013) e sotto il 70% in altri sei.
Alle ultime comunali, è stato pari all'89,86% a
Cagliari, all'89,64% a Milano, all'83,96% a Torino,
all'80,82% a Bologna, al 72,87% a Roma, al 68,23% a
Trieste, al 66,04% a Napoli. Stavolta, in una o più
città, si potrebbe finire sotto quota 60%. Se ciò
avvenisse in svariate circostanze saremmo di
57
fronte ad un'ulteriore prova che la transizione
verso un nuovo sistema dei partiti non solo non è
conclusa, ma è più duratura e complessa del
previsto.
58
Le comunali "arcobaleno"
21.5.2016
Sebbene ci siano alcuni precedenti importanti,
come il voto a Parma nel 2012 e le politiche del
2013 (così come, in parte, le scorse regionali, nelle
quale il M5S talvolta non è stato molto
competitivo), le elezioni amministrative del 2016
sono la prima grande competizione multipolare
della Seconda Repubblica. In tutti i sette
capoluoghi di regione dove si vota, quasi nessun
candidato e nessuno schieramento sono accreditati
del 50% più uno dei consensi: i ballottaggi sono
pressochè dati per scontati. Non è una novità:
anche quando si confrontavano Unione e Cdl
c'erano parecchi casi nei quali si ricorreva al
secondo turno. Il sistema per l'elezione dei sindaci,
inoltre, favorisce una competizione a due perchè
permette al secondo arrivato, sia pure se
svantaggiato di parecchie lunghezze al primo
turno, di giocarsi tutto al ballottaggio. Per venti
anni, però, la dinamica politica è stata piuttosto
semplice. C'erano tre risultati possibili: la conferma
59
della maggioranza (o anche del sindaco) uscente,
la vittoria della coalizione avversaria o un secondo
turno con in lizza i rappresentanti di Unione e Cdl.
Le rare eccezioni confermavano la regola. Ora non
è più così. Stavolta non sarà tanto importante
aggiudicarsi il comune al primo turno (sebbene ci
siano una o due città dove teoricamente,
guardando i risultati di un tempo, potrebbe essere
un’ipotesi da valutare) ma arrivare al ballottaggio.
In alcune situazioni, come quella di Roma e
Napoli, le combinazioni possibili sono numerose:
fra Raggi (M5S), Giachetti (Pd), Meloni (FdI-Lega)
e
Marchini
(centristi-FI)
tutti
appaiono
potenzialmente in grado di approdare al turno
successivo. Così a Napoli, dove il sindaco uscente
De Magistris competerà con gli esponenti di Pd,
centrodestra e M5S per dar vita ad una gara che si
preannuncia interessante al pari di quella romana.
Anzichè riproporre i confronti della Seconda
Repubblica (centrodestra contro centrosinistra)
potremmo avere perciò un arcobaleno di
combinazioni diverse, il che porterà come
conseguenza l'esclusione di candidati e partiti
60
rappresentativi di porzioni rilevanti dell'elettorato.
In certi casi, potrebbe bastare un 22-25% dei
suffragi per arrivare al ballottaggio: la somma dei
primi due ammessi potrebbe non superare il 50%
dei voti espressi al primo turno. In un quadro di
così marcata frammentazione si inserisce
l'astensione, che verosimilmente non sarà inferiore
al 40% degli aventi diritto, come ormai accade di
solito (nelle sette città il non voto è stato pari al
38% alle scorse regionali, al 45,9% alle europee del
2014, al 40,4% alle precedenti comunali). Nelle
elezioni amministrative della Seconda Repubblica,
normalmente, l'astensione riusciva a giocare un
ruolo rilevante soprattutto al secondo turno,
spesso favorendo il centrosinistra (gli elettori di
centrodestra erano considerati un po' più "pigri" e
meno propensi a votare due volte in quindici
giorni). Stavolta, invece, la mancata partecipazione
al voto potrebbe manifestarsi già al primo turno e
avere un peso ben più rilevante: la minore
mobilitazione o la maggior disaffezione rispetto ad
un candidato, un partito o uno schieramento
potrebbe precludere a qualcuno l'accesso al
61
ballottaggio. Data l'elevata competitività di questa
tornata elettorale, ogni aspirante sindaco dovrà
cercare di motivare il più possibile i suoi
sostenitori, perchè può essere sufficiente perdere il
2-3% dei voti rispetto al proprio risultato atteso o
prevedibile per trovarsi fuori dal secondo turno.
Inoltre, per venti anni la battaglia si è svolta sul
terreno più ristretto dell'elettorato "di frontiera" fra
un polo e l'altro. Oggi, invece, le dimensioni del
conflitto sono più numerose e i fronti sui quali
combattere possono essere anche tre o quattro. Nel
centrodestra in particolar modo, avrà luogo anche
una battaglia per il predominio fra la destra
antieuro e il centro moderato il quale - come
abbiamo accennato nel capitolo precedente - si rifà
invece al Partito popolare europeo. Essendo
possibili molte combinazioni (fra tutte: Pd-M5S,
Pd-Centrodestra, Lega-destra, Lega-M5S) sarà
complesso fare previsioni sull'esito delle diverse
competizioni comunali. In ciascuna, infatti, non ci
sono soltanto le tradizionali dinamiche locali che
possono agevolare la prevalenza in ballottaggio di
un candidato sull'altro, ma anche i flussi
62
provenienti dagli elettori dei candidati esclusi. In
presenza di un 30-40% di voti "orfani" (cioè di una
percentuale che raramente si osservava alle
elezioni comunali della Seconda Repubblica) la
vera competizione per la vittoria finale si giocherà
non tanto sulle "prossimità" ideologiche e
programmatiche ma, più semplicemente, sulla
scelta del "minor male". C'è infine da ricordare che
l'elettorato di alcuni partiti (soprattutto quello del
M5S) proviene da precedenti esperienze di voto
non omogenee (molti "cinquestelle" sono ex di
centrodestra, così come molti sono ex di
centrosinistra). La scomposizione e ricomposizione
(non completata) del sistema dei partiti a livello
locale avviata con le elezioni politiche del 2013 non
ha interessato i poli tradizionali in egual misura in
tutto il territorio nazionale: la diaspora degli ex di
Unione e Cdl si è diretta in particolare verso
l'astensione, ma in misura molto variabile da zona
a zona verso le forze politiche come il M5S. La
pluralità dei soggetti (la sinistra, il centrosinistra
imperniato sul Pd, il M5S, il centro neodc e
governativo, il centro "azzurro", la destra leghista e
63
"lepenista") ha trasformato in una sorta di Palio di
Siena quello che per circa venti anni è stato solo un
duello. In questo nuovo contesto, ciascuno (o
quasi) può vincere e non è chiaro se è opportuno
temere più l'avversario o l'amico. Il passaggio
elettorale delle comunali 2016 sarà utile per
esaminare alcune delle dinamiche di voto, tenendo
però presente che - sia sul lato dell'offerta politica,
sia su quello della domanda - la situazione è
destinata ad evolversi. La crisi del 2012-2013 non
sembra completamente superata e potrebbe non
esserlo neppure per le prossime elezioni
parlamentari, le quali, tuttavia, potrebbero
costituire il punto di avvio per una "terza fase" del
sistema partitico italiano.
64
Comunali, l'importanza dei candidati sindaci
28.5.2016
Uno fra gli elementi più importanti della
campagna elettorale comunale (forse quello
decisivo) è rappresentato dalla capacità del singolo
candidato di "trainare" la propria coalizione - cioè
di conquistare consensi personali che non
andrebbero ai partiti alleati – e "catturarne" altri
(grazie alla possibilità del "voto disgiunto") in
campo avversario. Si può dire che quella per i
comuni è una competizione "a cerchi concentrici":
in quello più piccolo c'è la lotta fra le liste, mentre
in quello più ampio c'è quella fra candidati sindaci.
Quest'ultimo cerchio è più vasto perchè mentre il
voto di lista va automaticamente al candidato
sindaco, il solo voto al sindaco non va alle liste
collegate. Alle ultime comunali, il 7,3%
dell'elettorato (corrispondente al 12,8% dei voti
validamente espressi) non ha votato per i partiti,
ma solo per il sindaco. Si tratta di una percentuale
che - nelle sette città chiamate al voto del 5 e 19
giugno - è stata del 7,7% sugli aventi diritto anche
65
in occasione delle elezioni regionali: segno che in
tutte le occasioni nelle quali l'elettore può dare un
voto alla persona e non al partito c'è una buona
quota di cittadini che si avvale di questa facoltà. Si
tratta di un possibile valore aggiunto, forse anche
in termini di affluenza alle urne. La
personalizzazione,
dunque,
è
un
tratto
caratteristico e dominante nella competizione per
la conquista dei comuni. Lo sarà anche stavolta? La
storia della Seconda Repubblica sembra costituire
un precedente a favore del voto al solo sindaco.
Nel periodo 1993-'97 - quando il nuovo sistema
elettorale fu introdotto e sperimentato - il numero
dei voti ai soli candidati sindaci superò del 20,9%,
nelle sette città ora al voto (Roma, Milano, Napoli,
Torino, Bologna, Cagliari, Trieste) i suffragi
espressi ai soli partiti: lo scarto ammontò a circa
novecentomila voti. Nella tornata 1997-'99 la
percentuale scese al 18,1%, per poi attestarsi al 19%
nel periodo 2001-'04. Dalla seconda metà dello
scorso decennio, però, la quota di voti ai soli
sindaci è drasticamente diminuita, passando al
10,5% nel 2006-'09 e risalendo al 12,8% del 2011-'13.
66
In termini assoluti (sul totale degli aventi diritto al
voto) i suffragi espressi nel 2011-'13 al solo sindaco
sono compresi fra il 6,2% e il 7,8% in ben sei delle
sette città al voto (a Trieste si è arrivati, nel 2011,
all'11,2%). Sui voti validi, invece, la differenza è
più marcata da città a città: a fronte del 12,8%
medio (2011-'13) abbiamo il 15,3% a Roma, il 9,4%
a Milano, l'11,2% a Torino, il 12,1% a Napoli, il
10,1% a Bologna, il 9,5% a Cagliari e il 24% a
Trieste. Scegliere un buon aspirante sindaco,
dunque, è fondamentale. Il "candidato perfetto" è
chi sa ottenere più voti del suo elettorato
tradizionale e sa conquistare la gran parte di chi,
avendo votato per i candidati esclusi al primo
turno, deve decidere se disertare le urne o meno e in quest'ultimo caso - chi scegliere al ballottaggio.
Se proprio non si riesce a vincere al primo turno
(eventualità che nelle sette città si è realizzata in 14
casi su 36, spesso con la conferma dei sindaci
uscenti), al secondo bisogna quasi cominciare da
capo. Nella storia dei 22 ballottaggi, ben nove
candidati su 44 hanno ottenuto meno voti al
secondo turno che al primo, quindi nulla può
67
essere considerato scontato. Gli aspiranti sindaci,
dunque, possono essere un valore aggiunto o una
zavorra troppo pesante, tale da affondare una
coalizione competitiva. Poichè la persona conta,
una buona scelta è già un vantaggio nei confronti
degli avversari. Ci sono poi tendenze consolidate
nella Seconda Repubblica, come quella che vede i
candidati di centrosinistra e di sinistra ottenere
una percentuale di voti maggiore rispetto alle liste
collegate, al contrario di quanto è avvenuto di
solito per quelli di centrodestra. Restando ai due
poli principali si può notare che il centrosinistra ha
avuto mediamente - al primo turno - il 5% in più
dei voti per i sindaci rispetto alle liste, mentre il
centrodestra ha conseguito il 6% in meno. In altre
parole, se su 100 voti ai partiti il centrodestra ne
prendeva - poniamo - 40 e il centrosinistra
altrettanti, su 100 voti espressi solo per i sindaci i
candidati della CDL ne conquistavano 34 e quelli
dell'Unione 45. A Roma, nel 2013, Marino
(centrosinistra) ha ottenuto al primo turno il 42,8%
dei voti ai soli candidati sindaci, contro il 22,2% di
Alemanno (centrodestra), il 18,7% di Marchini e il
68
10,3% del candidato del M5S. A livello di liste,
invece, le rispettive percentuali sono state pari al
42,6%, 31,7%, 7,8% e 12,8%. Una differenza
notevole si è avuta anche a Milano nel 2011
(Pisapia 55,6% voti al sindaco, 47,3% alle liste;
Moratti, 25,4% e 43,3%) per non parlare dei casi di
Napoli (De Magistris) e Cagliari (Zedda) dove il
numero dei voti raccolti è stato persino superiore
allo scarto fra i voti validamente espressi e quelli ai
soli sindaci, segno che quei candidati non solo
hanno avuto molti voti personali, ma hanno anche
beneficiato di un fortissimo voto disgiunto da
parte di elettori di altre coalizioni. Come
accennavamo, ci sono aree politiche che esprimono
di solito candidati più capaci di "trainare" la
propria alleanza. Il centrosinistra, ad esempio
(soprattutto dal '97 in poi, quando le coalizioni si
sono "assestate") ha avuto più voti per i sindaci che
per le liste in 25 casi su 35, mentre al centrodestra è
accaduto in 14 casi su 32. Nelle 36 votazioni
comunali del periodo 1993-2013 prese in
considerazione, i candidati primi classificati al
primo turno sono stati per 25 volte di sinistra o
69
centrosinistra (fra i quali 9 eletti senza dover
ricorrere al ballottaggio) e per 11 volte di destra
(Lega, MSI) o centrodestra (di cui 5 eletti subito).
Nel complesso delle competizioni, il centrosinistra
e la sinistra hanno avuto 24 sindaci eletti fra primo
e secondo turno contro 12 della destra e del
centrodestra. In media, i candidati sindaci di tutti i
partiti, nel periodo 1993-2013 hanno avuto il 16,1%
dei voti in più (in valore assoluto) delle rispettive
liste. In altre parole, hanno saputo aggregare
consenso
oltre
l'elettorato
tradizionale.
Analogamente, i candidati giunti al ballottaggio
hanno avuto in media il 17,7% dei voti in più
rispetto a quelli che avevano ottenuto al primo
turno, confermando di essere in grado di
intercettare parte dei consensi degli esclusi. I
suffragi in valore assoluto ai candidati sindaci del
primo turno sono stati però inferiori del 6,7%
(periodo 1993-2013) rispetto a quelli raccolti dai
due in lizza al ballottaggio. Su cento voti ottenuti
al primo turno da tutti i candidati, 85,33 erano dei
due giunti al secondo, dove questi ultimi hanno in
media ottenuto 93,29 voti. In altre parole, la
70
dispersione di voto ai candidati sindaci è stata
molto limitata da due fattori: al primo turno, da
quello che nel precedente capitolo abbiamo
definito "bipolarismo comunale"; al secondo, dalla
capacità degli aspiranti sindaci di farsi votare da
chi aveva scelto un candidato diverso (una logica
che in parte è di "minor male" e in altra parte di
"second best" rispetto al proprio beniamino
bocciato al primo turno). Non sempre, tuttavia,
l'operazione di allargamento del consenso è
riuscita ai candidati rimasti in lizza: se dividiamo
in fasce la variazione percentuale dei voti fra
primo e secondo turno, notiamo che in 2 casi c'è
stato un calo, in 6 l'incremento è stato inferiore al
10%, in 2 è stato fra il 10 e il 20%, in 4 fra il 20 e il
30% e nei restanti 8 oltre il 30%. Solo in una
occasione su ventidue, infine, i due candidati
sindaci giunti in ballottaggio (Roma 1993: Rutelli e
Fini) hanno avuto più voti (1.799.989 contro
1.726.730) di tutti i candidati sindaci del primo
turno. Si tratta di un record insuperato e
verosimilmente non raggiungibile nella tornata
elettorale amministrativa del 5 e 19 giugno. Quella,
71
del resto, fu un'occasione particolare, che diede
l'avvio alla Seconda Repubblica. Il voto per Roma
fu caratterizzato da un altro dato poco comune:
l'affluenza al secondo turno (79,85%) fu maggiore
rispetto a quella del primo (78,74%), con le schede
bianche e nulle ridotte da 93.824 a 50.401 nel giro
di due settimane, fra il 21 novembre e il 5 dicembre
1993.
72
Parte Seconda
Il voto nelle "sette capitali": un primo bilancio
11.6.2016
Mentre nei precedenti capitoli abbiamo descritto le
caratteristiche dei sette comuni capoluogo di
regione chiamati alle urne, siamo giunti al
momento di tracciare un primo bilancio,
ripercorrendo i temi che abbiamo trattato e
confrontando i dati del passato col voto del 5
giugno. Come avevamo sottolineato, le grandi città
hanno una minor propensione all'affluenza
rispetto alle altre. È stato così anche stavolta: quel
61,9% di votanti in 1274 comuni (esclusi quelli del
Friuli-Venezia Giulia) è stato “appesantito” dal
55,8% dei capoluoghi. Non va dimenticato, infatti,
che su 13 milioni e 316 mila aventi diritto al voto in
tutta Italia ben 5 milioni e 474 mila erano elettori
delle "metropoli". Così, nel turno amministrativo
del 5 giugno si conferma che nei sette capoluoghi
si vota meno che nel complesso del Paese: -0,8%
alle politiche 2008%, -3,5% alle europee 2009, -0,6%
73
alle politiche 2013, -4,6% alle europee 2014 e -6,1%
alle comunali 2016. Si potrebbe ipotizzare (in attesa
di indagini più approfondite) che nei grandi centri
ci sia una sorta di "non voto d'opinione". In quelle
città dove nella Prima Repubblica venivano
premiati partiti che di volta in volta
rappresentavano qualcosa di nuovo (il Pci nel
1976, i radicali nel 1979, il Pri nel 1983, i Verdi nel
1987) oggi potrebbe essere l'astensione ad essere
scelta per mandare un segnale politico. Si
attendeva, stavolta, un'affluenza bassa: se non si è
raggiunto il record negativo il merito è di Roma,
che andando in controtendenza ha avuto una
percentuale di non voto pari al 43,8% contro il 48%
delle europee e il 47,2% delle comunali 2013.
Tuttavia, il dato globale delle sette città capoluogo
di regione (affluenza al 55,8%) è più basso rispetto
alle ultime regionali (62%), alle politiche (74,6%) e
alle precedenti comunali (59,6%) mentre è di poco
superiore a quello delle europee 2014 (54,1%).
L'ondata del non voto, insomma, è stata meno
forte del temuto, ma va rimarcato che a Torino
l'astensione ha raggiunto il 42,8% (precedente
74
record alle regionali 2014: 37,2%) e a Milano il
45,3% (record europee 2014: 40%). Rispetto alle
scorse comunali il calo d'affluenza è del 3,7%, pari
a 290mila elettori. Un altro elemento, stavolta del
tutto nuovo, è la drastica diminuzione del voto ai
soli candidati sindaci/presidenti di regione, che
alle scorse comunali e alle regionali si era attestato
fra il 7,3% e il 7,7%, ma stavolta si è fermato al
4,4% degli aventi diritto. Non è il segno di un
ritorno di forza dei partiti o di una minore
personalizzazione della competizione, quanto
forse di una minore "appetibilità" delle
candidature. Sta di fatto che le schede con i voti al
solo sindaco (rispetto alle scorse comunali) sono
passate dal 7,1% al 3,4% a Torino, dal 6,2% al 3,4%
a Milano, dal 7% all'1,6% a Bologna, dal 7,8% al
5,1% a Roma, dal 6,9% al 3,4% a Napoli e dal 6,5%
al 5,3% a Cagliari. Unica eccezione, Trieste, dove
sono aumentate: dall'11,2% delle comunali 2011
all'11,7% del 2016. Si è poi detto, in passato, che le
sette città capoluogo di regione hanno sempre dato
la maggioranza (relativa o assoluta) dei voti al
centrosinistra. Anche stavolta è stato così, ma
75
mettendo insieme tutti i partiti dell'ex Unione
(quindi comprendendo anche quelli di sinistra che
oggi non sono al governo) si arriva appena al
41,6% dei voti contro il 48,1% delle regionali, il
51,9% delle europee, il 46,9% delle precedenti
comunali. Solo alle politiche 2013 (36,9%) è andata
peggio. In dettaglio, la lista del Pd ha ottenuto il
21,5% dei suffragi nei sette capoluoghi, contro il
30,5% delle regionali, il 44,1% delle europee, il
28,9% delle politiche, il 27,2% delle precedenti
comunali. Aggregando l'area dei gruppi di
centrosinistra (liste del sindaco/presidente, minori
affini e alleati di governo, esclusi però quelli
centristi come Ncd-Udc-Sc e verdiniani) abbiamo
un totale del 29,7% (i centristi sono invece,
complessivamente, al 5,4%) contro il 41,6% delle
regionali (centristi: 4,4%), il 44,1% delle europee
(centristi: 4,6%), il 29,2% delle politiche (centristi:
11,1%) e il 33,1% delle precedenti comunali
(centristi: 7,5%). L'area di governo, insomma, o il
complesso delle liste di riferimento, ha raccolto
circa il 35% dei voti contro il 46 delle regionali, il
48 delle europee, il 40 delle politiche e delle
76
precedenti comunali. Per quanto riguarda la
"sinistra radicale", normalmente attestata fra il 6 e
il 9%, il dato è molto vicino a quello delle scorse
comunali grazie all'exploit napoletano delle liste
facenti capo a De Magistris. Il M5S, invece, che
partiva dal 24,3% delle politiche, dal 21,7% delle
europee e dal 16,4% delle regionali (nonchè dal
7,4% delle comunali precedenti) ha ottenuto il
24,1%, frutto però di prestazioni molto diverse da
città a città. A Torino, infatti, il 30% dei
Cinquestelle supera di gran lunga il 25,6% delle
politiche (precedente record); a Milano il 10,4% di
queste comunali è inferiore all'11,2% delle
regionali, al 14,2% delle europee, al 17% delle
politiche; a Trieste il M5S ha avuto il 17,6%
(regionali 18,3, europee 20, politiche 28,7); a
Bologna il 16,6 dei pentastellati è il secondo
miglior risultato dopo il 19,1% delle politiche; a
Roma il 35,3% delle comunali di quest'anno supera
dell'8% il record delle politiche 2013; a Napoli il
dato è al di sotto del 10% (9,7%) contro il 24,6-26,5
ottenuto fra il 2013 e il 2015 (politiche, europee,
regionali); a Cagliari l'8,8% è di gran lunga
77
inferiore rispetto al 26,3-26,7% di politiche ed
europee. In altre parole, il 24,1% di oggi non ha la
stessa composizione del 24,3% delle politiche,
perchè è il frutto di risultati estremamente diversi
fra loro: un misto di grandi successi e clamorose
battute d'arresto. Una notazione particolare va poi
riservata alle "due anime" del centrodestra, quella
"popolare" che fa riferimento al PPE e quella
"lepenista" di Meloni e Salvini. La vecchia CDL
partiva dal 35,1% di elezioni comunali lontane
(tutte svolte nel 2011, tranne quelle di Roma) e dal
predominio del partito di Berlusconi (21,7%) su
Lega e destra (complessivamente 7%; c'era poi un
7% di liste miste di centrodestra che qui
considereremo solo per confrontare i totali di
schieramento ma non per i raffronti fra le due
"anime"), però i punti di riferimento a nostro
avviso più validi ed efficaci sono le elezioni
politiche, regionali, europee. Lo scorso 5 giugno i
partiti dell'ex CDL hanno avuto il 26,1% dei voti: 3
punti in meno rispetto alle regionali ma 4,4 in più
sulle europee e uno in più delle politiche.
Traslasciando le liste "di area" (6,1% 2016, 3,3%
78
regionali, 0,7% politiche) concentriamoci su quelle
tradizionali: Fi (ex Pdl) è ora all'8,5% contro il
15,8% delle regionali, il 14,4% delle europee e il
19,4% delle politiche, mentre Lega e FdI hanno
insieme l'11,2% (non contando i voti di Storace)
contro il 10% (che diventa 7,7 senza la lista Maroni
presidente) delle regionali 2013-2015, il 7,3% delle
europee 2014, il 4,9% delle politiche 2013, il 7%
delle comunali precedenti, il 5,9% delle europee
2009, il 7,5% delle politiche 2008. È opportuno
considerare che di solito il partito di Berlusconi è
più debole alle comunali che alle politiche e che in
questi sette capoluoghi ha sempre percentuali
inferiori a quelle nazionali, ma è anche vero che
nelle metropoli la Lega ha spesso la metà (o meno)
della quota di voti che riscuote in tutto il Paese. Il
discorso è diverso invece per FdI, che a Roma
(come si è visto con la Meloni) ha una vera e
propria roccaforte e che tuttavia il partito di destra
è cresciuto gradualmente di un punto percentuale
ad ogni occasione, dalle politiche alle europee, da
queste alle regionali e infine alle comunali del 5
giugno (6,1%). È difficile dire chi abbia vinto il
79
duello nel centrodestra: a livello di voti, l'ala
lepenista sembra più forte, ma conteranno anche i
risultati dei ballottaggi. Il dato politico "pesante" è
che Forza Italia ha un discreto risultato solo a
Milano (20% contro il 15,7% delle regionali, 16,6%
delle europee e 20,5% delle politiche), forse perchè
schiera Parisi. Ma altrove (tranne Trieste - 14,4% dove però perde voti rispetto alle precedenti
consultazioni) è in seria difficoltà: Torino 4,7%
(minimo precedente: 12,2% regionali), Bologna
6,3% (regionali: 9,6%), Roma 4,2% (europee:
13,5%), Napoli 9,7% (regionali: 14,2%), Cagliari
8,2% (europee: 16,5%). La destra "lepenista", però,
non "brilla" dappertutto: a Torino la Lega è al 5,8%
contro il 3,6% delle regionali e il 4,2% delle
europee, ma è sotto il 6,9% delle scorse comunali
(FdI è all'1,5% contro il 3,9 di regionali ed
europee); a Milano il Carroccio sale all'11,8%
mentre FdI è al 2,4% (fra politiche, regionali ed
europee è sempre stata intorno al 2-2,8%); a Trieste
il Carroccio raggiunge il 9,8% contro il 3-5% di
politiche, europee e regionali e il 6,7% delle scorse
comunali, mentre FdI è al 4,3%; a Bologna la Lega
80
si attesta su un 10,5% non lontano dal 10,7% delle
scorse comunali, inferiore al 14,5% delle regionali
ma superiore al 2-3% di politiche ed europee; a
Roma il partito di Salvini è al 2,7% (precedente
record: 1,4% alle europee) mentre FdI della Meloni
è al 12,3% contro il 5,3% delle europee; a Napoli la
destra non sfonda (FdI all'1,3%) e a Cagliari si
ferma comunque sotto il 4% (Fdi: 3,7% contro il
4,2% delle europee). Un'osservazione sulle
comunali di Roma: come abbiamo scritto in un
precedente capitolo, l'ex centrodestra poteva
contare complessivamente sul 24% (il dato delle
europee, che però andava considerato insieme al
31% alle regionali e al 33% alle politiche) che
secondo i sondaggi poteva arrivare al 32-34%. Le
liste a sostegno di Marchini e Meloni hanno
raggiunto il 30,9%, mentre i due candidati sono
arrivati al 31,6%, con la componente lepenista che
ha il primo partito (FdI) oltre ad aver doppiato
quella popolare sia nelle candidature (Meloni
contro Marchini), sia nel voto di lista.
81
Comunali: il rendimento dei candidati sindaci
15.6.2016
Nel nostro viaggio nelle elezioni comunali dei sette
capoluoghi di regione chiamati al voto il 5 giugno
(e, in sei casi su sette, il 19 giugno per i ballottaggi)
abbiamo fatto riferimento al "bipolarismo
comunale", cioè alla capacità dei due maggiori
candidati di attrarre il massimo numero dei voti
possibile. Mentre a livello nazionale i due "poli"
più forti hanno ottenuto il 77,2% nel 1994, per
salire all'85% nel periodo 1996-2001 e al 98,9% del
2006, ridiscendendo all'83,8% nel 2008 e crollando
fino al 58,7% del 2013, a livello comunale si è
assistito ad un primo dato più basso (1993-'95:
67,6%) per poi salire all'82,3% del 1997-'99,
assestarsi sul 92,2% del 2001-'09 e scendere al
79,75% del 2011-'13. In occasione delle elezioni
amministrative del 2016 i due candidati più votati
hanno ottenuto in media un più magro 72,4%,
segno che la competizione multipolare lascia circa
tre votanti su dieci senza il proprio candidato
sindaco al ballottaggio. È col voto degli "elettori
82
orfani" che si può decidere più di una
competizione.
Tornando
al
"bipolarismo
comunale" ci si è chiesti – nel capitolo precedente se la forte discesa dell'indice nazionale potesse
essere accompagnata da un abbassamento
altrettanto forte a livello locale, nelle sette maggiori
città al voto. In effetti, fra il 1994 e il 2006 lo schema
bipolare è stato più forte per il Parlamento che per
i comuni. Sul piano nazionale, si è passati – come
accennavamo - dall'83,8% del 2008 al 58,7% del
2013, con un calo del 25,1%, mentre localmente si è
scesi dal 92,2% del 2006-2009 all'attuale 72,4% (19,8%): una dinamica netta ma più contenuta. Fra
le comunali 2011-2013 e quelle del 5 giugno 2016 si
è assistito ad una diminuzione dei voti ai primi
due candidati, ma solo in cinque delle sette città al
voto: a Trieste si è risaliti al 70% dal 68,2% del
2011, mentre a Napoli De Magistris e Lettieri (gli
stessi sfidanti del 2011) hanno avuto il 66,8% dei
voti contro il 66% della scorsa volta. Per il resto, la
diminuzione è stata avvertita in modo netto,
indipendentemente dal tipo di competizione (cioè
dal colore politico degli sfidanti: le combinazioni
83
sono diverse) negli altri cinque capoluoghi: -6,7% a
Cagliari, -7,2% a Milano, -11,2% a Torino, -9,1% a
Bologna, -19,6% a Roma. Il caso romano è
interessante e va trattato a parte, perchè nel 2011,
nella Capitale, i candidati "forti" erano due (Rutelli
e Alemanno) e avevano ottenuto l'86,5% dei voti,
mentre nel 2013 i rappresentanti di centrodestra e
centrosinistra (Alemanno e Marino) si erano
fermati al 72,9% (per l'"ingresso in campo" del
candidato centrista Marchini e dell'esponente dei
Cinquestelle). Tuttavia, le comunali del 2013 si
erano svolte a pochi mesi dalle politiche, in
occasione delle quali le due coalizioni più votate
(quella di Bersani e quella di Berlusconi) avevano
ottenuto il 67,1% dei voti. Ci si attendeva, dunque,
data la maggior "resistenza" del bipolarismo
comunale nella Capitale, un risultato maggiore per
i primi due in lizza. Invece il moltiplicarsi
dell'offerta politica e delle candidature (una del
M5S, una di centrosinistra, una di sinistra, una di
centro, una di destra) ha fatto registrare a Roma il
più basso indice di tutti i capoluoghi di regione al
voto: il 60,1%, di ben 12 punti inferiore alla media
84
delle sette città. Non si è tuttavia assistito alla
discesa dell'indice sotto quota 60%. Così, mentre
nelle 36 competizioni comunali del periodo 19932013 si era avuto un indice inferiore al 60% in tre
casi, fra il 60 e il 70% in sei e sopra il 70% in 27
occasioni, nel 2016 due comuni sono rimasti fra il
60 e il 70 e gli altri cinque sopra il 70%, a conferma
che a livello locale permane una certa tendenza a
concentrare il voto intorno alle due personalità che
sono considerate più in grado di ottenere l'elezione
a sindaco. A Roma e a Napoli, dove c'era un terzo
candidato forte (così come a Bologna, dove l'indice
si è fermato a quota 71,7%) la pluralità dell'offerta
politica ha superato un'ormai storica tendenza
all'aggregazione bipolare. Nonostante ciò, come
abbiamo visto nel precedente capitolo, questa
pluralità non ha incoraggiato il voto al solo
sindaco; anzi, lo ha drasticamente ridimensionato,
non solo per questioni relative alla scheda di
votazione. Solo il 4,4% degli aventi diritto (contro il
7,3-7,7% del periodo 2011-2015, fra regionali e
comunali) ha scelto esclusivamente un nome
anzichè le liste collegate (o altre liste non
85
collegate). In termini di voti validi, si è passati dal
12,8% delle comunali precedenti all'8,1%. In
particolare, però, si fanno sempre più rari i
candidati che "trainano" i propri schieramenti. Di
solito, in passato, quelli di centrosinistra
svolgevano questa funzione, mentre quelli di
centrodestra erano più in difficoltà. Stavolta solo a
Milano e a Cagliari (in questo caso si è avuta
l'unica elezione al primo turno nei sette capoluoghi
di regione al voto) l'esponente del centrosinistra ha
fatto meglio delle liste. A Milano Sala ha avuto il
49,65% dei voti al solo sindaco, contro il 37,57% di
Parisi, mentre le liste sono finite quasi alla pari
(41,2% quelle di Sala, 41% quelle di Parisi). A
Cagliari, invece, Zedda ha fatto la differenza: le sue
liste si sono fermate al 47,7% dei voti, mentre lui ha
superato il 50%. Nel panorama degli altri candidati
di diversi schieramenti, pochi sembrano aver
avuto un ruolo trainante. Sono i casi di Giorgia
Meloni (FdI) col 30,3% dei voti fra quelli per i soli
sindaci (le sue liste, però, erano al 19,65% e la
spinta non è bastata), di Chiara Appendino (M5S)
a Torino (45,4% dei voti ai soli sindaci) e di Luigi
86
De Magistris a Napoli (22970 voti in più delle liste,
mentre la candidata del Pd Valente ne ha avuti
addirittura 3760 in meno), nonchè (sia pure in una
città nella quale i voti ai soli candidati sono stati
pochissimi, quindi il dato non è molto
significativo) di Lucia Borgonzoni (centrodestraLega) a Bologna (32,3% dei voti ai soli candidati
contro il 22% delle liste di coalizione). Insomma, i
casi nei quali la persona fa differenza ci sono
ancora, ma paiono divenire sempre più rari. A
questo punto, resta irrisolto il nodo relativo alla
durata della transizione italiana. I risultati sulle
sette più grandi città al voto ci danno qualche
indizio sul futuro del sistema politico? Anche
utilizzando altri indicatori, la risposta è ambigua.
L'indice di bipartitismo, per esempio, che misura i
consensi alle prime due liste classificate, è ancora
molto basso: 0,457 (pari al 45,7% dei voti), poco più
basso dello 0,469 delle regionali e dello 0,489 delle
scorse comunali. Si tratta, in effetti, di
consultazioni sempre ricche di liste aggiuntive
rispetto a quelle nazionali, che rendono
impraticabile un paragone con gli indici misurati
87
in altre consultazioni (europee 2014 0,658, politiche
2013 0,532, europee 2009 0,665, politiche 2008
0,767). Lo stesso risultato ci viene dall'indice di
frammentazione elettorale, che resta pressochè
invariato rispetto alle regionali e alle precedenti
comunali. Tuttavia, l'indice di transizione (che
misura, in parole povere, i movimenti di voto fra
un'elezione e l'altra) resta a livelli elevati, non
altissimi come nel periodo 2011-2013 ma tali da
farci avvertire che l'elettorato è ancora fluido,
disposto a spostarsi a seconda dell'offerta politica.
La transizione, dunque, non è conclusa, come
avevamo ipotizzato anche prima del voto del 5
giugno.
88
Bilancio dei ballottaggi
25.6.2016
Il turno di ballottaggio delle elezioni comunali nei
capoluoghi di regione ci ha riservato alcune
conferme e parecchie sorprese. Il primo dato in
controtendenza riguarda il rendimento dei
candidati sindaci: al primo turno, i voti ai soli
aspiranti primi cittadini erano stati appena il 4,4%
sugli aventi diritto. Tuttavia, al secondo turno i
due rimasti in lizza hanno mediamente ottenuto il
31,27% di voti in più rispetto al primo: un indice
record se confrontato con le consultazioni
precedenti, tranne quelle degli albori della Seconda
Repubblica (1993-'95: 36,46%). Su dodici candidati
in gara nei sei capoluoghi di regione, solo uno
(Lettieri a Napoli) ha ottenuto il 19 giugno meno
consensi che al primo turno (circa 4800 in meno).
Nella storia dei ballottaggi (1993-2013) su 44
candidati erano stati nove quelli con meno voti al
secondo turno (il 20,5%). Il dato aggiornato al 2016
è invece il seguente: su 28 ballottaggi e 56
candidati, solo 10 (17,9%) hanno perso voti rispetto
89
alla prima votazione. Resta da capire quanto
abbiano influito - in questo recupero di consensi - i
profili dei candidati del 2016 o, piuttosto, l'afflusso
degli elettori dei concorrenti esclusi al primo turno
(in altre parole: il voto "contro" uno dei due rimasti
in lizza). La differenza, sul piano politico, non è
irrilevante. Quel 31,27% in più è quasi il doppio
del 17,7% fatto registrare nel periodo 1993-2013.
C'è, inoltre, un dato generale da rilevare: anche
stavolta in nessun capoluogo di regione i candidati
hanno ottenuto più voti al secondo turno rispetto
al complesso dei concorrenti in lizza al primo.
Anzi: a fronte di un 6,7% di voti "non recuperati"
in ballottaggio (finiti nell'astensione) fra il 1993 e il
2013, nel 2016 il valore è salito all'11,6%. Segno che
tutti i valori (di recupero e di mancato recupero
degli "elettori orfani") sono condizionati dall'alto
numero di suffragi ottenuto dagli aspiranti sindaci
esclusi dal ballottaggio. Il rendimento degli
ammessi al secondo turno va dunque valutato
tenendo conto di questa massa di elettori "liberi"
più ampia che in passato. Avevamo visto in uno
dei precedenti capitoli che nel ventennio 199390
2013, nei sette capoluoghi considerati, su cento voti
conquistati al primo turno da tutti i candidati,
85,33 erano dei due giunti al secondo, dove questi
ultimi avevano in media ottenuto 93,29 voti.
Questa volta, i candidati ammessi al ballottaggio
hanno conseguito solo 67,34 voti su cento e ne
hanno avuti 88,40 al ballottaggio. Inoltre, bisogna
ragionare sui dati distinguendo fra diverse realtà
territoriali. Se dividiamo in fasce la variazione
percentuale dei voti fra primo e secondo turno,
notiamo che nel 2016 in un caso l'incremento è
stato inferiore al 10% (Napoli, 3,1%), in uno fra il
10 e il 20% (Milano, 15,4%), in uno è stato fra il 20 e
il 30% (Trieste, 25,72%) ma nei restanti tre ha
superato il 30% (Roma 48,3%; Torino 33,5%;
Bologna 42,8%). In sintesi: nel 50% dei casi
l'incremento è stato superiore al trenta per cento,
mentre nel periodo 1993-2013 ciò era avvenuto solo
nel 36,4% dei ballottaggi. Prima di analizzare i
rendimenti dei candidati nelle città, è opportuno
partire da un dato generale che ha influenzato
l'intera competizione del 2016: l'offerta politica è
stata multipolare. Gli effetti si sono visti: non
91
abbiamo avuto più soltanto ballottaggi solo fra
centrosinistra e centrodestra, ma soprattutto siamo
passati da una situazione di sei comuni su sette al
centrosinistra (tranne Napoli dove nel 2011 era
stato eletto De Magistris) a un quadro "arcobaleno"
(Bologna, Milano e Cagliari al centrosinistra, Roma
e Torino al M5S, Trieste al centrodestra, Napoli di
nuovo a De Magistris). La particolarità di ciascun
ballottaggio ha perciò determinato il recupero (o
meno) dei voti dei candidati esclusi e avuto
ripercussioni persino sull'affluenza alle urne. Se
infatti prendiamo per base il dato complessivo dei
sei comuni capoluogo di regione dove si è votato il
19 giugno, vediamo che l'affluenza è passata dal
55,8% del primo turno al 49% del secondo. Il calo
del 6,8% non è però omogeneo, perchè a Milano e
Torino (dove la partita era molta aperta e
combattuta) è stato del 2,8%, mentre a Roma,
Trieste e Bologna la diminuzione è stata del 6-6,5%
e a Napoli è stata addirittura del 18,2%. Non è un
caso, perchè la competizione nel capoluogo
campano aveva alcune caratteristiche peculiari: 1)
non c'era in lizza un candidato del Pd (quindi gli
92
esclusi non potevano votare "contro Renzi"); 2) le
forze escluse dal ballottaggio avevano elettorati
poco compatibili con i candidati giunti al secondo
turno (la distanza fra il Pd e De Magistris è
notevole, mentre per un elettore del M5S può
essere apparso inutile andare alle urne per un
ballottaggio che era la fotocopia di quello del
2011); 3) i Cinquestelle normalmente ricevono voti
dal centrodestra in funzione anti Pd ma non
"ricambiano il favore" quando il proprio candidato
non è in ballottaggio; 4) fra i voti raccolti da De
Magistris e Lettieri al primo turno (circa 270mila, il
34,21% sugli aventi diritto) e quelli del secondo
(278mila, il 35,28%) c'è una differenza minima (del
resto, al primo turno i due avevano raccolto il
66,8% dei voti contro il 66% del primo turno 2011);
5) a Napoli la vittoria di De Magistris era data per
scontata da molti, al punto tale che la
mobilitazione fra primo e secondo turno è stata
scarsa: il sindaco uscente ha guadagnato 13mila
voti e il suo sfidante ne ha addirittura persi 4mila.
Nel capoluogo campano, dunque, era difficile
ipotizzare un esito diverso da quello che si è
93
puntualmente verificato. Per quanto riguarda il
quadro generale dei sei ballottaggi, è interessante
notare che il rendimento dei candidati di
centrosinistra è stato leggermente inferiore (in
valore percentuale sui voti espressi) in confronto al
primo turno, così com'è accaduto a quelli di
centrodestra, mentre le due candidate del M5S
(Raggi e Appendino) hanno avuto un rendimento
di gran lunga superiore rispetto al 5 giugno
(l'afflusso – soprattutto dal centrodestra - è stato
dunque non marginale). Affrontato il "caso Napoli"
(che, come abbiamo visto, riguardava un confronto
molto particolare ed escludeva sia il Pd, sia il M5S)
restano gli altri cinque capoluoghi di regione, che
possiamo dividere in due gruppi a seconda del
tipo di competizione: da un lato Roma e Torino
(Pd contro M5S) e dall'altro Milano, Trieste e
Bologna (Pd-centrosinistra contro centrodestra). La
Capitale e il capoluogo piemontese hanno in
comune una forte rimobilitazione degli elettori
"esclusi": a Roma Raggi e Giachetti ottengono
insieme 1.147mila voti contro i 774mila del primo
turno e il milione e 287mila di tutti i candidati del 5
94
giugno; a Torino Appendino e Fassino conquistano
371mila consensi contro i 278mila del primo turno
e i 382mila di tutti i concorrenti del 5 giugno. La
differenza di risultato fra Fassino e Giachetti sta in
due fattori: il primo era sindaco uscente in un
quadro cittadino in cui il Pd è ancora abbastanza
radicato (al primo turno, il partito torinese e le liste
riconducibili al candidato hanno ottenuto il 34%,
mentre quello romano si sono fermate intorno al
23%; nel complesso, la "coalizione Fassino" ha
avuto il 5 giugno il 41,9% dei voti, mentre la
"coalizione Giachetti" è arrivata solo al 25,4%); in
secondo
luogo,
Roma
veniva
da
un
commissariamento (drammatico) del comune e
Torino no. Le due candidate del M5S hanno fatto
registrare una performance non dissimile: Raggi, a
Roma, ha guadagnato 317mila voti al secondo
turno mentre Giachetti ne ha ottenuti solo 56mila
più del 5 giugno; Appendino, a Torino, ha
incrementato i propri consensi di 84mila unità
contro le 8.800 di Fassino. La sproporzione,
l'astensionismo aggiuntivo non alto a Roma e
decisamente basso a Torino hanno fatto il resto,
95
unitamente ad una confluenza sui Cinquestelle
dell'elettorato
"escluso"
(soprattutto
di
centrodestra) che è stata evidente e marcata. Del
resto, in 20 ballottaggi comunali nei centri
maggiori
(tutti
con
un
avversario
del
centrosinistra), il M5S ne ha vinti 19, mentre in
quelli fra centrosinistra e centrodestra non c'è stata
una tendenza così forte "contro" i candidati del
partito di Renzi (anche se, sui 25 capoluoghi di
provincia dove si è votato, il Pd è passato dal 20
comuni amministrati a 8, il centrodestra da 4 a 10 e
il M5S da zero a 3). Nei tre capoluoghi di regione
(Milano, Bologna, Trieste) dove i Cinquestelle non
erano in ballottaggio (e la competizione era quella
tradizionale
della
Seconda
Repubblica:
centrosinistra contro centrodestra) il Pd conferma
due comuni su tre, mancando per poco la rimonta
a Trieste. A Milano - dove peraltro il M5S aveva
avuto un risultato modesto al primo turno - il
candidato del centrosinistra Sala ha ottenuto
40mila voti in più rispetto al 5 giugno, mentre
l’esponente del centrodestra Parisi ne ha
guadagnati solo 28mila. A Trieste il sindaco
96
uscente Cosolini ha guadagnato 12mila voti sul
primo turno, mentre il suo predecessore (e
successore) Dipiazza ne ha raccolti appena
cinquemila. Milano e Trieste confermano dunque
la vecchia tendenza dei candidati di centrosinistra
al miglioramento delle posizioni, al ballottaggio.
Bologna, infine, è un caso un po' diverso: il sindaco
uscente (e confermato) Merola ha ottenuto al
secondo turno 15mila voti in più rispetto al 5
giugno, ma la leghista Borgonzoni ne ha
conquistati circa 31mila (69660 contro i 38806 del
primo turno). In questo caso la personalità della
candidata e il fatto che fosse esponente di un
partito (quello di Salvini) che aveva dato a Torino e
Roma un sostanziale "sostegno morale" alle
candidate dei Cinquestelle può aver aiutato
l'esponente del centrodestra a tentare una rimonta
che però si è rivelata impossibile. Da sottolineare,
inoltre, che nei tre casi di confronti bipolari
“tradizionali” il centrodestra si è presentato in
formazione unita (laddove non l’ha fatto, come a
Roma e Torino, non ha avuto candidati al
ballottaggio) e che la percentuale più bassa di voti
97
fra i tre esponenti della coalizione a Milano, Trieste
e Bologna è stata ottenuta dalla Borgonzoni, unica
rappresentante dell’ala “lepenista” (Dipiazza e
Parisi si possono invece ascrivere a quella
“popolare” che fa riferimento al PPE).
L'impressione, nel complesso, è che l’esito dei
ballottaggi abbia avuto molte motivazioni locali e
personali, ma che sullo sfondo sia emersa una
tendenza (quella dei Cinquestelle a ricevere voti
dal centrodestra ma non a darne in cambio, se non
in casi limitati e marginali) sulla quale i partiti - in
primo luogo il Pd - dovrebbero riflettere in vista
della prima attuazione dell'Italicum (la legge
elettorale per Montecitorio) che prevede un
eventuale ballottaggio fra le due liste più votate se
nessuno supera il 40% dei voti al primo turno.
98
Comunali, i voti ai partiti
(Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, Cagliari)
99
Quaderno di
@Mentepolitica14
Edito nel mese di giugno 2016
100