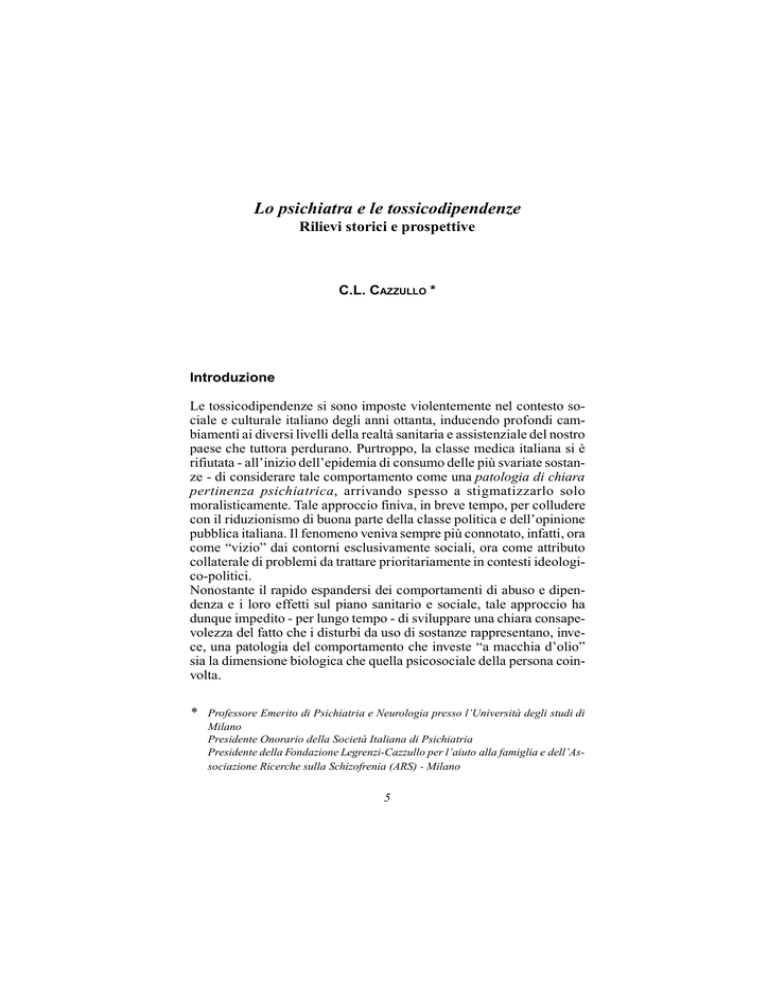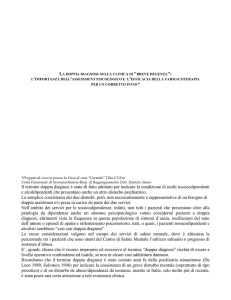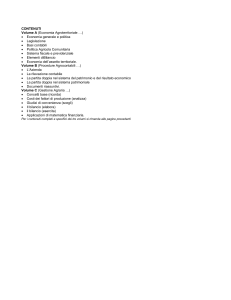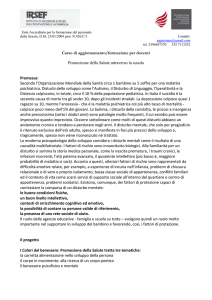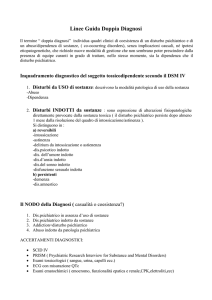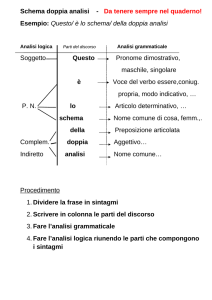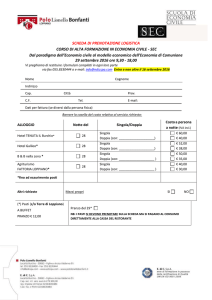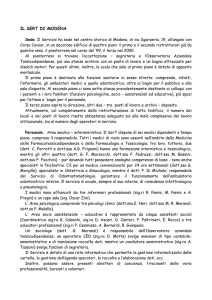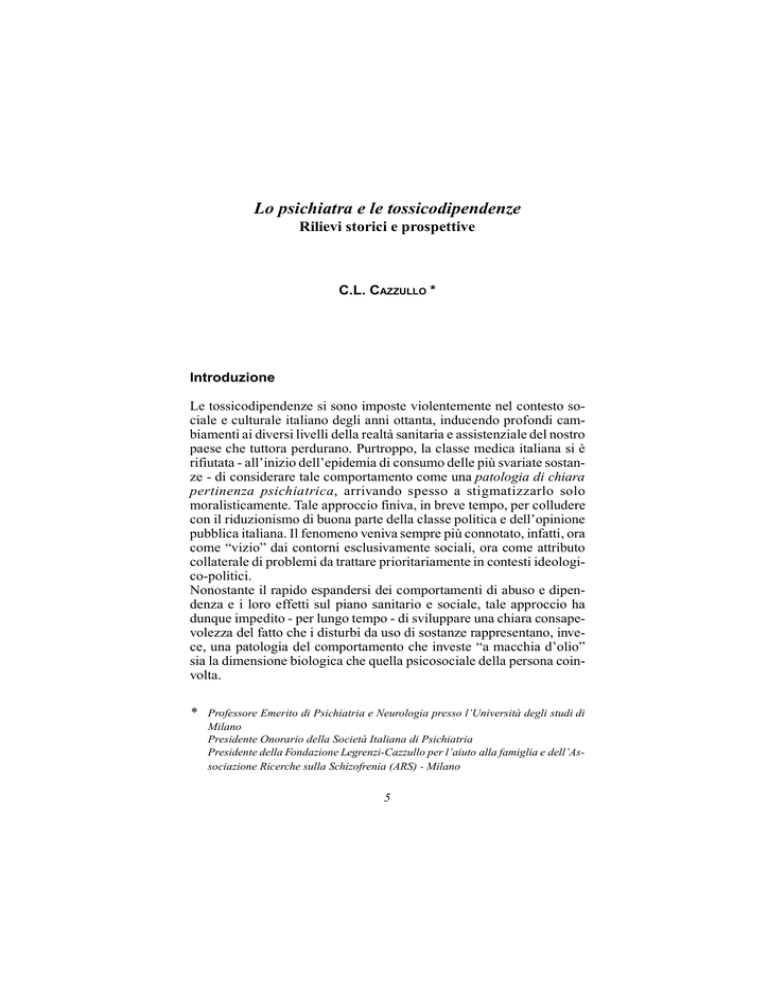
Lo psichiatra e le tossicodipendenze
Rilievi storici e prospettive
C.L. CAZZULLO *
Introduzione
Le tossicodipendenze si sono imposte violentemente nel contesto sociale e culturale italiano degli anni ottanta, inducendo profondi cambiamenti ai diversi livelli della realtà sanitaria e assistenziale del nostro
paese che tuttora perdurano. Purtroppo, la classe medica italiana si è
rifiutata - all’inizio dell’epidemia di consumo delle più svariate sostanze - di considerare tale comportamento come una patologia di chiara
pertinenza psichiatrica, arrivando spesso a stigmatizzarlo solo
moralisticamente. Tale approccio finiva, in breve tempo, per colludere
con il riduzionismo di buona parte della classe politica e dell’opinione
pubblica italiana. Il fenomeno veniva sempre più connotato, infatti, ora
come “vizio” dai contorni esclusivamente sociali, ora come attributo
collaterale di problemi da trattare prioritariamente in contesti ideologico-politici.
Nonostante il rapido espandersi dei comportamenti di abuso e dipendenza e i loro effetti sul piano sanitario e sociale, tale approccio ha
dunque impedito - per lungo tempo - di sviluppare una chiara consapevolezza del fatto che i disturbi da uso di sostanze rappresentano, invece, una patologia del comportamento che investe “a macchia d’olio”
sia la dimensione biologica che quella psicosociale della persona coinvolta.
* Professore Emerito di Psichiatria e Neurologia presso l’Università degli studi di
Milano
Presidente Onorario della Società Italiana di Psichiatria
Presidente della Fondazione Legrenzi-Cazzullo per l’aiuto alla famiglia e dell’Associazione Ricerche sulla Schizofrenia (ARS) - Milano
5
Le conseguenze di un approccio al fenomeno
La patologia da comportamento tossicomanico, e la rapida progressione degli effetti negativi dell’uso di sostanze sull’unità soma-psiche, si
manifesta drammaticamente nel continuo deteriorarsi dei rapporti sia
con la sostanza, sia con l’ambiente circostante - in primis la famiglia.
Ne consegue la necessità, quindi, di un intervento radicale - specifico e
specialistico - che tenga conto di tutti i fattori interagenti e delle conseguenze che mano a mano si evidenziano e, soprattutto, si complicano
col passare del tempo.
I limiti dell’approccio alle dipendenze testé citati hanno prodotto gravi
ritardi nello sviluppo di quelle competenze professionali che ci derivano dai risultati scaturiti dalla ricerca scientifica condotta a livello internazionale nel campo dei disturbi da uso di sostanze, sia in relazione
agli aspetti neuropsicobiologici dell’interazione “droga-cervello”, sia
per quanto riguarda la classificazione diagnostica delle patologie
correlate.
Sotto la pressione di un’opinione pubblica sostanzialmente disinformata,
anche il necessario approfondimento sul tema delle molteplici modalità di trattamento a disposizione si è rivelato un’occasione perduta per
quanto riguarda la possibilità di valorizzare il ruolo della psichiatria e
dello psichiatra in quest’area.
Oggi, forse, tale percorso comincia a subire una lenta revisione: ciò sta
avvenendo soprattutto in relazione all’interesse crescente per la
comorbidità psichiatrica nelle tossicodipendenze - la cosiddetta «doppia diagnosi» - che porta inevitabilmente ad un più serrato riconoscimento del ruolo che la psicopatologia svolge primariamente nell’induzione del ricorso alle sostanze con modalità spesso autocurative di altre sofferenze o, sull’altro versante, che le sostanze svolgono nel sollecitare la vulnerabilità individuale ad esprimersi come disagio psichico.
L’istituzione dei Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) - e la loro
collocazione all’interno del Sistema Sanitario Nazionale - ha portato
sempre più gli operatori a confrontarsi con tali problemi recuperando,
almeno parzialmente, la necessità di arrivare ad una primaria diagnosi
psicopatologica della tossicodipendenza (fino a pochi anni fa dai più
negata radicalmente!) e ad istituire protocolli diagnostico-clinici coerenti con la nosografia internazionale attualmente a disposizione in
campo psichiatrico (vedi l’impiego massiccio del DSM IV in tutti i
campi della sofferenza psichica!).
L’assenza, fino ad oggi, di un preciso iter formativo - sia a livello preche post-laurea - non facilita di certo la formazione degli operatori sa6
nitari e psicosociali inseriti in questi anni nei Servizi per le
Tossicodipendenze.
L’istituzione, anche in Italia, di una sottodisciplina che assimili la Medicina e la Psichiatria delle Dipendenze («Addiction Psychiatry», secondo la terminologia dell’Associazione Americana di Psichiatria APA) potrebbe rappresentare - in analogia con quanto avviene in altri
paesi - un’acquisizione importante. Tuttavia, resta ancora da definire
se il paradigma di tale branca debba essere interdisciplinare o squisitamente psichiatrico.
Alcune riflessioni in tema di “risposte al fenomeno”
La complessità e la vastità del fenomeno richiede, in questo campo, un
riconoscimento costante dell’importanza e della validità di interventi
anche non strettamente inquadrabili nella prassi psichiatrica.
Il contributo delle comunità terapeutiche, del privato sociale “no profit”
e del volontariato che operano nelle più diverse realtà della
tossicodipendenza, ha infatti allargato la dimensione terapeutica su
confini dove le distanze tra intervento sanitario e intervento socio-assistenziale sono meno definite e i luoghi della terapia meno esclusivi.
Le diverse tecniche di trattamento a disposizione - da quelle
farmacologiche a quelle psicoterapeutiche a quelle psicosociali e
riabilitative - non sono infatti più identificabili come modelli rigidi
erogabili esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale, ma piuttosto come strumenti che, di volta in volta, possono essere adattati al
progetto terapeutico necessario per ogni singolo paziente e realizzati
da protagonisti diversi, meglio se in collaborazione tra loro. Inoltre, la
messa in opera di risposte complesse e il più possibile integrate segue a
distanza ravvicinata l’emergere o il consolidarsi di nuovi fenomeni:
basti ricordare, a questo proposito la diversificazione delle
problematiche avvenuta nel corso degli ultimi venti anni e conseguente:
- ora alla comparsa delle patologie HIV-correlate,
- ora alla crescita e all’estendersi del consumo di droghe sintetiche a
basso costo,
- ora allo sviluppo di nuove forme di dipendenza (gioco d’azzardo,
dipendenze alimentari o altri disturbi nell’area dell’impulsività, etc.).
Le esigenze di un più corretto impiego delle risorse finanziarie a disposizione per la sanità e l’assistenza, nonché percorsi organizzativi dei
Servizi maggiormente improntati alla professionalità e alla qualità del7
le prestazioni erogate sembrano facilitare, oggi, il recupero della dimensione clinica e terapeutica della psichiatria in questo campo.
Un solo esempio può valere per tutti: la rilevante esperienza compiuta
dall’area della riabilitazione psichiatrica, con tutto il patrimonio che
questo filone ha potuto rappresentare nel corso dell’ultimo ventennio,
ben si colloca come paradigma di riferimento anche per il settore delle
tossicodipendenze.
Inoltre, il contributo che la ricerca scientifica in ambito psichiatrico
può dare al miglioramento progressivo dell’area delle tossicodipendenze
si rivela fondamentale per non ripetere errori che la psichiatria ha affrontato con fatica - e poi risolto - e che le tossicodipendenze non dovrebbero certo ripercorrere.
Tra i settori più importanti da sviluppare oggi in questo campo non si
possono trascurare:
a) Le problematiche inerenti la prevenzione dei comportamenti «a rischio»: oltre ai tossicodipendenti, sono soprattutto i pazienti psichiatrici più gravi - in primis, gli psicotici e i bipolari - a risultare
oggi particolarmente vulnerabili all’assunzione delle sostanze.
b) L’attenzione specifica ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza
come terreno primario di sofferenza e di frequente induzione di precoci avvicinamenti alle sostanze.
c) Uno studio attento delle interazioni fra trattamenti: medici (sostitutivi o antagonistici), infettivologici e psicofarmacologici destinati
al controllo della sintomatologia psichiatrica nelle condizioni di
comorbidità.
d) Il ruolo sempre più centrale della famiglia come risorsa nella terapia
e nella prevenzione a lungo termine delle ricadute.
Conclusioni
Le risorse da mettere in gioco nella parziale riformulazione, e nel rafforzamento, dell’approccio “medico-psichiatrico” alle dipendenze sono
molteplici, ma i vantaggi di tale sviluppo sono indiscutibili.
In primo luogo, ne potrà derivare un contributo importante allo sviluppo di quella identità culturale degli operatori dei SerT necessaria ad
una disciplina che, legittimata sul piano normativo dalle leggi di costituzione dei Servizi per le Tossicodipendenze, ancora manca di un solido impianto dottrinario, sia nei suoi aspetti teorici che operativi.
Secondariamente, una più solida professionalizzazione degli operatori
e dei Servizi non potrà che ricadere a beneficio dei pazienti che soffro8
no di questi disturbi e che, a tutt’oggi, vedono ancora troppa disparità
nelle opportunità messe a loro disposizione.
Infine, certamente la tossicodipendenza rappresenta oggi un’area aperta a molteplici contributi, ma sembra che essa domandi allo psichiatra
soprattutto una serie di risposte forse maggiore rispetto ad altre discipline limitrofe: sono sicuro che, in cambio, ne potrà ricevere un arricchimento di particolare spessore e di inesauribile valore clinico.
9
10
Psichiatria delle dipendenze
Un problema ancora irrisolto
M. CLERICI * - G. CARRÀ **
1. L’approccio al tema della comorbidità psichiatrica nei disturbi
correlati a sostanze - altrimenti detto “doppia diagnosi” - è rappresentativo di una realtà operativa e gestionale profondamente diversificata
a livello di singole nazioni, se visto da un punto di osservazione internazionale.
Il taglio dato alla gestione del fenomeno valorizza infatti ora una dimensione squisitamente psichiatrica del tema (assetto statunitense) con
espliciti supporti reperiti nell’area dell’auto-mutuo-aiuto di matrice AA,
ora una visione generalista che attribuisce competenze e risorse, rinforzandole operativamente, alla medicina di base (assetto inglese), ora
una visione di servizio specialistico abbastanza slegata da aree disciplinari che si declina più in funzione del bacino di utenza selezionato o
delle aree di disturbo privilegiate che di una appartenenza ad uno specifico sistema dei Servizi.
Su tale complessità di soluzioni fanno perno poi le differenze orientate
dal management - sanitario o/e assistenziale - cui è attribuito il
reperimento e la dislocazione delle risorse che “mantengono” il sistema o la redistribuzione del carico dei costi di utenti che vengono inevitabilmente a collocarsi “on the border” tra sistemi dei Servizi diversi
(area della medicina specialistica, della psichiatria o delle dipendenze,
senza voler citare i servizi sociali spesso così ampiamente coinvolti!).
In tale dimensione la scelta di un sistema pubblico, di uno totalmente
privatizzato (per di più se sostenuto da pacchetti assicurativi) o di una
area mista (pubblico-privato profit accreditato o pubblico-privato no
*
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Polo Didattico AO San Paolo, Università degli studi di Milano
** Dipartimento di Scienze Sanitarie Applicate e Psicocomportamentali, Sezione di
Psichiatria, Università di Pavia
11
profit, accreditato o meno) complica ulteriormente la possibilità di
mettere a confronto sia le singole esperienze, sia il funzionamento complessivo dei sistemi, sia - soprattutto - i risultati che le singole esperienze o gli specifici sistemi di intervento mettono a disposizione.
A tutt’oggi tali confronti possono avvenire soltanto, ma risulta già un
obiettivo di grande valore scientifico ed esperienziale, sui dati
epidemiologici, sui protocolli di assessment, di diagnosi e di trattamento, su eventuali linee-guida operative e gestionali, nonché sulle ricerche di follow-up a medio-lungo termine.
La realizzazione e il mantenimento, costante nel tempo, di iniziative di
confronto su tali temi, ma anche la realizzazione di ricerche a carattere
multicentrico possibilmente longitudinali sembrano poter offrire un
contributo rilevante alla conoscenza reciproca tra operatori di paesi diversi e alla messa in comune degli elementi più validi e funzionali alla
crescita di un sistema europeo di intervento altamente professionale.
2. Anche in Italia il problema della comorbidità tra disturbi correlati a
sostanze e altri disturbi psichiatrici è un tema che sta assumendo una
rilevanza epidemiologica, clinica e gestionale estremamente ampia e
in grado di coinvolgere culture operative differenti ed ambiti organizzativi molto diversi. Nel nostro paese, l’area delle tossicodipendenze
in senso lato - proprio a partire dal problema della comorbidità - ha
visto uno sviluppo rallentato e ha mostrato, nel contempo, rilevanti
limiti operativi a differenza di altre realtà europee, più omogenee nell’approccio al fenomeno, ma anche nello sviluppo di Servizi qualificati.
La “diversità” italiana può essere spiegata soprattutto con motivazioni
storiche e il nostro paese, che pure ha un sistema dei Servizi e una
quantità di operatori che mostra pochi rivali nel mondo intero, ha prodotto a tutt’oggi una ridotta quantità di ricerche epidemiologico-cliniche sul fenomeno vivendo - sul piano gestionale - una netta dicotomia
tra sistema di salute mentale e sistema delle dipendenze.
Ciò si esprime nelle difficoltà di dialogo e di progettazione comune tra
Servizi appartenenti a sistemi terapeutico-organizzativi differenti o alla
posizione assunta dalle Comunità Terapeutiche private nel sistema di
intervento complessivo sulle droghe in Italia.
Proprio a questo proposito, basti pensare al ruolo vicario che la costellazione delle comunità terapeutiche ha avuto in Italia rispetto al sistema dei Servizi pubblici fino alla metà degli anni novanta e che solo
recentemente ha visto definire, in molte regioni, degli specifici criteri
per l’accreditamento delle strutture private convenzionabili.
12
Nel contempo il sistema pubblico è passato dall’organizzazione in servizi ambulatoriali ad una dimensione dipartimentale in grado di gestire
unità operative differenti, progettare programmi sanitari, assistenziali
e di prevenzione, interfacciarsi con altri Dipartimenti, in primis la salute mentale, che concorrono alla gestione di utenti così spesso complessi e multiproblematici.
I confini con le realtà europee si stanno dunque assottigliando sia in
relazione alla disponibilità di un sistema professionalizzato e orientato
al controllo di gestione e alla verifica dei risultati e dei costi, sia in
rapporto ad un più forte imprinting verso l’assessment, la diagnosi strutturata, il monitoraggio dei percorsi terapeutici e la misurazione di efficacia dei trattamenti.
Alcuni di tali obiettivi si scontrano ancora con criticità organizzative,
con aspetti di rigidità del sistema, con difficoltà ad assorbire e valorizzare competenze diversificate o con limiti importanti nel reperimento
delle risorse, ma l’attuale dibattito in corso a livello politico e amministrativo può, senza dubbio, contribuire ad una accelerazione del processo in corso e ad una rimodulazione degli aspetti di sofferenza che
ancora si manifestano.
3. La Società Italiana di Psichiatria delle Dipendenze (SIP.Dip) si pone
attivamente - dal momento della sua costituzione come Sezione Speciale della Società Italiana di Psichiatria (SIP) nel 1989 - in questa
dimensione di confronto e di apertura alle realtà qualificate degli altri
paesi.
Contribuiscono a rafforzare tale orientamento l’adesione agli statuti e
alle linee operative delle Società gemelle in ambito europeo (Section
on Addiction Psychiatry dell’Association of European Psychiatrists –
AEP) e mondiale (Section on Addiction Psychiatry della World
Psychiatry Association – WPA), laddove i rapporti instaurati tra Società hanno permesso, e potranno offrire in futuro, una sempre maggiore
uniformità di proposizioni sul tema comune e un aggiornamento professionale e scientifico agli operatori italiani che si muovono nel campo della psichiatria delle dipendenze o della comorbidità psichiatrica
dei disturbi correlati a sostanze.
Gli Atti dell’ultimo Congresso Nazionale della SIP.Dip tenutosi a Milano nel luglio 2002 - e che proponiamo in tre tranches orientate al
dibattito generale, alle esperienze cliniche nel nostro paese e al panorama europeo - presentano una riflessione ad ampio spettro sul tema ed
una serie di considerazioni trasversali a Servizi diversi, nonché a realtà
geografiche non sempre sovrapponibili.
13
Editando questo insieme di contributi come volumi monografici di
Salute e Pevenzione, una delle storiche riviste di area a disposizione
degli operatori delle tossicodipendenze, la nostra Società vuole continuare a proporsi come mediatore di eventi culturali e scientifici, a tutto
vantaggio dei più diversi ruoli professionali operanti nel sistema dei
Servizi italiani, radicandosi peraltro, sempre maggiormente, nel terreno della sperimentazione di modelli e di strategie in grado di valorizzare in lavoro terapeutico e gli orientamenti peculiari della psichiatria
delle tossicodipendenze.
14
Doppia diagnosi
I cambiamenti e le integrazioni necessarie
nei servizi e nel loro assetto clinico
GIUSEPPE MAMMANA *
Molti cambiamenti, come spesso è avvenuto negli ultimi dieci anni,
sono stati annunciati nel difficile campo di cui ci occupiamo: quello
delle dipendenze patologiche. Pochi cambiamenti sono stati reali e
positivi tanto da riuscire a portarci fuori della marginalità clinica e dalla scarsa considerazione del problema psicopatologico. Ogni cambiamento vero in un sistema, come sappiamo, presuppone quanto meno
una ridefinizione degli obiettivi ed uno spostamento di risorse da una
direzione verso un altra. Poiché vi è un periodo intermedio nel quale il
sistema stesso non può cessare di dare le risposte che dava in precedenza e tuttavia deve avviare i cambiamenti. In questo periodo intermedio è spesso richiesto un investimento di risorse aggiuntivo, integrativo, finalizzato ad avviare i cambiamenti e limitato nel tempo.
Nel nostro campo la ridefinizione degli obiettivi ha avuto il seguente
significato: si riteneva, e noi siamo tra i sostenitori di questa ipotesi,
che negli ultimi anni si fosse generato un evidente squilibrio tra le risorse investite nel contenimento del fenomeno con la strategia definita
di “riduzione del danno” o della “bassa soglia” e quelle investite nelle
cure finalizzate alla riabilitazione ed al reinserimento dei tossicodipendenti che scelgono un percorso terapeutico. Si confrontano e si scontrano due modi di leggere il fenomeno e le risposte ad esso, alle quali
forse appartiene una parte di verità scientifica ma che tuttavia non trovano ancora il giusto modo di definire i loro spazi di riconoscimento
reciproco, interazione ed integrazione. Per stare alle parole-chiave si
potrebbe dire che oggi si passa dalla riduzione del danno alla riduzione
della cronicità. L’obiettivo è ambizioso e richiede sforzi, impegno e
strumenti non leggeri e soprattutto occorre un buon periodo di tempo
per le necessarie operazioni strutturali di modifica del sistema di inter*
Dipartimento Dipendenze ASL Foggia
15
venti. Se nel recente passato l’interesse prevalente sembrava quello
minimalista del ridurre il danno, nell’attualità sembrano essere presenti all’interno della ipotesi della riduzione della cronicità due orientamenti non necessariamente sempre sintonici come non necessariamente sempre contrapposti.
Vi è chi ritiene che un intervento più incisivo dello Stato in questa
materia passi anzitutto per una svolta giuridico-legislativa costruita sulla
base della pericolosità delle droghe, di ogni droga e che riproponga
l’ipotesi proibizionista e, quindi, la logica della dissuasione amministrativo-giudiziaria. Vi è chi ritiene, pur non essendo di principio contrario a iniziative di legge sul tema della pericolosità delle droghe, che
ogni svolta di questo genere da sola non produca nulla di buono ed anzi
riproponga l’altalena infinita del confronto tra legalizzatori e
proibizionisti che scarsi vantaggi ha arrecato alla cura concreta di questo male nel corso dell’ultimo ventennio.
È inutile dire che noi siamo tra quanti ritengono che la vera svolta
necessaria sia quella da dedicare alla cura clinica di questa malattia (la
quale va finalmente riconosciuta come tale), finalizzando ogni sforzo
possibile alla cura clinica della persona. Per questo riteniamo che la
parola chiave “riduzione della cronicità” debba essere non un proclama ideologico ma soltanto un contenitore di specifici interventi clinici
e sociali nel nostro campo.
La modificazione dello statu-quo e la produzione di risposte efficaci in
questo campo è dunque “conditio sine qua non” perché si possa parlare
di riduzione della cronicità. A nostro avviso esiste una quota di cronicità
che è prodotta dalle risposte inefficaci sinora disponibili in questo campo
e, tuttavia, non è possibile proporre una evoluzione della situazione se
non si eleva la capacità operativa dei servizi nella motivazione dei clienti
e nella disponibilità di strumenti adeguati per l’osservazione, la diagnosi e la disintossicazione finalizzata ai percorsi riabilitativi. Cercheremo di illustrare il nostro punto di vista sugli interventi che ci pare
necessario sviluppare a partire da queste premesse.
Cominciamo con la questione della disintossicazione
A noi pare un assurdo logico che, nel campo dove regna sovrana la
condizione di intossicazione, questo aspetto degli interventi non sia
curato più di tanto. Probabilmente in questo conta un pregiudizio culturale e scientifico che fonda le culture operative presenti nel campo:
16
quella biopsicosociale, propria del personale pubblico delle ASL e degli Enti locali, e quella educativa etico-affettiva del volontariato.
La prima cultura (ASL, enti locali, ecc..) spinge nella direzione degli
interventi tecnicamente fondati, utili ma non sufficienti perchè a nostro
avviso sottovaluta ampiamente la sfera educativa e dello stile di vita il
cui degrado accompagna costantemente le tossicodipendenze e nella
cui revisione terapeutica non basta l’intervento puramente clinico. La
seconda cultura (volontariato) spinge nella direzione degli interventi
fondati sulla educazione e sulla modificazione dello stile di vita, ma
spesso ha sottovalutato gli aspetti psicopatologici delle personalità che
accompagnano le tossicodipendenze. Questi ultimi forse non sempre
possono cambiare, ma di essi il tossicomane deve comunque prendere
conoscenza (se non vuole ricadere all’infinito nella sua condizione tossica) in un ambito non solamente educativo ma più specificamente
clinico biopsicosociale.
La contrapposizione spesso radicale di queste culture, ed il mancato
riconoscimento dell’una da parte dell’altra e viceversa, sono in parte
responsabili degli esiti minimi degli interventi in questo campo.
Nell’area della disintossicazione la sopravvalutazione della questione
clinica, in questo caso spesso solo farmacologica, ha portato alla realizzazione di interventi fini a sé stessi, incapaci di proporre percorsi di
cambiamento significativi ed adeguati alla gravità della patologia e/o
del comportamento di cui ci occupiamo. È il caso dell’UROD o delle
terapie brevi americane che non hanno prodotto significativi esiti in
termini di cure riabilitative.
All’opposto la sopravvalutazione educativa etico affettiva della questione della disintossicazione portata dalla cultura dei volontari ha, al
contrario, sottodimensionato dal punto di vista clinico ogni serio intervento finalizzato a definire almeno in parte nei nostri pazienti gli effetti
biologici e psichici preesistenti all’uso di droghe e quelli devastanti
prodotti dall’uso di sostanze attive sul sistema nervoso centrale. In tal
caso purtroppo si è ritenuto, anche inconsapevolmente, che la comprensione dei problemi psicopatologici fosse secondaria e che queste
sostanze fossero così poco efficaci sul sistema nervoso centrale da poter essere dimenticate con un semplice sforzo della volontà. Così non
è, e questa lettura della intossicazione ha prodotto “il tacchino freddo”,
“la disintossicazione a crudo”, i semplici accompagnamenti affettivi e
tutoriali ad un problema che ha fondate (e dimostrate) radici anche
biologiche e psichiche.
La possibilità, da parte di un centro di accoglienza pubblico o privato,
di essere efficaci su questo terreno si basa essenzialmente su due qua17
lità: la capacità di lavorare sulla motivazione e la capacità di orientare
a percorsi ben strutturati in cui la disintossicazione ben realizzata rappresenta il primo tassello e mostra al cliente ed alla sua famiglia la
reale coerenza e potenza del servizio di accoglienza ed orientamento.
Purtroppo oggi non è così poiché essa avviene spesso in luoghi e con
modi inadeguati come:
- In reparti ospedalieri che non accettano tali pazienti e nei quali i
nostri pazienti alterano con i loro comportamenti i delicati equilibri
interni dei reparti stessi (peraltro non addetti in modo specifico a
questa patologia e spesso poco competenti in merito).
- In comunità terapeutiche dove viene esaltato l’aspetto tutoriale, ma
sottovalutato quello medico – biologico e psicosociale.
- Con modalità che spesso sottovalutano le attuali risorse della
farmacologia che, ben utilizzate, potrebbero contenere fortemente
gli aspetti biologici della intossicazione e della dipendenza
(disintossicazione rapida, farmaci anticraving ecc..).
- Con modalità che (soprattutto nei reparti ospedalieri) ignorano il
necessario collegamento temporale e progettuale della disintossicazione con la successiva fase riabilitativa e che, quindi, non strutturano sin dall’inizio una copresenza degli strumenti medici e psicologici con gli strumenti educativo affettivi propri della successiva
riabilitazione psicosociale.
Un altro campo di interesse e di rivalutazione della lettura clinica e
psicopatologica della tossicodipendenza è costituito dai centri diurni
drug-free a media ed alta soglia. Si pensa, a nostro avviso erroneamente, che la fase riabilitativa possa essere condotta soltanto in due maniere: dentro la comunità residenziale (dove è accolto in condizioni drugfree il maggior numero di pazienti collocati in tale fase) o nei Ser.T.
(dove spesso i pazienti sono avviati a percorsi pseudo riabilitativi nei
quali di fatto si promuove un uso “controllato” di sostanze stupefacenti
e droghe legali ed illegali e la compresenza, talora, di attività riabilitative
di tipo sociale come borse lavoro ecc).
I centri diurni drug-free, che rientrano nel nostro campo di attenzione,
possono esistere con almeno tre o quattro finalità:
- essi, anzitutto, sono uno strumento di osservazione, diagnosi e, sostanzialmente, di passaggio verso percorsi più strutturati in una fase
nella quale il tossicomane ancora non è del tutto motivato al cambiamento;
- essi possono svolgere poi una vera ed autonoma funzione riabilitativa
per vari casi personali e familiari nei quali non tutto è destrutturato
nella famiglia e nel lavoro, la tipologia delle sostanze usate è parti18
colare (cocaina, stimolanti, cannabis, ecc..) e non vi è disponibilità
o possibilità per un allontanamento radicale dal luogo di vita;
- essi possono diventare luogo di prevenzione della “ricaduta” dopo
la fase residenziale della riabilitazione, soprattutto nei casi nei quali
la possibilità della recidiva appare come una potenzialità fortemente prossima alla realtà;
- essi possono diventare luogo di “riflessione” per quei tossicomani
che non reggono i percorsi residenziali, ne escono e per periodi transitori vivono questa incapacità come abbandono e disperazione o
impossibilità per il loro futuro senza possibilità di impegno alternativo.
Complessivamente essi costituiscono strutture intermedie tra lo spazio
troppo piccolo dell’ambulatorio del Ser.T. e quello assai più impegnativo della comunità terapeutica residenziale. In questa funzione intermedia non soltanto non comprimono Ser.T. e Comunità terapeutiche,
ma ne potenziano le capacità e ne legano gli interventi
Queste riflessioni fanno comprendere quanto questo strumento possa
essere importante, nell’insieme di interventi dedicati al settore, proprio
per colmare quei vuoti che inevitabilmente si producono nella risposta
a questa patologia (tra il tutto della comunità terapeutica ed il poco
dell’ambulatorio) e per lavorare fortemente sulla motivazione ad intraprendere significativi percorsi riabilitativi.
Nonostante queste qualità, tuttavia, questi interventi intermedi sembrano diminuire fortemente proprio negli ultimi anni: perché? Anzitutto perché, pur essendo così importanti, i centri intermedi a carattere
diurno costituiscono un intervento clinicamente impegnativo.
Noi riteniamo che su questo abbia inciso fortemente il generale clima
culturale orientato alla ipotesi minimalista della riduzione del danno
che ha fortemente demotivato utenti ed operatori rendendo minimamente interessati alle cure gli uni ed al campo clinico gli altri. Tuttavia
anche fattori di carattere tecnico hanno inciso non poco in questo ridimensionamento degli interventi diurni drug-free.
Vi è un problema di qualità nei programmi diurni e semiresidenziali
che è insito nella stessa natura di questi interventi.
Il loro carattere semiresidenziale, e spesso urbano, da un lato è un segnale forte di qualità e civiltà degli interventi ed essi stessi, per il solo
fatto di esistere nel territorio di una città, costituiscono elementi di prevenzione ed un segnale visibile di possibilità della cura per questo male
che molti nelle città percepiscono e vivono come inguaribile ed incurabile.
19
Proprio la sua localizzazione urbana espone gli utenti a molte variabili
di contatto (la strada, gli ambienti, le persone, la memoria) che rendono il programma strutturalmente più difficile e più necessariamente
attento al controllo di queste variabili, che risulta invece meno necessario alla struttura ed ai programmi residenziali.
Il controllo è ancor più necessario perché laddove un centro diurno
funzioni esso, come già detto,costituisce un forte segnale positivo nei
confronti del territorio; ma se esso non funziona e le persone accolte
diventano, coi loro comportamenti, disturbanti per il territorio circostante il danno è peggiore del vantaggio.
Bisogna peraltro ricordare che l’utenza afferente a questi centri è molto diversa sia da quella che afferisce ai SerT per i programmi di sostituzione di lungo periodo, sia da quella che afferisce alle comunita
terapeutiche residenziali per i programmi riabilitativi di quelle strutture. Il controllo necessario alla buona gestione di un programma diurno
è affidato essenzialmente alla qualità del programma stesso. Un programma diurno, semiresidenziale efficace deve essere, pertanto, un programma di qualità che sul piano tecnico integri la cura biologica e
psicosociale (farmaci anticraving ed eventualmente psicofarmaci per
gli aspetti di comorbilità psichiatrica, psicoterapia di supporto,
socioterapia) con gli aspetti educativi ed etico affettivi propri dello spirito e del metodo di comunità. Gli uni non funzionano senza gli altri e
l’integrazione operativa tecnici-volontari è fondamentale.
Inoltre, occorre la consapevolezza da parte degli operatori della loro
collocazione intermedia per la quale la loro funzione può svolgersi sia
in modo del tutto autonomo, sia in modo complementare ai SerT ed
alle Comunità terapeutiche residenziali. Questo richiede atteggiamenti
e comportamenti operativi elastici e non ideologici.
Vi è poi la questione, che più ci interessa, relativamente
alla doppia diagnosi ed alla comorbilità spesso esistente
tra gli effetti psichici dell’uso e dell’abuso di sostanze
psicoattive e l’evidenza di disturbi psichiatrici di altro tipo
classificabili secondo i criteri del DSM IV R
Si è passati in questo campo dall’ignoranza crassa e dalla rimozione
piena del problema che ha caratterizzato, con poche lodevoli eccezioni, l’approccio clinico degli ultimi venti anni nelle dipendenze patologiche, alla assunzione spesso acritica del problema nell’attualità.
20
Assistiamo così ai comportamenti più vari in materia che consistono
soprattutto in una autoaffermazione di competenza in questa “nuova
disciplina” (appunto la doppia diagnosi) senza alcuna modificazione
del modus operandi.
Per alcuni servizi pubblici, in generale la doppia diagnosi sembra che
sia utilizzata soprattutto per confermare la cronicizzazione e l’adattamento spesso iatrogeni dei pazienti ad una pratica clinica frequentemente rinunciataria, quasi esclusivamente farmacologico - sostitutiva
e, in ogni caso, povera di strumenti e risorse innovativi che stimolino i
pazienti in senso evolutivo e nel senso della riabilitazione psicosociale.
Per altri enti ausiliari c’è spesso l’autentica invenzione di una competenza acquisita sul campo senza che però nulla cambi né nell’approccio diagnostico né nel lavoro clinico ed educativo quotidiano.
Si tratta, naturalmente, dei sistemi gattopardeschi che, sia negli ambiti
pubblici che in quelli privati, un sistema spesso autoreferenziale come
quello degli interventi nelle tossicodipendenze inascoltato dalle autorità competenti ha adottato per sopravvivere a sé stesso mantenendo
immutate le sue caratteristiche di fondo.
Riteniamo invece che la questione della doppia diagnosi sia una questione della massima importanza nel nostro campo clinico ed educativo
e che, proprio per questo, non possa essere né sottovalutata né all’opposto strumentalizzata per lasciare tutto così com’è.
Essa, dal nostro punto di vista, costituisce inoltre un’occasione fondamentale proprio per la revisione critica della lettura clinica ed educativa
del male di cui ci occupiamo e per il cambiamento delle risposte che si
danno oggi ai nostri pazienti appunto nel campo clinico ed educativo.
Per fare questo bisogna rivisitare anzitutto la questione della diagnosi.
Difatti si parla di doppia diagnosi, ma spesso nei servizi pubblici e
privati non esiste nemmeno la diagnosi e la definizione del caso passa
per un unico criterio che è appunto quello dell’aver fatto uso di droghe
prescindendo da ogni altro dato di conoscenza della persona tossicodipendente nella sua struttura e nelle sue dinamiche di personalità, oltre
che nei suoi comportamenti.
Un primo passo serio che occorrerà fare in questo senso sarà quello di
tentare di definire seri criteri diagnostici comunemente riconosciuti che
puntino a costruire una diagnosi multidisciplinare e multiassiale.
Un corretto inquadramento dei casi secondo criteri corretti non può
prescindere da due passaggi che noi riteniamo fondamentali:
1) L’osservazione clinica del tossicodipendente in condizioni attive (facente uso di sostanze) e, successivamente, in condizioni drug-free
ed in ambiente protetto. Tale osservazione ha bisogno di dinamicità
21
poiché non definisce la diagnosi nel giro di un mattino ma certamente la realizza in periodi medio-lunghi nei quali la condizione
drug-free può lasciare emergere disturbi psichici preesistenti o generati dalle stesse sostanze. Il trattamento degli stessi può modificarli nel tempo modificando cosi lo stesso quadro diagnostico. La
diagnosi dinamica deve potersi realizzare dal momento del primo
accoglimento del caso in poi e richiede uno spirito comune tra gli
enti pubblici e privati che cooperano nel trattamento dei tossicodipendenti. Tale spirito comune, fondato sull’osservazione nei vari
setting del trattamento, richiede - se vi è la disponibilità generale al
compito - una formazione integrata.
Su queste basi si può costituire successivamente un utile
monitoraggio del trattamento dei tossicodipendenti.
2) La disponibilità di strumenti diagnostici che coinvolgano a vario
livello gli operatori implicati nel processo terapeutico e che giovino
a chiarire sia la complessiva condizione clinica del tossicodipendente sia l’eventuale copresenza di disturbi psichiatrici. Tra questi
strumenti certamente ci sono l’ASI, l’ MMPI, la SCID. Il problema
reale consiste nel come mettere insieme una procedura diagnostica
concreta, utile e realizzabile, che tenga conto della realtà dei servizi
e del loro necessario coinvolgimento in questa procedura.
In generale possiamo dire che questi due presupposti della doppia diagnosi, osservazione dinamica e disponibilità di strumenti diagnostici,
potrebbero essere realizzati in un Dipartimento delle dipendenze patologiche in cui si realizzi una integrazione pubblico privato così come
essa viene descritta nella riforma del d.m. 444 o anche in una comunità
terapeutica o in un servizio pubblico che dispongano da soli di tutte le
fasi del trattamento: dall’accoglienza in poi, così come lo stesso 444
riformato renderebbe possibile.
Una diagnosi diversamente curata rivelerebbe con ogni probabilità, così
come attesta la letteratura scientifica internazionale, la copresenza con diverse prevalenze - del disturbo derivante dalle sostanze e di disturbi della personalità o dell’umore o di tipo psicotico.
Si tratta, ovviamente, di situazioni molto diverse sia dal punto di vista
della diagnosi che da quello altrettanto importante del trattamento.
Soprattutto da quest’ultimo punto di vista, analogamente al campo psichiatrico, potrebbero configurarsi situazioni a bassa, media, alta intensità psichiatrica.
Ciò gioverebbe anche alla definizione degli standard di personale e
strutture che devono occuparsi di tali casi recuperando ed accreditando
22
in una funzione meglio definita l’intero e ricco sistema riabilitativo
italiano cresciuto e sviluppatosi negli ultimi venti anni.
Quest’ultimo infatti potrebbe riorganizzarsi attorno a questi presupposti ed alla propria migliore vocazione senza prevedere stravolgimenti
impossibili.
Un nuovo assetto delle strutture riabilitative così configurato consentirebbe il mantenimento di un giusto equilibrio tra funzioni cliniche ed
educative necessario nel trattamento di questa patologia e rispettoso
della storia di questi stessi servizi così come essi sono andati costruendosi nel tempo.
Nel caso di mancato cambiamento in tal senso continueremmo ad assistere al crescere dell’ attuale situazione caotica nella quale si oscilla tra
ipocrita misconoscimento del problema e magica auto-attribuzione di
competenze.
Anche il problema della recidiva e della sua prevenzione
acquisterebbe un’altra luce ed importanza in un’ottica
di maggiore ma non spropositata considerazione
della questione della doppia diagnosi
In che cosa consiste la frequenza delle recidive cosi ampia nel campo
delle tossicodipendenze se non anche nell’esito di un frequentissimo
limite della diagnosi che spesso, inizialmente, non è nemmeno posta e
che, tardivamente, si pone quando il quadro clinico si è deteriorato e
cronicizzato anche in funzione di interventi confusi ed inefficaci? Una
diagnosi dinamica dei singoli casi e nelle singole fasi di trattamento
consentirebbe certamente una maggiore consapevolezza clinica ed una
maggiore verificabilità e modificabilità dei trattamenti stessi. In ogni
caso, in situazioni di recidiva forse si saprebbe dare un nome a queste
situazioni curandole e prevenendole, per quanto possibile, per quel che
sono.
La questione dell’inserimento, possibile o talora impossibile, dei tossicodipendenti con problemi di comorbilità psichiatrica di varia entità
nel mondo del lavoro si porrebbe in maniera del tutto diversa.
Se è vero che una certa quota di tossicodipendenti soffre di gravi problemi psichici non si comprende come mai raramente la loro condizione sia inquadrata dal punto di vista dell’idoneità al lavoro come quella
dei malati psichiatrici per i quali risulta molto più facile ottenere riconoscimenti di invalidità o di ridotta validità lavorativa e professionale.
Certamente questa strada può presentare pericoli non piccoli per la
23
naturale predisposizione di coloro che presentano una personalità e
comportamenti dipendenti patologicamente a dipendere in modo patologico in ogni aspetto della loro vita, compreso il lavoro, e per il rischio
che questo poi possa finire per diventare un canale di privilegi gratuiti
anziché una garanzia di diritti per persone realmente malate. Tuttavia
una riflessione seria su quanto di migliorativo per i nostri pazienti almeno quelli più gravi e più anziani - potrebbe portare una buona diagnosi non può essere più elusa ora che appare a tutti molto più chiara la
presenza, in taluni casi, di rilevanti problemi di comorbidità psichiatrica.
Se tutto questo ha fondate ragioni per essere considerato verosimile, si
pone poi il problema di chi fa la diagnosi e di quale professionalità
debba disporre.
Ancora una volta si pone il nodo del personale che opera nei servizi
pubblici e privati e di un loro addestramento e di una loro formazione
all’utilizzo di strumenti diagnostici riconosciuti e validati nell’ambito
delle possibilità e delle realtà di servizio in cui operano. Poiché questi
servizi sempre più si connotano per aver risposto negli anni e per rispondere anche oggi ad un fenomeno massiccio e sempre più
intergenerazionale quale oggi può essere considerato il campo delle
dipendenze patologiche e, d’altra parte, buona parte del fenomeno sembra appartenere al campo della salute mentale, sembrano maturi i tempi per configurare nuovi profili professionali specifici di questo campo
in aggiunta a quelli tradizionali di medico, psicologo ed assistente sociale. Una specializzazione in questo campo potrebbe realizzarsi sia
con la istituzione di questi nuovi profili professionali (perché non pensare ad un operatore tecnico delle dipendenze patologiche), sia con
l’istituzione di master di specializzazione per le tradizionali figure laureate presenti in questo campo.
In ogni caso, la possibilità di elevare le capacità diagnostiche di questi
servizi non sembra realizzabile senza una adeguata rivisitazione di obiettivi e metodi di funzionamento degli stessi e senza un adeguato investimento nella formazione e riqualificazione del personale esistente.
In ultimo si pone la questione dei costi da affrontare
per fare la doppia diagnosi ed il trattamento di essa
Una generale revisione delle tariffe per le rette vincolata a modificazioni
del modus operandi significative ed adeguate e modulata a seconda
24
della intensità psichiatrica del soggetto, potrebbe costituire la soluzione più adeguata al problema.
La realizzazione di centri diurni drug-free, associata alla realizzazione
di un numero adeguato di centri per la crisi, l’osservazione e la diagnosi o le modifiche nel trattamento per i quadri di doppia diagnosi cambierebbero radicalmente il quadro clinico del paese nei confronti delle
tossicodipendenze, consegnerebbero agli operatori strumenti efficaci
per il lavoro clinico e scientifico, determinerebbero una pratica e reale
integrazione tra pubblico e privato sociale che rispetti la stima e l’autonomia di ciascuno, ma contemporaneamente ne integri le risorse. È
quello che vorremmo e che in gran parte è descritto nel decreto 444
sugli standard dei SerT. Basterà un’iniziativa legislativa analoga a quella
del 444 o altre iniziative future a produrre questo cambiamento? Noi
pensiamo di no, se ad esse non si associano concrete risorse finanziarie
destinate al cambiamento. Una quota di queste risorse potrà provenire
dai fondi derivanti dal DPR 309 per i progetti delle Regioni e dello
Stato. Queste somme vengono attribuite in relazione ai progetti che i
servizi pubblici e privati presentano. Tuttavia, l’operazione di cambiamento che viene proposta richiede anche un mutamento delle strutture
portanti del sistema e la costruzione di spazi dignitosi dove si possano
realizzare i centri per la crisi ed i centri diurni o altri interventi analoghi. Qui occorrerebbe, attraverso fondi strutturali, ripetere l’operazione che venne compiuta all’inizio degli anni 90 quando dopo il varo
della legge Jervolino-Vassalli l’istituzione del fondo CER consentì in
tutta Italia il miglioramento strutturale dei servizi pubblici e privati per
le tossicodipendenze.
Infine, vi è il problema non secondario delle risorse umane impegnate
e da coinvolgere in questo processo di cambiamento.
Investimenti significativi devono essere realizzati nei sistemi di formazione, di valutazione della qualità degli interventi, di incentivazione
del personale dei SerT nel mutamento di rotta verso la clinica delle
tossicodipendenze. Troppo spesso questo personale è stato confuso dalla
mancata considerazione da parte degli organismi istituzionali, dalla
mancata valutazione reale e critica del proprio operare, da mancate
possibilità di carriera, da carriere non legate a meccanismi di produzione qualitativa, ma di semplice contenimento dell’utenza.
Troppo spesso gli uomini e le donne più valorose nel settore sono stati
marginalizzati nella gestione dei servizi.
Anche nella gestione delle risorse umane destinate al settore occorre
una autentica svolta e forse l’istituzione di un fondo nazionale, sia pur
minimo, che sostenga gli interventi necessari per il cambiamento.
25
È il libro dei sogni? Lo è certamente se non ne parliamo, affidandoci
acriticamente ad una gestione istituzionale che spesso non coglie i nodi
più delicati del cambiamento. Quindi parliamone anche criticandoci,
ma parliamone.
Infine, le risorse umane e quelle economiche sono quelle che, se ben
gestite, potranno realizzare i cambiamenti. Viceversa, la riduzione della cronicità sarà un’altra bella “parola” senza possibile realizzazione
pratica. Anche se, lo sappiamo per certo, l’unica strada che può restituire dignità e ruolo a noi ed ai nostri clienti sta nel fondare solidamente
il campo clinico delle dipendenze patologiche.
26
Craving
Doppia diagnosi e rewarding systems
M. DI GIANNANTONIO * - C. FEDELE *
V. DI FABIO *
I sistemi diagnostici per l’alcolismo sono numerosi. Quelli identificati
prima del 1940 sono almeno 39. Nel 1941 Jellinek pubblicò per primo
una serie di sottotipi di quello che, fino al 1980, era definito alcolismo.
Jellinek associò i sottotipi a livelli diversi di deterioramento fisico, psicologico, sociale ed occupazionale.
La formulazione di criteri diagnostici continuò con la pubblicazione,
da parte dell’American Psychiatric Association, del Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, Prima Edizione (DSM-I) e
Seconda Edizione (DSM-II). L’alcolismo venne categorizzato in entrambe le edizioni come un subset di disturbi di personalità, omosessualità e nevrosi.
Per colmare le insufficienze dei DSM I e II, Feighner sviluppò negli
anni ’70 una ricerca base per i criteri diagnostici per l’alcolismo: benchè
definiti per l‘uso nella pratica clinica, ebbero più importanza per la
definizione di criteri diagnostici sempre più utili.
Alcuni anni dopo, Edwards and Gross centrarono l’attenzione unicamente sull’aspetto della dipendenza da alcool. Considerarono elementi
costitutivi della dipendenza e del repertorio legato al bere: il drinkseeking behavior (il comportamento di chi cerca da bere), la tolleranza, l’astinenza, il bere per eliminare i sintomi dell’astinenza, la consapevolezza della compulsione al bere e le ricadute dopo periodi di astinenza.
Le definizioni diagnostiche attualmente in uso sono quelle della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD), decima edizione,
dell’O.M.S., o del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), quarta edizione dell’Associazione Psichiatrica Americana.
*
Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti
27
In realtà le due classificazioni sono talmente simili da essere
intercambiabili. L’alcolismo viene collocato tra i Disturbi Mentali, nel
capitolo dei Disturbi da Uso di Sostanze.
Le caratteristiche “nucleari” dell’alcolismo (peraltro uguali per tutte le
Dipendenze) sono: astinenza, tolleranza, perdita di controllo, presenza
di un danno psichico, fisico o sociale. Vengono anche indicate tre caratteristiche di gravità ed alcune caratteristiche di decorso; una ulteriore specifica possibile, infine, è l’indicazione della presenza o meno di
Dipendenza fisica (cioè di Tolleranza ed Astinenza).
Nella attuale concezione la Dipendenza è una sindrome complessa, in
cui il fuoco è più sulle alterazioni comportamentali che su quelle
neuropatologiche.
Ricordiamo infine come le Classificazioni Internazionali citate siano
comunque organizzate come Sistemi Multiassiali. Per una diagnosi
completa dovrebbero essere indagati (DSM-IV):
- Asse 1: Disturbi Clinici e Altre condizioni rilevanti clinicamente;
- Asse 2: Disturbi di Personalità, Ritardo Mentale;
- Asse 3: Condizioni Mediche Generali potenzialmente rilevanti per
la comprensione dei primi due assi;
- Asse 4: Problemi Psicosociali ed Ambientali;
- Asse 5: Valutazione Globale del Funzionamento.
Il sistema diagnostico illustrato ci permette dunque di codificare: la
diagnosi di dipendenza, la gravità ed il decorso della stessa, la presenza di problemi neuropatologici.
Il DSM, come i suoi predecessori, include criteri non sovrapponibili
per dipendenza ed abuso. Si prevede, comunque, la sottotipizzazione
della dipendenza basata sulla presenza od assenza di tolleranza ed astinenza. I criteri per l’abuso, nel DSM IV, sono stati allargati per includere problemi sociali interpersonali e legali legati all’assunzione di alcool. Il DSM IV, inoltre, evidenzia il fatto che i sintomi di certi disturbi, come ansia o depressione, possano essere messi in relazione con un
uso individuale di alcool o altre droghe.
Il DSM, con la valutazione multiassiale e la definizione di gravità e
decorso, fornisce alcuni strumenti che vanno oltre la semplice definizione diagnostica. Questi sono tuttavia insufficienti per l’individuazione
di soggetti con negazione o resistenza al trattamento e ad un completo
inquadramento diagnostico. È necessario dunque affiancare ai sistemi
classificativi strumenti diversi.
In questa direzione possono inquadrarsi i recenti studi neurofisiologici
legati al craving, che mettono in evidenza come la conoscenza profonda dei meccanismi cerebrali che portano all’assunzione di sostanze sia
28
indispensabile per portare allo sviluppo di nuovi e migliori approcci
terapeutici. Molti ricercatori e clinici considerano il craving un importante fenomeno che contribuisce allo sviluppo e al mantenimento dell’
alcolismo, concetto esteso e analizzato ad altre sostanze di abuso, mettendo al centro il ruolo del nucleus accumbens come motore del sistema di gratificazione. Il craving è stato descritto come un potente desiderio di assumere una sostanza o come un’intensa “fame” della stessa.
The International Classification of Diseases (ICD–10) include il craving
come un criterio diagnostico opzionale per la dipendenza da alcool e
da altre droghe definendo il termine come un forte desiderio o una
necessità compulsiva di assumere la sostanza.
La mancanza di una visione univoca per questi argomenti è indicata
dall’omissione del craving dai criteri diagnostici per l’alcolismo nel
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–IV).
Il circuito cerebrale di gratificazione è modificato da sostanze quali
nicotina, cocaina, alcool.
L’idea che ha ispirato i recenti studi neurofisiologici contempla i sintomi del craving causati dal concorso di fattori come la memoria dell’ebbrezza alcoolica e degli effetti negativi dell’astinenza, essendo il circuito di gratificazione legato ad altre aree cerebrali coinvolte nelle
emozioni, nell’apprendimento e nella memoria. Si è visto come, a fianco di un ‘immagine di controllo neutrale, immagini PET indotte dal
craving siano associate ad attivazione bilaterale (maggiore nell’emisfero destro) dell’amigdala, dell’insula di sinistra e del giro cingolato
anteriore, e di aree del giro subcalloso di destra e del nucleus accumbens.
Ulteriori studi, su uomini ed animali, indagano sui meccanismi
molecolari che coinvolgono cambiamenti temporanei e permanenti
dell’espressione genica e della sintesi di proteine nella corteccia
prefrontale, in modelli di craving condizionato.
Il concetto di “craving” specifico della clinica delle farmacotossicodipendenze associato alla diagnosi psichiatrica, riserva delle interessanti
quanto contraddittorie implicazioni. Infatti se per “craving” si intende
l’estremizzazione patologica di una modalità di funzionamento “basico”
dell’apparato mentale, appare del più vivo interesse ricercarne le radici
e le tracce nelle configurazioni psicopatologiche apparentemente molto lontane dallo specifico delle malattie della “dipendenza”.
Le basi fisiologiche del craving hanno origine negli studi sul sistema
cerebrale di gratificazione. Si tratta di un sistema costituito da centri e
vie nervose coinvolti negli effetti rinforzanti dei meccanismi di abuso
e nelle risposte adattative dell’organismo.
29
È un sistema primitivo e potente in cui le strutture limbiche sono largamente rappresentate (Koob, Bloom, 1988). Nonostante la diversità dei
siti primari di azione, dei meccanismi di azione e degli effetti, sia gli
psicostimolanti che gli oppiacei e l’alcool si ritiene possano produrre i
loro effetti rinforzanti su questo sistema, il cui centro sarebbe essenzialmente rappresentato dal nucleus accumbens e da alcune vie nervose che ad esso convergono, in particolare la via dopaminergica proveniente dall’area del tegmento ventrale e vie nervose provenienti dalla
corteccia olfattoria e dalla corteccia limbica. I neuroni del nucleus
accumbens, oltre ad innervare reciprocamente il tegmento ventrale con
fibre GABA-ergiche, proiettano a loro volta al pallido ventrale, che
contrae connessioni col nucleo peduncolo pontino, col talamo dorsomediale e con la corteccia frontale. Il circuito si chiude col fascicolo
mediale prosencefalico, lungo il fascio di fibre ascendenti e discendenti che connettono diverse strutture limbiche e olfattorie prosencefaliche
con l’ipotalamo ed il tegmento mesencefalico; in particolare, il fascicolo mediale mette in comunicazione la corteccia fronto-orbitale con il
tegmento ventrale, inviando anche collaterali ai nuclei mediani e dorsali
del rafe che, a loro volta, inviano proiezioni serotoninergiche facilitanti ai neuroni dopaminergici del tegmento ventrale.
Le più importanti sostanze d’abuso (oppiacei, amfetamina, cocaina,
fenciclidina, etanolo e nicotina) hanno in comune la proprietà di far
aumentare la concentrazione extracellulare di dopamina nel nucleus
accumbens. Ciò significa che tutti questi farmaci, con meccanismi diversi (stimolazione del firing dei neuroni dopaminergici del tegmento
ventrale; stimolazione della liberazione di dopamina dalle terminazioni
della via mesolimbica che innerva l’accumbens; impedita ricattura della
dopamina da parte delle stesse terminazioni), fanno preferenzialmente
aumentare il tono dopaminergico mesolimbico a livello dell’accumbens.
Inoltre, attraverso i neuroni eccitatori 5-HT( localizzati sui neuroni
dopaminergici del tegmento ventrale, fibre serotoninergiche provenienti
dai nuclei del rafe probabilmente potenziano le capacità delle sostanze
d’abuso di attivare il firing dei neuroni dopaminergici (Carboni et al.,
1989).
Più recenti e sofisticati studi hanno perfezionato i meccanismi teorici
di questo sistema, rilevando con studi PET come il craving attivi una
rete di regioni limbiche, paralimbiche e striatali che comprendono le
strutture coinvolte nell’associazione stimolo-ricompensa (amygdala),
motivazione (subcallosal gyrus/nucleus accumbens) e anticipazione
(anterior cingulate cortex).
30
Si è visto come, a fianco di un ‘immagine di controllo neutrale, immagini PET indotte dal craving siano associate ad attivazione bilaterale
(maggiore nell’emisfero destro) dell’amigdala, dell’insula di sinistra e
del giro cingolato anteriore e di aree del giro subcalloso di destra e del
nucleus accumbens.
Ulteriori studi, su uomini ed animali, indagano sui meccanismi
molecolari che coinvolgono cambiamenti temporanei e permanenti
dell’espressione genica e della sintesi di proteine nella corteccia
prefrontale, in modelli di craving condizionato.
L’azione dopaminergica
Studi di letteratura in numero sempre maggiore mettono in correlazione il sistema dopaminergico con i meccanismi di ricompensa e il comportamento dipendente (Wise, 1987). È stato ipotizzato che alcuni individui possono avere deficit cerebrali nella trasmissione dopaminergica
che li porterebbe a provare esperienze di generalizzata sensazione di
disagio. Questi soggetti praticherebbero attività o userebbero sostanze
per aumentare e normalizzare la trasmissione dopaminergica.
Per esempio, considerando il gioco d’azzardo patologico ed altri comportamenti dipendenti non causati da sostanze, alcuni ricercatori hanno cercato di valutare la funzione dopaminergica nei soggetti affetti.
Roy et al. (1988) non hanno rilevato significanti differenze tra plasma,
concentrazione urinaria di dopamina e flusso cerebrale tra giocatori
patologici e controllo. Più recentemente, in uno studio con giocatori
d’azzardo patologici, Bergh et al. (1997) trovarono un decremento della dopamina nel CSF ed un parallelo incremento nei metaboliti della
dopamina rispetto ai volontari sani. Ciò suggerisce un aumentato rilascio della dopamina nei giocatori patologici.
Circuiti reward
Piacere e dolore
I ricercatori del NIH Pain Center hanno dimostrato che l’esposizione
ad uno stimolo doloroso, così come alle droghe di abuso, stimoli lo
stesso circuito di gratificazione.
“I nostri risultati - afferma Gear - gettano una nuova luce sul ruolo
della struttura chiave dei circuiti reward, il nucleus accumbens, e sul
31
ruolo che esso gioca nella modulazione dei comportamenti e nella
motivazione degli individui”.
Il circuito reward è un circuito neurale intracerebrale che procura sensazioni piacevoli in risposta a certi comportamenti, come soddisfare
fame e sete o fare sesso, e di conseguenza rinforza queste condotte
importanti dal punto di vista evolutivo. Comunque, il circuito risponde
alla sostanze di abuso come eroina, cocaina, amfetamina e nicotina,
che sembrano modificare la risposta dei suoi neuroni.
Il nucleus accumbens è il motore della risposta di gratificazione.
Nel loro studio i ricercatori dell’ UCSF Department of Oral and
Maxillofacial Surgery dell’University of South California hanno determinato che il circuito reward attiva il sollievo dal dolore tramite il rilascio sia di peptidi oppioidi endogeni, sia di dopamina, i cui effetti in
questo circuito possono essere minimizzati da droghe come cocaina ed
anfetamina.
I risultati capovolgono la consolidata concezione che il rilascio di
dopamina nel nucleus accumbens sia associato solo ad esperienze positive.
Il significato dell’analgesia in chiave evoluzionistica è chiaro, poiché
permetterebbe, ad esempio, ad un individuo ferito di scappare. Potrebbe altresì spiegare perché alcuni individui riportano ferite senza provare un dolore persistente. Ma il fenomeno potrebbe anche spiegare perché tossicodipendenti, in astinenza, possano sperimentare dolore o aumentata sensibilità dolorifica .
In altre circostanze, è possibile che lo stimolo doloroso, attraverso l’attivazione del nucleus accumbens, possa essere sperimentato come gratificante, come accade nelle condotte autolesive. Non a caso, infatti, il
trattamento di questa classe di disturbo include la somministrazione di
naloxone, un farmaco che antagonizza gli effetti degli oppioidi endogeni
nel circuito di gratificazione.
Craving e disturbi di personalità
La potente attivazione biochimica innescata e mantenuta in atto da un
meccanismo di comportamento come il craving mette in atto una serie
di riflessioni sul rapporto tra la biochimica ed il comportamento, e i più
recenti e raffinati studi neuroradiologici possono essere integrati con
osservazioni cliniche e diagnostiche di un ampio spettro di disturbi
psichiatrici, che hanno sì un punto di partenza nello studio dei comportamenti d’abuso (non è un caso che recentemente siano emerse osservazioni legate a meccanismi di abuso non legati a sostanze), ma che
non esauriscono certamente le indagini in questo settore, che anzi si
32
offre come possibile chiave di lettura e come possibile contributo al
dibattito sulle diagnosi doppie e sulla comorbidità.
Con l’adozione del sistema multiassiale, infatti, con uno specifico asse
diagnostico (Asse II) per i disturbi di personalità e con la sollecitazione
a formulare anche diagnosi multiple tra asse I e asse II, il DSM III e le
successive edizioni del manuale hanno favorito il determinarsi della
comorbidità tra sindromi cliniche e disturbi di personalità riproponendo
il significato dilemmatico della relazione tra “tratto “ e “stato” da sempre al centro della riflessione patologica.
Il “Neurobiological learning model “ di Cloninger, che si fonda su studi psicometrici e genetici nella popolazione generale, riconduce la struttura della personalità normale e patologica, nonché alcuni pattern di
comorbidità Asse I / Asse II, a tre dimensioni temperamentali (“novelty
seeking”, “harm avoidance”, reward dependance”) ognuna sottesa da
uno specifico neurotrasmettitore (“behavioral activation system” dopamina; ”behavioral inhibition system” - serotonina; ”behavioral
maintenance system” -norepinefrina). Dalle combinazioni delle deviazioni (in eccesso o in difetto) delle tre dimensioni temperamentali derivano configurazioni personologiche che ripropongono quelle di otto
categorie di disturbi di personalità del DSM. Nel modello di Cloninger
la comorbidità tra Asse I e Asse II trae origine dall’assetto dimensionale della personalità da cui emerge in risposta all’esperienza.
I disturbi di ansia cognitiva (“disturbo d’ansia generalizzato”) sono
positivamente correlati con la depressione non psicotica e la dipendenza alcoolica di tipo 1 e sono negativamente correlati con il disturbo
antisociale di personalità; i disturbi da ansia somatica (disturbo di
somatizzazione) sono positivamente collegati con il disturbo antisociale
di personalità e con l’alcolismo tipo 2.
Secondo Cloninger le dimensioni caratteriali condizionano il determinarsi o meno di un disturbo di personalità e quelle temperamentali il
tipo di disturbo: in questo senso depongono le correlazioni tra “high
novelty seeking” e disturbi del cluster B, “high harm avoidance” e disturbi del cluster C e “low reward dependence” e disturbi del cluster A
(Muldel e coll. 1994).
Muldel e coll. (1994) hanno rilevato che il temperamento mostra
correlazioni con specifici disturbi comorbosi (l’abuso di alcool è
correlato con un’alta “novelty seeking” e con un basso “reward
dependence”, gli attacchi di panico con un alto “harm avoidance”).
Goldman e coll. hanno rilevato una relazione tra “high harm avoidance”
e disturbo ossessivo-compulsivo ed evitante di personalità, tra “high
33
reward dependance” e disturbo dipendente di personalità e tra “low
reward dependance” e disturbo antisociale e schizoide di personalità.
Con il “Temperament and Character Inventory” (TCI) è stato rilevato
(Svrakic e coll., 1993) che i clusters e le categorie dei disturbi di personalità del DSM III R
presentano un determinato profilo temperamentale e caratteriale (pazienti del cluster A, B e C presentano rispettivamente “low reward
dependance”, “high novelty seeking” e “high harm avoidance”).
Utilizzando questi modelli vediamo che disturbi come l’abuso di alcool o di cocaina, i più studiati in rapporto al meccanismo del craving,
siano correlati con un alto “novelty seeking” e con un basso “reward
dependence”, condizioni - soprattutto la prima - che caratterizzano il
cluster B (drammatico) del DSM III in cui sono compresi i seguenti
disturbi di personalità:
a) Disturbo Antisociale di Personalità;
b) Disturbo Borderline di Personalità;
c) Disturbo Istrionico di Personalità;
d) Disturbo Narcisistico di Personalità.
Questi disturbi risultano essere in comorbidità tra di loro, fino a creare
dei rischi di overlap, come tra il Borderline e l’Istrionico (più del 50(
dei borderline soddisfa i criteri per questo disturbo; Dahl, 1986; Pfohl
e coll., 1986) ed in comorbidità con i disturbi di Asse I: disturbo della
condotta alimentare, disturbo da uso di sostanze, disturbo depressivo
maggiore (Gunderson e coll. 1991; APA, 1994).
Per i disturbi dell’Asse II di clusters diversi, il disturbo borderline di
personalità è stato messo in relazione con il disturbo evitante di personalità (Morey,1988); entrambi i disturbi sono in comorbidità con i disturbi dell’ umore e i disturbi della condotta alimentare (Millon,1991).
Conclusioni
Oltre che esaminare un fenomeno neuropsichico profondo e complesso come quello del craving dal punto di vista molecolare, attraverso
una raccolta dei più recenti studi neurofisiologici, si è tentato di dare
un significato clinico a questo aspetto delle dipendenze, osservando
come, attraverso alcuni strumenti di classificazione diagnostica, il sistema cerebrale di gratificazione possa essere coinvolto in disturbi che
apparentemente non hanno a che fare con le dipendenze.
Riteniamo, e speriamo pertanto, che questo altro punto di vista possa
essere di aiuto ad una migliore comprensione non solo del paziente
34
alcolista e tossicodipendente, ma che riesca a facilitare la comprensione di fenomeni di nuova insorgenza quali, ad esempio, le dipendenze
nelle quali non esiste fisicamente la sostanza di abuso ma esiste
l’irrefrenabile desiderio di essa, le cosiddette nuove dipendenze.
Bibliografia
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, First Edition. Washington, DC: the Association, 1952.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Second Edition. Washington, DC: the Association, 1968.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, Third Edition. Washington, DC: The Association, 1980.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders. 4th ed. Washington, DC: the Association, 1994.
Anton, R.F. What is craving? Models and implications for treatment. Alcohol Research
& Health 23(3):165–173, 1999.
Anton, R.F., Drobes, D.J., George, M.S. Use of functional MRI to evaluate brain activity
during alcohol cue exposure in alcoholics: relationship to craving. Alcoholism:
Clinical and Experimental Research 25(Suppl. 5):107S–108S, 2001.
Anton, R.F., Moak, D.H., Waid, L.R., et al. Naltrexone and cognitive behavioral therapy
for the treatment of outpatient alcoholics: results of a placebo-controlled trial.
American Journal of Psychiatry 156(11):1758–1764,1999.
Bergh,C., Eklund, T., Sodersten, P., Nordin, C. Altered dopamine function in
pathological gambling. Psychological Medicine 27(2):473-475, 1997.
Cloninger, C.R., Svrakic, D.M., Przybeck, T.R. A psycobiological model of temperament
and character. Archives of General Psychiatry 50:975-990, 1993.
Dahl, A. Some aspects of the DSM-III personality disorders illustrated by a consecutive sample of hospitalized patients. Acta Psychiatrica Scandinavica 73(Suppl
328):61-66, 1986.
Drummond, D.C. Theories of drug craving, ancient and modern. Addiction 96(1):33–
46, 2001.
Edwards, G., & Gross, M.M. Alcohol dependence: Provisional description of a clinical
syndrome. British Medical Journal 1:1058-1061, 1976.
Feighner, J.P., Robins, E., Guze, S.B., Woodruff, R.A.Jr., Winokur, G., Munoz, R.
Diagnostic criteria for use in psychiatric research. Archives of General Psychiatry
26(1):57-63, 1972.
Gear, R.W., Aley, K.O., Levine, J.D. Pain-induced analgesia mediated by mesolimbic
reward circuits. J. Neurosci. 19: 7175-7181, 1999.
George, M.S., Anton, R.F., Bloomer, C., et al. Activation of prefrontal cortex and anterior
thalamus in alcoholic subjects on exposure to alcohol-specific cues. Archives of
General Psychiatry 58(4):345–352, 2001.
35
Goldman, R.G., Skodol, A.E., McGrath, P.J., Oldham, J.M. Relationship between the
Tridimensional Personality Questionnaire and DSM-III-R personality traits.
American Journal of Psychiatry 151:274-276, 1994.
Gunderson, J.G., Phillips, K.A. A current view of the interface between Borderline
Personality Disorder and Depression. American Journal of Psychiatry 148:967975, 1991.
Hommer, D.W. Functional imaging of craving. Alcohol Research & Health 23(3):187–
196, 1999.
Kilts, C.D., Schweitzer, J. B., Quinn, C.K., Gross, R.E., Faber, T.L., Muhammad, F.,
Ely, T.D., Hoffman, J.M., Drexler, K.P.G. Neural activity related to drug craving
in cocaine addiction. Archives of General Psychiatry 58, 4, 2001.
Maggini, C., Pintus, A. Disturbi di personalità e comorbidità. Giornale Italiano di
Psicopatologia 2:133-145, 1996.
Millon, T. Avoidant Personality Disorder: a brief relief of issues and data. Journal of
Personality Disorders 5:353-362, 1991.
Morey, L. Personality Disorders in DSM-III and in DSM-III-R: an examination of
convergence, coverage and internal consistency. American Journal of Psychiatry
145:573-577, 1988.
Muldel, R.T., Joyce, P.R., Cloninger, C.R. Temperament and early enviroment influence
comorbidity and personality disorders in major depression. Comprehensive
Psychiatry 35:225-233, 1994.
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism No. 30 PH 359 October 1995.
Diagnostic Criteria for Alcohol Abuse and Dependence
Pfohl, B., Coryell, W., Zimmermann, M., Stungl, D. DSM-III personality disorders:
diagnostic overlap and internal consistency of individual DSM III criteria.
Comprehensive Psychiatry 27:21-34, 1986.
Rounsaville, B.J., Bryant, K., Babor, T., Kranzler, H., Kadden, R. Cross system
agreement for substance use disorders: DSM-III-R, DSM-IV and ICD-10. Addiction
88(3):337-348, 1993.
Roy, A., Adinoff, B., Roehrich, L., et al. Pathological gambling: a psychobiological
study. Arch Gen Psychiatry 45:369-373, 1988.
Schuckit, M.A. DSM-IV: Was it worth all the fuss? Alcohol and Alcoholism (Supp.
2):459-469, 1994.
Sora, I., Hall, F.S., Andrews, A.M., Itokawa, M., Li, X.F., Wei, H.B., Wichems, C.,
Lesch, K.P., Murphy, D.L., Uhl, G.R. (Molecular Neurobiology, National Institute
on Drug Abuse-Intramural Research Program, National Institutes of Health,
Baltimore, MD 21224; Laboratory of Clinical Science, National Institute of Mental
Health-Intramural Research Program, National Institutes of Health, Bethesda, MD
20892-1264; Department of Chemistry, Pennsylvania State University, PA 16802;
and Department of Psychiatry, University of Wurzburg, Wurzburg 97080, Germany)
Molecular mechanisms of cocaine reward: combined dopamine and serotonin
transporter knockouts eliminate cocaine place preference. Proc Natl Acad Sci USA
24; 98(9):5300-5305, 2001.
36
Svrakic, D.M., Whitehead, C., Przybeck, T.R., Cloninger, C.R. Differential diagnosis
of personality disorders by the seven factor model of temperament and character.
Archives of General Psychiatry 50:991-999, 1993.
Tiffany, S.T., Conklin, C.A. A cognitive processing model of alcohol craving and
compulsive alcohol use. Addiction 95(Suppl. 2):S145–S153, 2000.
Vaillant, G.E. The Natural History of Alcoholism Revisited. Cambridge: Harvard
University Press, 1995.
Volpicelli, J.R., Alterman, A.I., Hayashida, M., O’Brien, C.P. Naltrexone in the treatment
of alcohol dependence. Archives of General Psychiatry 49:876-880, 1992.
Wise, R.A., Bozarth, M.A. A psychomotor stimulant theory of addiction. Psychological
Review 94(4):469-492, 1987.
World Health Organization. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural
Disorders: Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. Geneva, Switzerland:
the Organization, 1992.
37
38
La "Doppia diagnosi"
vantaggi o limiti nella prassi operativa ?
R.C. GATTI *
“Da almeno vent’anni si è diffusa una precisa consapevolezza sull’importanza che la comorbidità psichiatrica nelle tossicodipendenze (altresì detta “doppia diagnosi”) - cioé la copresenza di disturbi psichici e
di disagio psicologico in questi pazienti - riveste in relazione alla salute della popolazione generale”. Queste affermazioni della Società italiana per lo studio dei comportamenti di Abuso e Dipendenza (SICAD,
ora SIP.Dip) appaiono sul sito internet www.doppiadiagnosi.it assieme
ad una serie di considerazioni riguardanti:
- una “vasta mole di evidenze” a proposito di un problema poco riconosciuto anche da parte dei Servizi che se ne occupano (SerT e
Comunità Terapeutiche);
- pazienti in carico ai Servizi Psichiatrici che, sempre più spesso, “incontrano” le sostanze;
- trattamenti non adeguatamente condotti dal punto di vista terapeutico
Una questione fondamentale
Perché se della questione “doppia diagnosi” esiste una precisa consapevolezza (accompagnata da una vasta mole di evidenze) da almeno
vent’anni … il paziente continua ad essere trattato non adeguatamente
dal punto di vista terapeutico?
A mio avviso non esiste un’unica causa: è un insieme di concause a
produrre questo tipo di risultato.
In un passato relativamente recente, le parole d’ordine ben presenti
attorno all’intervento sulle dipendenze patologiche erano “non
medicalizzare” e, ancor di più, “non psichiatrizzare”. Oggi, queste
*
Dipartimento Dipendenze Patologiche A.S.L. Città di Milano
39
espressioni, vengono utilizzate meno frequentemente ma le conseguenze
dei concetti che sottendevano sono ancora vive. La nascita del sistema
di intervento sulle tossicodipendenze avviene in un clima culturale contemporaneo, ed anche culturalmente attiguo, a quello dell’anti-psichiatria. I Servizi Tossicodipendenze, inoltre, vengono costruiti assieme
alle prime Unità Sanitarie Locali: luoghi dove si sarebbe voluto rendere territoriale e direttamente controllabile dai (rappresentanti dei) cittadini la gestione della salute sottraendola al potere degli Ospedali. Non
per nulla, ancor oggi, in Italia non esistono, di norma, reparti ospedalieri
dedicati al trattamento delle dipendenze ed i SERT sono, per definizione, territoriali.
È esistita una vera e propria frattura nei diversi ambiti del curare, tra
loro e con quelli propri del prendersi cura. Talvolta ciò ha compromesso la possibilità di intervenire nel modo più adeguato possibile su situazioni che avrebbero richiesto, logicamente, un continuo di azione.
Il trattamento delle dipendenze oggi si svolge, di fatto, all’interno di un
duopolio: SERT - Comunità che ha cercato di “bilanciare”, senza mai
riuscirci completamente, il concetto del “prendersi cura” dal punto di
vista educativo con quello del “curare” dal punto di vista clinico.
In diversi ambiti, compresi quelli sanitari, la tossicodipendenza da sostanze illegali viene considerata come un problema non medico. Anche se raramente viene esplicitato in modo diretto, la tossicodipendenza
è equiparata ad un vizio, più che ad una malattia. Un atteggiamento
differente viene conservato, invece, in ambito alcologico che risente di
un substrato culturale più collegato alla attività clinica ed a specialità
ospedaliere.
Il mandato sociale al Sistema di intervento sulle tossicodipendenze è
sempre stato ambiguo: molto più indirizzato al contenere i problemi
sociali e, forse, le persone che li provocavano, piuttosto che a curare e,
possibilmente, a guarire. È anche per questa ragione che i sistemi di
monitoraggio sono stati indirizzati soprattutto alla verifica del numero
dei soggetti in trattamento mentre altri parametri e modelli di valutazione atti a misurare l’efficacia dell’azione (e non solo l’efficienza)
sono ancora in stato embrionale oppure sono legati ad iniziative spontanee, locali, sperimentali o, comunque, ancora non consolidate. Evidentemente la misura dell’efficacia degli interventi non avrebbe potuto
prescindere da sistemi diagnostici validati e confrontabili.
La diagnosi e la prognosi non sono soltanto uno strumento di lavoro e
di scambio di informazioni tra tecnici, ma rappresentano anche un qualcosa di dovuto al paziente. Per una serie di motivi diversi, nel nostro
Paese, le associazioni di persone in cura con problemi di abuso di so40
stanze o non ci sono o hanno scarsa voce in capitolo: i diritti dei pazienti, quindi, sono poco tutelati.
L’insieme delle concause sopra esposte contribuisce alla costruzione
di un sistema di intervento sulle tossicodipendenze che, di fronte ad
una patologia definita cronica e con tendenza alla recidiva, in presenza
di un mandato generale contenitivo, rimane in un ambiguo equilibrio
ai margini della clinica. In questo tipo di situazione, non potendo o
volendo trovare misure della propria azione, finisce per giustificare la
sua esistenza soprattutto in base alla propria efficienza e non in base
alla misura della propria efficacia. Contemporaneamente, sistemi attigui - come quello psichiatrico - se da una parte individuano l’inadeguatezza dei trattamenti forniti a pazienti “doppia diagnosi”, dall’altra
faticano a proporre e a costruire collaborazioni per la costruzione di
modelli di intervento adeguati. Nella nostra cultura il “paziente doppia
diagnosi” tende a diventare … di competenza altrui … specialmente
quando la “doppia diagnosi” è dichiarata! La situazione peggiora se il
paziente si presenta in un momento di particolare crisi o quando è un
minore.
Nuovi orizzonti
Nonostante i presupposti, l’intenso interesse che si sta sviluppando attorno al tema “doppia diagnosi” potrebbe essere un segno particolarmente positivo. Il nostro sistema di intervento, superata una situazione
di relativa “giovinezza” (dove era privilegiata l’azione al pensiero, ma
all’interno di una visione dell’azione determinata esternamente), potrebbe essere pronto per un salto evolutivo. Potrebbe, cioè, aver maturato le condizioni per il raggiungimento di una propria identità nuova
attraverso un processo di sintesi tra discipline e approcci culturali differenti con il recupero di un mandato sociale meno ambiguo. In questa
ipotesi, il progressivo aumento delle conoscenze, il valore aggiunto
delle parziali sinergie sviluppate e l’energia liberata dalle contrapposizioni interne al sistema, avrebbero permesso, nel tempo, una equilibrata e progressiva percezione e comprensione della complessità di un
problema e dei limiti dell’attuale intervento. L’interesse per la doppia
diagnosi, quindi, potrebbe essere riletto come parte di un più generale
rinnovato interesse per la clinica, cioè per il curare assieme al prendersi cura all’interno di una situazione culturale ed operativa determinata
dal sistema stesso e non come conseguenza di emergenze socio-politiche.
41
Ci si muove, finalmente, verso nuovi orizzonti attraverso territori (un
diverso ruolo e diverse sinergie tra Pubblico e Privato Sociale, ad esempio) ancora da scoprire. Si tratta di una esplorazione interessante che
naturalmente può presentare anche alcuni pericoli da non sottovalutare.
La “doppia terapia”… chi, dove, quando, come?
Il tema “doppia diagnosi” , ad esempio, sembra effettivamente interessare molto e potrebbe essere un interesse positivo ma, per ora, pare
polarizzarsi soprattutto all’interno di due ambiti principali: parte della
Psichiatria ed alcune Comunità Terapeutiche. Si realizza così (apparentemente) un’alleanza tra ambito clinico-terapeutico ed ambito socio-educativo che sembravano in competizione. Stranamente, però, il
tema appare meno “caldo” all’interno dei Servizi che, ad oggi, hanno
in carico il maggior numero delle persone che manifestano problemi di
dipendenza e di abuso di sostanze: i SERT.
Al momento, perciò, è difficile valutare quali orizzonti potrebbero aprirsi
di conseguenza anche perché, come dicevo, la strada della costruzione
di nuovi ruoli e sinergie è stata aperta ma deve essere ancora esplorata.
Così come stanno le cose, oggi, quando si parla di Centri per il trattamento di pazienti doppia diagnosi, ci si riferisce principalmente a strutture residenziali quasi come se chi è “affetto da doppia diagnosi” dovesse … essere mandato da qualche parte … anziché essere curato lì
dove si trova. Probabilmente è sottinteso che una adeguata assistenza,
non solo un processo diagnostico, venga attuata anche a livello territoriale: ma da parte di chi?
Mentre alcune Regioni si apprestano ad accreditare strutture e prestazioni mi sembra che si rimanga un po’ troppo ancorati al concetto di
(doppia) diagnosi e si faccia ancora fatica a parlare di prognosi e trattamento. La gestione della crisi psichiatrica ed il trattamento psichiatrico
parallelo al trattamento della dipendenza richiedono risorse, organizzazione, preparazione e capacità che rappresentano un costo aggiuntivo
notevole e, sino ad oggi, ancora sottovalutato. Un intervento corretto e
dedicato non può che basarsi su di una rete costituita da più elementi
(ambulatoriali, ospedalieri, residenziali) con diversi gradi di
specializzazione ed buon collegamento tra loro. Questa rete, oggi, non
esiste.
La mia preoccupazione è che il sistema di intervento sia sempre più
consapevole e tecnicamente pronto ad un salto qualitativo ma che a
42
livello programmatorio non si possa o non si voglia investire in questa
direzione.
Le ragioni potrebbero essere banali:
- mancanza effettiva di risorse aggiuntive spendibili in questo settore
(contenimento della spesa pubblica);
- individuazione di questo settore come non prioritario;
- priorità verso un mandato contenitivo del problema sociale rispetto
ad un mandato terapeutico individuale (connesso anche alla convinzione sufficientemente diffusa che la tossicodipendenza non sia
una patologia e che, quindi, non sia curabile clinicamente).
La diagnosi, in generale, e la diagnosi di comorbidità, in particolare,
possono dunque essere la chiave di volta per costruire un salto di qualità nell’intervento nel settore delle dipendenze patologiche che, ormai, pare necessario. Tuttavia la diagnosi deve essere utilizzata per
quello che è: la parte di un processo clinico complesso che deve coinvolgere chi vi è sottoposto. Se questo processo non si sviluppa, affrontando le complessità che gli sono proprie, il risultato rimane esclusivamente un controproducente etichettamento.
In molti Servizi Territoriali ci accorgiamo che processi diagnostici
validati ed alla portata di chi in questi Servizi opera, non vengono applicati nella prassi operativa o, almeno, non vengono riportati nelle
documentazioni dei singoli casi, quasi come se non fosse necessario
comunicarli e utilizzarli. Anche dopo corsi di formazione di buon livello l’utilizzo di strumenti diagnostici sembra diventare quasi un’esercitazione intellettuale o un momento di ricerca scientifica piuttosto che
uno strumento di lavoro.
Perché? È possibile pensare che la non applicazione di strumenti
diagnostici perfezionati e disponibili abbia a che fare (più o meno consciamente) con la consapevolezza di non potere applicare programmi
di trattamento adeguati a quanto diagnosticato per mancanza di risorse
di diverso genere e della conseguente possibilità di realizzare setting
adeguati? L’ipotesi è inquietante ma potrebbe anche spiegare il perché
della questione fondamentale posta all’inizio: della “doppia diagnosi”
esiste una precisa consapevolezza (accompagnata da una vasta mole di
evidenze) da almeno vent’anni ma il paziente continua ad essere trattato non adeguatamente dal punto di vista terapeutico.
43
Un meccanismo vizioso
Ciò, naturalmente, genera un meccanismo vizioso. La mancanza di
esperienza condivisa, confronto, comunicazione e utilizzo della diagnosi come strumento decisionale nella prassi operativa clinica, finisce per rendere il processo diagnostico meno attendibile, meno valido
e, soprattutto, difficilmente perfezionabile. Addirittura il concetto di
doppia diagnosi rischia di essere utilizzato come una vera e propria …
diagnosi (quel paziente è un “doppia diagnosi”) avvitandosi su di sé in
un atteggiamento mentale che chiude possibilità anziché aprirne. In
mancanza di diagnosi la dimostrazione della appropriatezza e dell’efficacia di un trattamento terapeutico diventa impossibile. Ciò finisce per
colludere con un mandato contenitivo – quantitativo e per convincere il
programmatore della inutilità di investire ulteriori risorse in processi
terapeutici più sofisticati in mancanza di risultati dimostrabili. I gestori
delle Unità di Offerta, in carenza di risorse, sono stimolati a sostituire
alle capacità cliniche capacità contenitive perché meno onerose. Ciò
rende inutili processi diagnostici. I programmi terapeutici continuano
ad essere inadeguati.
Giochi di “ruolo”
Ecco un gioco di ruolo percorribile in questa situazione:
- ricorrere ai trattamenti Residenziali in Comunità per doppia diagnosi solo per una non capacità (o volontà) di organizzare anche
territorialmente setting idonei alla cura di pazienti complessi;
- concludere, di conseguenza, che i pazienti “doppia diagnosi” possono essere curati solo in Comunità;
- non fornire alle Comunità risorse idonee per sviluppare interventi
complessi e non pretendere standard adeguati alla complessità dei
casi;
- mantenere i pazienti in strutture residenziali.
Appropriarsi della complessità… e dichiararla!
Ritorniamo ad un argomento primario di questa trattazione.
La diagnosi psichiatrica connessa all’abuso di sostanze pone una importante questione: in quali condizioni del soggetto e in quale setting
ambientale sia effettivamente attuabile.
44
In presenza di sintomi psichiatrici e uso di sostanze, infatti, si possono
ipotizzare le seguenti condizioni:
- l’astinenza, l’intossicazione acuta o cronica possono sfociare in un
sintomo psichico o in un vero e proprio Disturbo mentale: scompariranno, anche senza trattamento, dopo alcune settimane di non uso
della sostanza o delle sostanze che ne sono origine;
- esiste un sintomo psichico che perdura nonostante l’astensione dall’uso di sostanze dovuto a: “craving” o “astinenza protratta”; presenza di un disturbo mentale autonomo rispetto all’uso di sostanze;
presenza di possibili disfunzioni direttamente conseguenti all’uso
pregresso di sostanze.
È effettivamente possibile pensare di fare una diagnosi attendibile in
presenza di sostanze che, per loro principale attività, alterano lo stato
mentale anche ricordando che la maggior parte dei soggetti che si presentano alla nostra attenzione utilizzano, di fatto, più sostanze?
Sarebbe buona norma, prima di fare una diagnosi psichiatrica, osservare il paziente in condizioni di astinenza o, almeno, in situazione stabilizzata. Una diagnosi corretta richiederebbe la possibilità di osservazione e valutazione clinica adeguata.
L’attuale sistema di intervento, proprio nei casi complessi, non lo permette. Infatti la diagnosi deve essere eseguita in ambito ambulatoriale,
in condizioni dove l’astensione dall’uso di sostanze non può essere
garantita. Anche le strutture residenziali (comprese molte di quelle che
potrebbero essere previste come accreditabili per “doppia diagnosi” in
alcune regioni) non sembrano dotate di standard tali da poter garantire
in sicurezza l’osservazione clinica necessaria e gli interventi del caso.
Tutto ciò fa parte di un problema più ampio: nel nostro Paese, per un
insieme di motivi, la fase dell’abbandono delle sostanze di abuso e
dell’osservazione diagnostica che ne dovrebbe conseguire non è mai
stata organizzata in modo adeguato. Ne deriva, per i pazienti, un’oggettiva maggiore difficoltà ad abbandonare l’uso delle sostanze; per i
terapeuti, un’oggettiva difficoltà nel fare diagnosi attendibili soprattutto nel caso di disturbi mentali e contemporaneo uso di psicostimolanti.
Ma se i processi diagnostici sono inadeguati, anche i programmi
terapeutici ed i luoghi dell’intervento non saranno scelti in modo opportuno, i “drop-out” dal trattamento diverranno più frequenti, i costi
dei trattamenti ed i costi individuali e sociali della tossicodipendenza
aumenteranno di conseguenza.
Se partiamo da alcune consapevolezze:
- una diagnosi ben fatta non determina di per sé un trattamento adeguato;
45
- non tutte le patologie diagnosticabili sono curabili;
- una diagnosi psichiatrica in mancanza di una possibilità di trattamento adeguato può provocare azioni peggiorative della situazione
del paziente, ci accorgiamo rapidamente che, già in condizioni
ottimali, intervenire correttamente su patologia psichiatrica e uso di
droghe assieme è una situazione complessa che non può essere affrontata con soluzioni semplicistiche.
Le potenzialità tecniche ed operative maturate in questo settore sono,
oggi, sacrificate da un sistema di intervento che non gode ancora delle
risorse e degli investimenti (anche culturali) necessari per applicarle
correttamente.
È strano come questa complessità non venga sufficientemente dichiarata e discussa anche in ambito clinico. Forse l’evoluzione e la sofisticazione del concetto di diagnosi all’interno di un sistema che non è in
grado di sviluppare (di pari passo) la capacità clinica-terapeutica e la
logistica necessaria ad attuarla comincia già ad ottenere risultati paradossali: rinunciare consapevolmente a parte della clinica… come meccanismo di difesa.
Questioni aperte
Rimangono, pertanto, aperte alcune questioni fondamentali che riguardano tutti gli attori che determinano, internamente o esternamente,
l’azione del sistema di intervento sulle tossicodipendenze:
- Quale tipo di peso e di priorità si intende dare all’interno del sistema di intervento sulle tossicodipendenze al processo di cura del
tossicomane?
- Quale tipo di peso si intende dare al processo di cura del tossicomane all’interno del sistema di sanitario?
Ancora oggi la programmazione sembra orientata a risolvere una serie
di epidemie e di emergenze riguardanti la popolazione giovanile (eroina… ecstasy… cocaina…) piuttosto che a considerare come l’abuso
di sostanze legali e illegali, sia - nel nostro Paese - endemico e molto
diffuso in diverse fasce sociali e di età. Nell’emergenza di una epidemia non c’è tempo di trattare certi sostanziali argomenti di fondo: si fa
quel che si può con quello che si ha in quel momento. Ma un’emergenza non può durare decenni ed attraversare generazioni. Il sistema di
intervento, nel suo complesso, pare oggi più un insieme di progetti
sperimentali che un vero e proprio sistema. Se così non fosse permetterebbe al cittadino di scegliere il luogo di cura ed al terapeuta di sceglie46
re la cura più adeguata. Il nostro sistema, pur avendo una capacità
ricettiva relativamente alta, troppo spesso non lascia adeguate possibilità di scelta al cittadino e nemmeno al terapeuta.
La sempre maggior consapevolezza dei limiti dell’attuale sistema sarà,
probabilmente, la spinta propulsiva necessaria per un salto evolutivo
che si sta dimostrando necessario ... ma che non è ancora avvenuto,
anche con un diverso bilanciamento dell’offerta e dell’impiego delle
risorse.
Un possibile orientamento?
1. Costruzione di reti locali costituite da gestori diversi corresponsabilizzati nella programmazione e nella manutenzione tecnico-economica delle reti stesse con il fine di realizzare possibilità di offerta
più ampie ed adeguate ai bisogni dell’utenza.
2. Messa in comune, tra i diversi gestori, di risorse tecniche e professionali per la realizzazione di nodi funzionanti per tutta la rete locale (es. osservazione diagnostica residenziale – disassuefazione – trattamento “doppia diagnosi” … ma anche supervisione, formazione
e prevenzione).
3. Superamento dell’unità di tempo, di luogo e di azione nell’operatività
delle equipe multidisciplinari mediante una interazione diversa tra
persone che pur operando in tempi, luoghi ed azioni differenti sulle
stesse persone, possano condividere la creazione di equipe trasversali alle diverse organizzazioni.
Con un diverso sistema di intervento, forse, la diagnosi potrebbe addirittura… non essere più “doppia” ma diventare una. In tutti gli altri
ambiti della clinica, la compresenza di due patologie diverse non viene
definita con il termine di “doppia diagnosi”: ci sarà pure una ragione
anche per questo.
47
48
Tossicodipendenza e psicopatologia
un'ipotesi psicodinamica
A. LO RUSSO *
Il malinteso iniziale
Oggi non tutti sono consapevoli che troppo a lungo la componente
psicopatologica della tossicodipendenza strutturata (differenziandola
così da una meno grave “tossicofilia”) è stata misconosciuta, o addirittura esplicitamente negata. La prima legge che regolamentava l’intervento nella tossicodipendenza (legge 685/75) sanciva che il soggetto
tossicodipendente poteva essere ricoverato nelle comuni strutture
ospedaliere “ad eccezione degli ospedali psichiatrici”; inoltre non veniva richiesta la competenza psichiatrica come requisito necessario
nemmeno ad una parte dei medici che venivano assunti per lavorare
nei SerT. Di fatto i rari psichiatri che, fin dall’inizio, hanno scelto di
lavorare nei Servizi per le Tossicodipendenze sentivano il rimbombo
dell’eco dell’“eresia quando si affannavano a spiegare a colleghi, ad
amministratori o in sedi di pubblico dibattito, che la tossicodipendenza
aveva le sue radici nei processi psichici infantili, nÈ più nÈ meno come
altre sintomatologie psichiatriche.
Non sono passati molti anni da quando mi sono sentita porre con grande reciproca costernazione questa domanda “ma tu che sei psichiatra
cosa ci fai in un SerT?”.
Parziale fonte dell’equivoco è il fatto che la condizione mentale del
tossicodipendente viene mascherata dall’effetto psicotropo delle sostanze di abuso; pertanto la valutazione di un paziente tossicodipendente si fa di necessità in tempi medio-lunghi. Per molti anni lo squilibrio psichico manifestato dalla persona dedita all’uso di sostanze illegali è stato attribuito esclusivamente all’effetto psicotropo delle droghe, sottovalutando il fatto che inizialmente le droghe sono usate come
*
Dipartimento delle Dipendenze - Venezia
49
tentativo “autoterapeutico” per lenire, consapevolmente o inconsapevolmente, il disagio psichico di cui si soffre.
Concausa della disattenzione verso la componente psicopatologica della
tossicodipendenza è sicuramente da ricercarsi anche nelle traversie che
negli anni ’70 travolgevano il mondo della psichiatria, in una fase di
grandi modificazioni ideologiche e organizzative. In tempi in cui il
movimento di Psichiatria Democratica minimizzava il significato del
mondo psichico interiore, dando maggiore attenzione alle influenze
sociali anche rispetto a malattie psichiche conclamate come la psicosi,
è stato facile dare una lettura medico-internistica, da un lato, e
sociologica, dall’altro, a un fenomeno nuovo come il diffondersi della
tossicodipendenza giovanile.
Molti SerT si sono organizzati fin dall’inizio in un’ottica internisticofarmacologica, privilegiando pertanto l’obiettivo della disintossicazione
o della stabilizzazione del paziente con farmaci “sostitutivi”, senza porsi
il problema della valutazione delle condizioni mentali del soggetto,
delle problematiche psicologiche che sostengono il comportamento
tossicomanico e quindi, spesso, neppure del differente significato dei
modelli di intervento.
Servizi Psichiatrici e SerT
Bisogna riconoscere che le Comunità Terapeutiche hanno di fatto contribuito, spesso prima dei SerT, a darci una lettura delle condizioni
mentali del soggetto tossicodipendente, proprio perché potevano osservarne l’evoluzione in condizioni drug-free.
Si potrebbe tracciare una sommaria differenziazione in tre tipologie
psicopatologiche dei soggetti che accedono alle Comunità Terapeutiche:
a) psicopatologia dell’area borderline: soggetti che in C.T. si adattano in tempi brevi e senza troppe difficoltà riescono ad interrompere
l’uso di sostanze con rapido miglioramento delle loro condizioni
fisiche. Sono soggetti che, in mancanza di interventi psicoterapeutici
che permettano una evoluzione psichica, spostano inconsapevolmente la dipendenza dalle sostanze alla C.T. e presentano una elevata
percentuale di ricaduta all’uscita dalla C.T. o, in prospettiva, alla
separazione da “fine - programma”.
b) psicopatologia dell’area psicotica: soggetti che, nel primo periodo
di residenza in Comunità e in condizioni di astinenza da sostanze
psicotrope, presentano uno scompenso psichico con sintomatologia
allucinatoria o con elevato rischio suicidiario. Sono soggetti che
50
vengono quasi sempre espulsi dalle Comunità, soprattutto se non
possono essere trattati con farmaci neurolettici e/o antidepressivi.
c) psicopatologia dell’area nevrotica: soggetti che presentano iniziale
difficoltà, con progressivo doloroso e partecipato adattamento all’ambiente comunitario. Dimostrano capacità di cambiare “apprendendo dall’esperienza”. Sono soggetti a prognosi favorevole.
Esiste già una variegata letteratura relativa ai disturbi di personalità
che sostengono il manifestarsi di una sintomatologia tossicomanica.
Credo, inoltre, che nessuno psichiatra in buona fede possa non riconoscere la stretta affinità nei presupposti psicopatologici di un paziente
“psichiatrico” e di un paziente tossicodipendente. Eppure moltissime
sono state per anni, e spesso tuttora persistono, le resistenze degli psichiatri che lavorano nelle istituzioni psichiatriche a riconoscere la propria competenza di fronte a pazienti tossicodipendenti.
A mio avviso sono preoccupazioni “organizzative” quelle che giustificano le resistenze dei colleghi della psichiatria: tale preoccupazione
“realistica” potrebbe essere esplicitata più o meno così: “ se riconosciamo la componente psichiatrica della tossicodipendenza, le nostre
strutture diventano ingestibili”.
Un’occasione come questa, che coinvolge psichiatri dei SerT e dei Servizi Psichiatrici, deve essere pensata come una sede importante per
avviare un confronto scientifico, libero da deviazioni opportunistiche,
per comprendere quali siano i punti di accordo e quali di disaccordo
sulla gestione clinica dei rispettivi pazienti.
L’ assenza di esponenti delle istituzioni psichiatriche nel dibattito sulla
tossicodipendenza ha fatto sì che, negli ultimi vent’anni e più, si siano
strutturate due modalità operative che, per certi aspetti, appaiono poggiarsi su presupposti opposti:
a) da un lato, una rigida ideologia “antimanicomiale” ha indotto a perseguire l’obiettivo di ridurre il più possibile la degenza ospedaliera,
o l’accoglienza in strutture residenziali, del paziente psichiatrico;
b) dall’altro, si è diffusa l’ enfatizzazione dell’importanza di prolungati programmi comunitari, lontani dal contesto familiare e sociale
d’origine, per i soggetti tossicodipendenti.
Sembra arrivato finalmente il momento adatto per riuscire ad avviare
un serio confronto sulle origini di questa dicotomia, e per formulare
delle ipotesi cliniche circa la giustificata conferma di tale dicotomia, o
la necessità di modificarla. È un dibattito epistemologico quello che
urge avviare; dobbiamo vedere se troviamo un’intesa sui criteri della
valutazione, dell’intervento clinico/terapeutico, della organizzazione
51
dei Servizi, della gestione della cronicità (dove più evidente appare
l’affinità delle problematiche).
Imparare dall’esperienza: dietro la tossicodipendenza
Gli operatori dei SerT hanno imparato con la propria esperienza a scoprire pian piano le dinamiche psichiche e la patologia psichiatrica, più
o meno strutturata in sintomatologia specifica o in disturbi di personalità, che si nascondono dietro il comportamento tossicomanico.
In maniera schematica vorrei riassumere qual’é il quadro psicodinamico
che nella maggior parte dei casi si nasconde dietro il sintomo della
tossicodipendenza, secondo quanto emerge dalla letteratura specialistica e viene confermato dalla nostra esperienza psicoterapeutica
pluriennale.
Prima di inoltrarci in un approfondimento delle origini psichiche della
tossicodipendenza e, di conseguenza, capire quali interventi siano più
appropriati, dobbiamo convenire su una prima necessaria distinzione
tra:
a) cause recenti o occasionali che inducono una persona all’uso di
sostanze psicotrope: per molti anni sono state le uniche ad essere
prese in considerazione, riducendo di conseguenza la tossicodipendenza a un disturbo del comportamento da affrontare unicamente
con farmaci per la disassuefazione, da un lato, e con interventi
rieducativi dall’altro;
b) cause predisponenti, la cui origine è da ricercare nelle relazioni
oggettuali delle prime fasi dello sviluppo infantile e che giustificano attualmente l’enfasi dell’espressione “Doppia Diagnosi”.
Molti autori, che hanno affrontato la questione in termini psicodinamici,
convengono che la causa predisponente di maggiore significato consiste nell’essere rimasti psichicamente ancorati a quella fase dello sviluppo infantile in cui si articola il processo di “individuazionedifferenziazione”, cioè nella fase in cui, tra i 6 e i 18 mesi, il bambino
comincia a percepire se stesso, differenziandosi dalla madre, punto di
riferimento per il suo equilibrio emozionale. La matrice psicopatologica,
nella maggior parte dei casi di tossicodipendenza, ha le sue origini in
quella fase dello sviluppo da cui prende origine la variegata
sintomatologia dell’area borderline.
52
Il bambino de-negato
Il futuro tossicodipendente é spesso un bambino “de-negato”: con tale
definizione Perrella descrive un bambino che viene investito di un
amore narcisistico da parte di uno o di entrambi i genitori che usano
inconsapevolmente il bambino per compensare le proprie frustrazioni,
trattandolo come una parte di sé a cui non si può rinunciare. In questo
modo il bambino si ritrova nella confusiva situazione di percepire di
avere diritto a vivere solo nella misura in cui assolve al compito di
garantire l’equilibrio psichico del genitore. Trovandosi impigliato subdolamente nella problematica di un genitore “dipendente dal proprio
figlio”, il bambino si trova ad affrontare una serie di conseguenze che
segneranno il suo successivo sviluppo psico-emotivo.
Sinteticamente vorrei elencare i punti salienti che caratterizzano la condizione mentale del bambino de-negato:
- non viene aiutato in quel processo di individuazione-differenziazione
indispensabile alla sua crescita;
- non viene riconosciuto nella sua individualità (negazione): gli viene negato il diritto a un’esistenza autonoma;
- non può riconoscere il sentimento della rabbia per la violenza subdola di cui é oggetto, essendo una violenza espressione di troppo
amore;
- rimane impigliato nella ragnatela dell’amore ricevuto e da corrispondere, senza potersi appigliare al fondamentale aiuto del sentimento di odio che, nella norma, permette di prendere le distanze dal
troppo amore che intrappola nella dipendenza.
Il meccanismo di difesa tipico della condizione mentale di dipendenza
a buona ragione può essere definito “de-negazione”: cioé negazione di
essere stati oggetto di negazione per troppo amore. Il meccanismo di
negazione della negazione sarà alla base di quella specificità del soggetto tossicodipendente che nega continuamente la verità, i suoi comportamenti, i suoi sentimenti, il suo stesso sintomo: da tale meccanismo di difesa dalla propria rabbia inconscia deriva la peculiare “falsità” che rende i tossicodipendenti spesso così “odiosi” e infidi, “moralmente” deprecabili.
Conclusioni
Da questa sommaria descrizione delle dinamiche psichiche che
sottendono allo sviluppo di una personalità dipendente, possiamo più
53
facilmente comprendere le dinamiche controtransferali che si mettono
in moto di fronte a un paziente tossicodipendente. Abbiamo assistito
infatti allo svilupparsi di due reazioni opposte, e forse complementari,
che potremmo così schematizzare:
- controtransfert “salvifico”, che ha determinato negli anni ’80 il moltiplicarsi di strutture comunitarie pronte ad accogliere i tossicodipendenti con il messaggio del “io ti salverò”;
- controtransfert negativo, determinato dall’aspetto infido e manipolatore della personalità tossicomanica e che forse ha condizionato
anche il rifiuto delle istituzioni psichiatriche a farsene carico.
Concludiamo con l’auspicio che operatori dei SerT, delle Comunità
Terapeutiche e delle Psichiatrie possano finalmente incontrarsi per riflettere insieme sul vissuto controtransferale degli operatori e per poter
comprendere meglio gli aspetti psicopatologici della tossicodipendenza.
Bibliografia
Ammaniti, M., Stern, D. Attaccamento e psicoanalisi. Laterza, Bari, 1992.
Bergeret, J., Fain, M., Bandelier, M. Lo psicoanalista in ascolto del tossicomane. Dedalo, Bari, 1983.
Bowlby, J. (1969) Attaccamento e perdita, vol.1: L’attaccamento alla madre. (Tr. It.)
Boringhieri, Torino 1972.
Bowlby, J. (1973) Attaccamento e perdita, vol.2: La separazione dalla madre. (Tr. It.)
Boringhieri, Torino 1978.
Bowlby, J. (1980) Attaccamento e perdita, vol.3: La perdita della madre. (Tr. It.)
Boringhieri, Torino 1983.
Cancrini, L. Quei temerari sulle macchine volanti. NIS, Roma, 1982.
Cancrini, L., La Rosa, C. Il vaso di Pandora. NIS, Roma, 1991.
Cirillo, S., Berrini, R., Cambiaso, G., Mazza, R. La Famiglia del tossicodipendente.
Raffaello Cortina, Milano, 1996.
Clerici, M. Tossicodipendenza e psicopatologia. Implicazioni diagnostiche e valutazione degli interventi terapeutici. Franco Angeli, Milano, 1993.
Kernberg, O.F. (1975) Sindromi marginali e narcisismo patologico. (Tr.it.) Boringhieri,
Torino 1978.
Kohut, H. (1977) La guarigione del Sé. (Tr. it.) Boringhieri, Torino 1980.
Laufer, M., Laufer, E. Adolescenza e break-down evolutivo. Boringhieri, Torino, 1986.
Lo Russo, A. La presa in carico: ovvero la costruzione di uno spazio terapeutico.
ITACA, 1, 3, 30 - 36, 1997.
Lo Russo, A. Il gioco dell’identificazione proiettiva. ITACA, 4, 11, 40 - 45, 2000.
Meltzer, D. (1986) Studi di metapsicologia allargata. (Tr. it.) Raffaello Cortina, Milano 1987.
Olievenstein, C. L’infanzia del tossicomane. Arch. Psicol, Neurol. e Psich., XLI, 201 –
227, 1981.
Perrella, E. Per una clinica delle dipendenze. Franco Angeli, Milano 1998.
Rosenfeld, H. (1965) Stati psicotici. (Tr. it.) Armando, Roma 1973.
Selvini Palazzoli, M., Cirillo, S., Selvini, M., Sorrentino, A.M. I giochi psicotici nella
famiglia. Raffaello Cortina, Milano, 1988.
54
Limiti e prospettive degli strumenti diagnostici
nella clinica della Doppia Diagnosi
R. SCIOLI * - G. CARRÀ * - F. BARALE *
Il modello metodologico utilizzato per giungere alla diagnosi in medicina, per cui, dai segni patognomonici, si deduce l’esistenza di casi
concreti, mal si adatta alla psichiatria, anzitutto perché, fino ad oggi,
nella nostra disciplina non esistono malattie, ma al massimo sindromi
o disturbi.
Infatti, il tentativo di affermare che esistono alcune unità naturali di
malattia, per esempio nel campo delle psicosi, ha fallito lo scopo, giacché non si conoscono costrutti patognomonici associati a queste categorie, né legami definiti tra le categorie, né agenti eziologici specifici
ad alcuna categoria (Crow, 1998).
Sebbene viviamo nell’epoca dell’egemonia del DSM IV, nato con la
pretesa di una totale ateoreticità, per cui i vari disturbi dovrebbero essere definiti empiricamente solo in maniera descrittiva, nella pratica
corrente i clinici talora lo utilizzano erroneamente come se si trattasse
di un elenco di malattie, che invece dovrebbero essere definite anche
dalle cause o per lo meno dalla fisiopatogenesi. In tal modo si perde il
principale vantaggio dei sistemi diagnostici di tipo categoriale, che
consiste proprio nella possibilità di identificare gruppi omogenei di
diagnosi per la ricerca ed anche di costituire una base su cui formulare
una prognosi, tentando di uniformare i linguaggi descrittivi ed i criteri
diagnostici della psichiatria, come punto di partenza per effettuare una
ricerca empirica.
Non è questa la sede in cui elencare pregi e difetti dei sistemi di classificazione categoriale, ma tra le principali argomentazioni dei detrattori
vi è anche la “produzione” di eccessive diagnosi e lo scarso avanzamento di ricerche di tipo eziologico (Goldberg, 1996). Secondo tale
*
Dipartimento SSAPP - Sezione di Psichiatria, Università di Pavia
Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia
55
tesi, i metodi statistico-quantitativi avrebbero dato la possibilità di
mantenere categorie diagnostiche omogenee, ma avrebbero prodotto
diagnosi multiple (Andrade, 1994).
Il termine comorbidità è divenuto solo recentemente consueto in psichiatria, sia per l’introduzione dei criteri operazionali per specifici disturbi mentali, sia per i conseguenti “shift” da un paradigma all’altro
nella ricerca in psicopatologia, così come accade nel modello
neokraepeliniano, dominante in molti paesi.
Su questo concetto e sul suo significato vi è totale mancanza di consenso, ma studi epidemiologici di larga scala in vari paesi e condotti con
analisi statistiche sofisticate, concludono che la comorbidità non è un
semplice artefatto e che la coesistenza di più di un disturbo in una persona non è un fenomeno raro ed anzi, se considerata lifetime, è più la
regola che l’eccezione (Wittchen, 1996).
Nei tossicodipendenti l’affidabilità delle diagnosi psichiatriche è stata
particolarmente messa in discussione a causa della difficoltà a distinguere la gerarchia tra le diagnosi e cioè quali siano secondarie all’uso
di sostanze e quali siano invece i disturbi primari, dell’elevata prevalenza di disturbi da uso di sostanze in popolazioni di pazienti psichiatrici e del mascheramento reciproco dei sintomi delle due patologie.
Una diagnosi accurata in questi pazienti è resa difficoltosa, inoltre, anche dall’attitudine di questi pazienti a mettere in atto meccanismi difensivi tipici (negazione, minimizzazione ecc.).
La costruzione e l’uso di strumenti di valutazione per esaminare pazienti psichiatrici con disturbi mentali è sembrato quindi utile a molti
autori (Carey et al, 1996), anche per sfidare la complessità del problema della “doppia diagnosi” non solo dal punto di vista diagnostico, ma
anche terapeutico (Sheean, 1993).
La valutazione diagnostica è utilizzata per avviare i pazienti ad interventi e trattamenti efficaci, nel caso in cui essi siano indicati attraverso
una considerazione preliminare dei singoli casi (Lehman, 1994;
Mowbray et al, 1997), anche a causa del gran numero di drop out (Siegal
et al, 1995). Uno degli scopi principali consiste nell’evidenziare specifici indicatori di risultato. Inoltre, poiché la tossicodipendenza non è
un fenomeno ad una dimensione, la diagnosi deve essere multidimensionale ed esplorare le aree di funzionamento tipicamente compromesse
nei pazienti tossicodipendenti (McLellan, 1979, 1980).
Il fine principale della valutazione del paziente consiste in un’accurata
diagnosi delle condizioni di abuso e dipendenza e delle relazioni tra
queste ed altri disturbi psichiatrici e fisici, giacché per pianificare interventi in questo tipo di pazienti occorre confrontarsi con le difficoltà
56
che scaturiscono dalle varie declinazioni della patologia psichiatrica e
d’abuso, dalla loro gravità e dal loro decorso (Mowbray et al, 1997).
La stabilità dei sintomi è un elemento fondamentale per distinguere tra
disturbi cronologicamente primari o secondari. Inoltre l’età di esordio,
i periodi di remissione e di scomparsa dei sintomi offrono significative
informazioni utili ai fini diagnostici. Per quanto riguarda i disturbi in
Asse II, il clinico deve fare un’osservazione che riguardi il funzionamento lifetime e non solo il periodo della valutazione, spesso caratterizzato da un miscuglio di sintomi floridi legati anche alle sostanze. La
diagnosi quindi non va posta dopo la prima valutazione (Oyefeso, 2002),
anche perché il rischio di errori diagnostici è elevato ed è particolarmente cruciale con un primo episodio di psicosi in cui ci sia un elevato
abuso di sostanze (Cantwell et al., 1999).
Il miglioramento delle condizioni psichiche si ritiene che influenzi
positivamente tutte le altre aree indagate, compresa quella riguardante
l’abuso (Mc Lellan et al., 1981; Alterman et al., 1993). Ma su quale sia
l’indicatore più utile ai fini prognostici non vi è concordanza: più recentemente, attraverso la somministrazione dell’ASI, si è sottolineato
che il composite score nell’area del consumo di sostanze non è sempre
un indicatore efficace né sufficientemente predittivo nel prevedere la
compliance al trattamento, mentre lo sono il sesso, la razza (caucasica)
e un punteggio elevato nell’area dell’impiego lavorativo (McCaul et
al., 2001).
L’enfasi posta sul problema della diagnosi è criticata da chi ritiene che,
in tal modo, si dimentichi la “persona” del paziente; in realtà, la scarsa
considerazione in cui il processo diagnostico è tenuto da alcuni è di
pregiudizio ad una completa conoscenza. Anche la scarsità di tempo a
disposizione per la valutazione può portare a trascurare elementi clinici indispensabili (Fioritti & Solomon, 2002). Infatti, un modo più sofisticato di diagnosticare i disturbi mentali e di studiarne le radici (Van
Praag, 1996), invita, dal punto di vista pratico, a non trascurare nel
trattamento alcuna declinazione della sofferenza del paziente.
Nel campo delle tossicodipendenze in generale esistono due tipi di test
di valutazione:
• Test di Screening: identificano popolazioni a rischio, ma ovviamente non sostituiscono un’anamnesi accurata, nè permettono valutazioni diagnostiche.
• Test di Assessment: standardizzano la selezione di avvio al trattamento e lo studio degli outcome diminuendo quindi la possibilità di
trascurare domande o segni riguardanti sintomi significativi.
Tra questi se ne descriveranno solo alcuni tra i più usati.
57
I Test di assessment
Negli USA, dall’ultimo ventennio del secolo scorso, è sorta l’esigenza
di razionalizzare e sistematizzare approcci più formali alla diagnosi ed
al trattamento dei disturbi da uso di sostanze, soprattutto per aumentare la qualità della cura, pur contenendo il crescente aumento dei costi.
La Structured Clinical Interview for DSM III-R (SCID) (Spitzer et al.,
1992), disponibile sia per uso di ricerca sia clinico (First et al., 1994),
ha dimostrato una buona reliability per il disturbo da uso di sostanze,
ma meno buona per disturbi in comorbidità come ansia e depressione
(Skre et al., 1991), un’ottima affidabilità nei disturbi correlati all’abuso, moderata per la depressione e la personalità antisociale, scarsa per
i disturbi d’ansia (Kranzler et al., 1996).
Superiore nell’affidabilità al semplice esame urine o alle diagnosi cliniche al momento del ricovero o della dimissione anche per pazienti
ricoverati (Albanese et al., 1994), ha ottimizzato la validità e l’affidabilità
delle diagnosi psichiatriche.
La reliability della SCID nei disturbi da uso di sostanze è stata dimostrata negli adulti, ma anche fra gli adolescenti è stato possibile dimostrare un elevato grado d’attendibilità per l’abuso di alcool e di sostanze (Martin et al., 2000).
La versione italiana secondo il DSM III-R è stata utilizzata per valutare la prevalenza dei disturbi di personalità e dei loro modelli di
comorbidità con i disturbi in Asse I nei pazienti psichiatrici ospedalizzati,
confermando un’associazione significativa tra personalità antisociale e
disturbo da uso di sostanze, come già riscontrato da vari autori
(Marinangeli et al., 2000).
In pazienti ambulatoriali affetti da depressione, è stata anche utilizzata
con successo per valutare se uno specifico abuso di sostanze preceda o
segua l’inizio del disturbo dell’umore, sottolineando l’uso di alcool e
di cocaina come automedicazione (Abraham & Fava, 1999): si è inoltre evidenziato che la gravità dell’abuso di sostanze non è correlata alla
configurazione precoce di un quadro di psicosi (Rabinowitz et al., 1998).
I quesiti che ci si deve porre riguardo l’affidabilità diagnostica sono
relativi a vari aspetti: la veridicità dei resoconti dei tossicodipendenti
sui propri disturbi psichici, l’eventuale sovrapposizione di sintomi direttamente dovuti all’abuso di sostanze, che produce di per se stesso
sintomi psichici e quindi rende più problematica la diagnosi psichiatrica, la possibilità che categorie diagnostiche definite più strettamente
differiscano nell’affidabilità rispetto a categorie più ampie (per esempio depressione maggiore rispetto a disturbi dell’umore).
58
Proprio applicando la SCID, Bryant et al (1992) tentano di dare una
risposta a questi ed ad altri quesiti e giungono alla conclusione che il
gruppo di pazienti che non avevano mai usato sostanze e quello che le
aveva usate nel passato mostravano caratteristiche simili nell’affidabilità
dei loro resoconti su sintomi psichiatrici passati e presenti e che invece
nel gruppo dei consumatori attuali le diagnosi di disturbi dell’umore e
disturbi psicotici sono meno affidabili, perché ai sintomi psichiatrici si
sovrappongono gli effetti delle sostanze.
Altri autori, invece, hanno utilizzato la Composite International
Diagnostic Interview - CIDI - (Robins et al., 1988) per studiare a fondo
la comorbidità.
In pazienti ricoverati per disintossicazione, somministrando l’ASI
(McLellan et al, 1979; 1980) prima della disintossicazione e la CIDI
dopo la disintossicazione, si è evidenziato che l’inizio precoce dell’uso
di sostanze illecite è associato ad una più elevata comorbidità con i
disturbi in Asse II, piuttosto che con quelli in Asse I (Franken, Hendriks,
2000). In associazione con altri strumenti ha permesso di rilevare il
fatto che i pazienti con disturbo antisociale di personalità hanno un più
precoce esordio di abuso di sostanze e che i pazienti con disturbo di
personalità hanno una più elevata probabilità di presentare un disturbo
sull’asse I in comorbidità.
Entrambe non sono facilmente somministrate dai clinici, soprattutto
perché nei Servizi si lavora in genere in un clima di continua emergenza ed entrambi questi strumenti richiedono molto tempo per la loro
somministrazione.
Inoltre non mancano discordanze sulla sensibilità dei vari strumenti in
campo psicopatologico: confrontando i dati ottenuti attraverso l’ASI e
la SCID si conferma una buona specificità dell’ASI (Lehman et al.,
1996), mentre somministrando l’ASI e la CIDI si evidenzia che i due
strumenti su larga scala non concordano, poiché una parte dei casi con
note di psicopatologia vengono persi nelle misure di gravità ottenute
con l’ASI. Viene quindi confermata la validità della somministrazione
dell’ASI per la misura della gravità psicopatologica, mentre con la CIDI
si giunge a più precise diagnosi psichiatriche categoriali che soddisfano i criteri del DSM. In questo senso, assumendo come standard le
diagnosi del DSM, si evidenzia quindi che utilizzando solo l’ASI si
perderebbe una parte della psicopatologia (Eland-Goossensen et al.,
1997).
L’Addiction Severity Index nella sua quinta edizione (McLellan et al,
1992) è un’intervista semi strutturata relativamente breve (45 min), che
permette di tracciare un profilo multidimensionale dei pazienti tossi59
codipendenti in sette aree di funzionamento tradizionalmente compromesse dall’abuso di sostanze e che richiedono un trattamento aggiuntivo
(area medica, lavorativa, consumo di alcool, consumo di droghe, area
legale, delle relazioni familiari/sociali e dei problemi psichiatrici).
L’ASI fornisce in ciascun’area, attraverso una scala di autovalutazione
del paziente (4 punti), che mette in scala la percezione personale della
gravità dei propri problemi e della necessità di trattamento aggiuntivo,
un severity rating che deriva dall’assegnazione di un punteggio da parte dell’intervistatore (9 punti), con una stima della necessità di trattamento per il paziente. In ciascuna area si ricava inoltre un composite
score, basato soltanto sull’osservazione degli ultimi 30 giorni, il cui
range, calcolato attraverso algoritmi matematici, va da 0,0 a 1,0 e rappresenta una valutazione più obiettiva della gravità.
Dalla versione statunitense dell’ASI è stato in seguito tratto un adattamento europeo, l’Europ-ASI (Kokkevi & Hartgers, 1995; Pozzi et al,
1995).
Originariamente usata in pazienti dipendenti da oppiacei in trattamento metadonico, è ora utilizzata in un’ampia varietà di setting:
- Uso anamnestico-descrittivo,
- “Abbinamento” paziente - trattamento (McLellan et al, 1983), anche in base alla comorbidità per disturbi psichiatrici,
- Informazioni circa i campi in cui maggiore è l’urgenza di trattamento (Meulenbeek, 2000),
- Distinzione di sottogruppi di pazienti con doppia diagnosi in base
al funzionamento nei vari campi, mettendo i Servizi in condizioni
di pianificare interventi, che sono potenzialmente diversi (Lehman
et al, 1994).
Nel campo della ricerca ha permesso di stabilire un metro di confronto
sulla gravità dei problemi dei tossicodipendenti rispetto a quelli della
popolazione generale (Weisner et al, 2000).
Insieme ad altri strumenti ha offerto possibilità di verificare le
correlazioni tra diagnosi e funzionamento esistenziale (Mason et al.,
1998), per esempio con MMPI (Ball et al., 1997), SCID (Lehman et
al., 1996), CIDI (Eland-Goossensen, 1997).
Individua specifici indicatori, predittivi di outcome, per cui è possibile
una valutazione d’esito di programmi ambulatoriali, diurni e residenziali
Classicamente alcuni autori ritengono che il principale indicatore di
risultato sia la gravità dei sintomi psichiatrici (McLellan et al, 1983;
Rounsaville et al, 1986) ma, oltre alla gravità dei sintomi psichiatrici
(Mc Lellan, 1986), appaiono sicuramente importanti anche fattori am60
bientali quali ad esempio l’ampiezza del network e la disponibilità di
familiari accoglienti (Rutheford et al., 1994). Il miglioramento delle
condizioni psichiche influenza per alcuni positivamente tutte le altre
aree indagate, compresa quella riguardante l’abuso (Mc Lellan et al.,
1981; Alterman et al., 1993). Più recentemente, attraverso la
somministrazione dell’ASI, si è sottolineato che il CS nell’area del
consumo di sostanze non è un indicatore efficace né sufficientemente
predittivo nel prevedere la compliance al trattamento, mentre lo sono il
sesso, la razza (caucasica) e un CS elevato nell’area del lavoro (McCaul
et al., 2001).
Sebbene sia risultata minore l’utilità delle aree legale, familiare/sociale e dell’area riguardante il lavoro, l’ASI si conferma uno strumento
adeguato a distinguere sottogruppi di pazienti con doppia diagnosi in
base al funzionamento nei vari campi, mettendo i Servizi in condizione
di pianificare più correttamente i loro interventi (Lehman et al., 1994),
giacché di solito il riscontro complessivo della gravità della
psicopatologia non si è rivelato sufficiente per valutare l’impatto di
questa dimensione sull’outcome del trattamento.
Va ricordato, per completezza, che più recentemente sono emersi risultati opposti (Saxon et al., 1996), analizzando i probabili fattori predittivi di outcome in pazienti sottoposti a terapia di mantenimento con
Metadone ove, al contrario, se alti valori di gravità psichiatrica nell’ASI
inducono questi soggetti, prima di incominciare il trattamento, ad utilizzare la droga come auto-medicazione, in seguito, grazie all’effetto
ansiolitico, antipsicotico e antidepressivo del Metadone, con l’inizio
del trattamento sembrano avere meno bisogno di ricorrere alle sostanze. D’altronde, anche in pazienti cocaino-dipendenti si dimostra talora
che la gravità psichiatrica, tratta dai composite scores, non sempre si
mostra un valido indicatore del futuro esito dei trattamenti (Tidey et
al., 1998). Non mancano inoltre possibilità di variazioni dipendenti dal
setting (Appleby et al., 1997) e possibilità di errore legate
all’intervistatore, al paziente o allo strumento stesso (Zanis et al., 1997)
per cui, assumendo come standard le diagnosi del DSM IV, se si utilizza solo l’ASI, si perde una parte della psicopatologia (Eland-Goossensen
et al., 1997)
Nel Regno Unito, l’adattamento Europeo dell’ASI non ha avuto un
grosso seguito per la necessità di molto tempo per la somministrazione.
Ciò ha stimolato l’attenzione alla costruzione di tipi di strumenti più
snelli, come il Maudsley Addiction Profile - MAP - (Marsden et al.,
1998). Tale strumento è stato validato insieme al Treatment Perception
61
Questionnaire (TPQ) (Marsden et al., 2000) anche in Italia, Portogallo
e Spagna.
Il MAP è stato concepito come una breve intervista strutturata per una
diagnosi multidimensionale che può essere somministrato prima di iniziare il trattamento, in determinati momenti di questo ed alla fine. Le
domande riguardano la condotta d’abuso, i sintomi fisici e psichici ed
il funzionamento sociale, comprendendo dati sull’abitazione, sul lavoro, sulle relazioni sociali e sul comportamento criminoso. Questo strumento si differenzia dall’ASI perché, omettendo l’osservazione lifetime,
esplora la situazione attuale del paziente e cioè quella soggetta ad eventuale cambiamento. Raccoglie inoltre dati precisi anche sui comportamenti a rischio, fattore poco evidenziato nell’ASI e, nell’area dell’abuso, prende in esame anche la dose media di una giornata-tipo e non
solo la frequenza di assunzione, nella presunzione che il miglioramento possa consistere sia in una diminuzione della frequenza di assunzione sia in una diminuzione della dose, pur rimanendo invariata la frequenza. Tale importanza data alla dose giornaliera manca totalmente
nell’ASI.
Nel confronto tra Europ-Addiction Severity Index e MAP si riscontrano differenze sull’accuratezza della valutazione dei comportamenti a
rischio ma, nell’area riguardante la salute psichica, il MAP prende in
considerazione solo i sintomi depressivi e d’ansia, mentre con l’ASI
può essere vagliata anche la presenza di sintomi psicotici.
Nel complesso i due strumenti sembrano integrarsi: il MAP fornisce
una più accurata descrizione dell’attualità, mentre l’Europ-ASI mostra
maggiore completezza anamnestica e più ampio spettro di valutazione
nell’area psichiatrica, specialmente se applicata a pazienti con doppia
diagnosi.
Conclusioni
I Servizi che si accingono a prendere in carico pazienti con doppia
diagnosi devono affrontare urgenti problemi. La presenza di eccessive
barriere culturali, che differenziano i settino, e una definizione troppo
rigida dei programmi e della competenza territoriale da parte di ciascuno dei due Servizi sono di ostacolo alla continuità terapeutica, essenziale per farsi carico della complessità dei bisogni individuali di questi
pazienti che necessitano di una più stretta integrazione. Inoltre i Servizi, sia per le dipendenze sia psichiatrici, adottano talora mezzi di valu62
tazione e di diagnosi approssimativi, non disponendo sempre di uno
staff adeguatamente formato.
I risultati dei test stanno diventando indispensabili per razionalizzare
le decisioni in merito al trattamento: nessun singolo trattamento funziona per tutti i pazienti, ma risulta indispensabile che il trattamento
sia personalizzato sulla base delle caratteristiche individuali dei singoli. La scelta del setting di trattamento più appropriato, infatti, include
numerosissime considerazioni che includono la presenza o meno di
sintomi d’astinenza attuali o passati, precarietà delle condizioni di salute fisica, i fallimenti della terapia nel passato, la presenza di comportamenti a rischio e di comorbidità psichiatrica (Schinka et al., 1998).
L’uso degli strumenti di valutazione in questo campo limita la soggettività di giudizio dell’intervistatore e permette di suddividere in gruppi
più omogenei i pazienti con doppia diagnosi, in base ai deficit di funzionamento nei vari campi, su cui è necessario intervenire con interventi terapeutici e riabilitativi.
Per questo, dove è possibile, viene applicato più di uno strumento, anche ai fini di rendere la valutazione più sistematica e quantificabile.
Mentre è chiaro che tale approccio offre vantaggi dal punto di vista
clinico e dell’organizzazione dei Servizi, non è ancora stato dimostrato
se abbia minori costi rispetto all’approccio basato sulla semplice osservazione clinica.
Bibliografia
Abraham, H.D., Fava, M. Order of onset of substance abuse and depression in a sample
of depressed outpatients. Comprehensive Psychiatry 40/1: 44-50, 1999.
Albanese, M.J., Bartel, R.L., Bruno, R.F., Morgenbesser, M.W., Schatzberg, A.F.
Comparison of measures used to determine substance abuse in an inpatients
psychiatric population. American Journal of Psychiatry 151(7): 1077-78, 1994.
Alterman, A.I., McLellan, A.T., Shifman, R.B. Do substance abuse patients with more
psychopatology receive more treatment? The Journal of Nervous and Mental
Disease 181: 576-82, 1993.
Andrade, L., Eaton, W.W., Chilcoat, H. Lifetime comorbidity of panic attacks and
major depression in a population-based study. British Journal of Psychiatry 165:
363-9, 1994.
Appleby, L., Dyson, V., Altman, E., Luchins, D.J. Assessing substance use in
multiproblem patients: reliability and validity of the Addiction Severity Index in a
mental hospital population. The Journal of Nervous and Mental Disease 185: 15965, 1997.
63
Ball, S.A., Carrol, K.M., Robinson, J.E., O’Malley, S.S. Addiction severity and MMPIderived typologies in cocaine abusers. American Journal of Addiction 6(1):83-8,
1997.
Bryant, K.J., Rounsaville, B., Spitzer, R.L., Williams, J.B.W. Reliability of Dual
Diagnosis. Substance dependence and psychiatric disorders. The Journal of Nervous
and Mental Disease 180 (4): 251-57, 1992.
Cantwell, R., Brewin, J., Glazebrook, C., Dalkin, T., Fox, R., Medley, I., Harrison, G.
Prevalence of substance misuse in first episode psychosis. British Journal of
Psychiatry 174: 150-153, 1999.
Carey, K.B., Cocco, K.M., Simons, J.S. Concurrent validity of clinicians’ ratings of
substance abuse among psychiatric outpatients. Psychiatric Services 47: 842-47,
1996.
Crow, T.J. From Kraepelin to Kretschmer leavened by Schneider. Archives of General
Psychiatry 55: 503-04, 1998.
Eland-Goossensen, A., van der Goor, I.A.M., Garretsen, H.F.L., Schudel, J. Screening
for psychopathology in the clinical practice. Journal of Substance Abuse Treatment
14: 585-91, 1997.
Fioritti, A., Solomon, J. Doppia diagnosi. Epidemiologia, clinica e trattamento. Franco Angeli, Milano, pag. 103, 2002.
First, M.B., Frances, A.J., Pincus, H.A., Vettorello, N., Davis, W.W. DSM IV in progress.
Changes in substance related schizophrenic and other primarily adult disorders.
Hospital Community Psychiatry 45 (1): 18-20, 1994.
Franken, I.H.A., Hendriks, V.M. Early onset of illicit substance use is associated with
greater axis-II comorbidity. Not with axis-I comorbidity. Drug and Alcohol
Dependence 59/3: 305-308, 2000.
Goldberg, D. A dimensional model for common mental disorders. British Journal of
Psychiatry 168 (30 suppl): 44-49, 1996.
Kokkevi, A., Hartgers, C. EUROP-ASI: European adaptation of a multidimensional
assessment instrument for drug and alcohol dependence. European Addiction
Research 1: 208-210, 1995.
Kranzler, H.R., Kadden, R.M., Babor, T.F., Tennen, H., Rounsaville, B.J. Validity of
the SCID in substance abuse patients. Addiction 91 (6): 859-68, 1996.
Lehman, A.F., Myers, C.P., Dixon, L.B., Johnson, J.L. Defining subgroups of dual
diagnosis patients for service planning. Hospital and Community Psychiatry 45:
556-61, 1994.
Lehman, A.F., Myers, C.P., Dixon, L.B., Johnson, J.L. Detection of substance use
disorders among psychiatric inpatients. The Journal of Nervous and Mental Disease
184: 228-33, 1996.
Marinangeli, M.G., Butti, G., Scinto, A., Di Cicco, L., Kalyvoka, A., Petruzzi, C.,
Ross, A. Valutazione della prevalenza di disturbi di personalità in una popolazione
di pazienti psichiatrici ospedalizzati per disturbi dell’umore, disturbi da uso di
sostanze psicoattive e disturbi d’ansia. Epidemiologia e Psichiatria Sociale 9: 3644, 2000.
Marsden, J., Nizzoli, U., Corbelli, C., Margaron, H., Torres, M., Prada de Castro, I.,
Stewart, D., Gossop, M. (2000) New european instruments for treatment outcome
64
research: reliability of the Maudsley Addiction Profile and Treatment Perceptions
Questionnaire in Italy, Spain and Portugal. European Addiction Research 6: 115122, 2000.
Marsden, J., Gossop, M., Stewart, D., Best, D., Farrel, M., Lehemann, P., Edwards, C.,
Strang, J The Maudsley Addiction Profile (MAP): A brief instrument for assessing
treatment outcome. Addiction 93(12): 1857-67, 1998.
Martin, C.S., Pollock, O.G., Bukstein, O.G., Lynch, K.G. Inter-rater reliability of the
SCID alcohol and substance use disorders section among adolescets. Drug and
Alcohol Dependence 59/2: 173-176, 2000.
Mason, B.J., Kocsis, J.H., Melia, D., Khuri, E.T., Sweeney, J., Wells, A., Borg, L.,
Millman, R.B., Kreek, M.J. Psychiatric comorbidity in methadone maintained
patients. Journal of Addictive Disease 17(3): 75-89, 1998.
McCaul, M.E., Svikis, D.S., Moore, R.D. Predictors of outpatients treatment retention:
patient versus substance use characteristic. Drug and Alcohol Dependence 62: 917, 2001.
McLellan, A.T., Kushner, H., Metzger, D., Peters, R., Smith, I., Grissom, G., Pettinati,
H., Argeriou, M. The fifth edition of the Addiction Severity Index : Historical
critique and normative data. Journal of Substance Abuse Treatment 9: 199-213,
1992.
McLellan, A.T., Luborsky, L., Erdlen, F.R., LaPorte, D.J., Intitolo, V. The Addiction
Severity Index: a diagnostic/evaluative profile of substance abuse patients. In:
Gottheil, E., McLellan, A.T., Druley, K.A. (eds) Treatment of substance abuse among
the psychiatric illness. New York, Pergamon, 1979.
McLellan, A.T., Luborsky, L., Woody, G.E., Druley, K.A., O’Brien, C.P. Predicting
response to drug and alcohol treatment: Role of psychiatric severity. Archives of
General Psychiatry 40, 620-25, 1983.
McLellan, A.T., Luborsky, L., Woody, G.E., O’Brien, C.P. An improved diagnostic
evaluation instrument for Substance Abuse patients. The Journal of Nervous and
Mental Disease 168: 26-33, 1980.
McLellan, A.T., Luborsky, L., Woody, G.E., O’Brien, C.P., Kron, R. Are the “Addictionrelated” problems of substance abuse really related? The Journal of Nervous and
Mental Disease 169: 232-39, 1981.
McLellan, A.T. “Psychiatric severity” as a predictor of outcome from substance abuse
treatments. In: Meyer E. (ed.) Psychopathology and Addictive Disorders. New York,
The Guilford Press, 1986.
Meulembeek, P.A.M. Addiction problems and methadone treatment. Journal of
Substance Abuse Treatment 19(2): 171-74, 2000.
Mowbray, C.T., Ribisl, K.M., Solomon, M., Luke, D.A., Kewson, T.P. Characteristics
of Dual Diagnosis patients admitted to an urban, public psychiatric hospital: an
examination of individual, social, and community domains. American Journal of
Drug and Alcohol Abuse 23: 309-26, 1997.
Oyefeso, A. Problems and issues of conceptualisation. In: Rassool, G.H. (ed.) Dual
Diagnosis. Blackwell Science, Oxford, pag. 37, 2002.
65
Pozzi, G., Tacchini, G., Di Giannantonio, M., Tempesta, E. Disturbi mentali nei tossicodipendenti in trattamento: studio di prevalenza e valutazione retrospettiva mediante interviste diagnostiche strutturate. Minerva psichiatrica 36: 139-54, 1995.
Rabinowitz, J., Bromet, E.J., Lavelle, J., Carlson, G., Kovansznay, B., Schwartz, J.E.
Prevalence and severity of substance use disorders and onset of psychosis in first
admission psychotic patients. Psychological Medicine 28/6: 1411-19, 1998.
Robins, L.N., Wing, J., Wittchen, H.U., Helzer, J.E., Babor, T.F., Burke, J., Farmer, A.,
Jablenski, A., Pickens, R., Regier, D.A. et al. The Composite International
Diagnostic interview. An epidemiological instrument suitable for use in conjunction
with different diagnostic System and in different cultures. Archives of General
Psychiatry 45, 1069-77, 1988.
Rounsaville, B.J., Kosten, T.R., Weissman, M.M., Kleber, H.D. Prognostic significance
of psychopatology in treated opiate addicts. A 2.5 years follow-up study. Archives
of General Psychiatry 43: 739-45, 1986.
Rutheford, M.J., Metzger, D.S., Alterman, A.I. Parental relationships and substance
use among methadone patients: The impact on levels of psychological
symptomatology. Journal of Substance Abuse Treatment 5: 415-23, 1994.
Saxon, A.J., Wells, E.A., Fleming, C., Jackson, T.R., Calsyn, D.A. Pre-treatment
characteristic, program philosophy and level of ancillary services as predictors of
methadone maintenance treatment outcome. Addiction 91: 1197-1209, 1996.
Schinka, J.A., Francis, E., Hughes, P., LaLone, L., Flynn, C. Comparative outcomes
and costs of inpatients care and supportive housing for substance-dependent
veterans. Psychiatric Services 49/ 7: 946-50, 1998.
Sheehan, M.F. Dual diagnosis. Psychiatric Quarterly 64: 107-34, 1993.
Siegal, H.A., Fisher, J.H., Rapp, R.C., Wagner, J.H. Presenting problems of substance
abusers in treatment: implications for service delivery and attrition. American
Journal of Drug and Alcohol Abuse 21: 17-26, 1995.
Skre, I., Onstad, S., Torgersen, S., Kringlen, E. High interrater reliability for the Stuctured
Clinical interview for DSM-IIIR Axis I (SCID-I). Acta Psychiatrica Scandinavica
84(2): 167-73, 1991.
Spitzer, R.L., Williams, J., Gibbon, M. Structured clinical interview for DSM-III-R
(SCID): user’s guide. Washington DC, American Psychiatric Press, 1992.
Tidey, J.W., Mehl Madrona, L., Higgins, S.T., Badger, G.J. Psychiatric symptoms
severity in cocain-dependent outpatients: demographics, drug use characteristic
and treatment outcomes. Drug and Alcohol Dependence 50 (1): 9-17, 1998.
Van Praag, H.M. Comorbidity (Psycho)analyzed. British Journal of Psychiatry 168,
(30 suppl): 129S-34S, 1996.
Weisner, C, McLellan, A.T., Hunkeler, E.M. Addiction Severity Index data from general
membership and treatment samples of HMO members- One case of norming the
ASI. Journal of Substance Abuse Treatment; 19(2): 103-09, 2000.
Wittchen, H.U. What is comorbidity - Fact or Artefact?. British Journal of Psychiatry
168, (30 suppl): 7-8, 1996.
Zanis, D.A., McLellan, A.T., Corse, S. Is the Addiction Severity Index a reliable
instrument among clients with severe and persistent mental illness and substance
abuse disorders? Community Mental Health 33:213-217, 1997.
66
Disturbo da uso di sostanze e comorbilità psichiatrica
cenni e prospettive terapeutiche mirate
G. GERRA * - A. ZAIMOVIC * - G. MOI *
M. BUSSANDRI * - C. BUBICI *
La relazione tra disturbi psichiatrici
e disturbi da uso di sostanze
La considerazione del fatto che il disturbo additivo (dipendenza e/o
abuso di sostanze) possa essere associato a un disturbo psichiatrico si
va sempre più affermando sia in ambito scientifico che tra coloro che
direttamente si occupano di tossicodipendenti e di alcolisti. Se in passato si sono potuti liquidare in modo sbrigativo i disturbi psichiatrici
dei tossicodipendenti come semplici conseguenze dell’assunzione delle sostanze psicoattive, in questi ultimi tempi una crescente mole di
evidenze documenta come, nelle diverse storie cliniche, il disturbo psichiatrico possa precedere, associarsi, o conseguire all’uso di sostanze,
costituendosi, tra le due condizioni, rapporti che possono essere, di
volta in volta, di autocura, di causalità o di semplice associazione
(Rounsaville, Luthar, 1993).
Occorre sottolineare come ad associarsi con i disturbi da uso di sostanze non sia sempre un quadro psichiatrico conclamato: più spesso si
tratta di condizioni “di confine”, cioè quadri intermedi tra le difficoltà
temperamentali, relazionali e di natura psicopatologica che entrano in
un coinvolgimento e in un equilibrio possibile con l’assunzione di droghe, venendone modificati, cristallizzati oppure condotti a lunghi periodi di latenza nella storia che va dalla adolescenza alla prima giovinezza (Gerra, 1994).
In questo senso, grande attenzione deve essere posta, dal punto di vista
clinico, alla sequenza cronologica con cui si presentano i disturbi psichici
e quelli addittivi (Kaye et al., 1998): infatti, l’esordio di sintomi psicotici
immediatamente successivo all’assunzione di psico-stimolanti non ha
*
Centro Studi Farmacotossicodipendenze Ser.T. AUSL di Parma
67
lo stesso significato degli stessi sintomi che compaiono a distanza di
tre mesi dall’assunzione di cocaina. Tutte le sostanze da abuso sono
capaci di “mimare” i disturbi psichiatrici e se la diagnosi duale è posta
in un periodo troppo ravvicinato alla disassuefazione c’è il rischio di
una sopravvalutazione dei livelli di comorbidità psichiatrica.
Anche in relazione agli studi sulla comorbidità psichiatrica non si possono equiparare le diagnosi attribuite ai pazienti nel corso della vita
(lifetime) con quelle attuate direttamente sui pazienti al momento dello studio (current).
L’incidenza dei disturbi psichiatrici tra i pazienti
affetti da disturbo da uso di sostanze
Una recente valutazione su soggetti in trattamento per la dipendenza
da sostanze, secondo i criteri del DSM, ha rilevato la presenza anche di
notevoli differenze di genere nelle percentuali ottenute e evidenzia,
comunque, un prevalere dei disturbi di personalità del cluster drammatico, dei disturbi d’ansia e del tono dell’umore nel campione studiato
(Comptom et al., 2000). Uno studio sui soggetti in trattamento
metadonico pubblicato sugli Archives (Brooner et al., 1997) mostra
che circa il 48 % dei soggetti maschi studiati e il 47% delle femmine
sono affetti dai disturbi psichiatrici.
Le percentuali di patologie di asse I e asse II individuate da Brooner
mettono in luce una prevalenza della depressione nei soggetti di sesso
femminile (24% vs 9%) e del disturbo di personalità antisociale nei
soggetti di sesso maschile (40% vs 15%). Vistose sono anche le differenze della diagnosi lifetime rispetto alla diagnosi attuata al momento
dello studio.
Una verifica della comorbidità psichiatrica all’interno di una unità di
disassuefazione mostra percentuali molto più elevate di disturbi psichiatrici, a riprova del fatto che la valutazione a ridosso della
disassuefazione comporta il rischio di una sovrastima dei disturbi mentali in questi pazienti (Craig, Di Buono, 1993). Anche nelle popolazioni dei cocainomani sono state evidenziate elevate percentuali di diagnosi duale, con un prevalere del disturbo di personalità antisociale tra
le diagnosi lifetime. Al contrario tale diagnosi non sembra prevalere
numericamente nella diagnosi attuale dove si incontrano maggiormente i disturbi affettivi e le fobie (Halikas et al., 1994). Del tutto più consistenti la quota di depressione e di ideazione suicida rilevabili nei
68
cocainomani senza che sia possibile verificare quale sia la relazione di
causalità tra questi disturbi e la cocaina.
Per poter affermare che la diagnosi duale sia veramente tale, occorre
poter verificare anamnesticamente che i disturbi psichiatrici hanno preceduto il disturbo di uso da sostanze di almeno 6 mesi, oppure che i
criteri per la diagnosi sono stati riscontrati in un periodo di astensione
dalle droghe che si è prolungato per 6 mesi. Nel caso in cui si tenga
conto di questi criteri, le diagnosi precedentemente poste senza di essi
risulteranno inconsistenti in una percentuale superiore al 75% (Kadden
et al., 1994).
Comorbidità psichiatrica e interventi mirati
La necessità di combinare la tipologia dei pazienti con specifici trattamenti è particolarmente sentita nell’ambito clinico che si occupa di
dipendenze e potrebbe massimizzare i vantaggi terapeutici grazie a un
assessment individuale del paziente (Boyarsky, McCance, 2000). Ma
il machting paziente-trattamento risulta particolarmente difficile in relazione alla disomogeneità dei campioni studiati, alle metodologie di
trattamento non standardizzate, e alle sovrapposizioni tra terapie prescritte e farmaci da abuso. Tali difficoltà sono espresse da chi (Gastfriend
et al., 2000) elenca le difficoltà per la collocazione adeguata dei pazienti in trattamenti specifici. Una delle difficoltà maggiori che impedisce di considerare i pazienti tossicodipendenti secondo tipologie caratterizzate dalla comorbidità psichiatrica, o che comunque necessitano di un assessment individuale, è costituita dalla concezione della
tossicodipendenza come una sindrome isolata a sé stante, sostenuta da
quella situazione biologica che viene definita da Blum il tratto ipodopaminergico (Blum et al., 1995).
Se questa visione unitaria delle dipendenze patologiche ha una sua legittimità scientifica e un sicuro riscontro clinico, i disturbi da uso di
sostanze non possono essere interpretati con una modalità uniformante
che comporti un appiattimento diagnostico-terapeutico.
Al contrario, la dipendenza da sostanze deve essere caratterizzata e
analizzata in modo articolato e specifico, a partire da una serie di condizioni psichiche e comportamentali associate al disturbo additivo. Una
sorta di pato-plasticità vede la Reward Deficency Sindrome di Blum
assumere profili variegati quando alla condizione novelty seeking, alla
impulsività che non consente di dilazionare la fruizione delle gratificazione, alla suscettibilità e alla noia, si associano le connotazioni dei
69
disturbi di personalità o delle psicopatologie di asse I. In queste condizioni, alla disfunzione del tratto dopaminegico che sembrerebbe responsabile dell’RDS si assommano le possibili alterazioni biologiche
connesse con i disturbi psichiatrici.
Tipologie psicobiologiche di pazienti:
iniziali ricadute sulla pratica clinica
A fronte di questa ancora inesplorata e fitta serie di alterazioni neuroormonali associate, alcuni studi hanno iniziato a investigare lo specifico assetto biologico di tipologie di pazienti tossicodipendenti affetti da
comorbidità psichiatrica. La tipologia dei tossicodipendenti con storia
di disordini della condotta e iperattività mostra, ad esempio, una alterazione della sensibilità alfa-adrenergica che non sembra essere connessa con la storia di droga, ma piuttosto con la personalità antisociale
(Gerra et al., 1994). Proprio recentemente, si è dimostrata valida la
prospettiva che si propone di trattare i cocainomani con psicostimolanti,
in relazione alla storia clinica di disordine da deficit di attenzione con
iperattività: un trattamento diretto alla difficoltà di fondo del paziente e
alla relazione di tali disturbi con la cocaina, piuttosto che a contrastare
l’assunzione di cocaina di per sé (Levin et al., 1998; Schubiner et
al.,1995). Nostri studi hanno ripetutamente mostrato, almeno per quanto
concerne il controllo degli ormoni ipofisari, un deficit del sistema
serotoninergico negli eroinomani depressi, non verificabile invece negli eroinomani antisociali, in quelli in cui il disturbo additivo non si
associa alla comorbidità psichiatrica (Gerra et al., 1995a; 1995 b). A
tale proposito, diverse segnalazioni suggeriscono che l’associazione di
farmaci serotoninergici al trattamento con naltrexone possa essere vantaggiosa per migliorare l’outcome (Landabaso et al., 1998).
Altri Autori sostengono, comunque, la necessità di trattare con
antidepressivi i disturbi del tono dell’umore nei tossicodipendenti ottenendo, oltre a un miglioramento dei sintomi psichiatrici, anche un ridotto ricorso alle sostanze d’abuso (Nunes et. al., 1998).
Ancora nostri studi hanno investigato il sistema dopaminergico degli
eroinomani depressi, evidenziando una elevata sensibilità recettoriale
post-sinaptica in queste tipologie di pazienti: tale quadro biologico può
essere attribuito a una scarsa concentrazione di dopamina extracellulare
e a una verosimile eccessiva funzione del transporter della dopamina
(Gerra et al., 2000). Anche per questa condizione potrebbe essere ne70
cessaria una medicazione specifica rivolta al disturbo psichiatrico e ai
suoi correlati biologici.
In questa stessa ottica è stata investigata la funzione del sistema
GABAergico negli eroinomani disintossicati, con il rilievo di una stretta correlazione tra disturbi di personalità del cluster ansioso (ossessivocompulsivo) e una alterata risposta all’agonista GABA B baclofen
(Gerra et al., 1998). Non è escluso che in futuro si possano individuare
strategie specifiche che mettano in relazione l’intervento terapeutico
con gabaergici indirizzati ai disturbi d ’ansia.
Gli stessi studi di brain-imaging (SPECT) suggeriscono che la personalità antisociale e la depressione siano caratterizzate negli eroinomani
da alterazioni specifiche dei flussi cerebrali: una generalizzata modesta riduzione dei flussi è stata osservata in tutti gli eroinomani, a confronto con i soggetti normali di controllo, mentre vere e proprie riduzioni del flusso cerebrale venivano osservate in relazione ai disturbi
del tono dell’umore e all’antisocialità (Gerra et al., 1998).
Assessment individuale e temperamento
Se al disturbo da uso di sostanze non si associano disturbi psichiatrici
conclamati, comunque, la necessità di un assessment individuale, che
valuti gli aspetti del temperamento, del carattere e delle condizioni cliniche di confine, è essenziale per l’orientamento delle scelte del trattamento. Infatti, lo studio della funzione delle vie monoaminergiche (DA,
5-HT, NE), in eroinomani astinenti, ha mostrato correlazioni importanti tra le caratteristiche temperamentali e le risposte dopaminergiche
e serotoninergiche (Gerra et al., 2000). Il temperamento novelty seeking,
a questo proposito, è stato dimostrato assumere un ruolo predittivo della ritenzione in trattamento a lungo termine con i trattamenti nuovi
quali la buprenorfina, anche se, all’inizio della terapia, un maggior
numero di soggetti novelty seeking usciva dal protocollo (Helmus et
al., 2001).
Tipologie identificate tra i cocainomani
Le alterazioni biologiche che si verificano durante l’astensione dalla
cocaina, valutate durante le prime tre settimane dopo l’interruzione della
sostanza, comprendono un significativo deficit serotoninergico (Haney
et al., in press) ma, anche in questo caso, occorre tenere conto degli
71
aspetti anamnestici relativi alle varie tipologie della personalità. Differenze nella funzione serotoninergica sono state osservate in relazione a
tipologie di cocainomani con storia di impulsività e aggressività, più
precoce esordio della dipendenza, elevata incidenza di alcoolismo paterno (Buydens-Branchey et al., 1997; 1999) .
Il trattamento con desipramina ottiene un significativo miglioramento
dei sintomi depressivi e dell’outcome nei cocainomani con diagnosi
duale, ma non si mostra efficace in quei soggetti che sono affetti dal
disturbo additivo soltanto (Carroll et al., 1995). Dunque, anche il sistema noradrenergico appare coinvolto nei substrati biologici della depressione diagnosticata tra i cocainomani, ma sembra non influire sulla compulsione per la sostanza. Sempre in questa prospettiva McDowell
et al. (2000) suggeriscono di trattare i cocainomani affetti da depressione con venlafaxina, un farmaco attivo sia sul reuptake della serotonina
che della noradrenalina, documentando sia un miglioramento dei sintomi psichici che una consistente modulazione dell’addiction.
Scelte mirate anche per i trattamenti
con metadone e buprenorfina
Se gli interventi di psicofarmacologia selettiva richiedono di essere
necessariamente mirati su specifici quadri clinici, anche il trattamento
del disturbo additivo in sé, con agonisti o con antagonisti degli oppioidi,
non potrà in futuro essere utilizzato in modo casuale o orientato da
generiche valutazioni di gravità. A livello di indicazioni, nella pratica
clinica di base, è stato suggerito di confinare il naltrexone ai pazienti
meno gravi, il metadone ai più gravi e la buprenorfina ad una fascia di
gravità intermedia: è facile comprendere quanto questa impostazione
sia riduttiva e non tenga conto della specificità dei diversi farmaci.
Per ciò che concerne i trattamenti con stupefacenti, la tipologia di
eroinomani affetti da comorbidità psichiatrica, considerata in generale,
sembra rispondere meno bene al trattamento con buprenorfina (Pani et
al., 2000). Diversi Autori suggeriscono che il confronto tra metadone e
buprenorfina non debba essere posto tra pazienti inseriti in trattamento
in modo indistinto, ma comparando specifiche tipologie di soggetti
caratterizzati dal punto di vista psichico e comportamentale (Barnett et
al., 2001; Fischer et al., 1999). A questo proposito, l’importanza di
studi che vadano a investigare le risposte al farmaco agonista in relazione alle tipologie dei pazienti diviene sempre più evidente.
72
Per la tossicodipendenza certamente le aspettative dell’outcome appaiono più modeste in presenza di una diagnosi duale, ma questo non
deve scoraggiare il clinico, in quanto è stato dimostrato che, in risposta
ad una adeguata terapia psicofarmacologica, prescritta a fianco del trattamento mirato a contrastare il disturbo additivo, gli esiti a lungo termine non sono significativamente differenti (Saxon, Calsyn, 1995).
Interventi specifici per l’alcoolismo
Anche nel trattamento degli alcoolisti, insieme a strumenti diretti a
controllare la compulsione per il bere, quali l’acamprosate, il disulfiram
e il naltrexone, si è verificato che i farmaci serotoninergici (SSRI), non
efficaci sulla popolazione degli alcoolisti in generale, erano capaci di
ridurre il ricorso all’alcool in specifici gruppi di pazienti (Kranzler,
2000). Dati contrastanti sono stati ottenuti sin qui ma, comunque, indicano una strategia che tenga conto delle tipologie del carattere, della
personalità, della familiarità e quindi della genetica dei pazienti. La
sertralina e la fluoxetina sembrano essere efficaci, secondo alcuni, in
quegli alcolisti che mostrano minore severità del disturbo, una ridotta
componente di psicopatologia, e meno elevati rischi comportamentali
(Pettinati et al., 2000). In un nostro studio, al contrario, la comparazione tra fluoxetina e acamprosate dimostrava un miglior esito negli
alcoolisti con familiarità positiva, quando veniva somministrato il farmaco serotoninergico e, specularmente, un maggior controllo del bere
ottenuto con l’acamprosate nei soggetti con alcoolismo meno pesante
e senza storia familiare di abuso di sostanze (Gerra et al., 1992). Tale
studio è stato ripreso da JAMA in una recente review sulle indicazioni
terapeutiche per l’alcoolismo emerse durante gli anni 90.
Prospettive specifiche di prevenzione della ricaduta
Da ultimo, occorre accennare ad alcune prospettive estremamente affascinanti a riguardo di differenti possibilità di prevenzione della ricaduta, connesse con le tipologie dei pazienti e, verosimilmente, con le
loro caratteristiche personologiche, psichiatriche e relazionali. Infatti,
nell’animale da esperimento il reinstaurarsi del condizionamento, che
induce a riutilizzare la sostanza interrotta da qualche tempo (ricaduta),
può essere innescato da fattori stressanti (foot-shock; digiuno) o dalla
esposizione a piccole dosi della sostanza stessa (priming): ebbene, è
73
stato dimostrato, ad esempio, che se i farmaci serotoninergici sono capaci di impedire il ricorso all’alcool da parte del topo che ha subito uno
stress sperimentale, al contrario il naltrexone è efficace nell’inibire la
ripresa del bere alcool dopo l’esposizione all’etanolo che dovrebbe
sostenere il priming (Stewart et al., 2000; Shalev et al., 2001). Si può
immaginare dunque, in futuro, di poter disporre di strumenti
psicofarmacologici specifici che, a fronte di una accurata anamnesi e
dell’identificazione di tipologie di pazienti omogenee, soprattutto in
relazione alla comorbidità psichiatrica, possano contrastare vie specifiche dell’instaurarsi della ricaduta (pathways to relapse), ottenendo
ciò che con interventi anti-craving standard e generalizzati non si è
riuscito ad ottenere sino ad oggi.
Bibliografia
Barnett, P.G., Rodgers, J.H., Bloch, D.A. A meta-analysis comparing buprenorphine
to methadone for treatment of opiate dependence. Addiction 96(5):683-90, 2001.
Blum, K., Sheridan, P.J., Wood, R.C., Braverman, E.R., Chen, T.J., Comings, D.E.
Dopamine D2 receptor gene variants: association and linkage studies in impulsive-addictive-compulsive behaviour. Pharmacogenetics 5(3):121-41, 1995.
Boyarsky, B.K., McCance-Katz, E.F. Improving the quality of substance dependency
treatment with pharmacotherapy. Subst Use Misuse 35(12-14):2095-125, 2000.
Brooner, R.K., King, V.L., Kidorf, M., Schmidt, C.W.Jr., Bigelow, G.E. Psychiatric
and substance use comorbidity among treatment-seeking opioid abusers. Arch Gen
Psychiatry 54(1):71-80, 1997.
Buydens-Branchey, L., Branchey, M., Fergeson, P., Hudson, J., McKernin, C. The metachlorophenylpiperazine challenge test in cocaine addicts: hormonal and
psychological responses. Biol Psychiatry 1;41(11):1071-86, 1997.
Carroll, K.M., Nich, C., Rounsaville, B.J. Differential symptom reduction in depressed
cocaine abusers treated with psychotherapy and pharmacotherapy. J Nerv Ment
Dis 183(4):251-9, 1995.
Compton, W.M. 3rd, Cottler, L.B., Ben Abdallah, A., Phelps, D.L., Spitznagel, E.L.,
Horton, J.C. Substance dependence and other psychiatric disorders among drug
dependent subjects: race and gender correlates. Am J Addict 9(2):113-25, 2000.
Craig, T.J., DiBuono, M. Recognition of comorbid psychopathology by staff of a drug
detoxification unit. American Journal on Addictions 5, 76–80, 1996.
Fischer, G., Gombas, W., Eder, H., Jagsch, R., Peternell, A., Stuhlinger, G., Pezawas,
L., Aschauer, H.N., Kasper, S. Buprenorphine versus methadone maintenance for
the treatment of opioid dependence. Addiction 94(9):1337-47, 1999.
Flynn, P.M., Luckey, J.W., Brown, B.S., Hoffman, J.A., Dunteman, G.H., Theisen,
A.C., Hubbard, R.L., Needle, R., Schneider, S.J., Koman, J.J. 3rd, et al. Relationship
74
between drug preference and indicators of psychiatric impairment. Am J Drug
Alcohol Abuse 21(2):153-66, 1995.
Gastfriend, D.R., Lu, S.H., Sharon, E. Placement matching: challenges and technical
progress. Subst Use Misuse 35(12-14):2191-213, 2000.
Gerra, G. Drogati si nasce? Percorsi nell’infanzia-adolescenza prima della
tossicodipendenza. S. Paolo Torino, 1994.
Gerra, G., Caccavari, R., Del signore, R., Bocchi, R., Fertonani, G., Passeri, M. Effects
of fluoxetine and Ca-acetyl-homotaurinate on alcohol intake in familial and
nonfamilial alcoholic patients. Current Ther. Res. 52:291-295, 1992.
Gerra, G., Caccavari, R., Fontanesi, B., Delsignore, R., Fertonani, AG., Marcato, A.,
Maestri, D., Avanzini, P., Perna, G., Brambilla, F. Alpha-2-adrenoreceptors
sensitivity in heroin addicts with and without previous attention deficit disorder/
hyperactivity and conduct disorder. Neuropsychobiology 30: 15-19, 1994.
Gerra, G., Calbiani, B., Zaimovic, A., Sartori, R., Ugolotti, G., Ippolito, L., Delsignore,
R., Rustichelli, P., Fontanesi, B. Regional cerebral blood flow in abstinent opioid
addicts: correlation with personality traits. Psychiatry Research 83:117-126, 1998.
Gerra, G., Ferri, M., Zaimovic, A., Giucastro, G., Palladino, M., Sartori, R., Delsignore,
R., Maestri, D., Marzocchi, G., Brambilla, F. Gabaergic function in detoxified heroin
addicts: relationship to anxiety disorders. Psychiatry Research 77:89-96, 1998.
Gerra, G., Fertonani, G., Tagliavini, P., Zaimovic, A., Delsignore, R., Maestri, D.,
Avanzini, P., Caccavari, R., Brambilla, F. Serotonin function in detoxified heroin
abusers: prolactin and cortisol responses to fenfluramine challenge. Psychiatry
Research 58: 153-160, 1995.
Gerra, G., Fertonani, G., Zaimovic, A., Rota-Graziosi, I., Avanzini, P., Caccavari, R.,
Delsignore, R., Lucchini, A. Hostility in heroin abusers subtypes: fluoxetine and
naltrexone treatment. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological
Psychiatry 19: 1225-1237,1995.
Gerra, G., Zaimovic, A., Timpano, M., Zambelli, U., Begarani, M., Marzocchi, G.F.,
Ferri, M., Delsignore, R., Brambilla, F. Neuroendocrine correlates of temperament
traits in abstinent opiate addicts. J Subst Abuse 11(4):337-54, 2000.
Gerra, G., Zaimovic, A., Zambelli, U., Delsignore, R., Baroni, M.C., Laviola, G., Macchia, T., Brambilla, F. Neuroendocrine correlates of depression in abstinent heroindependent subjects. Addiction 96: 221-234, 2000.
Haney, M., Gerra, G., Fischman, M.W., Foltin, R.W. Neuroendocrine effects of dfenfluramine after repated cocaine self-administration in humans. Drug Alcohol
Depend (in press).
Helmus, T.C., Downey, K.K., Arfken, C.L., Henderson, M.J., Schuster, C.R. Novelty
seeking as a predictor of treatment retention for heroin dependent cocaine users.
Drug Alcohol Depend 1;61(3):287-95, 2001.
Kadden, R.M., Kranzler, H.R., Rounsaville, B.J. Validity of the distinction between
“substance-induced” and “independent” depression and anxiety disorders. American
Journal of Addictions 4, 107–117, 1994.
Kaye, S., Darke, S., Finlay-Jones, R. The onset of heroin use and criminal behaviour:
does order make a difference? Drug Alcohol Depend 1;53(1):79-86, 1998.
75
Kranzler, H.R. Pharmacotherapy of alcoholism: gaps in knowledge and opportunities
for research. Alcohol Alcohol 35(6):537-47, 2000.
Landabaso, M.A., Iraurgi, I., Jimenez-Lerma, J.M., Sanz, J., Fernadez de Corres, B.,
Araluce, K., Calle, R., Gutierrez-Fraile, M. A randomized trial of adding fluoxetine
to a naltrexone treatment programme for heroin addicts. Addiction 93(5):739-44,
1998.
Levin, F.R., Evans, S.M., Coomaraswammy, S., Collins, E.D., Regent, N., Kleber, H.D.
Flupenthixol treatment for cocaine abusers with schizophrenia: a pilot study. Am J
Drug Alcohol Abuse 24(3):343-60, 1998.
Luthar, S.S., Rounsaville, B.J. Substance misuse and comorbid psychopathology in a
high-risk group: a study of siblings of cocaine misusers. Int J Addict 28(5):415-34,
1993.
McDowell, D.M., Levin, F.R., Seracini, A.M., Nunes, E,V. Venlafaxine treatment of
cocaine abusers with depressive disorders. Am J Drug Alcohol Abuse 26(1):25-31,
2000.
Pani, P.P., Maremmani, I., Pirastu, R., Tagliamonte, A., Gessa, G.L. Buprenorphine: a
controlled clinical trial in the treatment of opioid dependence. Drug Alcohol Depend
1;60(1):39-50, 2000.
Pettinati, H.M., Volpicelli, J.R., Kranzler, H.R., Luck, G., Rukstalis, M.R., Cnaan, A.
Sertraline treatment for alcohol dependence: interactive effects of medication and
alcoholic subtype. Alcohol Clin Exp Res 24(7):1041-9, 2000.
Saxon, A.J., Calsyn, D.A. Effects of psychiatric care for dual diagnosis patients treated
in a drug dependence clinic. Am J Drug Alcohol Abuse 21(3):303-13, 1995.
Schubiner, H., Tzelepis, A., Isaacson, J.H., Warbasse, L.H.3rd, Zacharek, M., Musial,
J. The dual diagnosis of attention-deficit/hyperactivity disorder and substance abuse:
case reports and literature review. J Clin Psychiatry 56(4):146-50, 1995.
Shalev, U., Yap, J., Shaham, Y. Leptin attenuates acute food deprivation induced relapse
to heroin seeking. The Journal of Neuroscience 21: 1-6, 2001.
Stewart, J. Pathways to relapse: the neurobiology of drug and stress induced relapse to
drug-taking. J Psychiatry Neurosc 25(1): 125-136, 2000.
76
Il processo di cambiamento psicologico
nel setting multipolare
riflessioni e proposte
G.G. ALBERTI * - P. RIGLIANO * - E. BIVI *
M.I. GRIECO * - P. MIRAGOLI *
Introduzione
L’intervento sul paziente tossicodipendente con rilevanti problemi
psicopatologici mira, in molti casi, alla stabilizzazione farmacologica
basata su oppiacei come il metadone, oltre che su neurolettici,
antidepressivi, modulatori dell’umore (Galanter, Kleber, 1998; Dowd,
Rugle, 2001).
Meno frequentemente esso mira a cambiamenti delle strutture psichiche
e delle disposizioni relazionali associate alla patologia, quali sono
conseguibili mediante una psicoterapia. Questa frequente rinuncia all’obiettivo più ambizioso ha diversi motivi: in primo luogo, certamente, l’importanza centrale della dipendenza da sostanze nell’economia
motivazionale dei pazienti, ma poi anche una loro scarsa propensione
all’auto-osservazione e alla metacognizione, come anche la difficoltà,
presente nei disturbi di personalità di secondo cluster, a mantenere relazioni stabili nel tempo e a modulare le emozioni (Linehan, 1993;
Ryle, 1997; Fonagy, Target, 2001; Liotti, 2001).
Si tratta, cioè, di persone che in gran parte non riescono a sostenere nel
tempo un impegno psicoterapeutico formalizzato. Nonostante tutto ciò,
crediamo che sia possibile svincolare da uno specifico setting
psicoterapeutico il processo di cambiamento delle strutture psichiche e
relazionali e realizzarlo, a certe condizioni, entro il percorso curativo
normale che il paziente segue nel corso della sua presa in carico nelle
diverse strutture deputate.
I programmi oggi ritenuti idonei per i tossicodipendenti, anche con
gravi psicopatologie, prevedono che essi facciano alcune fondamentali
esperienze: a) un rapporto con un medico investito del coordinamento
*
Dipartimento di Salute Mentale - A.O. San Carlo Borromeo - Milano
77
delle diverse iniziative; b) la stabilizzazione farmacologica, mirante al
contenimento dei sintomi astinenziali come di quelli psicopatologici in
senso stretto; c) ricoveri ospedalieri in medicina e in psichiatria; d)
periodi di vita comunitaria caratterizzata, oltre che da attività
riabilitative, da regole per lo più rigide; e) in parte dei casi, una relazione psicoterapeutica con uno psichiatra o psicologo, con funzioni di
sostegno, ma avente talora anche lo scopo di favorire la presa di coscienza e il cambiamento di aspetti della personalità che rivestono importanza patogenetica; f) un lavoro sulle dinamiche dei rapporti del
paziente con i familiari (Fioritti, Solomon, 2002).
Il cambiamento delle strutture psichiche e relazionali può realizzarsi
strutturando queste esperienze di trattamento in maniera tale da far fare
al paziente esperienze di carattere correttivo (Alexander, French, 1946;
Kiesler, 1979; Carpy, 1989; Safran, Segal, 1990) atte a modificare gli
elementi essenziali dei processi patogenetici che sono alla base della
loro patologia psichica e tossicofilica.
Attraverso il mantenimento nel tempo, dovuto principalmente agli operatori, di relazioni di attaccamento a diverse figure delle équipes
terapeutiche, queste esperienze correttive dovrebbero attivare nel paziente diversi processi di cambiamento.
Tra questi i più importanti appaiono essere: a) la presa di coscienza e il
controllo delle sequenze di emozioni, cognizioni e comportamenti
che sfociano nell’uso di sostanze; b) la promozione dell’esperienza,
del riconoscimento e della modulazione delle emozioni; c) lo sviluppo
delle competenze metacognitive, tra cui il riconoscimento e la critica
dei processi di costruzione di vissuti allucinatori e deliranti; d) l’assunzione, per modellamento, di modalità di percezione e gestione della
realtà che siano antitetiche con le dinamiche che portano all’uso di
sostanze; e) la correzione di cognizioni patologiche; f) la modificazione delle rappresentazioni patogene del rapporto Sé-Altro e dei diversi
stati assunti dal proprio Sé; g) il collegamento del processo patogenetico
attuale con la storia personale e familiare; h) il cambiamento di dinamiche interpersonali e familiari che favoriscono l’uso di sostanze.
Il cambiamento finale è conseguenza del succedersi delle diverse esperienze legate ai diversi contesti, ognuna suscettibile di favorire cambiamenti parziali, in progressiva concatenazione, e concorrenti a una globale riorganizzazione della psiche individuale e delle sue modalità di
relazionarsi con gli altri, correlata alla rinuncia alla dipendenza (Linehan,
1993; Ryle, 1997; Safran, Muran, 2000; Ryle, Kerr, 2002).
78
Fattori generali di cambiamento
Se, in questa prospettiva, ogni fase richiede un’attenzione psicoterapeutica specifica, volta a definire i bisogni particolari del paziente e a
cercare di promuoverne certi particolari cambiamenti, vi sono nondimeno delle caratteristiche comuni a tutto l’aggregato dei servizi coinvolti che si costituiscono come fattori terapeutici generali (Friedman,
1993).
Essi riguardano gli atteggiamenti che tutti gli operatori devono condividere, in funzione sia di una coerenza dei loro compiti e dei messaggi
dati al paziente, sia anche dell’esigenza terapeutica di non farsi coinvolgere dalle dinamiche tipiche dei tossicodipendenti e di modificarne
invece le modalità relazionali patogene: la sfida, la delega, l’impotenza
presunta, l’urgenza esibita, l’inattinenza e la deresponsabilizzazione,
la profezia negativa.
Tutti gli operatori dovranno allora condividere la necessità di concordare il progetto curativo, in particolare tempi, modalità, strumenti, ruoli,
responsabilità, vie di comunicazione, controindicazioni.
La definizione, da parte degli stessi operatori, dei limiti e dei confini,
delle responsabilità e dei ruoli e, con ciò, della propria identità, contrasta un aspetto fondamentale della dinamica tossicomanica, quello per
cui non vengono posti mai né limiti né definizioni reciproche, e propone quindi l’operatore come modello di un’identità capace di limitarsi e
definirsi (Rigliano, 1998).
Analoga funzione ha il porsi “down” degli operatori, l’assunzione cioè
di un ruolo non salvifico né totipotente che alimenterebbe le dinamiche dicotomico-scissionali dei pazienti.
Un’altra dimensione del processo patogenetico tossicomanico, quella
dell’ ”avere tutto e subito” viene contrastata e corretta facendo concordemente sperimentare al soggetto, e al suo contesto d’appartenenza, la
processualità temporale - il “passo dopo passo”, la ”azione dopo azione” - cioè i ritmi non tossicomanici della scansione delle varie fasi del
progetto e la gradualità necessaria per una sua reale attuazione.
Importante, in questa prospettiva, è la definizione degli obiettivi finali
e intermedi, come anche l’introduzione della prospettiva del possibile
fallimento, e di cosa si fa in tal caso: criteri definitori dell’evento e dei
suoi significati e implicazioni. Introdurre questa prospettiva significa
rompere la circolarità viziosa della tossicodipendenza, tesa tra aspettative irrealistiche e idealizzanti e delusioni catastrofiche mai analizzate:
imparare ad apprendere dai fallimenti, andare a un livello più profondo
di comprensione delle cause e delle alternative positive.
79
Gli operatori devono offrire spazi di differenziazione, così contrastando le modalità tipicamente tossicomaniche di confusione, agglutinamento e collasso in modelli ripetitivi e sterilmente distruttivi. Devono
offrire al paziente l’opportunità di sperimentare diversi livelli del proprio Sé e di cimentarsi in costruzioni positive, in azioni, relazioni, progetti costruttivi.
Ogni operatore può essere chiamato a sviluppare ipotesi su quali sofferenze - specificamente individuate in contenuti, motivazioni e forme siano alla base dell’uso di sostanze da parte del singolo paziente e su
come le dinamiche psicopatologiche interagiscano con le dinamiche
più propriamente tossicomaniche.
Esperienze mutative nei diversi contesti
SERT e CPS
Entro il contesto multipolare integrato assume carattere peculiare il
rapporto tra, da un lato, il SERT e, dall’altro, il CPS. Ci concentreremo
qui soprattutto sul paziente tossicodipendente con disturbo di personalità di secondo cluster, borderline e narcisistico in particolare, come
esso è curabile - sotto un profilo psicologico - in un CPS.
I pazienti con comorbilità psicotica traggono più giovamento, a nostro
vedere, soprattutto da una farmacoterapia stabilizzante e poi, come
vedremo più avanti, da una prolungata esperienza non ambulatoriale
ma comunitaria.
Se riteniamo di poter attribuire al SERT alcuni compiti chiave, come la
terapia sostitutiva con metadone o la determinazione degli stupefacenti
nelle urine, al CPS dovrebbero competere la definizione diagnostica
della psicopatologia di primo e secondo asse, l’impostazione di una
eventuale psicofarmacoterapia e, infine, anche gli interventi psicoterapici
individuali e familiari.
Un approccio in forma consulenziale può consistere nel fare esplorare
al paziente il suo percorso storico, fornendogli prospettive nuove per
costruire la propria storia relazionale e affettiva, come anche per superare atteggiamenti difensivi autosconfiggenti come, ad esempio, le tendenze proiettive o grandiose che ribaltano responsabilità e potenzialità
di cambiamento al di fuori del raggio d’azione del soggetto, su altri o
sulla società in genere.
La proposta interpretativa della motivazione all’uso di droghe come
tentativo di automedicazione apre l’ampio discorso della sofferenza,
80
della compensazione del vissuto di vuoto depressivo da fallimento
relazionale o da diffusione dell’identità.
L’opzione psicoterapeutica individuale, specie se incorpora procedure
di tipo cognitivo, permette di perseguire molti degli obiettivi poc’anzi
indicati, prioritari nel lavoro sui nuclei patogeni centrali della patologia borderline e narcisista. Essa sarà allora la sede elettiva ma non esclusiva del cambiamento psicologico, sia perché le interazioni tra il paziente e gli altri operatori impongono una continua sintonizzazione, sia
anche perché l’esistenza di relazioni curative parallele è una preziosa
risorsa che permette di recuperare e riparare le relazioni, anche
psicoterapeutiche, che inevitabilmente il paziente tende a rompere
(Liotti, 2001).
Una funzione dello psichiatra psicoterapeuta è quella di intervenire sulle
dinamiche familiari patogene, sia in quanto fattori a se stanti di sofferenza e quindi di uso di stupefacenti, sia in quanto ostacolo a un inserimento comunitario. Far luce sulle relazioni affettive familiari rinsalda i
legami e il senso di appartenenza del paziente alla propria famiglia.
Poiché solo ciò che è connesso si può separare, la contestualizzazione
del paziente nella storia della sua famiglia può responsabilizzarlo e
portarlo a una scelta autonoma di entrare in comunità, e non perché
espulsovi dai familiari (Haley, 1983).
SPDC
Un vertice del setting multipolare che, negli ultimi anni, viene sempre
più a contatto con tossicodipendenti con problemi psicopatologici è
l’SPDC, unica risorsa esistente per il ricovero di pazienti con condizioni psichiche acutamente compromesse, per lo più in termini di psicosi
e crisi di discontrollo pulsionale, ma anche di depressioni con
autolesività.
Nonostante l’apparenza di evento accidentale, quasi di fuoriuscita
emergenziale dal contesto terapeutico, il ricovero in SPDC ha assunto
un ruolo che può avere gran rilievo nel percorso di cambiamento psicologico del paziente.
Se l’équipe, del reparto ma anche del pronto soccorso psichiatrico, è
in grado di evitare reazioni espulsive agendo l’irritazione, la paura, la
rabbia indotte negli operatori da pazienti spesso violenti, impulsivi,
manipolatori, instabili e inaffidabili, si pongono le basi per poter costruire un’alleanza terapeutica. Un’équipe addestrata a condividere le
responsabilità e a sempre riesaminare le proprie esperienze emotive in
rapporto al paziente e ai suoi familiari è allora in grado di porre limiti
senza essere coartante o umiliante, di essere rispettosa e validante sen81
za essere collusiva, di mantenere stabilmente un atteggiamento
empatico, chiaro e sollecito che rappresenta per il paziente un riferimento sicuro nel tempo (Linehan,1993; Liotti, 2001).
Con questo atteggiamento essa fornisce al paziente, di ricovero in ricovero, una protezione da condizioni di vita dolorose e talvolta tragiche
e, soprattutto, una “tregua” nel turbolento ciclo interpersonale che lui
stesso si crea attraverso le proprie inconsce azioni induttive.
Ciò lo mette in condizione di distanziarsi emotivamente e di vivere con
consapevolezza crescente la possibilità reale di un efficace e soddisfacente rapporto interpersonale che, in particolari momenti, si concreta
in ristrutturazioni delle sue rappresentazioni interne.
Ad esempio, quando nelle ricostruzioni anamnestiche fatte con lo psichiatra egli può riesaminare gli eventi senza esserne travolto emotivamente, osservare e descrivere le proprie vicende e i propri comportamenti, attribuendo loro nuovi significati, valutare i fatti distinguendoli
dalle interpretazioni. Entro questo tipo di rapporto la stessa ripetizione
dei ricoveri non è più solo scoraggiante segno di immutabilità ma occasione per iscrivere le ripetute crisi in una storia dotata di senso, superando la vergogna del fallimento e la conseguente negazione del problema.
Analogamente, il permanere in un reparto con vincoli e regole, le
interazioni con un’équipe medica e infermieristica, le relazioni con gli
altri degenti, creano - oltre che l’adeguamento comportamentale al limite - anche la progressiva accettazione del relativo vissuto emotivo
che si connette alla consapevolezza decentrante della sua reciprocità,
cioè dell’identica limitazione cui sono tenuti gli altri.
La Comunità Terapeutica
Prevale oggi la tendenza a distinguere tra comunità terapeutiche per
pazienti duali con disturbi di personalità e pazienti duali con psicosi
(De Leon, 1998; Galanter, Kleber, 1998; Rigliano, Miragoli, 2000).
Ovviamente restano comuni ad esse la dimensione comunitaria della
vita quotidiana, il ruolo terapeutico delle relazioni tra pazienti e operatori, il carattere non-performativo ma riabilitativo delle attività che vi
si svolgono. Tuttavia esse si differenziano per alcuni aspetti.
La comunità per duali psicotici è caratterizzata da regole meno rigide,
da un’atmosfera affettiva più accogliente e dalla preminenza delle attività riabilitative (Carli, 1987). Il lavoro terapeutico mira alla comprensione delle proiezioni delle figure interiorizzate della propria famiglia
82
fantasmatica che ognuno dei partecipanti, paziente od operatore, opera
su ognuno degli altri partecipanti, creando complesse dinamiche di
aspettative, costruzioni percettive e reazioni emotive e comportamentali.
L’obiettivo è allora la modificazione delle rappresentazioni interne patologiche del paziente, formatesi nella famiglia d’origine e messe in
atto nella realtà relazionale e nelle attività riabilitative della comunità.
L’atto terapeutico non è l’interpretazione esplicita dei vissuti e dei comportamenti del paziente ma l’azione terapeutica simbolica che risponde a tali vissuti e comportamenti, modulata - a seconda delle diverse
attività riabilitative - in modo tale da fornire al paziente esperienze che
modificano le sue rappresentazioni interne originarie e i loro fondamentali schemi relazionali.
Più articolato è invece l’insieme delle esperienze mutative che caratterizzano le comunità per pazienti duali con disturbo di personalità, in
gran parte mediate dal lavoro di gruppo. Vi hanno particolare rilievo:
l’elaborazione delle regole, volta a promuoverne una visione non solo
di limite esogeno imposto ma anche di modulatore di impulsi utile per
il collettivo e per il singolo; la condivisione dell’esperienza
tossicomanica e del suo superamento attraverso il reciproco sostegno;
la promozione dell’esame di realtà attraverso l’esperienza della molteplicità delle diverse posizioni emergenti nel gruppo; il graduale apprendimento, anche grazie al sostegno del gruppo, di modalità
relazionali tolleranti e reciproche, non onnipotenti né manipolatorie,
prima nel gruppo stesso, poi con familiari e amici, poi ancora in attività
lavorative e interessi; la facilitazione e l’accoglimento di nuove consapevolezze e desideri individuali; l’orientamento alla scansione di una
temporalità condivisibile con gli altri; l’orientamento alla risoluzione
dei problemi nella famiglia e nel contesto sociale allargato
(Hinshelwood, 1989; Kranzler, Rounsaville, 1999).
L’integrazione delle diverse esperienze
La diffusione delle esperienze terapeutiche comporta la difficoltà di
coordinarle in maniera che non si contrastino a vicenda e, invece, che
si potenzino reciprocamente.
In linea generale, quest’opera richiede non solo un progetto unitario
d’intervento, ma anche una continua risintonizzazione tra gli operatori
delle diverse équipes coinvolte. E ciò presuppone regolari contatti allargati a tutti gli interessati, volti a definire e ridefinire obiettivi, regole,
modalità concrete d’intervento, risultati parziali, impasses,
83
avvicendamenti tra sottoprogrammi e singoli interventi, passaggi di
informazioni, elaborazioni collettive di modelli del processo
patogenetico del paziente e dei percorsi terapeutici su cui questi va
portato, guidato, sostenuto.
Va considerato che alcuni mutamenti sono conseguenza di precedenti
cambiamenti, che cioè nei pazienti si producono cambiamenti secondari i quali sono, in molti casi, il vero scopo dell’intervento. Si pensi
all’autostima, così centrale nella patogenesi e che non può essere migliorata intervenendo direttamente sul paziente, ma solo aiutandolo a
fare autonomamente progressi in certi settori come la capacità di modulazione emotiva o di reciproca interazione con gli altri. Ovviamente,
una giusta modulazione della difficoltà dei compiti, assegnati al paziente da strutture sanitarie magari diverse, è essenziale affinché non si
abbia un ritiro precoce del paziente dall’impegno curativo: per esempio, sarà da discutere attentamente l’eventualità di avviare il paziente a
un’attività lavorativa, che potrebbe risultare prematura, portandolo a
un’esperienza di fallimento.
Il problema del coordinamento si pone con particolare pregnanza in
determinate fasi del percorso, come l’iniziale coinvolgimento del paziente, la continuità del suo impegno all’astinenza e alla cura, il suo
ingresso in comunità. In queste fasi si possono delineare tendenze elusive, per cui il paziente può approfittare del suo passaggio da un’équipe all’altra per abbandonare il progetto curativo.
Spesso, ad esempio, il proposito di smettere viene maturato nella situazione protettiva dell’SPDC, quando l’abituale caos relazionale appare
lontano. Nella prospettiva che il paziente vi ritorni è evidente che sarà
fondamentale una presa di contatto il più possibile approfondita con i
curanti ambulatoriali e che, se la problematica relazionale si incentra
sulla famiglia, si intervenga su di essa simultaneamente.
Analogamente, nella fase della stabilizzazione dell’astinenza sarà necessaria una comunicazione puntuale e tempestiva tra le diverse équipes
coinvolte, presso le quali il paziente affiora di volta in volta: Pronto
Soccorso, SPDC, SERT, CPS, eventualmente comunità, con coerenti
rinvii del paziente alla struttura che, secondo il progetto terapeutico
condiviso, è al momento competente e responsabile.
Anche l’ingresso in comunità è una fase di grande delicatezza in cui,
come si è già detto, dinamiche familiari espulsive possono giocare
antiterapeuticamente, invalidando la bontà dell’iniziativa. Qui è comprensibile che la decisione operativa debba essere preceduta da un’elaborazione del problema di rapporto del paziente con i suoi familiari, in
84
modo tale che essi ne favoriscano la riuscita invece che facilitarne il
fallimento.
Come realizzare, praticamente, questo coordinamento delle esperienze
correttive?
Il metodo basilare è quello delle riunioni periodiche e frequenti di tutti
coloro che partecipano alla gestione del singolo caso: esso ha il fondamentale vantaggio della globalità e della continuità nel tempo, indispensabile per percorsi terapeutici che possono richiedere anni, ma è
però dispendioso in termini di risorse e difficile da realizzare, specie se
gli operatori appartengono a équipes diverse.
Allora appare utile concentrare almeno una parte significativa del lavoro di coordinamento nelle mani di un solo operatore - una figura
definibile come coordinatore psicoterapeutico - il quale, oltre ad avere
una relazione significative col paziente, segua nel tempo lo svolgersi
delle esperienze correttive che egli fa, mantenendo anche contatti diretti, anche se meno frequenti, con le diverse équipes che man mano lo
prendono in carico. Si avrebbe così, oltre alla globalità/continuità e a
un miglior uso delle risorse, anche una maggiore puntualità nell’indicazione ed elaborazione delle diverse esperienze.
Questa figura di coordinatore delle esperienze psicoterapeutiche non
dovrebbe costituire una semplice riproposizione dello psicoterapeuta
individuale, chiuso nel rapporto diadico con il suo paziente, ma dovrebbe coniugare una relazione molto personale con la funzione di individuare le esperienze di cui il paziente ha man mano bisogno, di avviarvelo e sostenerlo e, soprattutto, di indurlo a elaborarle in funzione
di un’evoluzione della sua personalità e delle sue relazioni.
Dovrebbe cioè divenire il regista di un processo psicoterapeutico eclettico (Alberti, 2000) e, insieme, continuamente pensato e verificato, che
metta a frutto ogni esperienza parallela nel senso del superamento dei
meccanismi patogenetici di cui il paziente è prigioniero.
Bibliografia
Alberti, G.G. Le psicoterapie. Dall’eclettismo all’integrazione. Franco Angeli, Milano
2000.
Alexander, F., French, T.M. Psychoanalytic therapy: principles and application. Ronald
Press, New York, 1946.
Carli, R. Obiettivi e struttura dell’intervento di comunità. In: Kaneklin C., D’Ambrosio
G. (a cura di) Atti del Convegno “Interventi di comunità”. Il Pensiero Scientifico,
Roma 1987.
85
Carpy, D.V. Tolerating the countertransference: a mutative process. International Journal
of Psychoanalysis 70, 287-294, 1989.
De Leon, G. Community as method, Praeger, New York, 1998.
Dowd, E.T., Rugle, L. La tossicodipendenza. Trattamenti a confronto, McGraw-Hill,
New York, 2001.
Fioritti, A., Solomon, J. Doppia diagnosi. Epidemiologia, clinica e trattamento. Franco Angeli, Milano, 2002.
Fonagy, P., Target, M. Attaccamento e funzione riflessiva. Raffaello Cortina, Milano,
2001.
Friedman, L. Anatomia della psicoterapia, Bollati Boringhieri, Torino, 1993.
Galanter, M., Kleber, H. Trattamento dei disturbi da uso di sostanze, Masson, Milano,
1998.
Haley, J. Il distacco dalla famiglia, Astrolabio, Roma, 1983.
Hinshelwood, R.D. Cosa accade nei gruppi, Raffaello Cortina, Milano, 1989.
Kiesler, D.J. An interpersonal communication analysis of relationship in psychotherapy,
Psychiatry 42, 299-311, 1979.
Kranzler, H., Rounsaville, B.J. Dual diagnosis and treatment, Derner, New York, 1999.
Linehan, M. Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Guilford
Press, New York, 1993.
Liotti, G. Le opere della coscienza. Raffaello Cortina, Milano, 2001.
Rigliano, P. InDipendenze. Alcol e cibo, farmaci e droghe, comportamento d’azzardo:
le relazioni di dipendenza, Ed. Gruppo Abele, Torino, 1998.
Rigliano, P., Miragoli, P. Tossicomania e sofferenza mentale. La questione della “doppia diagnosi”, Rivista Sperimentale di Freniatria, 124, 83-95, 2000.
Ryle, A. Cognitive analytic therapy and borderline personality disorder. Wiley,
Chichester, 1997.
Ryle, A., Kerr, I.B. Introducing cognitive analytic therapy. Wiley, Chichester, 2002.
Safran, J.D., Muran, J.C. Negotiating the therapeutic alliance. Guilford Press, New
York, 2000.
Safran, J.D., Segal, Z.V. Interpersonal process in cognitive therapy. Basic Books, New
York, 1990.
86
Intese fra servizi territoriali, collaborazione
e protocolli nella presa in carico e nel trattamento
di pazienti con Doppia Diagnosi
G. FAVARETTO * - S. COMPAGNO *
G. BELLIO **
La questione della doppia diagnosi è diventata, negli ultimi anni, un
argomento di rilevante interesse non solo fra gli operatori ma anche, e
soprattutto, per le Istituzioni e i Servizi originariamente interessati all’uno o all’altro di questi problemi.
Uno degli elementi di sicuro interesse è rappresentato dal fatto che
questa emergenza dimostra ancora una volta, se mai ve ne fosse stata la
necessità, che i comportamenti e i fenomeni nell’ambito clinico non
avvengono secondo i confini di competenza dei Servizi. Qualsivoglia
organizzazione, infatti, è sensibile di riflessione e aggiornamento, in
quanto a specificità e competenza su bisogni e problematiche delle
persone, essendo essa stessa - l’organizzazione - ampiamente condizionata dal contesto storico e socio-culturale.
È questo un contesto di conoscenze in cui la realtà nazionale (la più
generale del modello a matrice di Thornichoft e Tansella) ha un’indiscussa rilevanza a partire dalla propria originalità sia per gli aspetti di
tipo legislativo sia per quelli delle risorse sociali che sono state attivate.
E così, in un’epoca relativamente vicina alla fondazione separata di un
servizio per le dipendenze ed uno per la salute mentale, ci si trova a
trattare di quei casi dove entrambe le questioni sono rilevanti, entrambi
gli interventi si rivelano necessari ed entrambe le competenze vengono
evocate anche se, come vedremo, per un procedimento “ inverso”.
È questo un destino comune a tutti i confini che finiscono poi con il
generare “zone franche“ o comuni all’interno delle quali lo stesso confine viene annullato. Con esso vanno considerati, nella evoluzione di
questi rapporti fra Servizi e fra confini, l’evoluzione e i diversi assetti
* Dipartimento di Salute Mentale ULSS 7 - Regione Veneto, Coregliano (TV)
** Dipartimento delle Dipendenze ULSS 8 - Regione Veneto, Castelfranco Veneto (TV)
87
che i Servizi hanno assunto nel corso di questi anni: l’istituzione di
Dipartimenti, la creazione di strutture intermedie residenziali e
semiresidenziali, una organizzazione dei Servizi per la comunità nel
territorio, il confronto con problemi clinici e patologie “nuove” come,
per esempio, la psichiatria di liaison, i disturbi del comportamento alimentare, il gioco d’azzardo patologico e il confrontarsi con utenti provenienti sempre meno da precise e determinate fasce sociali ma, piuttosto, da ogni contesto socio-economico e con manifeste richieste di
aiuto e di cura e non tanto di controllo sociale.
A tale percorso si sono sommati, poi, tutti quei cambiamenti introdotti
nel corpo stesso del sapere psichiatrico da movimenti diversi, come
per esempio quello epidemiologico o della medicina basata sull’evidenza, e - soprattutto in ambito SerT - l’intervento di rete e l’auto-aiuto
(Galanter 2001).
La presenza del contesto territoriale (o della comunità locale, come si
preferisce dire oggi) resta un riferimento per questo tipo di persone che
dovrebbero trovare una risposta all’interno dei Servizi sociosanitari della
stessa comunità. Il Distretto Sociosanitario, macrostruttura territoriale
dell’Azienda Sociosanitaria Locale, idealmente dovrebbe porsi come
garante di una risposta integrata ai bisogni della comunità, anche per
quei casi in cui non esiste una perfetta corrispondenza con specifiche
competenze di un Servizio.
Il problema della doppia diagnosi si colloca, invece, in un contesto
dove il Distretto è intrinsecamente debole, e tra i Servizi vi è una chiara
difficoltà a collaborare e a identificare linee comuni per la diagnosi e la
gestione rispetto a casi nei quali si accumulano risentimenti nei confronti o dell’uno o dell’altro Servizio a causa delle modalità di relazione o risposte che vengono ritenute, nella migliore delle ipotesi, inadeguate.
Nel farsi di una cultura terapeutica e di relazione fra i Servizi in merito
alla questione della doppia diagnosi si finisce (o meglio si comincia)
dal dover partire dai casi più gravi, dal punto di vista istituzionale e
dalle emergenze. Qui, come da molte altre parti, non È necessariamente vero che l’epidemiologia svolge un ruolo a priori regolatore e di
“giusta conoscenza del fenomeno“, ma anzi succede di dover partire
dal concreto di esigenze rimaste insoddisfatte di parte di utenti che
concretamente dimostrano, per esempio, il fallimento di strategie
predefinite e non adatte ai loro bisogni.
Molti operatori, in realtà, si dichiarano non competenti (a ragione o per
opportunità), ma chi invece sottolinea il proprio interesse è importante
lo faccia sempre con garbo, consapevole di non avere una risposta in
88
un “metodo” ma, al contrario, l’opportunità di esplorare una zona
epistemologicamente instabile e, quindi, promettente dal punto di vista
delle scoperte e delle innovazioni.
Vista da questo punto la questione della cultura dei Servizi e degli operatori può essere un elemento significativo dell’analisi più complessiva
del “che cosa fare” con i casi di doppia diagnosi.
Approccio integrato e determinanti socio-ambientali
È possibile ipotizzare che una “giusta” cultura istituzionale ed un “corretto” atteggiamento dei Servizi potrebbero determinare un buon riconoscimento e una presa in carico anche nei casi di doppia diagnosi.
Questo a partire da un visione integrata dell’approccio a questi problemi. Ma una buona integrazione richiede un senso di identità istituzionale saldo e i SerT tendono ad essere più fragili da questo punto di
vista sia per la loro giovane età sia per la loro storia evolutiva e per la
incertezza del ruolo assegnato loro dalla cultura dominante, sensibile
com’è alle massicce proiezioni che invadono il campo delle
tossicodipendenze.
Se la prospettiva della Sanità Pubblica e di Comunità è quella di conoscere il fenomeno e dare una risposta adeguata dal punto di vista
quantitativo e qualitativo sul piano dell’iniziativa legislativa, della distribuzione delle risorse e della organizzazione dei servizi specifici
(Thornicoft e Tansella), qui, invece, ci troviamo di fronte ad una marcata variabilità (de Girolamo) sia quantitativa che qualitativa determinata da insondabili fattori e che, invece, rende difficile generalizzare
soluzioni trovate localmente.
Dal punto di vista dei fenomeni, segnaliamo come esistano svariate
modalità organizzative e culturali dei DSM e dei SerT. La differenza,
forse, fra i due contesti istituzionali è legata al fatto che se nel DSM
resta prevalente una cultura e identità psichiatrica (o delle psichiatrie
secondo taluni) i SerT. sono vere realtà multiprofessionali complesse
come testimonia l’organizzazione dei loro dipartimenti allargati. Psicologi e tossicologi hanno indiscutibilmente messo in minoranza gli
psichiatri, perlomeno in determinate realtà, il che ha reso i rapporti e i
linguaggi più complessi e talora più conflittuali. SerT orientati in senso psichiatrico sono profondamente diversi da SerT orientati in senso
tossicologico, da SerT orientati in senso internistico-infettivologico e
da SerT non orientati.
89
Contesti e cultura degli operatori
I conflitti, come è facile presumere, riguardano soprattutto comportamenti in caso di emergenza, l’uso dell’SPDC, l’effettiva presenza del
servizio “competente“ e la continuità della sua risposta terapeutica ma
anche la mancanza di ausilio in casi “senza prospettive” o nei quali il
riproporre coattivamente strategie proprie di quel Servizio altro non fa
che far accumulare fallimenti e frustrazioni.
Si tratta di difficoltà che, se non sempre sono declinabili sul piano della teoria, lo sono invece molto spesso su quello concreto dei comportamenti degli operatori i quali, pur non rifacendosi a nessuna specifica
teoria di base o flusso decisionale particolare, vivono determinate emozioni come ostilità, incomprensione, isolamento.
Un interessante confronto è partito nella Regione Veneto da un movimento di tipo culturale: psichiatri di formazione professionale simile,
ma di collocazione istituzionale diversa hanno provato ad incontrarsi e
a creare i presupposti per una riflessione comune sul che “cosa era
diventata” la loro identità professionale e culturale, costituendo un gruppo di lavoro detto “gruppo dipendenze Psi.Ve.” di cui parleremo in
seguito. Riconducendo, in un produttivo gioco di incroci gli aspetti “di
dipendenza“ e “psicopatologici” nella organizzazione dei diversi Servizi sono emerse importati opportunità di confronto che hanno portato
a interrogarsi su che cosa stava oltre la consueta dichiarazione di non
appartenenza di un paziente con doppia diagnosi al proprio Servizio
per poter finalmente cominciare a chiedersi quali concretamente fossero gli strumenti per la comprensione oltre che per il trattamento di tali
pazienti complessi.
L’intesa fra Servizi: un’esperienza
Se il termine doppia diagnosi è stato, di fatto, adottato per indicare la
condizione di molte persone che contestualmente manifestano problemi di dipendenza e disturbi psichiatrici, la semplice coesistenza dei
due disturbi, però, non necessariamente è rappresentativa di un bisogno di doppia assistenza e/o presa in carico da parte dei due Servizi.
Nell’ambito dei Servizi per le Tossicodipendenze, infatti, non tutti i
pazienti che presentano oltre alla patologia da dipendenza anche un
sintomo psicopatologico vengono considerati pazienti a doppia diagnosi; né i Servizi di Salute Mentale inviano ai SerT tutti gli utenti che
manifestano un utilizzo regolare, saltuario o pregresso di alcool o di
90
altre sostanze d’abuso. È, quindi, chiaro che il ricorso improprio ed
eccessivo al termine “doppia diagnosi” rischia di essere - a livello operativo - confondente ed inutile, se non in alcuni casi addirittura dannoso.
Sul piano operativo ci si trova spesso a dover definire la competenza:
tale operazione dovrebbe riferirsi più al Servizio che al paziente. In
altre parole si tratta di individuare prioritariamente “di chi è il paziente”, quanto piuttosto “quali sono le risorse che il mio Servizio può
mettere in campo”. Un simile approccio tende a rinforzare l’identità
dei Servizi e ad evitare deleghe improprie o peggio espulsive.
Gli operatori di entrambi i Dipartimenti si rendono conto che virtualmente nessun paziente che presenta sintomi in ambedue le aree può
dirsi totalmente estraneo alle proprie competenze. Inoltre, un’accurata
diagnosi nosografica non è sempre dirimente; nella valutazione è doveroso ampliare il campo osservativo pesando accuratamente elementi
problematici e risorse personali ed ambientali del paziente.
Infine, importanza non secondaria assume l’assegnazione di competenza e la scelta dell’interlocutore da parte del paziente stesso e della
sua famiglia. Non è raro, infatti, che paziente e famiglia enfatizzino un
consumo occasionale di sostanze al fine di negare l’esistenza di una
psicosi. Talora molto lavoro è destinato ad accompagnare certi utenti
verso la presa in carico più opportuna e anche il Servizio “non competente” non può esimersi da tale compito.
In ogni caso, uno dei problemi che ci si deve porre prima di arrivare a
una sofisticata gestione delle diagnosi e dei trattamenti, nella previsione di costruire un modello più articolato ed integrato della gestione dei
pazienti, è di cominciare a far parlare SerT e Servizi psichiatrici facendoli uscire da quella reciproca diffidenza che spesso contraddistingue
la loro relazione.
A questo fine appare di capitale importanza la creazione di occasioni
di formazione comune per operatori dei due Dipartimenti, compresi
quelli che afferiscono al privato sociale. Intendiamo qui una formazione a diversi livelli, dagli eventi di interesse nazionale, alle iniziative
locali, queste ultime avendo il grosso vantaggio di favorire la partecipazione e un coinvolgimento più capillare. La formazione dovrebbe
indirizzarsi verso temi particolarmente sentiti e dibattuti, non dimenticando peraltro di evidenziare anche i numerosi punti comuni che caratterizzano l’operatività dei due Servizi, ad esempio:
- molteplicità dei setting di trattamento e complessità dei programmi
terapeutici;
- approccio alla persona e continuità assistenziale;
91
- livelli multipli di assistenza (domiciliare, ambulatoriale,
semiresidenziale, residenziale);
- rapporti con l’associazionismo ed il privato sociale.
Tutto ciò rappresenta la premessa per un futuro sviluppo di linguaggi
condivisi. Allora quali strategie organizzative? Come dovrebbe essere
organizzato il trattamento dei casi doppia diagnosi? Quali dovrebbero
essere i servizi interessati e le professionalità maggiormente coinvolte? considerando che i casi con doppia diagnosi stanno in mezzo tra i
Servizi per le tossicodipendenze, i Servizi per la salute mentale e i
Servizi del privato sociale e/o del volontariato.
Strategie organizzative
Sulla base delle esperienze fatte finora con questi casi è possibile distinguere tre diversi modelli di trattamento:
Secondo il modello seriale viene trattato prima il disturbo più acuto o
più grave, rimandando ad un momento successivo il trattamento del
disturbo meno eclatante. In questo caso, di solito, le équipe curanti
sono diverse e, di conseguenza, si può creare il problema dello “scarico” o del “rimpallo” del paziente. È, comunque, difficile che si ottengano risultati terapeutici soddisfacenti in un’area senza che si intervenga anche nell’altra.
Secondo il modello parallelo le due distinte équipe curanti (delle
Tossicodipendenze e della Salute Mentale) operano due contemporanee prese in carico, instaurano due trattamenti diversi e separati,
focalizzati sui disturbi dei rispettivi campi di competenza. In questo
caso nascono frequentemente problemi legati alla non comunicazione
tra le due équipe curanti e alla loro diversa formazione, di modo che la
divaricazione dei trattamenti può essere confondente per il paziente.
Secondo il modello integrato la presa in carico dei casi con doppia
diagnosi viene fatta da un’unica équipe specializzata in questo settore,
competente nel trattamento sia dei disturbi da dipendenza che dei disturbi mentali. In questo caso il paziente riceve una spiegazione coerente della sua malattia ed una prescrizione terapeutica coerente piuttosto che un insieme contraddittorio di messaggi da parte di diverse
équipe curanti.
Risulta evidente che, quando possibile, il modello integrato è il più
completo, poiché i trattamenti effettuati in tal ottica mirano a ridurre i
conflitti tra i curanti, a eliminare le difficoltà dei pazienti di dover seguire due diversi programmi terapeutici e sentire messaggi potenzial92
mente contrastanti e a rimuovere barriere di vario genere (anche finanziario) per accedere al trattamento e permanere nello stesso (Minkoff
1989).
Esistono due livelli organizzativi che perseguono l’integrazione:
- la costituzione di una équipe specifica per la doppia diagnosi, formata da operatori che hanno ricevuto uno specifico training e che
hanno sviluppato competenze sia nel campo dell’assistenza psichiatrica che nel campo delle tossicodipendenze;
- la formazione di mini-équipes sul caso miste, SerT e DSM, e
multiprofessionali.
Quest’ultima forma organizzativa sembra attualmente la più praticabile. È, se si vuole, un compromesso fra il modello parallelo e quello
integrato, ed è immediatamente implementabile in molte realtà. Ha il
vantaggio di permettere agli operatori di parlarsi direttamente e di concordare il programma terapeutico, minimizzando i rischi di scollamento
tra i due Servizi.
D’altro canto, esiste comunque il problema della responsabilità di cura:
chi sarà l’operatore di riferimento del paziente? Presso quale struttura
potrà contattarlo? Di fatto verrà sancita l’appartenenza ad uno dei Servizi. Una buona relazione personale operatore/paziente e la continuità
terapeutica sono fattori essenziali per un efficace aggancio e per una
adeguata permanenza in trattamento.
L’équipe che pianifica e gestisce il trattamento deve essere messa in
grado di poter contare su una ampia gamma di risorse terapeutiche e di
assistenza sociale, dato che i casi con doppia diagnosi manifestano spesso gravi ed urgenti bisogni primari.
Per quanto riguarda la realtà Italiana, in alcune Aziende Sociosanitarie
stanno nascendo gruppi misti di lavoro con operatori provenienti dal
SerT e dal DSM che, sulla base di accordi e metodologie condivise e
predefinite attraverso appositi protocolli, prendono in carico i casi con
doppia diagnosi, curando l’assessment e la successiva formulazione
del piano terapeutico.
Modalità operative
È possibile individuare differenti fasi all’interno della presa in carico
del paziente con doppia diagnosi
1. Fase di aggancio
2. Fase di assessment
3. Fase di trattamento in acuto
93
4. Fase del trattamento a lungo termine/stabilizzazione
5. Riabilitazione/prevenzione delle ricadute
Il primo obiettivo è l’aggancio del paziente che, talora, è reso possibile
attraverso il ricovero ospedaliero. In altri casi si procede al trattamento
dei sintomi acuti, sia dell’area tossicologica che di quella psicopatologia.
Si procede alla disintossicazione o, in alternativa per gli eroinomani,
alla stabilizzazione con terapia sostitutiva. Una volta recuperata maggiore lucidità, saranno valutati attentamente i livelli motivazionali e, se
necessario, si attiverà un counselling specifico.
Si procede, quindi, a formulare una diagnosi corretta, tossicologica e
psichiatrica, nonché un’accurata valutazione e pesatura dei problemi e
delle risorse. Confermata la “doppia diagnosi” e trattati i sintomi acuti,
il trattamento prevede l’inserimento in un programma riabilitativo nel
contesto di un programma integrato a lungo termine, trattamento per il
quale potrebbe essere necessario un inserimento in Comunità
Terapeutica.
Sebbene i progetti terapeutici prevedano solitamente tempi molto lunghi, di rado definibili a priori, spesse volte è opportuno indicare episodi di trattamento, segmenti più brevi e più definiti sul piano della
metodologia, delle risorse impiegate, degli obiettivi da perseguire.
Qualche parola merita anche la famiglia. Spesso i pazienti con doppia
diagnosi hanno una situazione familiare molto precaria e priva di risorse, altre volte invece la famiglia è presente e può essere coinvolta. Possono essere utili, in questo caso, interventi psicoeducazionali con l’obiettivo di migliorare i livelli di conoscenza dei processi patologici e
terapeutici e, di conseguenza, la collaborazione con l’équipe curante.
La riabilitazione, infine, mira a recuperare o rinforzare specifiche abilità attraverso programmi di skills training e counseling.
Ricordiamo alcune regole di base:
- I programmi terapeutici saranno flessibili e adattabili al mutare delle circostanze.
- Tutte le azioni necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati saranno distribuite secondo le reciproche competenze.
- All’interno dell’équipe doppia diagnosi ciascun operatore mantiene le responsabilità sulle proprie competenze professionali.
- Ciascun operatore si impegna a comunicare agli altri componenti
dell’équipe in modo tempestivo ogni variazione al programma
precedentemente concordato.
- Nel caso in cui il soggetto interrompa il rapporto, l’équipe integrata
decide per ogni caso quali sono le modalità e gli operatori da attivare per ricoinvolgere il paziente nel programma.
94
Questi primi passi, a dire il vero semplicissimi dal punto di vista teorico, rappresentano invece, dal nostro punto di vista, un contesto importantissimo per permettere operativamente nascita e sviluppo di una
adeguata collaborazione fra Servizi, strada che noi riteniamo praticabile, se non necessaria, per poter permettere ai Servizi per la Salute Mentale della comunità di crescere in qualità nella propria capacità di risposta.
Il gruppo dipendenze della PSI.VE
Potrebbe essere interessante, a questo punto, accennare alla situazione
veneta che - per certi versi - potrebbe essere definita come privilegiata
per molte ragioni, non ultima la relativa abbondanza di psichiatri che
lavorano nei SerT. A questo proposito tre anni fa alcuni di noi hanno
sentito l’esigenza di riunirsi in gruppo di studio misto cui partecipano
psichiatri provenienti dalle due aree e che hanno iniziato ad interrogarsi sulla propria identità culturale e professionale. La Psi.Ve, Sezione
Veneta della Società Italiana di Psichiatria, ha offerto il proprio supporto formale. È stato interessante come gli psichiatri dei Ser.T. fossero ben lungi dal provare nostalgia per la disciplina madre: erano assai
motivati a proseguire il loro lavoro entro il proprio ambito e, sul piano
organizzativo, tendevano a valorizzare l’autonomia dei SerT e la loro
separazione dai Dipartimenti di Salute Mentale.
Il gruppo ha organizzato un seminario che si è svolto a Padova proprio
sul tema della doppia diagnosi, un’occasione in cui, tra l’altro, si è
riflettuto sulla nascita e l’evoluzione storica dei due sistemi assistenziali, sul senso della presenza di psichiatri nei SerT (il che equivale a
porre la questione se le dipendenze siano di per sé di pertinenza psichiatrica) e sui rapporti che legano i SerT ai DSM. È stato curioso
rilevare, in quell’occasione, che gli psichiatri dei DSM tendevano a
condividere la stessa visione stigmatizzata del tossicodipendente, come
persona manipolativa, in malafede, scarsamente gratificante, fonte di
problemi e grattacapi, nonché avido consumatore di risorse. Ci è stato
subito chiaro che era necessaria una politica estesa di formazione congiunta tra operatori, non necessariamente solo medici, dei due Servizi.
È in questa direzione che il gruppo attualmente si sta muovendo.
95
Protocolli Ser.T.-Dipartimento di Salute Mentale:
tre esempi nel Veneto
Abbiamo esaminato tre protocolli di collaborazione tra i SerT e i DSM
in tre ULSS Venete, cioè Chioggia (VE), Conegliano (TV) e Castefranco
Veneto (TV).
Il primo protocollo (Chioggia) enfatizza inizialmente la necessità di
individuare con precisione i soggetti che potrebbero avvantaggiarsi di
trattamenti integrati. Invita i Servizi a valutare l’esistenza di una doppia diagnosi in tutti i casi di psicosi acuta e nelle dipendenze refrattarie
agli usuali trattamenti. Il caso con doppia diagnosi viene seguito congiuntamente dalle mini-équipes dei due Servizi che si riuniscono periodicamente per discutere i casi comuni. Il trattamento deve essere
inizialmente indirizzato alla eliminazione dei sintomi indotti da sostanze,
alla stabilizzazione tossicologica, e/o alla riduzione dei sintomi
psicopatologici o comportamenti patologici. Successivamente verrà
attivato un programma integrato personalizzato. Il protocollo individua alcuni indicatori per la valutazione dell’andamento del progetto
terapeutico.
Il secondo protocollo (Conegliano) individua in modo preciso, anche
con diagrammi di flusso, le procedure di contatto e di reciproca consulenza urgente, di media urgenza e non urgente. Se viene ritenuta opportuna una presa in carico congiunta le mini-équipes dei due Servizi si
consultano ed eventualmente danno origine ad un gruppo di lavoro misto
integrato. Vengono, altresì, individuate le procedure per l’avvio di programmi di Comunità o di reinserimento lavorativo.
Il terzo protocollo (Castelfranco Veneto), infine, stabilisce alcuni principi alla base della collaborazione: la formazione di un’équipe mista
sul caso, la rinuncia alla definizione delle competenze sulla base della
sintomatologia prevalente o primaria, quanto piuttosto la messa in comune delle risorse terapeutiche necessarie.
Queste tre esperienze, di recente avvio, sono accomunate tutte
dall’individuazione dell’équipe mista sul caso come momento fondante dell’integrazione. In tutti e tre i casi il modello organizzativo perseguito è quello integrato, come d’altra parte era prevedibile data la lunga tradizione di lavoro multidisciplinare in gruppo da parte sia della
psichiatria che delle tossicodipendenze. L’esigenza di entrare nel dettaglio delle procedure è variabile: ciò potrebbe essere il frutto di differenti situazioni della realtà locale.
96
Conclusioni
Ricordiamo, alla fine, alcuni chiarimenti terminologici e concettuali.
Tutta la problematica della doppia diagnosi rischia di farci dimenticare
che il paziente non è realmente doppio, né presenta una vera e propria
molteplicità di patologia. Il consumo di sostanze e gli aspetti
psicopatologici rappresentano un’unità esistenziale all’interno della
quale i fenomeni patologici acquistano un senso proprio, specifico per
quel paziente. Uno dei compiti dell’équipe curante è giungere ad una
comprensione sempre più adeguata della funzione di senso dei sintomi
psico-comportamentali.
Diagnosi e Assessment: questa fase della presa in carico viene giustamente enfatizzata da tutti. Riteniamo importante ricordare che il processo diagnostico in psichiatria sia molto lungo e, di fatto, accompagni
tutto il trattamento. Nel caso della doppia diagnosi, e anche nelle
tossicodipendenze pure, il campo osservativo deve essere ampio e comprendere le diverse aree di funzionamento (area psichica, biomedica,
tossicologica, relazionale, affettiva, familiare, area della scolarità/lavoro, area legale, funzionamento ed adattamento sociale). L’indagine a
tutto campo ha la funzione di rilevare elementi problematici, ma pure
risorse personali o presenti nell’ambiente. Tutto ciò ha importanza ai
fini della prognosi e del trattamento. È altrettanto importante
l’individuazione della corretta sequenza temporale della comparsa dei
sintomi o dei comportamenti patologici; ma la discriminante primario/
secondario non dovrebbe essere utilizzata per decidere della competenza sul caso di questo o quel Servizio.
Non è sempre vero che è difficile per un paziente con doppia diagnosi
smettere di drogarsi o di bere. Non è infrequente che tali pazienti raggiungano la sobrietà in modo più rapido dei tossicodipendenti puri;
tuttavia il loro comportamento e le difficoltà di adattamento alla
quotidianità non si modificano. Spesso i sintomi psicopatologici si esacerbano dopo l’astensione dalle sostanze, ma il paziente potrebbe abusare dei farmaci prescritti, soprattutto di tranquillanti.
Il privato sociale rappresenta una risorsa ineliminabile anche nei pazienti con doppia diagnosi. Le strutture residenziali, semiresidenziali, i
programmi di Pronta Accoglienza, gli appartamenti protetti rappresentano un’offerta di Servizi ampia e flessibile. Purtroppo gli operatori
non sempre dimostrano una competenza specifica per l’approccio a
questa tipologia di pazienti. Appaiono sempre più urgenti adeguate iniziative di formazione.
97
Una formazione adeguata dovrebbe coinvolgere in modo integrato tutte le componenti coinvolte nell’assistenza ai casi con doppia diagnosi:
SerT, DSM, privato sociale. La formazione dovrebbe essere intesa non
solo come mezzo per acquisire nuove competenze, ma anche come
occasione per elaborare i vissuti controtransferali. La supervisione continuativa dell’équipe di un Servizio da parte di un consulente esterno
dovrebbe entrare nella prassi normale.
Bibliografia
AAVV. DSM IV. Masson, Milano, 1998.
AAVV. Atti della “Terza conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione
delle sostanze stupefacenti e psicotrope”. Genova 28-30 Novembre 2000.
Clerici, M. Tossicodipendenze e Psicopatologia. Franco Angeli, Milano, 1993.
Clerici, M. et al. La comorbidità per uso di sostanze nei disturbi psicotici e nella schizofrenia. Noos, Aggiornamenti in Psichiatria 2, 133-156, 2000.
De Leon, G. Psychopathology and substance abuse and psychiatric disorders: what is
being learned from research in therapeutic community. Journal of Psychoactive
Drugs 21, 177-188, 1989.
Fioritti, A., Solomon, J. (a cura di) Doppia diagnosi epidemiologia clinica e trattamento. Franco Angeli 2002.
Galanter, M. Terapia di rete per i disturbi da uso di sostenze. Bollati Boringhieri
Torino 2001.
Gerra, G., Frati, F. La ricerca sui disturbi psichiatrici nei pazienti tossicodipendenti ed
alcolisti. Personalità/Dipendenze (in press).
Hambrecht, M. et al. Substance abuse and onset of schizophrenia. Biol Psychiatry 1;
40 (10): 1104-7, 1996.
Kosten, T. et al. DSM-III personality disorders in opiete addicts. Compr. Psychiatry
23: 572-576, 1982.
Maremmani, I. et al. Tossicodipendenza e comorbidità per i disturbi dell’umore. Noos,
Aggiornamenti in Psichiatria 2,111-132, 2000.
Minkoff, K. An integrated treatment model for dual diagnosis of psychosis and addiction.
Hospital and Community Psychiatry 40, 1031-1036, 1989.
Regier, D.A., et al. Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse:
results from the Epidemiological Catchment Area (ECA) study. JAMA 264: 251118, 1990.
Rounsaville, B.J. et al. Heterogenity of psychiatric diagnosis in treated opiete addicts.
Arch. Gen. Psychiatry 39:161-166, 1982.
Solomon, J. Doppia diagnosi. Personalità/Dipendenze 2, 279-289, 1996.
Vukov, J., et al. Personality dimensions of opiate addicts. Acta Psychiatrica Scandinavica
91: 103-107, 1995.
Zanda, G., Margaron, H. Il problema della doppia diagnosi: l’esperienza della Regione
Toscana.
98
Doppia diagnosi, Tripla Diagnosi
e psicopatologia da HIV
fraintendimento linguistico o realtà
G. CAMPIONE *
Doppia diagnosi o tripla diagnosi:
questo non è il problema !
Il termine anglosassone dual diagnosis o “doppia diagnosi”, spesso
usato, a torto, come sinonimo del più latino comorbidità, rappresenta
la conseguenza - sul piano linguistico - del sempre più frequente uso
del sistema diagnostico statistico DSM dell’American Psychiatric
Association organizzato, com’è noto, in cinque assi valutative. Il termine però, nel suo uso più frequente, indica soprattutto una condizione
clinica di associazione fra disturbo correlato a sostanze e altra
psicopatologia, al contempo indicando nella separazione di due fenomeni - in realtà strettamente correlati - il tentativo di comprendere,
semplificandolo, un fenomeno assai più complesso (Iannitelli et al.,
2002). In alcuni casi, addirittura, il termine diventa sinonimo di doppia quota o di doppia partecipazione alla spesa, di due Servizi differenti come SerD e DSM, per un progetto assistenziale, più o meno
comune, in ambiente protetto (comunità terapeutica).
Il termine comorbidità, invece, indica una coesistenza di psicopatologie
senza far riferimento a modelli etiologici lineari o a modelli biologici o
pedagogici e cerca di riunire - epistemologicamente e organizzativamente - ciò che legislativamente (legge 685/75 e 309/90) e
ideologicamente (contrapposizione fra riduzionismo biologico e
riduzionismo pedagogico) è stato da tempo separato.
Com’è noto la condizione di comorbidità, molto spesso, è connotata
da difficoltà nella risoluzione di quesiti di diagnosi differenziale, da
peggiore prognosi e da problematica programmazione, monitoraggio e
compliance delle terapie concomitanti.
*
U.O. Ser.T. di Rozzano - ASL MI 2 - Lombardia
99
La psicopatologia associata alla malattia da Hiv non fa eccezione sia
che consista, come nella popolazione tossicodipendente classica, in
disturbi correlati a sostanze associati a disturbi dell’umore, disturbi
d’ansia, disturbi dell’adattamento, disturbi psicotici in comorbidità con
disturbi di personalità e in concomitanza con l’infezione da hiv e/o
infezione da hbv o hcv e/o altre MTS, sia che consista - nella popolazione emergente, soprattutto eterosessuali - in disturbi sessuali come
parafilie o disturbo del controllo degli impulsi n.c.a in comorbidità con
disturbi di personalità narcisistico, borderline o antisociale e in
concomitanza con abuso o dipendenza da sostanze e/o gambling.
Merita una particolare menzione il caso del paziente sano che teme
ossessivamente di essersi infettato, il cosiddetto “worried well”, spesso contraddistinto da disturbo ossessivo della personalità o da disturbo
d’ansia ossessivo-compulsivo.
Quando si parla però di doppia diagnosi e hiv il termine risulta ancora
più scomodo per diversi motivi. Se il termine, infatti, indica l’associazione o la sequenza o il parallelismo fra disturbo correlato a sostanze e
altra psicopatologia come si fa a usarlo con hiv non tossicodipendenti
che presentano psicopatologia? Tra l’altro, ciò che meno si conosce
attualmente e più si teme, di conseguenza, è proprio la crescita in termini di incidenza di questo tipo di soggetti, eterosessuali o bisessuali
frequentatori di prostitute o prostituti o sex-addict, parafilici, perversi,
molestatori, pedofili dediti a comportamenti a rischio (come chiedere
prestazioni sessuali non protette), portatori di psicopatologia sommersa e poco evidente nel senso psichiatrico più comune, che non frequentano i Servizi di cura e che, pertanto, non possono essere oggetto di
ricerca e conoscenza.
Il termine doppia o tripla diagnosi - se può ben corrispondere ad esigenze di universalizzazione del linguaggio psicologico psichiatrico, che
peraltro non tutti condividono soprattutto in Europa (vedi il dibattito
fra sistemi diagnostici categoriali o dimensionali, e le osservazioni critiche di Giacomini) - dall’altro può prestare il fianco a scissioni eccessivamente tecniche dell’oggetto della cura, la persona nella sua unicità, con pericolose ricadute in termini qualitativi dell’organizzazione
dell’assistenza. Se, invece, la contemporanea morbidità rappresenterà
l’occasione per unificare nel pensiero e nell’azione Servizi diversi per
allocazione, tradizione, appartenenza o quant’altro, attraverso la costituzione di équipes miste, allora vorrà dire che il ruolo svolto dal termine sarà stato senz’altro fecondo.
100
Il IV Asse del DSM e l’evoluzione della malattia
Una caratteristica dell’infezione da Hiv sin dal suo primo momento
diagnostico, in questo simile alla malattia oncologica e ad altre patologie
invalidanti, è quella di rappresentare di per sé stessa, anche alla luce
del pesantissimo stigma sociale che la contraddistingue nonostante tutto, un grave “stressfull life event” (evento di vita stressante) nel linguaggio del IV asse del DSM. Migone (1996) ha sottolineato il valore
di “evento di vita” della morte (e noi, mutatis mutandis, diciamo lo
stesso della malattia): si tratta di situazioni destinate a provocare grosse ripercussioni nell’equilibrio psicologico del soggetto. L’impatto di
qualunque evento dipende dai valori adottati dal soggetto e dai significati che esso assume in quel determinato momento del ciclo vitale.
“Non a caso - afferma Magone - gli eventi di vita sono tradizionalmente divisi in due sommarie categorie: i timely events e gli untimely events.
I primi sono gli eventi prevedibili che avvengono in un tempo “normale”, mentre i secondi quelli invece non prevedibili che vanno contro al
tempo che regola le aspettative della nostra esistenza. Un esempio di
evento normale è la morte di un genitore in età avanzata, mentre un
esempio di untimely event è la morte di un figlio per un genitore. La
malattia può avere significati molto diversi: una cosa è ammalarsi in
età avanzata dopo una ricca e soddisfacente vita; ben altra cosa è ammalarsi in età giovanile per l’infezione di un virus (magari preso in
modo accidentale o a causa di un comportamento illegale, di cui ci si
sente in colpa e che si è poi abbandonato”; Migone 1999).
La malattia da Hiv rappresenta sia un evento stressante di tipo acuto
cui può conseguire shock emozionale (Nichols), secondo le sequele
del post traumatic stress disorder o del disturbo dell’adattamento, sia
un evento stressante cronico con conseguenze dal punto di vista
neuroormonale e immunologico (Pancheri).
Montecchi e coll. (2002), in un’originale ricerca italiana di
psicoimmunologia hanno sottolineato l’importanza che i fattori stressanti incrociati con particolari stili di reazione hanno nel determinare
diversi tipi di evoluzione della malattia. “L’obiettivo era verificare la
correlazione fra eventi stressanti recenti (misurati con la scala di Holmes
e Rahe) e remoti (misurati con un test modificato dal Dsm IV) in cui i
soggetti erano stati coinvolti e comportamenti abitudinari da loro assunti (misurati dal test Tsr di Biondi e Pancheri) da una parte e, dall’altra, la progressione dell’infezione da Hiv. Secondo Martin Nowak la
progressione dell’infezione, dal primo contatto con il virus al manifestarsi della sindrome, si può classificare in tre tipologie ben definite ed
101
identificabili. Su un piano prettamente immunologico, e semplificando, questo significa che “tutto si gioca” nel momento della risposta
dell’organismo ospite all’attacco virale. La documentata associazione
tra stress e livello delle difese immunitarie, a questo punto, spinge ad
argomentare positivamente sulla validità dell’ipotesi della ricerca. Da
qui possono essere tratte indicazioni affinchè sorgano dei gruppi
terapeutici il cui compito è “combattere la depressione in soggetti colpiti da infezione da Hiv”. Il gruppo contribuisce ad avvicinare i pazienti ai Servizi e ad aumentare la loro disponibilità alla cura (compliance).
Meritano un futuro approfondimento sia l’importanza delle strategie di
risposta allo stress che lo sviluppo di terapie di supporto psicologico
adeguate ai vari stadi di progressione dell’infezione”.
Il long time survivor, di fatto, viene descritto come un individuo profondamente malato dal punto di vista fisico che è capace di mantenersi
sano dal punto di vista mentale. Il long term survivor è un soggetto che
ha la capacità di aggregarsi, di comunicare apertamente e di accettare
la diagnosi rifiutandosi di viverla come sentenza di morte. Il long time
survivor è una persona che ha un sufficiente senso di responsabilità per
la propria vita, è capace di mantenere una relazione collaborativa con i
medici, di porsi nuovi obbiettivi esistenziali, di continuare ad essere
propositivo ed assertivo, di dare senso all’esperienza della sieropositività
e di mantenere un contatto positivo e intenso con altri soggetti
sieropositivi” (Maffei1998).
Le nuove terapie
In poche patologie la ricerca di base, le ricadute terapeutiche, i cambiamenti dei bisogni e degli aspetti organizzativi, psicologici, etici e sociali sono tanto rapidamente e strettamente correlati come nell’epidemia da Hiv.
I nuovi farmaci antiretrovirali e le più recenti strategie terapeutiche
hanno seguito di pochi anni i risultati sugli studi della dinamica della
replicazione virale, della variabilità virale, delle basi biologiche delle
resistenze, della compartimentazione delle cellule infette non produttive.
I nuovi farmaci e le nuove strategie hanno impresso rapidi e radicali
mutamenti nell’immagine pubblica dell’infezione, uscita dal novero
delle malattie incurabili, hanno modificato la tipologia delle esigenze
assistenziali, spostando attività dai reparti di degenza agli ambulatori,
hanno posto gli amministratori di fronte al problema dei costi farma102
ceutici e del reperimento dei fondi, hanno posto gli operatori di fronte
alla gestione della cosiddetta “Sindrome di Lazzaro”, hanno posto le
associazioni di fronte alla necessità di ridisegnare obiettivi e programmi, hanno posto il mondo del lavoro di fronte al dovere di facilitare il
reinserimento delle persone sieropositive recuperate a condizioni di
buona salute. La lunga spettanza di vita che oggi si prevede per le persone sieropositive impone la revisione delle procedure burocraticoamministrative, al fine di continuare ad assicurare la ancora irrinunciabile riservatezza con la continua necessità di ricettazioni per farmaci e
controlli (Moroni1999).
Mentre fino ad ora, cioè, ci siamo occupati di dare ai pazienti un’assistenza e di aiutarli a morire, dovremo occuparci di aiutarli a vivere, a
rifare un progetto di vita a lungo termine e a convivere con un’infezione che durerà molti anni. Occorrerà aiutarli ad essere padri, madri di
famiglia, ad allevare dei figli, occorrerà farli reinserire nel lavoro, aiutarli ad essere dei cittadini, con tutti i diritti e i doveri di ogni cittadino,
dovendo nello stesso tempo fare i conti con la loro malattia.
Questo vuol dire fare i conti con molte cose, innanzi tutto “con questa
specie di segregazione e di marchio che la società ha posto su questa
malattia” (Cargnel 1998).
La Sindrome di Lazzaro e la Sindrome di Damocle
La psicologia delle reazioni agli eventi di vita, o psicologia dell’adattamento, si trova dall’introduzione delle nuove terapie ad avere a che
fare con una nuova situazione. Le persone affette da Hiv che stanno
attualmente godendo dei benefici delle nuove terapie sono pervase,
nonostante tutto, da confusione ed incertezza.
Soprattutto per le persone cui era stato diagnosticato l’Aids prima dell’introduzione di questi farmaci molto efficaci, la gioia di una notevole
ripresa della loro salute è smorzata da nuovi interrogativi e preoccupazioni rispetto alla propria identità, alla carriera lavorativa, agli aspetti
economici e alle relazioni sociali.
Questo tipo di esperienza è stata denominata “Sindrome di Lazzaro”.
Per molti la ripresa della salute ha comportato il ritorno dalla tomba o
da un rapido avvicinamento alla morte per Hiv alle gioie e ai problemi
della vita (Brashers 1999).
Le persone che si occupano di cura dovrebbero essere consapevoli che
il miglioramento della salute può essere causa di incertezza e un potenziale stress per i loro pazienti. Mishel (1997) sostiene che gli individui
103
con malattie croniche o malattie che minacciano di recidivare devono
essere aiutati nell’imparare a vivere nell’incertezza continua. Il fallimento della gestione dell’incertezza può condurre ad un “dolore cronico”, già rilevato nei malati di cancro. I fattori di stress quali l’incertezza possono avere, infatti, un impatto negativo sul funzionamento
immunologico. Gli interventi sulla gestione dell’incertezza dovranno
rappresentare, in futuro, sicuramente una parte fondamentale dell’approccio olistico alla cura dell’Aids o dell’Hiv. L’incertezza può essere
valutata sia come pericolo che come opportunità. Se gli individui considerano l’incertezza come un pericolo, dovrebbero essere fornite informazioni, e capacità di acquisire informazioni, per ridurre l’incertezza. Comunque, per molte delle aree legate all’incertezza vi sono insufficienti informazioni che possano dare delle risposte. Le persone che
vivono l’esperienza della sopravvivenza, che sono preoccupati rispetto
all’efficacia e alla sicurezza a lungo termine delle cure, dovrebbero
essere continuamente aggiornati sui risultati degli studi e i tentativi di
tipo clinico. Queste informazioni dovrebbero essere fornite in modo
chiaro e attraverso mezzi accessibili.
Perversioni, prostituzione, “unsafe behaviour”
e diffusione dell’Hiv
A dispetto di quanto atteso, con l’ingresso degli inibitori delle proteasi
si é assistito ad una serie di fenomeni correlati, alcuni dei quali inaspettatamente negativi.
Alcuni soggetti, da sempre “complianti”, hanno smesso di esserlo, con
un ritorno di comportamenti problematici, della tossicodipendenza,
della sessualità promiscua. Questi soggetti, molto impulsivi e distruttivi e con una percezione della realtà alterata, hanno avuto un funzionamento “regolare” fino a quando la morte era concreta e tangibile ed il
problema quotidiano era quello di sopravvivere al rischio di morte imminente ed ineluttabile; dal momento che si prospetta loro la possibilità di vivere e di poter progettare la propria vita riprendono ad agire
comportamenti autolesivi e “mortiferi”.
Soggetti apparentemente normali sono in realtà artefici di comportamenti gravemente patologici, come per esempio quello di richiedere
insistentemente rapporti sessuali non protetti a prostitute e prostituti.
Questi soggetti generalmente non hanno precedenti psichiatrici, ma il
loro comportamento é gravemente disturbato, poiché in alcuni momenti
o in alcune situazioni essi non sono in grado di valutare il rischio dei
104
loro comportamenti e quindi di preservare la propria incolumità e quella
degli altri. Si tratta di soggetti che rientrano in una categoria più allargata della patologia psichiatrica, compresa fra aspetti più eclatanti, per
esempio quelli del soggetto borderline tossicodipendente, e quelli più
silenti come i soggetti con perversioni narcisistiche o sadomasochistiche (Maffei, Visintini, Campanini 1998).
E’ una popolazione emergente soprattutto composta da bisessuali e/o
eterosessuali in disturbi sessuali come le parafilie o il disturbo del controllo degli impulsi n.c.a in comorbidità con disturbi di personalità
nercisistico, borderline o antisociale e in concomitanza con abuso o
dipendenza da sostanze e/o gambling.
La Babele dei Servizi: i precedenti legislativi
Un paio di recenti esempi legislativi, fra i tanti, basterebbero a dimostrare come, se esistesse la volontà ” politica”, si potrebbe procedere a
organizzare un coordinamento effettivo quantomeno tra Dipartimenti
di Psichiatria e Servizi delle Dipendenze. Il D.p.r 7.4.1994 “Approvazione del progetto obiettivo tutela della salute mentale 1994-1996” infatti recita: “…il funzionamento integrato e continuo…è richiesto dalla pluralità di strutture psichiatriche che insistono sullo stesso
territorio…dalla presenza d’altri servizi non psichiatrici che hanno confini operativi che interessano la salute mentale (…servizi per le dipendenze…)”, “…la protezione della salute mentale…è garantita da…
l’azione congiunta e il coordinamento delle attività svolte dai servizi
psichiatrici e da altri…(servizi per le dipendenze)”.
Il piu recente D.P.R 444 14.6.2002 art.1, che indica linee guida per
l’organizzazione dei Servizi per le Dipendenze, sottolinea come: “…Il
dipartimento delle dipendenze opera funzionalmente…con opportuna
definizione delle relazioni operative con le aree ed i dipartimenti della
salute mentale e materno infantile. Resta comunque comune obiettivo
la costruzione di progetti integrati con particolare riguardo agli ambiti
di confine come…la doppia diagnosi…”.
L’attuale situazione organizzativa dell’assistenza psichiatrica ai pazienti
Hiv non può che ricordare invece l’immagine biblica di Babele, sia per
l’aspetto caotico e improvvisato dell’assistenza, nonostante ormai la
letteratura di riferimento non manchi sull’argomento, sia per problemi
di difficoltà di comunicazione che di reale o pretesa (e pretestuosa)
diversità di linguaggi.
105
In realtà l’assistenza a questi pazienti si rivela problematica soprattutto
perché, allo stato attuale delle cose, è troppo costosa a vari livelli. Le
terapie antiretrovirali, già di per sé costose, vanno ad aggiungersi alle
terapie psicofarmacologiche, alle rette di comunità terapeutiche per
doppia diagnosi e /o case alloggio Aids, al costo del lavoro degli operatori della psichiatria, dei Dipartimenti delle Dipendenze, ai costi delle degenze in clinica di malattie infettive per ricoveri e day hospital,
ecc.
Sono molti i Servizi che interagiscono per la cura e la diagnosi di questi pazienti (vedi schema). In più si tratta di Servizi tradizionalmente
lontani per esperienze e mentalità oltre che per organizzazione.
Mancano tavoli comuni di programmazione per infettivologi, psichiatri e medici dei Serd, nonché tradizionalmente scarso si presenta il contributo dei medici di base sia nell’interazione con i Serd che con la
psichiatria.
I pazienti hiv non tossicodipendenti con psicopatologia associata cronica o temporanea dovrebbero poter essere presi in cura dai DSM e
dagli infettivologi o dai centri per le MST o consultori ma è davvero
raro che questi Servizi siano in rete fra loro.
I tradizionali modelli di interazione organizzativa per la cura dei pazienti con doppia diagnosi sono tre: trattamenti paralleli, trattamenti
sequenziali, trattamenti integrati.
Nel primo, il paziente è curato contemporaneamente da più Servizi ma
senza che essi programmino insieme valutazione e intervento. Lo svantaggio è rappresentato dal fatto che vi possono essere sovrapposizioni,
duplicazioni (quindi sprechi) o conflitti negli interventi.
Nel secondo, il paziente viene curato prima da uno e poi dall’altro Servizio seguendo criteri d’urgenza o maggiore gravita di una delle due
patologie.
Nel terzo, i due Servizi si incontrano e programmano insieme valutazione e intervento. La letteratura sull’argomento depone per una maggiore efficacia di quest’ultimo modello soprattutto grazie alle garanzie
di continuità che esso offre.
In termini propositivi vale qui quello che si è già proposto con scarsa
fortuna in tema di doppia diagnosi nelle dipendenze patologiche. E’
fondamentale che a livello regionale si organizzino tavoli comuni di
programmazione fra i rappresentanti dei diversi Servizi e che a questo
consegua, a livello territoriale, la creazione di équipes integrate organizzate secondo lo stile del “case management”. Importantissima è la
programmazione di momenti comuni di formazione degli operatori
106
poiché va affrontata la questione della diversità (talvolta più apparente
che sostanziale) dei linguaggi e dei presupposti epistemologici.
FIGURA
107
Bibliografia
American Psychiatric Association. DSM IV, Edizione Italiana, Masson, Milano, 1998.
Brashers, D.E., et al. In an important way, I did die: uncertainty and revival in persons
living with or Hiv or A.i.d.s. Aids Care 11, 2, 201-219, 1999.
Brashers, D.E., et al. Managing uncertainty about Hiv and A.i.d.s.: the role of
information seeking, Paper presented at the Annual Meeting of the Speech
Communication Association, San Diego, 1996.
Brashers, D.E., et al. Uncertainty in illness across the Hiv-A.i.d.s. trajectory. Journal
of Association of Nurses in A.i.d.s. Care 1999.
Campione, G. La sindrome di Lazzaro, la sindrome di Damocle e le nuove terapie. In:
G. Campione (a cura di) La consulenza psichiatrica nei servizi sociosanitari per pazienti affetti da Hiv e Aids, Franco Angeli, Milano 2002.
Campione, G., Colaianni, A., Lucchini, A. Il dipartimento delle dipendenze patologiche, la psichiatria, l’assistenza domiciliare integrata. In: G. Campione (a cura di) La
consulenza psichiatrica nei servizi sociosanitari per pazienti affetti da Hiv e Aids, Franco
Angeli, Milano 2002.
Campione, G. Doppia diagnosi, Hiv e Psichiatria, Workshop residenziale C.I.C.A Coordinamento italiano case alloggio Aids, Livorno 2002.
Campione, G. I disturbi psicopatologici associati alla malattia da Hiv/aids: revisione
della letteratura. In: G. Campione (a cura di) La consulenza psichiatrica nei servizi
sociosanitari per pazienti affetti da Hiv e Aids, Franco Angeli, Milano 2002.
Cargnel, A. Il futuro delle case alloggio: cambiamenti e bisogni di assistenza
extraospedaliera, Seminario Europeo – A.i.d.s e case alloggio, Milano 1998.
Holmes, T.H., Rahe, R.H. The Social Readjustment Rating Scale. Journal of
Psychosomatic Research XI, 213, 1967.
Montecchi, L., et al. Fattori stressanti e schemi di reazione implicati nella progressione
dell’infezione da hiv in soggetti tossicodipendenti. In: G. Campione (a cura di) La
consulenza psichiatrica nei servizi sociosanitari per pazienti affetti da Hiv e Aids, Franco
Angeli, Milano 2002.
Maffei, C. Il futuro delle case alloggio: cambiamenti e bisogni di assistenza
extraospedaliera, Seminario Europeo – A.i.d.s e case alloggio, Milano 1998.
Maffei, C., Campanili, E., Visintini R. Aspetti Psichiatrici e Psicologici della patologia da Hiv, Seminario Europeo – A.i.d.s e case alloggio, Milano 1998.
Magone, P. Che cosa si dice ad un paziente terminale? Il Ruolo Terapeutico 73: 4045,1996.
Mishel, M.H. Uncertainty in chronic illness. Annual review of Nursing Research 15,
57-80, 1997.
Moroni, M. La diversificazione come scelta obbligata, Sito Web -Roche Farmaceutici
Italia, 1999.
Nichols, S.E. Emotional aspects of AIDS: implications for care providers. Journal of
Substance Abuse Treatment 4: 137-140,1987.
Nowak, M.A., et al. Come l’HIV sconfigge il sistema immunitario. Le Scienze 326,
65-75, 1995.
108
Orsi, M., et al. Le strutture residenziali extraospedaliere per persone con A.I.D.S: aspetti
culturali e organizzativi, 1° progetto ricerca sociale AIDS dell’I.S.S. 1995-1996. In:
C.I.C.A (a cura di) Casa alloggio, un’accoglienza per la vita. C.I.C.A, Monte Porzio
Catone (Roma ), 2000.
Pancheri, P. Test Schemi di Reazione, Università di Roma, Istituto di Psichiatria-Psicologia Clinica.
Cancheri, P. Trattato di Medina psicosomatica, USES, 1984.
Pistuddi, A. Profilo psicologico e tratti di personalità di un campione di pazienti frequentatori abituali di prostitute. Atti del XI Congresso della Società Italiana di
Andrologia, Monduzzi, ottobre 1997, Bologna.
Pistuddi, A., et al. Disfunzioni sessuali e comportamenti: frequentatori abituali di prostitute. Atti della Seconda Conferenza Internazionale di Sessuologia, Roma, 6/8 ottobre 2000.
Rena, A. Il nuovo scenario: dalla paura di morire alla paura di vivere. In: C.I.C.A (a
cura di) Casa alloggio, un’accoglienza per la vita. C.I.C.A, Monte Porzio Catone
(Roma ), 2000.
109
110
Il ruolo del privato sociale nel trattamento
della comorbilità
L. GROSSO *
Stretto tra Ser.t e S.S.M, tra diagnosi nosografiche e trattamenti
farmacologici multipli, “che ci azzecca” il privato sociale col problema delle comorbilita’?
Intanto si pone come soggetto “terzo”, non specialistico, tradizionalmente dedicato alla presa in carico della persona nella sua interezza
prima ancora che nella sua sintomatologia e nella sua “doppia” patologia. È un prendersi cura che costituisce uno sfondo, un “contenitore”
indispensabile per l’innesto stesso della cura e per le sue maggiori probabilità di successo. Ma procediamo con ordine e tentiamo di identificare i diversi ambiti di apporti in cui il privato sociale può, su questa
questione, tentare di mettere in rete alcune sue potenzialità.
Un contributo al processo diagnostico
La complessità della diagnosi nell’individuare il disturbo psichiatrico
non consiste solo nell’identificazione dell’asse e del cluster del DSM
IV, con tanto di trasversalità sottostanti, in cui “catalogare” il paziente.
Pur non negando l’importanza descrittiva, la confrontabilità e l’utilità
comparativa di questa operazione, fondamentale per delineare le ipotesi di trattamento, il processo diagnostico apre ad almeno altri tre aspetti di estrema importanza: uno di metodo, uno di approfondimento di
conoscenza, uno di esito.
Il metodo riguarda la possibilità di formulare la diagnosi anche in base
ad un’osservazione delle persone e delle manifestazioni di sé: un’osservazione prolungata ed intensa. Già qui il privato sociale può dire la
sua. Da tempo ha attivato, e anche trasformato, alcune sue strutture in
*
Gruppo Abele - Torino
111
Centri Crisi a breve periodo di residenzialità (max 2-3 mesi), con l’obiettivo di una disassuefazione, di una “tregua”, di dipanare una prospettiva, di comprendere meglio il paziente, di fare diagnosi. In alcune regioni d’Italia tali strutture si chiamano per l’appunto Centri di osservazione e diagnosi (es: Emilia Romagna). L’osservazione viene portata
avanti tramite l’affiancamento e la condivisione delle attività e dei vari
momenti della giornata da parte degli operatori, 24 ore su 24 per un
periodo medio di 30-45 giorni, in una situazione drug-free; più spesso
durante un intervento in cui viene scalato il sostitutivo e diminuito, in
qualche caso azzerato, ogni altro apporto farmacologico, per cui le persone non fruiscono delle usuali coperture chimiche. Si espongono e si
mettono in gioco in base a dinamismi non alterati o condizionati dall’uso di sostanze, quanto piuttosto dalla loro assenza. La capacità di
rinunciarvi, le modalità con cui si sopperisce alla mancanza, le risorse
che vengono messe in gioco appaiono o non appaiono, così come lo
spettro delle proprie modalità relazionali, il senso di realtà, l’arco delle
proiezioni, l’aggressività auto e eteroriflessa, le strategie di adeguamento
o meno alle diverse situazioni. Con lo strumento dell’osservazione prolungata ed intensiva, che si aggiunge agli altri già in possesso, quali
l’anamnesi, i colloqui clinici, i test, il reperimento di altre fonti di informazione (dai familiari ai Servizi già in contatto con le persone), si è
in grado di approfondire la diagnosi descrittiva con interpretazioni
psicodinamiche, evidenziando meglio le mappe del funzionamento
intrapsichico del soggetto.
Il processo diagnostico, nel setting del Centro Crisi o di osservazione e
diagnosi, consente infine di stringere un’alleanza di lavoro, con la conoscenza e la fiducia che si cerca di sviluppare da parte degli operatori,
e che trova una buona conclusione di tappa nella restituzione all’interessato di quanto insieme, in quel luogo, si è scoperto. È un lavoro che
non viene svolto all’insaputa della persona coinvolta, ma che ne cerca
la collaborazione già dall’inizio, definendone insieme l’obiettivo e rendendo già intervento di cura/pre-cura il processo diagnostico stesso.
La restituzione diagnostica non è solo un esercizio di correttezza da
parte degli operatori proposti: è invece un’azione inerente ad un metodo che caratterizza tutta l’impostazione del lavoro in struttura. Tutto
ciò non è possibile nel setting ambulatoriale dove l’osservazione sporadica é più legata a ciò che l’utente sceglie di portare, di volta in volta,
di sé; dove, inoltre, l’aspetto confondente dell’assunzione di sostanza è
una variabile maggiormente in rilievo. I centri diurni strutturati si presentano ad assolvere la stessa funzione dei Centri Crisi; meno i drop-in
112
caratterizzati da altre finalità e da una più alta discontinuità di presenza.
Un aiuto alla gestione della crisi
Lo scompenso psichiatrico, affrontato farmacologicamente senza dover ricorrere al ricorso in repartino, può comportare la necessità della
ricerca di un riparo, un luogo protetto, in cui le persone possono gradualmente ripigliarsi fruendo di attenzioni e relazioni non medicalizzate.
La vita di strada, in cui più si osserva la confluenza tra disagio psichico
ed abuso di sostanze, comporta, soprattutto per le persone più fragili,
isolamento, solitudine, emarginazione all’interno delle stesse
aggregazioni dei senza dimora. Dormitori, ripari notturni, foyer in risposta all’emergenza freddo, così come case di pronta accoglienza ed
alloggi per un’ospitalità breve, possono assolvere sul breve periodo ad
una funzione di accudimento, utile per una prima stabilizzazione, a
partire dalla quale è prospettabile un intervento successivo. Sono strutture a bassa soglia, non specialistiche, ma che posseggono know-how
per gestire situazioni di “smarrimento” variamente connotate e che sono
in rete con i servizi specialistici in grado di produrre, in caso di bisogno ed in tempi brevi, il supporto necessario. Sono strutture agili che,
anche se non specificatamente dedicate all’ambito psichiatrico, della
dipendenza o della comorbilità, possono essere utili anche nelle situazioni di lacerazione ed esasperazione familiare, quando i comportamenti agiti non trovano più una capacità di gestione o di tolleranza nel
milieu tradizionale, per cui si configura una emergenza relazionale
risolvibile, in alcuni casi, solo con l’offerta di altre opportunità d’accoglienza e con l’allontanamento. Sono tutte situazioni di difficoltà e d’urgenza analoghe, ma non assimilabili né alla crisi di astinenza delle persone tossicodipendenti in difficoltà nel procurarsi le sostanze, né alla
crisi psichiatrica tout-court che trova risposta nell’emergenza
ospedaliera. Sono crisi meno conclamate e più “striscianti”, che non
hanno bisogno di un setting tradizionale di trattamento, che finirebbe
per essere eccessivo ed etichettante e potrebbe comportare rischi
iatrogeni. C’è oggi estrema necessità di queste strutture, mai al passo
col procedere veloce dell’ampliamento delle fasce di emarginazione,
per lo più gestite dal volontariato, da associazioni e cooperative del
privato sociale. Consentono un contenimento, assolvono a una funzione “tampone”, sono interventi agili e brevi, ma necessari e preziosi.
113
I trattamenti residenziali
Si è molto discusso, e molto si discute ancora, su quali trattamenti residenziali per quali pazienti comorbidi. Rispetto alla varietà delle diagnosi psichiatriche ed alla loro diversa combinazione con l’abuso e la
dipendenza delle varie sostanze stupefacenti, le proposte di residenzialità
non possono che essere articolate in programmi diversificati in base,
più che alla specificità delle problematiche, ai “bisogni di fase” a cui si
tratta di rispondere.
Innanzitutto le differenziazioni. Lo spettro delle schizofrenie su cui si
innesta generalmente un abuso - e non una vera e propria dipendenza
da eroina - può trovare ospitalità, in numero ridotto (non più di due
pazienti per ogni struttura), accanto agli utenti tradizionali delle comunità terapeutiche. Possono costituire l’eccezione nell’applicazione rigida del programma, non condizionando sostanzialmente la vita in comunità dell’intero gruppo di utenti. Se l’identificazione nel ruolo del
tossicodipendente non è troppo accentuata, nel cui caso si coglie un
movimento difensivo di copertura rispetto al malessere psichico, anche una comunità psichiatrica può fare all’uopo. Controindicata invece
appare la scelta di un inserimento in una comunità apposita per soggetti in doppia diagnosi e, tantomeno, in una struttura per soggetti schizofrenici che abusano di sostanze stupefacenti. Verrebbe troppo indebolita la possibilità di fare gruppo, il principale strumento a disposizione
della comunità e l’effetto traino dello stesso verso gli utenti meno attrezzati.
Diverso invece è il discorso per i disturbi borderline di personalità.
Soggetti gravi e gravosi, sono sempre stati e sono già presenti nelle
comunità terapeutiche e di accoglienza, spesso all’insaputa degli operatori che li accolgono e degli operatori che li propongono, in mancanza di una diagnosi definita. Per le “sociopatie”, già Cancrini - in “Quei
temerari sulle macchine volanti” - proponeva la comunità come lo strumento più idoneo per un’esperienza intensiva che fosse ricostruttiva e
riparativa delle loro modalità di porsi e di agire. Gli operatori già le
conoscono; a differenza degli utenti precedenti sanno di più come comportarsi con loro anche se alcune situazioni sono al limite della
sostenibilità e spesso lo scenario comportamentale che propongono è
da Far West. L’aumento dell’età e l’aumento di anni e decenni di
tossicodipendenza rende determinate situazioni ancora più gravose.
Le problematiche psichiatriche indotte dal consumo e dall’abuso di
droghe di sintesi non hanno bisogno della risposta di comunità. All’
acuzie risponde il servizio d’emergenza psichiatrica, le “psicosi clini114
che” vengono trattate in repartino ed il lavoro successivo si configura
come ambulatoriale.
L’”Aids dementia complex” ed altre sindromi organiche vengono trattate nelle case famiglie per l’Aids o in strutture psichiatriche.
Molte persone con disturbi di personalità borderline non reggono i programmi tradizionali di comunità. Sono già ripetenti e pluriripetenti,
non avendo portato a termine i precedenti percorsi o, più semplicemente, avendo ricavato un proprio uso dal periodo di accoglienza in
comunità. Si tratta di partire da una migliore comprensione dei loro
bisogni, pensare più ad una stabilizzazione dello stile di vita e ad un
contenimento dei comportamenti disfunzionali che non all’obiettivo
drug-free di piena emancipazione dall’uso di sostanze stupefacenti. Si
tratta di mirare gli interventi all’integrazione sociale possibile,
riconnettendoli col mondo del lavoro, la produzione di reddito e limitando, insieme al consumo, i comportamenti illegali connessi. Comunità residenziali aperte, da cui durante la giornata ciascuno esce conducendo una propria attività in forte collegamento col territorio di riferimento, che consentono un’alternativa al carcere, alla strada, al consumo compulsivo e coatto.
Il reinserimento
Il reinserimento non è la cenerentola degli interventi di comunità. Non
è solo la prova del nove del lavoro svolto, ma anche la fase che necessita di maggiori attenzioni e risposte. Questo è vero per tutte le persone
tossicodipendenti ma, in particolare, per i pazienti comorbidi. Il
reinserimento lavorativo deve cominciare molto presto e, nei casi di
pazienti borderline con disturbi di personalità che non riescono a stare
per un lungo periodo in strutture residenziali, spesso quasi
contestualmente all’inserimento in comunità. Il reinserimento abitativo
sarà invece successivo e da individuarsi in qualche forma: singola, di
gruppo, oppure in convivenza guidata. Prima si rende necessaria una
sufficiente affermazione di abilità nei rapporti sociali, nella cura di sé
e, ovviamente, nell’esercizio di un’attività lavorativa. Il reinserimento
ambientale del paziente comorbido è compito degli operatori di comunità, anche se non solo loro (il monitoraggio dell’inserimento lavorativo in senso stretto potrebbe essere condotto da appositi tutors). La
stabilizzazione nell’assunzione di un impegno di lavoro, nella capacità
di portarlo avanti rispetto alle mansioni e ritmi richiesti ed al sistema di
relazioni entro il quale si svolge, costituisce l’obiettivo propedeutico
115
alla più ampia operazione di reinserimento ambientale ed abitativo. La
gradualità di passaggi dovrebbe tutelare maggiormente i soggetti da
crisi, scompensi ed acting-out o da ricadute nell’uso di sostanze. In
queste situazioni la comunità si prefigge in primo luogo la
stabilizzazione del paziente, farmacologica e psico-sociale. L’obiettivo è un reinserimento ambientale in assoluta continuità con l’esperienza in comunità (ad esemepio: borsa lavoro in cooperative di tipo B e
collocazione in un alloggio a convivenza guidata), “appoggiato” su un
mantenimento metadonico conseguito ed ampiamente sperimentato
durante il periodo di permanenza in struttura e concomitante (o quasi)
inserimento lavorativo.
Per le situazioni in cui la dipendenza (più spesso l’abuso) è successivo
alla problematica psichiatrica, il reinserimento è generalmente di tipo
tradizionale, a compimento del percorso pieno di comunità (mediamente 18 mesi), dopo che si è consolidato uno stato drug-free ed il
soggetto riesce a sviluppare una discreta compatibilità con la realtà
senza o con un trattamento farmacologico ben accettato. Anche in queste situazioni la gradualità del reinserimento consente di meglio
monitorare l’ulteriore cambiamento, con più possibilità di prevenire
crisi di scompenso, abbandono del trattamento farmacologico ed eventuale riutilizzo di sostanze stupefacenti.
Mediazione col nucleo familiare di appartenenza
Sia con la famiglia d’origine che con la famiglia acquisita, è propria
del privato sociale che lavora con i soggetti in comunità, un’esperienza
ed una capacità di portare avanti un percorso parallelo per i familiari.
Soprattutto là dove l’autonomia dei soggetti permane precaria e l’obiettivo della “restitutio ad integrum” non è realisticamente perseguibile,
tantomeno con la stabilizzazione dello stato drug-free, il lavoro con la
famiglia - per ottenere la disponibilità e l’idoneità ad un prendersi cura
del paziente - è parte della finalità strategica del complesso degli interventi. Sia nel caso di un reinserimento abitativo presso i familiari, come
anche nel caso più limitato, ma non necessariamente meno impegnativo, di un loro ingaggio in una relazione d’appoggio che abbia il segno
della continuità e della disponibilità nel caso dell’urgenza, il lavoro
con le famiglie consiste in lavoro di capacitazione e mediazione.
Saper assumere gli atteggiamenti più adeguati alla situazione, saper
cogliere i segnali premonitori di una crisi, saper ricorrere all’aiuto professionale, per sé e per il paziente in caso di bisogno, contribuire alla
116
compliance alla cura, saper gestire o quantomeno evitare alcuni errori
nel caso di uno scompenso psichico, costituiscono un’insieme di abilità acquisibili con l’apporto di competenze professionali specifiche e
con la conoscenza dei dinamismi propri di ciascun paziente. Gli operatori di comunità, avvalendosi dell’aiuto dei tecnici del Sert e del Servizio di Salute Mentale possono, nell’arco di un periodo di tempo prolungato, costruire insieme ai familiari un tale know-how.
Progetti di de-istituzionalizzazione
Non pochi portatori di problematiche psichiatriche, giovani in età non
superiore ai 35 anni con esperienza di abuso di sostanze stupefacenti,
sono, per lungo tempo, ricoverati in strutture protette, a grave rischio
di cronicizzazione. Sono per lo più case di cura tradizionali in cui al
trattamento farmacologico si abbina una residenzialità protratta, senza
elementi di progettualità. Si ritiene possibile, ed alcune esperienze già
condotte in merito sono confortanti (ad esempio il progetto “Mainero”
della coop. Progetto Muret ed Asl 1 di Torino), predisporre un percorso
in grado di ricondurre, nell’arco di tempo di 1-2 anni, alla riacquisizione
di una possibile autonomia e ad una ricollocazione nella comunità territoriale.
Il percorso inizia con una ridefinizione diagnostica, un’analisi delle
risorse e delle potenzialità dei soggetti ricoverati, una loro selezione in
base all’evidenziazione di fattori prognostici evolutivi ed un inserimento
in una struttura di accoglienza. Essa è anche centro di osservazione e
conoscenza, a partire dalla quale viene programmato e parzialmente
realizzato l’inserimento lavorativo possibile, per poi ipotizzare un inserimento successivo in casa alloggio. Sono generalmente pazienti con
diagnosi in Asse I che, nell’arco dell’anno di realizzazione del progetto, evolvono da comportamenti cronicizzati tipici di una permanenza
prolungata in istituzioni chiuse, in comportamenti più trasgressivi che
si associano all’uso di un esercizio maggiore di libertà che, in precedenza, li avevano condotti all’abuso di sostanze stupefacenti e di alcool.
La popolazione psichiatrica “tradizionale”, ancor giovane, fortemente
esposta all’uso di sostanze, numericamente in crescita, e che viene contenuta per anni nelle case di cura, non è di poco conto. È a forte rischio
di lunga degenza, a volte più per i comportamenti trasgressivi messi in
atto, che non per la protratta gravità della malattia psichiatrica. Rischia
117
oggi di essere dimenticata nel pur vivace dibattito che si è aperto sulle
comorbilità e sulla cosiddetta doppia diagnosi.
Conclusioni
Il ruolo del privato sociale, che non si esaurisce nell’offerta di opportunità residenziali anche se molto articolate e su misura dei diversi bisogni dei pazienti comorbidi, è di consentire spazio e praticabilità agli
indispensabili interventi psicosociali che si affiancano ai trattamenti
farmacologici, rendendoli più a tempo, più mirati, e sostanzialmente
più efficaci allorchè entrano in sinergia con una migliore qualità ed
organizzazione della vita di molti pazienti.
Sollecitare il territorio, stanare risorse, portare avanti una progettazione di inserimento sociale, insieme ad un costante appoggio relazionale,
significa produrre azioni di contrasto all’emarginazione, all’isolamento ed alla solitudine. Significa diminuire le disperazioni, gli acting-out,
gli atti etero e autolesivi, limitare un abuso abbruttente delle sostanze
stupefacenti e dell’alcool, mettere in guardia da pericolosi miscugli di
droga e psicofarmaci, riuscire a portare avanti la stessa cura medica.
Il ruolo del privato sociale è un ruolo di fondamentale attenzione al
problema, al modo in cui non viene trattato o viene bistrattato dalle
stesse istituzioni preposte alla cura. Ma non si esaurisce in azioni di
vigilanza e denuncia. Vuol essere propositivo, offrire opportunità, spazi di accoglienza cogestibili in collaborazione coi servizi specialistici
e, allo stesso tempo, interpellare le comunità locali perché cresca una
cultura più qualificata intorno a tali problematiche, che è pre-condizione per attrarre più risorse e contenere il ricorso ad una delega sempre
più specialistica ed esclusiva, ai tecnici ed alle loro strutture. I farmaci,
da soli, contengono ed evitano le lacerazioni più distruttive; ma i farmaci, da soli, non curano e non si prendono cura delle persone.
118
Problemi d'integrazione
tra ruoli professionali, équipe e sezioni
riflessioni
A. ORSENIGO *
Premessa: la prospettiva di riflessione
Le questioni, le osservazioni e le riflessioni che possono essere sviluppate attorno al tema dell’integrazione tra professioni, gruppi di lavoro
e Servizi sono assai ampie. In questo ridotto spazio di poche pagine mi
limiterò a proporre alcuni spunti, delle suggestioni dal punto di vista
particolare di chi, assieme al gruppo professionale di cui è parte, realizza interventi d’accompagnamento, formazione, riorganizzazione e
progettazione di consistente durata ed impegno. Si tratta della prospettiva di chi, pur dedicando da anni una quota significativa dell’impegno
lavorativo nel settore delle tossicodipendenze e della salute mentale,
non lavora continuativamente nei SerT o nei DSM. Per scelta professionale cerco, infatti, d’arricchire la competenza misurandomi con problemi di differenti tipi d’organizzazione, in contesti diversi: ospedali,
comuni, regioni, il sistema giudiziario, sistemi di Servizi privati e di
cooperative, reticoli d’istituzioni, aziende private. Si tratta d’esperienze in cui, con elevata frequenza, uno dei fuochi dell’intervento è quello
dell’integrazione - interna all’organizzazione e con il sistema di Servizi esterni - dei processi che la caratterizzano, delle diverse forme che
assume, dei costi e dei benefici che essa comporta. Una serie d’elementi cruciali sono assolutamente ricorrenti, mentre altri segnano le
specificità dei differenti contesti lavorativi.
L’integrazione è, in effetti, un problema che attraversa ogni ambito della
vita organizzativa, sociale ed individuale. Dalla mia esperienza ho tratto l’impressione di un oscillare, spesso ambiguo, tra il dividere ed il
collegare. Da un lato, sembra si voglia tenere distante, scindere parti
dell’organizzazione, del sistema sociale, della nostra vita e dei nostri
*
Studio APS - Milano
119
stessi pensieri. Dall’altro, si vorrebbe collegare consensualmente o
forzosamente parti del mondo e di noi stessi che sembra proprio insieme non vogliano stare. Le nostre organizzazioni e la nostra vita mi
sembrano spesso una collezione di desideri, sogni, necessità, sforzi,
successi e fallimenti nel cercare di separare e nel tentare, per contro, di
collegare, integrare.
Vorrei sottolineare come il nostro stesso sentire, vedere, pensare è un
continuo processo di distinzione ed integrazione. Dobbiamo distinguere sensazioni, emozioni, riflessioni. Dobbiamo separare rumori da parole, figure da sfondi. Ma dobbiamo anche continuamente organizzare,
collegare un insieme spesso caotico di segnali, comunicazioni, episodi. Questo continuo lavorìo sociale ed individuale, di divisione ed integrazione, ci porta a costruire il senso di ciò che avviene attorno a noi ed
a noi stessi, nei contesti di lavoro e nel resto della nostra vita. È la
nostra capacità – nostra nel senso di sociale ed individuale – d’esercitare questa funzione che ci permette di conservare una certa salute
mentale, di poter vivere integrando sofferenze e gioie senza dover dipendere coattivamente da altri o da altro. In questo senso penso che le
capacità di distinguere ed integrare dei SerT e dei DSM abbiano una
specifica e critica importanza. A loro è richiesto, diversamente dalla
generalità dei Servizi, di aver cura di quanti – individui e sistemi –
manifestano più acute e croniche difficoltà nel mettere in campo efficaci e socialmente condivisi sistemi di differenziazione ed integrazione. E, per di più, la loro cura è spesso, specificatamente rivolta a migliorare le capacità d’integrare dei loro clienti.
Vorrei richiamare l’attenzione del lettore anche su un’ultima premessa
che caratterizza il mio punto di vista e che avrò modo di riprendere
successivamente. Gli esseri umani – e non solo quelli – hanno dovuto
sempre trovare forme d’integrazione. Queste forme d’integrazione sono
assai variegate e, nonostante si tenda a dare una valutazione in sé positiva alla cosa, alcune di queste appaiono ai nostri occhi come primitive,
disdicevoli o negative. Ho, invece, l’impressione che se ne abbia
diffusamente una visione riduttiva ed idealizzata. L’integrazione in sé
non è né buona, né necessaria. Non possiamo, infatti, dimenticare che
forme di società fortemente integrata sono state quella indiana per caste o quella romana con nobili, liberi e schiavi. Forme d’organizzazione del lavoro basate sulla schiavitù, sui servi della gleba erano fortemente integrate eppure risultano per noi generalmente vergognose.
Eppure quelle società e la costruzione delle piramidi o delle opere classiche continuano ad affascinarci. Le forme stesse dell’organizzazione
del lavoro fordista, della catena di montaggio di chapliniana memoria,
120
che sono state capaci d’integrare in modo estremamente efficace soggetti tanto differenti e con scarse competenze, sono oggi diffusamente
criticate, anche da imprenditori e manager, per la loro rigidità, per i
rapporti di dipendenza che strutturano. Si cercano nuove forme d’integrazione più flessibile, a legami più deboli. Vale dunque la pena d’integrarsi ed in quale forma?
Contestualizzare per comprendere le difficoltà
I processi d’integrazione non si sviluppano nel vuoto, al di fuori della
storia, ma in contesti mutevoli e specifici. Una riflessione sui problemi
d’integrazione deve quindi partire da una rappresentazione dell’ambiente in cui si sviluppano.
La nostra società è caratterizzata da situazioni complesse, ambigue,
contraddittorie. Ci muoviamo in un contesto decisamente poco chiaro.
Non si è in grado di prevedere cosa accadrà nei prossimi anni o nemmeno mesi. La nostra è diventata una società più aperta: una serie di
vincoli e costrizioni sono saltate. Opportunità e rischi sembrano cresciuti. I confini tra organizzazioni, stati, sistemi sono diventati più incerti e permeabili. Messaggi contraddittori sono rivolti ai cittadini: essere più autonomi, ma anche essere più disciplinati. Essere indipendenti, ma fedeli. E’ alimentata l’idea della bontà dell’individualismo e,
nello stesso tempo, si fa appello alla necessità di forme d’integrazione
sempre più complesse ed elastiche, che lo Stato non è più in grado di
garantire. Sembra che sempre meno si possa far conto su sistemi pubblici di protezione, costosi, ma contenitivi. La flessibilità di cui tutti
parlano ne è un evidente elemento. Le organizzazioni sembrano alla
ricerca d’individui che più che dotati di saperi solidi e definitivi, siano
disponibili ad una continua ricerca, ad un inesauribile lavoro d’integrazione di sempre nuove conoscenze, di differenti ed originali punti di
vista. In modo sempre più evidente appare come l’integrazione non sia
solo un problema organizzativo o sociale, ma anche mentale. Parte
inscindibile della professionalità, a mio giudizio, in questo mondo complesso, confuso e contraddittorio, è diventata la capacità di far fronte ai
problemi d’integrazione su più livelli.
Le organizzazioni sanitarie, particolarmente, sembrano vivere in una
fase d’accentuata turbolenza e confusione. Logiche contraddittorie sembrano essere propugnate senza che appaia un investimento per la loro
integrazione. Il mandato istituzionale dei Servizi Sanitari sembra assai
poco chiaro: tutela generalizzata della salute, tutela degli obiettivi di
121
budget, profitto, accrescimento dell’offerta, valore economico, valore
sanitario? Teorie dichiarate relative al governo di queste organizzazioni, appaiono in contrasto con le teorie in uso, rilevabili nella prassi
quotidiana.
Nello specifico delle tossicodipendenze gli operatori si trovano ad agire nell’ambito d’indicazioni spesso contraddittorie. I tossicodipendenti vanno visti come malati o come viziosi? È questo un settore in cui
smobilitare gli investimenti, perché altri se ne occupino, ad esempio il
privato? Primari dei SerT segnalano richieste di Direttori Sanitari a
ridurre il numero di soggetti in carico, mentre nel contempo la quantità
dei cittadini in carico è utilizzata come indice per attribuire risorse.
Altri sono pubblicamente ripresi perché gli invii in comunità di tossicodipendenti sono stati ridotti, mentre nel contempo è loro chiesto di
tagliare i budget per gli inserimenti in comunità.
Relativamente al raccordo coi DSM il mandato appare decisamente
nebuloso. È possibile raccogliere discorsi e programmi di vario genere
ed orientamento. Tanto che risulta assai difficile dire se l’integrazione
sia un mandato per il S.S.N. a livello nazionale, oppure se sia una scelta locale. Ma risulta ai responsabili poco chiaro se un’opzione nella
direzione dell’integrazione possa essere intesa come positiva o negativa. E quale tipo d’integrazione poi?
Ne deriva un diffuso disorientamento nei Servizi ed una mancanza di
chiarezza sul senso e le priorità d’investimenti. Ciò alimenta un
ripiegamento in visioni localistiche od individualistiche. Oppure in visioni polarizzate ed assolute, rigide ed ideologiche posizioni difensive
che appaiono uno sforzo per uscire dall’incertezza, seppure con una
chiarezza fittizia. Ciò spinge a rappresentarsi la questione in termini di
opposti: giusto/sbagliato, bene/male, amici/nemici. “L’integrazione col
DSM è giusta”. “L’integrazione col SerT è da evitare assolutamente”.
“Quelli sono nemici, ma per fortuna tra loro ci sono amici”. “Sono per
l’integrazione, a patto che li mettano tutti sotto di me!”.
Società e contesti organizzativi alimentano, spesso inconsapevolmente, posizioni che rendono assai difficile l’integrazione ai vari livelli.
Così, l’individualismo narcisistico, fortemente alimentato nella nostra
cultura e che trova un fertile terreno nella logica libero professionale
assai diffusa nella sanità, certo non alimenta forme evolute di collaborazione. Esso spinge piuttosto all’isolamento o ad una competizione
escludente in cui l’altro è visto come avversario da sconfiggere, come
elemento funzionale all’implementazione dell’immagine di sé. Il grande interesse per il proprio punto di vista, il proprio progetto di lavoro,
122
mette del tutto in ombra quelli degli altri. Alimenta soliloqui invece
che dialoghi. Scissioni piuttosto che integrazioni.
La visione economicistica della vita lavorativa, che pure è alimentata
in questi anni, porta a credere che tutto sia riducibile, valutabile attraverso una visione monoculare, aritmetico-ragionieristica della vita
organizzativa. L’integrazione è allora presa in considerazione solo se
funzionale a immediati riconoscimenti economici. Essa tende a rappresentare l’altra parte in una visione strumentale, funzionale al proprio profitto. Che vantaggio economico ho nell’integrarmi col DSM? I
costi sono visti esclusivamente e riduttivamente in termini economici.
Un terzo elemento che osservo diffusamente, in grado di influenzare
negativamente gli investimenti in termini d’integrazione, consiste nella visione negativa, persecutoria dei problemi. I diversi attori organizzativi vogliono evitarli, piuttosto che avvicinarsi per condividerli. Ciò
porta ad evitare i contatti con chi è rappresentato come portatore di
problemi. Perché quindi integrarsi con un Servizio che è fonte potenziale o certa di nuovi problemi? In questa prospettiva vale la pena di
collegarsi maggiormente solo se l’altro – DSM, piuttosto che SerT, lo
psichiatra, piuttosto che l’assistente sociale – rappresenta una soluzione di problemi. Non è sentito, o è messo del tutto in ombra, il piacere
del condividere il lavoro sulle difficoltà, attorno a interrogativi. Si può
facilmente immaginare quale integrazione alimenti un Direttore Generale che ostenta, come m’è capitato di osservare, sulla sua scrivania e
rivolto all’interlocutore un quadretto con l’interrogativo: ”Sei venuto a
portare problemi o soluzioni?”
Una quarta diffusa posizione che caratterizza di questi tempi la vita
organizzativa di molti Servizi è il ritiro sfiduciato, la demotivazione, la
perdita di senso nell’investimento lavorativo. In queste condizioni appare più difficile, per molti versi, lavorare per sviluppare integrazione.
Infatti, il ritiro alimenta, a sua volta, solitudine, delega ed un consenso
molle e lamentoso. Sempre meno ci si interessa alle sorti complessive
del Servizio, si pensa al proprio orticello, si delega l’autorità a prendere iniziative relative all’integrazione, alimentandone così il narcisismo,
l’ansia e l’inevitabile inadeguatezza, data la complessità della situazione. Ma non solo, in termini sempre più generalizzati, gli operatori finiscono per accondiscendere senza energia alle decisioni nel mentre
manifestano la loro insoddisfazione con un diffuso lamentarsi
deresponsabilizzato. In effetti, le esperienze lavorative degli operatori,
e quelle ripetutamente richiamate dai responsabili ai diversi livelli, sembrano punteggiate da faticosi, spesso frustranti, tentativi d’integrazione con altri Servizi più che da piacevoli esperienze di coordinamento.
123
Da un lato l’integrazione appare, nelle dichiarazioni, connotata
diffusamente come cosa in sé positiva. Mentre nella prassi e nei racconti viene frequentemente rappresentata come un rischio, se non come
una minaccia. Se poi, all’interno degli stessi singoli DSM o SerT, l’integrazione non è sperimentata come positiva, è ben facile che si tenda a
proiettare la difficoltà all’esterno, rappresentandosi allo stesso modo
l’integrazione con SerT o DSM. In effetti, frammentazioni, isolamenti,
costi elevati già sperimentati non alimentano fantasie e progettazioni
verso integrazioni generative.
Un ulteriore elemento di contesto che caratterizza la situazione rendendola difficile e sfidante è che questa dovrebbe realizzarsi con soggetti – i cittadini/clienti, i sistemi sociali – che manifestano specifiche,
accentuate ed anche patologiche difficoltà d’integrazione. Questi riversano, riproducono, proiettano nelle relazioni con i Servizi queste
loro difficoltà, accentuando quelle di ogni organizzazione e rendendo
peraltro più urgente l’azione integrativa. In più, l’oggetto stesso dell’integrazione – il problema del trattamento della comorbilità – ha confini poco chiari e definiti, ha dimensioni nebulose, se non ambigue.
Ciò certo non facilita processi d’integrazione. Cosa ben diversa sarebbe il realizzare un processo d’integrazione tra due organizzazioni chiamate a costruire un ben definito oggetto – ad esempio una sedia – o a
trattare un ben definito problema - ad esempio il trattamento di un’appendicite acuta - con clienti ben integrati ed evoluti.
Perché l’integrazione può essere utile
L’integrazione ai vari livelli nel settore della comorbilità è sostenuta da
differenti necessità. Innanzitutto gli individui, le singole professioni, le
équipes ed i Servizi non sono onnipotenti. I limiti che caratterizzano
questi diversi soggetti rendono necessaria la collaborazione con altri
attori sociali per progettare e realizzare interventi adeguati. Se fossero
in grado di risolvere autonomamente i problemi connessi alla
comorbilità, non sarebbe allora necessaria l’integrazione.
Ogni soggetto individuale o collettivo costruisce nel tempo consolidate e relativamente statiche modalità di conoscere ed agire. La “realtà”
tende ad essere vista in modo stereotipato da parte delle singole professioni e organizzazioni. Si sviluppano così delle routine cognitive ed
operative. Per far fronte alla complessità ed ambiguità che caratterizzano i problemi della comorbilità, sono richieste capacità di costruire
rappresentazioni dei problemi, sviluppare progetti e realizzare azioni
124
più ricche ed innovative. C’è bisogno di capacità d’inventare, non solo
di ripetere, di riapplicare un sapere consolidato. È di fondamentale
importanza, in simili situazioni, una capacità di vedere, rappresentarsi
diversamente le situazioni, i problemi. I processi d’integrazione, mettendo a contatto con le differenze, favoriscono la messa in discussione
delle routine, aprono alla diversità, favoriscono la messa in discussione
di modi di rappresentarsi la realtà e di agire di conseguenza. Possono
alimentare le curiosità e le trasgressioni.
L’integrazione è anche l’occasione per costruire un contenitore sufficientemente buono - non eccellente per carità - per soggetti che si debbono misurare, come clienti ed operatori, con la complessità ed ambiguità della comorbilità. Piuttosto che una serie di soggetti e contenitori
frammentati, che si fanno portatori di visioni di rappresentazioni dei
problemi e di strategie spezzettate, si può così costruire un contenitore,
un’organizzazione, forse temporanea, che si prenda cura di questioni,
sofferenze e speranze.
Che contenitore mettiamo in campo con le nostre professionalità,
équipes e Servizi?
Perché l’integrazione non è necessariamente utile?
L’integrazione può essere certamente generativa. Può produrre attraverso l’incontro di diversità qualcosa di nuovo, anche d’imprevisto e
forse di trasgressivo. Essa può generare valore aggiunto in termini
d’erogazione di servizi più evoluti ed apprezzati, sviluppo di conoscenze, coordinamento tra Servizi.
L’integrazione può però anche essere distruttiva, mortifera. Può essere
impiegata per distruggere valore, capacità delle parti. In questi casi si
osserva come una professione od un Servizio siano orientati a sottomettere o parassitare l’altra parte. È il caso in cui si mira all’integrazione, ad esempio con un altro gruppo professionale od équipe, per affermare la superiorità dei propri quadri di riferimento. L’integrazione è
allora intesa quasi come sinonimo di gerarchizzazione del sapere. L’assistente sociale sarà ben integrata se ben subordinata allo psicologo od
allo psichiatra. In questa direzione sembrano anche andare i processi
d’integrazione tra Servizi quando, ad esempio, un DSM manifesta interesse per l’integrazione con un SerT per colonizzarlo, per utilizzarne
le risorse indirizzandole secondo un progetto proprio e non sviluppato
in una prospettiva dialogica. Se una delle parti si rappresenta il rapporto in termini parassitari, si costruiscono delle premesse per un’integra125
zione distruttiva, assolutamente poco o nulla generativa, almeno per
l’altro.
L’integrazione, anche quando ha potenzialmente elementi generativi, è
anche una minaccia alle difese costruite faticosamente da ciascun attore individuale e collettivo. Ciascun gruppo ha sviluppato, come sopra
accennavo, modi di vedere ed agire stabili, divisioni del lavoro, rapporti gerarchici, che, per quanto imperfetti, offrono una mappa sufficientemente stabile, una cornice entro cui muoversi. Si tratta d’elementi
che definiscono, spesso inconsapevolmente, il senso, il valore, gli orientamenti nel lavoro, ma anche cosa sia una patologia. Una delle funzioni fondamentali di un’organizzazione è di cercare di costruire un legame tra episodi, segni, fatti, dando a ciò un senso. L’organizzazione cerca di produrre ordine in ciò che di per sé potrebbe essere solo caotico,
angosciosamente frammentato. Ciò dovrebbe permettere di dare un
senso alla sofferenza, a comportamenti individuali e sociali, all’uso di
sostanze proibite e certamente dannose, a pensieri, comportamenti,
emozioni angosciosi, altrimenti definiti come insensati. Così potranno
essere rappresentati, secondo i punti di vista, come immorali, patologici, asociali, folli, criminali, scandalosi, …. Il professionista dovrebbe
essere in grado di vedere in termini più ricchi ed articolati del semplice
cittadino. Ma anche il più preparato professionista, la più ricca organizzazione vedono in termini limitati, necessariamente parziali, le situazioni. Nella mia esperienza di costruzione di integrazioni tra Servizi, come DSM e SerT, è stato assolutamente interessante rilevare delle
definizioni ampiamente distanti su cosa fosse un tossicodipendente tra
operatori di questi Servizi. Così è stato possibile osservare come, in
assenza di specifiche competenze nel settore delle tossicodipendenze,
gli operatori del DSM cercassero a volte, per comprendere questi specifici problemi, di ricondurli all’interno di quadri concettuali sperimentati nella psichiatria o applicassero quadri di lettura non professionali.
Abbondano in tal senso stereotipi e luoghi comuni. Illuminante in tal
senso l’affermazione di uno psichiatra a fronte delle difficoltà nel formulare una diagnosi soddisfacente per un soggetto tossicodipendente
con evidenti disturbi psichiatrici: “Il quadro clinico è inquinato dalla
tossicodipendenza; come posso fare una diagnosi psichiatrica?”. Oppure un’altra psichiatra di un CSM che affermava: “Fino a che F.C. si
fa, è evidente che non si possa fare una diagnosi psichiatrica”. Sono
parole che ben evidenziano come, a fronte di mappe cognitive date e in
cui si ha fiducia, il dato della tossicodipendenza possa essere inteso
come semplice “rumore”, elemento che impedisce di capire e non come
informazione ulteriore, se affrontato in una prospettiva monoculare.
126
Penso allora che serva riconoscere i costi, anche emotivi, dell’integrazione per poterla sviluppare. Il valore che può generare non è scindibile
dai costi che essa comporta, quindi dai rischi e dalle difficoltà ad assumerli.
Piste per sviluppare un’integrazione generativa
Nell’esperienza che abbiamo maturato nello Studio APS, abbiamo potuto osservare come spinte di tipo economicistico/mercantile, centrate
sull’idea che compensi, premi e disincentivi economici siano strumenti adeguati a realizzare integrazioni tra professioni, équipe e Servizi,
non siano sufficienti ad alimentare processi d’integrazione generativi e
non solo strumentali. Se il motore risulta prevalentemente di tipo monetario il personale viene orientato ad ottenere il massimo vantaggio
immediato col minor costo. L’obiettivo diventa così, spesso anche esplicitamente, quello del conseguimento del guadagno economico e non
quello dell’erogazione di un servizio integrato orientato al cliente. Il
senso che guida l’integrazione, se meramente economico, è troppo debole od esclusivamente strumentale.
Non sono nemmeno sufficienti ed efficaci interventi di tipo prescrittivo,
centrati sul comando, sulla definizione di protocolli rigidi, in cui le
varie parti sono chiamate ad adempiere a procedure standardizzate. Ciò
perché si ha a che fare con situazioni, oggetti, problemi fluidi, dai confini incerti, che non richiedono tanto fedeli esecutori, ma soggetti capaci di un pensiero specifico per le diverse situazioni con cui sono
chiamati a misurarsi. Non sono efficaci, in queste situazioni, protocolli
di tipo meccanicistico in cui si prescriva con precisione cosa e chi deve
fare specifiche operazioni, ben definite e quindi controllabili. Non sono
efficaci integrazioni basate sulla precisa e rigida definizione dei confini di competenza ed operativi tra DSM e SerT, o tra psichiatri e psicologi, tra medici e infermieri. Serve piuttosto la capacità di costruire
luoghi che aiutino gli operatori, i gruppi ed i Servizi a dialogare, a
pensare in modo generativo. Spazi in cui sia alimentata, suscitata la
curiosità, il confronto, la ricerca attorno ad oggetti di lavoro (i problemi da trattare) ambigui, dai confini sfumati. Serve capacità di pensiero,
di riflessione sulle questioni che vengono poste. Sono queste condizioni che motivano ad investire per erogare servizi di valore, integrandosi
con altri soggetti.
Serve dunque assumere una posizione clinica, nel senso letterale del
termine: di vicinanza, dialogo, ricerca “con” e non “su”, in cui si abbia
127
cura dei problemi e dei clienti. Purtroppo, nonostante ci si trovi in un
ambiente sanitario, una prospettiva clinica fatica a trovare spazio. Come
sopra accennavo sembrano prevalere logiche di natura differente, ad
esempio quelle d’ordine economicistico od una visione persecutoria
dei problemi. La costruzione di processi d’integrazione tra DSM e SerT
può costituire un’occasione interessante per ravvivare l’interesse clinico nelle équipes. Si tratta di coltivare uno stile di lavoro in cui soggetti
con competenze differenti si “mettono al letto del malato” per dialogare con lui e tra loro alla ricerca dei problemi, del senso di ciò che viene
raccontato od accade. Le esperienze degli uni e degli altri, in questa
prospettiva clinica, sono poste in dialogo. Gli interventi sono costruiti
in un’ottica di ricerca. Questa prospettiva clinica può essere utilmente
assunta sia nei confronti dei tossicodipendenti, sia nei confronti degli
altri operatori, sia nei confronti delle équipe chiamate ad integrarsi. Si
tratta di un approccio differente da quello tecnico o tecnicistico, che
spesso viene confuso con il clinico. La logica di tipo tecnico, assai
diffusa ed idealizzata nella nostra società, orienta a cercare nella memoria individuale od in quella collettiva le soluzioni esatte a problemi
predefiniti e precisi. Si tratta di un prezioso sapere accumulato, che
richiede capacità di riconoscimento (del problema) ed applicative (della soluzione). Questa prospettiva alimenta la convinzione che ogni problema possa essere risolto. La memoria e non l’intelligenza, la capacità di pensare, diventa la base della competenza. Succede così che ciascuno, possedendo un determinato numero di soluzioni, cerca – inconsapevolmente - di trovare i problemi adeguati. Quanto più un professionista, un’équipe ha sperimentato dei successi praticando determinate soluzioni, tanto più tenderà a ripercorrerle e quindi a cercare di trovare i problemi che permettono di avere successo. È un approccio che
non alimenta l’interesse per processi d’integrazione generativa. Al limite può favorire l’acquisto di soluzioni e procedure, ma non l’interesse per uno scambio clinico.
Una delle piste che propongo è orientata a sviluppare una rappresentazione dei problemi non persecutoria, ma come oggetto di ricerca clinica, di sviluppo professionale. Per il “tecnico” un problema senza soluzione o non è un problema o è il segno persecutorio della propria inadeguatezza. I problemi possono essere interessanti e sfidanti. Possono
alimentare l’interesse per l’integrazione con l’altro. A condizione che
si assuma, appunto, una prospettiva di ricerca e che non si pensi che
tutti i problemi possano o debbano essere risolti (spesso il prodotto
consiste in una loro migliore gestione). Una visione non persecutoria
dei problemi relativi alla comorbilità può alimentare l’interesse all’in128
tegrazione tra prospettive differenti, anche perché può essere vista come
l’occasione per costruire nuovi problemi, ridisegnarli, invece che ostinarsi in una definizione che ci rende impotenti. La nostra impotenza è
spesso legata ad una definizione delle questioni che ci ingabbia. Più
volte ho assistito a scontri attorno al problema: “Ma questo signore era
agli esordi un malato mentale od un tossicodipendente?”. Oppure attorno alla questione di chi definiva tossicodipendente un soggetto. L’integrazione con altri può essere utilizzata come occasione per riformulare
i problemi e diventare quindi più capaci di trattarli.
Potrà forse apparire banale, ma uno degli elementi critici su cui far leva
per costruire un’integrazione costruttiva tra SerT e DSM consiste nell’investimento sulla costruzione di un senso sufficientemente condiviso dell’agire coordinato tra i due Servizi e tra gli operatori che li compongono. Nel campo della comorbilità e nelle condizioni generali della sanità sono d’importanza sempre più critica gli interventi orientati a
ridurre la confusione in cui gli operatori debbono pensare ed agire.
Qual è il senso del lavorare assieme? Perché dovremmo collaborare? A
quali finalità risponde l’investimento in questa direzione di risorse, tempo, affetti e pensieri? Il fornire delle risposte convincenti, ed ancor
meglio il costruire assieme un senso sufficientemente condiviso tra
Servizi e clienti, sono dei potenti collanti organizzativi. L’aver lavorato
assieme per dare senso alla collaborazione mette alla prova i differenti
punti di vista, gli stereotipi, genera interrogativi e sollecita a trovare
risposte condivise. È evidente che per questa via propongo una pista
assai diversa dall’integrazione basata sul rispetto di norme e procedure
(che pure possono avere una loro utilità). L’ipotesi, che ho coi miei
colleghi più volte verificato positivamente, è che dare spazio, sollecitare interrogativi sul perché valga la pena avviare e gestire processi d’integrazione, per cercare assieme delle risposte a interrogativi complessi, sia un interessante ed efficace itinerario per alimentare il coordinamento e rafforzarlo. L’arricchimento che può essere generato in un processo di questo tipo, porta anche ad uno sviluppo interno ai singoli
Servizi. Per questa via sono sollecitati a rivedere e ripensare il senso
delle loro routine cognitive ed operative. La necessità di esplicitare ad
altri il senso, le logiche che sottendono le proprie azioni, sollecita operatori ed équipes a chiarificare le proprie posizioni, mette in luce la
relatività delle visioni. Lo sviluppare assieme il senso dell’integrazione, ed ancor prima quello del trattamento, aiuta a contestualizzare problemi ed obiettivi. Un investimento in termini d’integrazione tra due
servizi come DSM e SerT, non ha un senso in sé, ma muta a seconda
dei contesti geografici, temporali e culturali. D’altro canto un’integra129
zione che non ha bisogno di senso, che va fatta perché semplicemente
prescritta da protocolli, da una razionalità strumentale, può ben essere
definita come “insensata”.
Accanto ad una ricerca sul senso, è uno strumento di grande importanza per sviluppare integrazione la costruzione di una rappresentazione
sufficientemente condivisa dell’oggetto di lavoro. In alcuni contesti
lavorativi risulta chiaro ed esplicito quale sia l’oggetto su cui i membri
dell’organizzazione sono chiamati ad intervenire per modificarlo: tubi
da piegare e saldare, oppure parti di plastica e metallo da comporre
secondo un disegno, ingredienti da cucinare per preparare uno stufato,... In diverse organizzazioni che producono servizi, ed in particolare
nel settore della comorbilità, l’individuazione dell’oggetto di lavoro è
cosa complessa, interessante, ma spesso lasciata in ombra, se non indefinita. Non è così scontato che operatori di un Servizio sappiano dire
quale sia il loro oggetto di lavoro. Spesso accade che sia confuso col
cliente o paziente. Nell’ipotesi di una collaborazione tra SerT e DSM è
d’importanza critica che si sia sviluppato un accordo su ciò che pensiamo di voler trasformare. L’integrazione tra due organizzazioni lavorative ha infatti senso in quanto orientata a trasformare un qualcosa. Questo
è per l’appunto l’oggetto di lavoro. Lo definirei quindi come il problema o l’insieme dei problemi che si intende assumere come oggetto di
lavoro, per risolverlo o per meglio gestirlo. Qual è, quindi, il problema
– l’oggetto di lavoro – che si vuole trattare, sul quale si vuol lavorare
assieme, SerT e DSM? Può essere un problema del tossicodipendente,
ma anche un problema di uno dei Servizi. Che, ad esempio, può trovarsi nelle condizioni di non sapere come rispondere ad alcune difficoltà
di un cliente. Ancora più interessante è il caso in cui uno dei Servizi
abbia dei dubbi, non riesca a configurare o riconfigurare i problemi che
il cliente pone o genera. L’oggetto di lavoro può essere allora individuato nelle riconfigurazione, ridefinizione, costruzione congiunte del
problema da trattare. Il cercare di definire gli oggetti di lavoro, elementi essenziali nell’integrazione, presenta due benefici. Da un lato, appunto, permette di chiarire su cosa s’intende lavorare insieme. Dall’altro, alimenta un processo di riflessione, interna ai singoli Servizi, di
grande aiuto per i soggetti coinvolti, oltre che per l’integrazione stessa.
Ancora una pista attraverso la quale è possibile condurre un processo
d’integrazione tra SerT e DSM e che, nel contempo, è parte essenziale
della stessa integrazione, è costituita dal lavoro volto a costruire rappresentazioni sufficientemente condivise del suo valore. Coordinarsi,
collegarsi costa, come abbiamo visto, su più piani. Risulta assai più
facile rappresentarsi gli oneri, anche economici, di un processo d’inte130
grazione di questo tipo, che il valore aggiunto. Perché i differenti attori
organizzativi e sociali possano riconoscere un valore, e quindi l’opportunità d’investire nell’integrazione, è necessario che sia rappresentabile
il prodotto e, secondariamente, che se ne riconosca la capacità di risolvere, ridurre, o fornire mezzi per meglio gestire i problemi, oggetto di
lavoro. “È attraverso il fatto che si sperimenta questa riduzione o soluzione che i cittadini o le organizzazioni cliente apprezzano, nel senso
che danno un prezzo, il prodotto e quindi il servizio.” Il valore dei
servizi prodotti non è, in questo caso specifico, un elemento dato, socialmente riconosciuto. Quindi può non essere letteralmente visto. Richiede d’essere autoriconosciuto dagli operatori stessi, ma perché abbia un valore economico è necessario che sia socialmente riconosciuto. Non è sufficiente che interessi a qualche operatore, è necessario che
susciti l’interesse di altri, che altri desiderino quest’integrazione o siano interessati ad investirci perché in grado, a sua volta, di generare
valore. Ciò che per una parte dell’organizzazione può essere visto come
dotato di valore, per l’altra può essere rappresentato come una perdita
di tempo od una minaccia. I primi investiranno, mentre i secondi cercheranno di sottrarsi all’operazione. In sostanza potremmo dire che
l’individuazione del valore dell’integrazione sulla comorbilità, in gran
parte, consiste in un’operazione di sensemaking. Anche in questo caso
l’integrazione passa attraverso la ricerca, la costruzione del valore e
nel contempo lo genera. Attraverso l’integrazione di Servizi, professioni ed équipe infatti si genera valore. Si aumenta il capitale sociale
dell’organizzazione. Ossia si arricchisce il sistema di relazioni che sostiene la capacità di lavorare e vivere assieme, di aver fiducia, che rende comprensibili e quindi prevedibili i comportamenti degli altri. Il
capitale sociale, come dice Coleman, non è una ricchezza depositata
negli individui, né nei mezzi di produzione, ma è intrinseca alla struttura di relazioni tra le persone. È questo un genere di valore particolarmente prezioso in un contesto complesso, caratterizzato da incertezze
ed ambiguità, da alti rischi di frammentazione, con richieste crescenti
di senso, di flessibilità ed autonomia, che tratta oggetti dai confini scarsamente definiti, come appunto il campo della comorbilità. Il valore
dunque, che può essere generato da un processo d’integrazione in queste condizioni, risiede sia nel prodotto (soluzione, evoluzione, differente gestione del problema), che nel processo stesso (sviluppo di capitale sociale).
Per costruire processi d’integrazione, in questo settore ed in queste
condizioni, servono responsabili, autorità in grado di sostenere processi quali quelli che ho sopra tratteggiato. Capaci quindi di costruire le131
gami, senso, interesse per affrontare assieme i rischi della ricerca e
della novità. Sono di scarsa o nulla utilità, quando non decisamente
distruttivi, soggetti che comandano o che si sottraggono a queste funzioni imprenditive.
Conclusioni
In queste pagine ho proposto una serie di riflessioni sull’opportunità e
le difficoltà del costruire un processo d’integrazione a più livelli: tra
ruoli professionali, équipe e Servizi che operano nell’area, dai confini
assai sfumati, della comorbilità. Ho anche cercato di mettere in luce
delle possibili piste per svilupparla.
Di fronte alla fatica ed alle incertezze che s’incontrano nella costruzione di processi d’integrazione evolutivi tra SerT e DSM, ci può consolare il riflettere sul fatto che quando sappiamo bene cosa fare stiamo
applicando protocolli, modelli, programmi e non pensiamo. Questo,
invece, è un campo in cui serve pensare, quindi accettare di misurarsi
con l’incertezza.
132