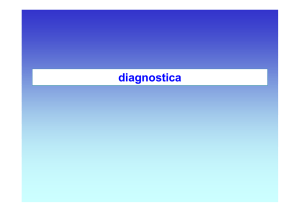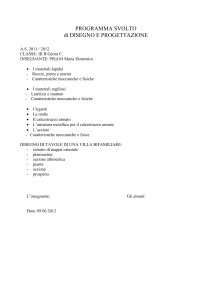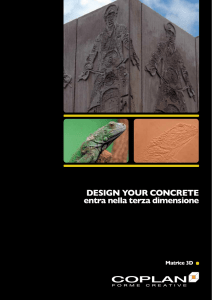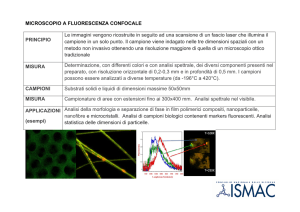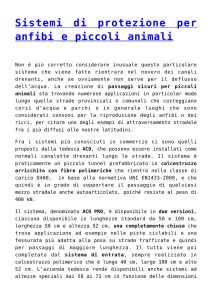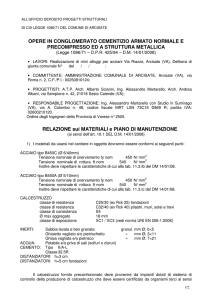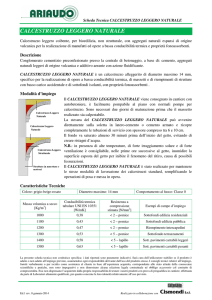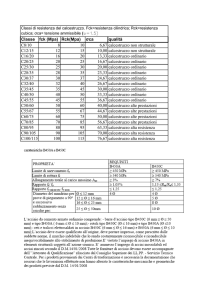TRAFORO DEL MONTE BIANCO
DETERMINAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DEL CALCESTRUZZO E DELLA
ROCCIA A SEGUITO DELL’INCENDIO VERIFICATOSI IL 24 MARZO 1999
PREMESSA
Il Tunnel del Monte Bianco, inaugurato nel 1965, ha una lunghezza di 11.6 Km, la sua altezza è di 4.35 m e la
larghezza è di 8 m. L’ingresso lato Italia è a quota 1381 m, mentre quello francese è a 1271 m. rispetto alla frontiera il
traforo passa all’altezza de l’Aiguille du Midi, dove lo spessore della copertura granitica raggiunge i 2480 m.
A seguito dell’incendio verificatosi il 24 marzo 1999 all’interno del Tunnel del Monte Bianco, la società di gestione
programmò l’esecuzione di un’indagine geologica-geomeccanica al fine di valutare lo stato delle strutture coinvolte e
per fornire ai progettisti i parametri necessari per la ristrutturazione del Tunnel con la costruzione di nicchie e rifugi
antincendio ad intervalli di 100 m.
Le indagini, svolte in più fasi da
settembre 1999 a marzo 2002, sono
consistite
nell’esecuzione
delle
seguenti prove:
•
Prelievo
di
campioni
di
calcestruzzo del rivestimento
della galleria
•
Prove con martinetto piatto
nel calcestruzzo
•
Sondaggi
a
carotaggio
continuo sub-orizzontali
Ingresso lato Italia del Tunnel del Monto Bianco
•
Prove dilatometriche
•
Prove doorstopper
•
Prove
geomeccaniche
di
laboratorio.
1
PRELIEVO DEI CAMPIONI DI CALCESTRUZZO
I campioni di calcestruzzo sono stati prelevati al fine di valutare i danni causati dall’incendio al rivestimento della
galleria.
In
corrispondenza
di
6
sezioni significative sono
stati prelevati 10 campioni
per
ciascuna
sezione,
distribuiti come riportato
nello schema allegato.
Per il loro prelievo è stata
utilizzata una carotatrice
elettrica e più carotieri a
pareti sottili diamantati di
diametro variabile da 80 a
110 mm.
Schema di prelievo dei campioni in corrispondenza di una sezione tipo
Per ridurre al minimo le vibrazioni
durante il carotaggio, con conseguente
aumento della qualità dei campioni
prelevati,
l’ancoraggio
è
stato
della
determinante
carotatrice
alle
pareti della galleria, effettuato tramite
una apposita piastra munita di uno
snodo che consentiva di bloccare la
carotatrice in qualsiasi posizione.
Prelievo di un campione in calotta
2
Campioni di calcestruzzo prelevati nella zona dell’incendio
Campioni di calcestruzzo prelevati in zone non interessate dall’incendio
3
PROVE CON MARTINETTO PIATTO
Misura dello stato tensionale superficiale in sito con martinetto piatto
Le prove con martinetto piatto sono state eseguite in posizioni tali da ottenere un quadro il più possibile completo ed
esauriente sullo stato tensionale del rivestimento della galleria.
Sono stati utilizzati martinetti piatti di forma semicircolare-ellittica con superficie nominale pari a 778 cm 2, spessore
3.5 mm, diametro semicircolare 350 mm, profondità 260 mm.
Il taglio della struttura nella quale inserire il martinetto è stato effettuato per mezzo di troncatrice manuale con lama
diamantata avente trasmissione eccentrica.
Le misure delle deformazioni del rivestimento della galleria sono state effettuate per mezzo di un deformometro
meccanico millesimale (sensibilità 0.001 mm).
basi di misura
taglio
100 mm
100 mm
350 mm
Disposizione delle basi per la misura con deformometro
Rilievo dello stato tensionale
Le prove con martinetto piatto sono basate sulla misura degli spostamenti indotti dal rilascio tensionale nell’intorno di
un taglio normale alla superficie della struttura in prova ovvero in questo caso il rivestimento della galleria in
corrispondenza dei piedritti e/o delle reni.
4
Il rilascio delle tensioni comporta, in caso di stato
tensionale di compressione, una richiusura del
taglio rilevabile attraverso misure di convergenza
tra più coppie di punti posti in posizione
simmetrica rispetto ad esso.
Mediante l’utilizzo del martinetto piatto inserito
all’interno del taglio e pressurizzato in modo da
annullare la convergenza (ripristinando così,
nell’intorno
del
taglio
lo
stato
tensionale
originario) è possibile la misura delle tensioni
agenti nella struttura nell’area di prova.
Martinetto con i manometri per la misura delle pressioni
La pressione applicata al martinetto che riporta alle condizioni di deformazione precedenti al taglio è prossima alla
tensione in sito, tenendo conto delle caratteristiche del martinetto (Km) e del rapporto tra l’area del martinetto in
contatto con la muratura e l’area del taglio.
La tensione può essere quindi calcolata come segue:
1)
fm= Km Ka p
dove
Km = coefficiente di taratura del martinetto
Ka = rapporto tra area del martinetto ed area del taglio
p = pressione nel martinetto per la quale si recupera lo stato di deformazione antecedente al taglio (MPa)
GRAFICO PRESSIONE-DEFORMAZIONE
MEDIA BASI B E C
5
Grafico pressione-
4,5
deformazione con
4
pressione di ripristino a
3,5
4 bar
P (bar)
3
2,5
2
1,5
1
0,5
-0,06
-0,05
-0,04
-0,03
-0,02
-0,01
0
0,00
0,01
DL (mm)
5
SONDAGGI A CAROTAGGIO
Per la realizzazione di nuovi rifugi antincendio sono stati eseguiti, in due fasi, 25 sondaggi a carotaggio continuo con
inclinazione variabile da 25° verso l’alto a 40° verso il basso.
Nei fori di sondaggio sono state eseguite prove dilatometriche e prove doorstopper
Sonda di perforazione posizionata su un sondaggio suborizzontale
Modalità esecutive della perforazione
Per ridurre al minimo il disturbo sulle carote e quindi per ottenere attendibili valori di TCR e di RQD (schede
geomeccaniche), i sondaggi sono stati eseguiti a carotaggio continuo con circolazione di acqua utilizzando carotieri
doppi di diametro 101 mm con corone diamantate a diverso grado di impregnazione. In prossimità dell’imbocco lato
Italia,
caratterizzato
argillitico-scistose
da
rocce
spesso
molto
fratturate (vedi foto a lato) è stato
usato il doppio carotiere T6, mentre
nel massiccio granitico centrale
(vedi foto seguenti) e nella zona
dell’imbocco francese con scisti
occhiadini è stato impiegato il
doppio carotiere T2 con corona
impregnata a matrice molto tenera.
6
Sempre al fine di ridurre il più possibile il disturbo meccanico della roccia, le carote sono state estratte dal doppio
carotiere mediante estrusione a pressione idraulica controllata.
Esempi di struttura e tessitura del granito del Monte Bianco
PROVE DILATOMETRICHE
La prova dilatometrica viene eseguta all’interno di un foro di sondaggio per definire le caratteristiche di deformabilità
di un ammasso roccioso mediante l’espansione della membrana elastica della sonda dilatometrica.
La sonda dilatometrica, di diametro 96 mm e lunghezza 1 m, è costituita da un corpo in acciaio rivestito da una guaina
armata che si deforma per effetto della pressione prodotta dall’afflusso di azoto attraverso una tubazione flessione.
La deformazione della guaina produce a sua volta l’applicazione di una pressione sulla superficie laterale del foro, per
la lunghezza di circa 1 m.
7
Le deformazioni della membrana, e quindi della parete rocciosa del foro, per effetto dell’applicazione della pressione
sono misurate mediante tre trasduttori di spostamento potenziometrici, disposti secondo tre direzioni a 120° nella zona
mediana della sonda. La pressione all’interno del dilatometro è misurata mediante un trasduttore situato a bocca foro
sulla linea di alimentazione.
Le
variazioni
di
pressione
e
spostamento sono trasmesse mediante
un cavo elettrico multiconduttore ad
una centralina di alimentazione che si
trova in superficie. Questi segnali,
opportunamente
amplificati,
sono
inviati ad un computer portatile per la
loro registrazione (vedi figura).
Elaborazione dei dati
I valori dei moduli elastici e dei moduli di deformabilità nelle singole direzioni dei tre trasduttori sono stati calcolati
impiegando la seguente relazione (ISRM Commission on testing methods, Suggested methods for deformability
determination using a flexible dilatometer, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr., Vol. 24, n, 2, 1987):
Ei = (1+v) [∆PD0/∆Di]
Ei =
v =
∆P =
D0 =
∆Di=
modulo elastico o di deformabilità nella direzione del trasduttore i-esimo [MPa]
coefficiente di Poisson (assunto pari a 0,2)
livello di pressione applicata [MPa]
diametro iniziale del foro (mm)
variazione diametrale corrispondente a ∆P misurata dal trasduttore medesimo (mm)
Grafico Pressione deformazione
media
8
PROVE DOORSTOPPER
Premessa
Le prove consistono nella determinazione dello stato di sollecitazione (relativa) piana effettuate mediante
sovracarotaggio.
Rosetta incollata nel granito a fondo foro (4.8 m)
Sono state eseguite in una prima fase 3 prove nel granito
e successivamente 16 prove nel rivestimento in
calcestruzzo del tunnel.
Le prove nel granito sono state eseguite all’interno di due
fori di sondaggio sub-orizzontali a profondità comprese
tra 3 e 5 m.
I metodi di misura delle sollecitazioni relative utilizzano
tecniche basate sulla determinazione delle deformazioni
conseguenti al rilascio o al ripristino delle tensioni di
parete.
Nel caso in questione il metodo prescelto e utilizzato
consiste nella registrazione delle deformazioni subite da
un elemento sensibile (rosetta estensimetrica a quattro
componenti orientati a 45° l’uno dall’altro in modo da
coprire un arco di 135°) a causa del rilascio delle
sollecitazioni ottenuto mediante intaglio periferico della
superficie sulla quale è cementato il sensore.
In maggior dettaglio il punto di misura viene preparato eseguendo un carotaggio seguito dalla spianatura del fondo
foro, mediante utensile diamantato, per favorire il successivo incollaggio della rosetta estensimetrica. L'elemento
sensibile, in concomitanza con il suo incollaggio al fondo foro spianato, viene orientato secondo riferimenti certi. A
cementazione avvenuta, dopo avere effettuato una prima misura di zero (mediante ponte estensimetrico), si procede al
sovracarotaggio del sensore ed alla successiva misura.
Attrezzatura
L'attrezzatura per la conduzione delle prove di rilascio di tensione in parete è costituita da un insieme di strumenti
necessari per la preparazione della sede di misura, per la realizzazione del sovracarotaggio e da una catena di misura
(di tipo elettrico) per il rilievo delle deformazioni.
Sonda di perforazione per le prove nel granito
Carotatrice per le prove nel calcestruzzo
9
Per le operazioni di preparazione della sede di misura sono richiesti, oltre ad una sonda di perforazione, dotata di
carotiere diamantato in parete sottile, una serie di spianatori frontali diamantati a grana di diversa dimensione.
Occorre inoltre un dispositivo ad aria calda per l'essiccazione del fondo foro, una bussola ed una livella per definire
l'appropriato orientamento del trasduttore rispetto alla superficie oggetto di studio.
Per il rilievo delle deformazioni è stato utilizzato
l’elemento sensibile (doorstopper o rosetta) di forma
cilindrica, avente diametro di 35 mm, e munito di
quattro estensimetri elettrici formanti tra di loro
angoli di 45° messo a punto presso lo CSIR (Council
Scientific Industrial Reseach South Africa) da
Leeman (figura 2).
Sono inoltre stati impiegati adesivi di tipo ceramico
a due componenti ed a pronta presa, un
compensatore di deriva termica e tre diverse
centraline di misura consistenti in un ponte di
Weatstone di elevata precisione, alle quali vengono
collegati in successione gli estensimetri dei quali si
intende misurare la variazione di resistenza elettrica.
Granito sovracarotato con rosetta incollata
Le tre centraline impiegate durante le misurazioni
Fase di inserimento della rosetta all’interno del foro di
sondaggio nel granito.
10
Ela b o r a z io n e d e i d a ti
L'elaborazione dei dati misurati è stata condotta secondo lo schema di calcolo descritto in letteratura ed ha consentito
di stimare lo stato di sollecitazione complessivamente in 16 differenti posizioni del rivestimento in calcestruzzo e in tre
posizioni nel granito.
Rosetta incollata nel calcestruzzo
Sovracarotaggio
11
PROVE GEOMECCANICHE DI LABORATORIO
La caratterizzazione meccanica di laboratorio dei campioni di roccia prelevati nei sondaggi ha riguardato la
determinazione della resistenza a compressione monoassiale.
La caratterizzazione meccanica di laboratorio dei campioni di calcestruzzo prelevati per l’esecuzione delle prove
doorstopper ha riguardato la determinazione della resistenza a compressione monoassiale C0; la determinazione delle
costanti pseudoelastiche E, modulo di elasticità (tangente e secante), ν, coefficiente di Poisson (tangente e secante); la
determinazione della resistenza a trazione indiretta con il metodo brasiliano.
I campioni sono stati dapprima avviati alle consuete lavorazioni meccaniche necessarie per la realizzazione di provini
di dimensioni standardizzate da sottoporre ai successivi saggi. Gli spezzoni di carota sono stati preliminarmente
sottoposti all’operazione di “troncamento o sfacciatura”, consistente nell’esecuzione di due tagli eseguiti a distanza
predeterminata, in direzione perpendicolare all’asse della carota. Le basi dei provini sono state in seguito rettificate
per mezzo di una fresatrice in modo da assicurarne il parallelismo reciproco e l’ortogonalità rispetto all’asse dei
provini stessi.
Operazioni di troncatura e spianamento dei provini di calcestruzzo
Le prove di caratterizzazione meccanica sul calcestruzzo sono state condotte utilizzando una pressa “rigida” (107
kN/m) a controllo digitale di classe A, agente in circuito chiuso (closed loop) e con acquisizione automatica dei dati di
prova. Tutti i sensori utilizzati nelle diverse determinazioni hanno precisione migliore dello 0.1% fondo scala.
Tutte le determinazioni eseguite sono state effettuate in aderenza alle raccomandazioni tecniche dell’International
Society for Rock Mechanics (I.S.R.M.).
Determinazione della resistenza a trazione indiretta (metodo brasiliano) (ISRM, 1978)
La prova consiste nel portare a rottura un provino cilindrico (disco), avente rapporto altezza/diametro variabile tra 0.5
÷ 1, mediante l’applicazione di un carico crescente, lungo generatrici diametralmente opposte. La sollecitazione di
compressione del provino è attuata con una pressa sopra descritta.
12
La resistenza a trazione del materiale viene valutata attraverso il rapporto tra la forza necessaria a provocare la
rottura del provino e le dimensioni geometriche dello stesso (T0 = 2F/πDH).
D e te r m in a z io n e d e lla r e s is te n z a a tr a z io n e
i n d i r e t t a ( m e t o d o b ra s i l i a n o ) s e c o n d o a l
n o r m a tiv a I S R M , 1 9 7 8 ).
L’esame dei risultati ha consentito di notare una bassa variabilità nella determinazione della resistenza a trazione
indiretta del materiale, soprattutto tenendo in conto il fatto che i provini sottoposti a saggio provenivano ciascuno da
sezioni di prova diverse. Il valore medio misurato è pari a circa 4-5 MPa.
Determinazione della resistenza a compressione semplice (monoassiale) (ISRM, 1978, 1979, 1983)
La valutazione della resistenza a compressione semplice, usualmente denominata C0 (rapporto tra il carico massimo
sostenuto e la sezione iniziale mediana resistente), si effettua somministrando allo stesso, a velocità controllata e sino
alla sua rottura, una sollecitazione crescente di compressione agente nella direzione del suo asse maggiore. I provini
da sottoporre alla prova hanno in genere forma cilindrica, con facce parallele tra loro e normali all’asse longitudinale
e rapporto altezza/diametro compreso tra 2.5 e 3.
Determinazione della resistenza a compressione monoassiale, a sinistra attuatore di carico di compressione; a destra,
equipaggiamento del provino per il rilievo delle deformazioni longitudinali e circonferenziali.
13