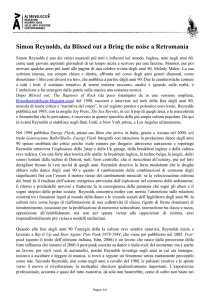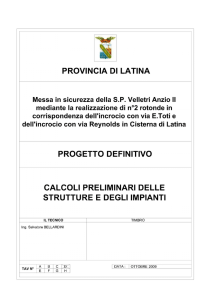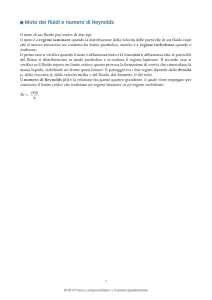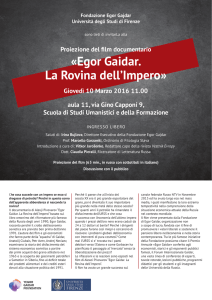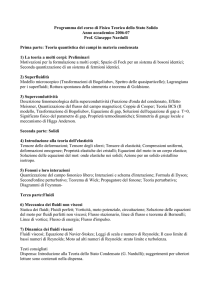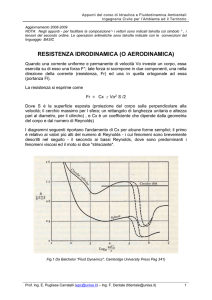Davvero siamo quasi tutti confondibili con i meccanismi di
pubblicità e consumo. Quanti festival ci saranno, oggi in
Italia? E quanti nuovi festival nuovi nascono, nel giro di
pochi mesi? Non c’interessa tanto discutere del fatto che
ovunque si faccia un gran festeggiare quando dappertutto
ci sia pochissimo da ridere. Ci interessa discutere un
poco su cosa significhi progettare, produrre, smazzarsi un
festival. Esiste una strada tuttosommato semplice: si raduna
una gran quantità di roba in pochi giorni, si pagano cachet
(spesso ridicoli, perché si sta comunque parlando di ambienti
indipendenti) e si chiama una marea (più o meno piccola, come
sopra) di avventori. È davvero difficilissimo non imboccare questa strada,
oggi, perché ci siamo più o meno tutti abituati a consumare cultura come
fossero patate fritte: tanti eventi: festival figo. E questo vale più o meno un po’
per tutte le discipline, dalle rassegne musicali a quelle di teatro. Volendo provare
una strada “non consumata”, ci si dovrebbero porre alcune domande: come fare
per non limitarsi all’intrattenimento, seppure di qualità? Come fare per affiancare
alla rappresentazione (di concerti, spettacoli, mostre, film) una riflessione, vale a
dire un tentativo di comprendere il mondo che ci circonda? Come fare per proporre
(e produrre) qualcosa di cui un territorio, grande o piccolo, abbia davvero bisogno?
Non stiamo dicendo che Arca Puccini – Caligari 2011 abbia queste risposte; certo è
che queste sono alcune domande che il progetto nevrosi si è posto. Così si propone
una residenza ad alcuni musicisti, sfidandoli a scendere nei meandri de Il gabinetto
del dottor Caligari per immaginare un concerto collettivo (sabato 17 al Bolognini),
s’invita un musicista elettronico a sonorizzare lo stesso film (del 1920, fatto
avvenuto l’11 settembre 2011 ad Agliana ad opera di Dj Iaui), si compone una
giornata di riflessione con il critico rock per eccellenza (Simon Reynolds) in cui
si discute anche di produzione culturale a Est e a Ovest (citiamo almeno, fra gli
ospiti, lo scrittore russo Zachar Prilepin, il tutto la domenica da mattina a sera,
comprensivo di mostra di manifesti polacchi), per concludere all’Ex-tipografia
con il piano-sequenza musicale. Nero su Bianco, il foglio che avete fra le
mani, prova a muoversi tra le diverse anime del festival, approfondendone
alcune parti, introducendone altre. Il resto sta nella mente, negli occhi e nelle
orecchie di chi sarà a Pistoia, e avrà voglia di una birra e di...
(lorenzo donati)
foglio di sala e di approfondimento di ARCA PUCCINI - Caligari 2011
17-18 settembre 2011
Percezione e sensazione
Dj Iaui e Il gabinetto del dottor Caligari
di Matteo Moca
Agliana, 11 settembre 2011
Musica elettronica e cinema muto tedesco. Una connubio strano, ma non insolito. Negli anni ‘20, quando veniva proiettato Il gabinetto del
dottor Caligari, l’accompagnamento era fatto da musicisti che, in diretta, all’interno del cinema, musicavano ciò che era proiettato sullo
schermo. Questa pratica viene ripetuta anche oggi: è la cosiddetta sonorizzazione di un film, ed è quello che Dj Iaui ha fatto al teatro Il
Moderno di Agliana lo scorso 11 settembre, fondendo la musica elettronica con le immagini di Robert Wiene.
Ma quale doveva (e deve ancora oggi) essere la vera funzione di questi musicisti? Quella di far seguire lo svolgersi del film agli spettatori
stando in un angolo, cioè suonando una musica che sia accompagnamento continuo, o piuttosto dare risalto a immagini precise con
crescendo, per catturare e far concentrare chi assiste alla proiezione? Domanda a cui non è semplice dare una risposta, per diversi motivi.
Parliamo della percezione. Non solo quello che si vede, ma che anche quello che prova chi assiste ad una performance artistica riguarda la
valutazione del significato dell’opera. Dando tanto peso al momento percettivo, alle considerazioni circa la maggiore o minore attendibilità
di lettura – o leggibilità – dell’opera, si rischia di non assaporare quello che stiamo vivendo. Talvolta c’è bisogno di non porsi troppe
domande, ma di porsi domande giuste. Prendiamo ad esempio un fotogramma del film tedesco, quello in cui il sonnambulo Cesare, in uno
dei baracconi della fiera, viene svegliato dal dottor Caligari. Per chi non era presente all’evento, per dare un’idea di quello che ha fatto Iaui,
basti pensare ad un suono elettronico alto di frequenza che andava salendo verso un’esplosione. Questo preciso momento può essere
analizzato distinguendo tre diversi livelli di percezione.
Un primo livello è quello di ciò che mi viene comunicato dallo scenario, dal primo piano di Cesare, dal suo abito, dalla cassa di legno in
cui era chiuso e che si intravede alle sue spalle; può essere definito momento comunicativo. A livello simbolico – quindi il secondo livello
– c’è il trucco molto pesante che ha sugli occhi Cesare, simbolo appunto del suo sonnambulismo, ma anche la fiera che fa da scenario:
leggendo l’etimologia della parola, siamo portati a pensare alla bestia, al monstrum e a tutto
l’immaginario che a quei tempi evocava una simile manifestazione. Il terzo livello non
è qualcosa di razionale, qualcosa che può essere analizzato in maniera simbolica
e/o comunicativa, è un momento personale in cui la scena mi trascina e muove
qualcosa nel mio pensiero. È un momento che definirei personale-percettivo.
Adesso entra in gioco la musica. Udire è un fenomeno fisiologico, di cui tutti
siamo capaci, ascoltare invece è un fenomeno psicologico, dell’udire si possono
descrivere tutti i processi e i meccanismi fisici, dell’ascoltare invece si può dire
solo partendo dal suo oggetto, il suo obiettivo. Al primo livello si indagano
degli indizi e non c’è nessuna differenza tra uomo e animale, un leone sente il
rumore di una preda, un bambino sente il rumore dei passi della madre. È il
secondo livello quello che ci interessa, quando si cercano di captare, tramite
l’orecchio, dei segni, dei suoni che ci portano a determinate sensazioni.
Cosa si crea dall’incontro tra questa precisa serie di suoni e la scena che
abbiamo davanti agli occhi? Il suono sarebbe potuto esplodere e non l’ha fatto, è
stato un crescendo che non ha avuto nessuno sbocco ed è riuscito, volontariamente
o involontariamente, a carpire in pieno il senso del film. Un horror in cui per
la prima volta nel cinema, ecco la sua grande importanza, la paura non è solo
visiva e visibile ma anzi, si scopre che il terrore psicologico può essere anche
più spaventevole di quello visivo. In questo caso, quindi, il suono ci ha aiutato,
ha voluto spingere il nostro pensiero in un lido preciso, la sua scelta è stata
quella di non restare in disparte ma di guidarci. Ecco perché rispondere alla
domanda iniziale non è affatto facile. Perché ci si basa sui diversi modi di
interpretazione dell’artista, la singola scena può per me significare una
cosa che è il completo opposto di quello che significa per un’altra persona
(momento personale-percettivo). Quindi ben vengano lavori come quelli
di Iaui, lavori di ricerca, di sintonizzazione di suoni con immagini creando
uno stimolante vortice di sensazioni, ma anche percorsi che creano un
flusso sonoro che accompagni in maniera incondizionata lo svolgersi di ciò
che vediamo.
COLOPHON
nero su bianco split arca puccini
foglio di sala e di approfondimento
Redazione
Bernardo Brogi
Lorenzo Donati
Francesco Gori
con
Simone Caputo
Lorenzo Maffucci
Matteo Moca
Nicola Ruganti
Rodolfo Sacchettini
2
Disegni
Marco Smacchia
Hanno collaborato
Serena Terranova, Nicola Villa,
Filippo Rea
www.nevrosi.org/arcapuccini
www.altrevelocita.it
[email protected]
feedback
www.feedbackmagazine.it
Studio per una factory
Incontro con Father Murphy, Jealousy Party e Rico
Come si mette insieme un nucleo di persone così diverse? Che pensieri
state facendo in vista di sabato?
Rico: chi risponde?
WJ (Jealousy Party): all’unisono.
Pogo (jp): siamo nel pieno e ci state venendo a chiedere queste
cose mentre stanno succedendo, senza avere la coscienza di un poi.
WJ (jp): però c’è la coscienza di pre.
Pogo (jp): del durante.
WJ (jp): no, del pre e del durante.
Pogo (jp): la coscienza del pre e del durante, è vero. Perché
effettivamente ce la siamo premeditata e abbiamo pure avuto delle
discussioni preventive.
Rico: sicuramente la parte più interessante è vedere cosa stiamo
tirando fuori.
Pogo (jp): questo mi sorprende da te, trovi più interessante il
processo della forma finale?
Per come ti conosco, sei uno molto attento al risultato formale.
Come Jealousy Party per anni abbiamo lavorato più sul processo
che sulla forma; abbiamo impiegato 11 anni per fare un album, ci
siamo formati nel ‘95 e il primo album è uscito nel 2006.
WJ (jp): comunque è molto stimolante, siamo piuttosto diversi e
una mescola più calcolata avrebbe gettato delle premesse diverse.
C’è l’incognita della collaborazione con persone con cui non si
lavora abitualmente.
Pogo (jp): Siamo realtà musicali molto differenti, ma nemmeno così
tanto. Io so già di avere delle comunanze con gli altri. Prendiamo
anche solo il fatto di avere un’etichetta con cui più o meno siamo in
contatto come Boring Machine, un’etichetta che convoglia dentro
cose molto diverse, ma che crea molti contatti.
Freddie (Father Murphy): siamo partiti parlando, raccontandoci
un po’ quali potevano essere i punti a favore e i punti a sfavore di
un progetto che potesse divertirci e che potesse interessarci. Siamo
dei gruppi che si incontrano, ma con la presenza di un “regista”,
Rico: dobbiamo capire che idee ha e cosa pensa il regista.
Rico: un regista che è fortemente antidemocratico!
Puntiamo a un risultato che sia personale, di tutti gli individui che
hanno partecipato. Una somma più o meno comprensibile per noi
e per chi assisterà. È difficile da spiegare con esattezza, ma cosa
non lo è?
Freddie (fm): Se la serata di sabato potesse diventare la
testimonianza di questi giorni passati assieme sarebbe già un
risultato. Ci stiamo confrontando con gli Influx per quanto riguarda
le proiezioni, e quindi già stiamo andando oltre il semplice lavoro
che stiamo facendo tra noi.
Come arriva Il gabinetto del dottor Caligari nel vostro percorso?
Pogo (jp): a parte il fatto che si è trattato di una commissione,
quindi “arriva dall’alto”, io sono influenzato da quel film da quando
ho tre anni.
Chiunque di noi lo è, si tratta del film horror più bello della storia
del cinema
WJ (jp): al di là della definizione di genere un po’ simpatica, si
tratta di un film che porta in campo tutta una serie di questioni che
ti staccano dalla realtà. È una delle prime occasioni in cui si scende
nelle stanze più basse dell’individuo.
Ne parlottavamo un po’ ieri sera, stiamo cercando di andare
“all’espressione dal sotto”: non ci resta che mettere le mani sotto e
tirarle fuori, ci si può anche fare senza droghe.
Usando le vostre parole, per ora si tratta quindi più di addizione o di
amalgama?
Freddie (fm): più che amalgama è addizione e sottrazione. O
ascolto, per capire chi siamo dove siamo e che stiamo facendo,
sempre sapendo che abbiamo un corrispettivo dall’altra parte,
Rico. La sua figura in questa occasione non è quella di un
produttore dei suoni, ma è appunto chi incolla le varie cose, chi
suggerisce. Ci stiamo orientando, per sabato, nello scandire il
concerto in stanze o momenti. Vorremmo mantenere tutto molto
terra terra, proporre qualcosa di molto vicino a ciò che stiamo
facendo, ma contemporaneamente con l’idea che se sia necessaria
un’astrazione per collaborare ad esempio con gli Influx.
Possiamo approfondire le “mansioni” del regista? Come si relaziona
ai suoni dei singoli gruppi? È più un lavoro di orchestrazione o
piuttosto di suggerimento di direzioni?
Pogo (jp): è terribile, commenta mentre si suona, con dei
microfoni...
Rico: il termine regista è stato introdotto più per gag con Lorenzo
Maffucci, perché non è una vera e propria regia. Non parte da me
l’idea e non do degli ordini, piuttosto si tratta di spunti; sottolineo
le cose che mi piacciono e le cose che da fuori, da un punto di vista
più simile a quello del pubblico, possono essere più fruibili, perché
7 persone che improvvisano contemporaneamente, senza sentirsi
reciprocamente, potrebbero essere 7 figate, ma la percezione da
fuori potrebbe essere solo un grande caos. Per quanto possibile
cerco di mostrare a loro quale è la sensazione che stanno
effettivamente trasmettendo fuori e non quella che percepiscono
come individui. C’è poi il fatto della regia audio: effettivamente
sto alla regia e quindi posso mettere in primo piano qualcuno e
in secondo piano qualcun altro a seconda dei momenti del brano.
In linea generale cerco di dare una confezione al tutto per fare in
modo che dal palco esca il suono di un gruppo, anche se si tratta di
identità diverse che si stanno fondendo. La differenza tra qualcosa
che suona semplicemente in contemporanea e qualcosa che suona
invece assieme può stare in pochi decibel di riverbero in più o in
meno, in accorgimenti minimi. L’attenzione, la sensibilità verso
questi tipi di dettagli, aiuta ad amalgamare qualcosa che parte
come non unitario, evitando di fare delle emulsioni.
In che misura prevedete di strutturare la serata di sabato, e quanti
spazi interni di improvvisazione lascerete?
Rico: ci saranno un sacco di momenti di libertà, proprio come
idea di partenza. Uno degli obiettivi di queste giornate di prove
è stabilire dei paletti dentro i quali muoversi, dei recinti o stanze
per limitare la libertà d’azione: limitarla ma non escluderla. Non ci
sarà uno spartito che potrà descrivere ciò che verrà fatto sabato:
potranno forse esserci dei grafici, degli schemi, dei disegni che
potrebbero rappresentare cosa succederà. Immagino che anche i
3
musicisti non sapranno al 100% cosa fare. Se però si sa in quale
direzione si è, cioè se tutti stanno guardando nella stessa direzione,
quello che emergerà sarà un insieme di gente che guarda nella
stessa direzione, quindi avrà un senso anche se le note o gli spartiti
non saranno scritti.
Pogo (jp): per Jealousy Party non c’è distinzione, organizzazione
e chiusura in una forma non escludono che ci sia uno spazio di
libertà. La struttura e la forma, quando ci sono, vengono create
perché ci sia maggiore libertà. La nostra scrittura avviene in larga
parte attraverso un continuo andare e venire fra libertà e forma.
Ordine e organizzazione per avere libertà. Sono un po’ nazista.
Vittorio (fm): ritiralo subito, sei già a posto.
Rico: no, lascialo, fa più notizia.
Freddie (fm): noi, ad esempio, lavoriamo con materiali schematici,
come dei canoni, ma sempre con dell’aria in mezzo che serve per
passare da una cosa all’altra. Effettivamente quando è arrivata la
proposta in un primo momento siamo rimasti un po’ disorientati.
Non siamo abituati a metterci in relazione. Per esempio i Jealousy
Party hanno una storia completamente diversa dalla nostra, eppure
esiste un’attitudine comune che rende possibile condividere idee
differenti.
Che tipo di pubblico vi aspettate, sabato sera?
Rico: L’ideale è che vengano un sacco di bambini. Mi è capitato di
vedere un concerto di elettronica noise, qualcosa di socialmente
classificabile come rumore (e va detto che tutta la musica, da questo
punto di vista, è rumore interpretato) a cui erano presenti molti
bambini che erano pervasi da momenti di esaltazione altissima,
braccia al cielo e urla per del noise.
Come pensate avverrà la narrazione, rispetto al contributo delle
parole di Alessandro Fiori ma non solo?
Pogo (jp): Il gabinetto del dottor Caligari suggerisce che la
narrazione può avvenire su vari livelli e in vari modi, mi sembra che
si sia già innescato un meccanismo di intersecazione di linguaggi
per cui anche la narrazione non è detto che debba essere veicolata
solo dalla parola.
WJ (jp): Vale a dire, la parola cantata e co-cantata non deve
necessariamente avere un ruolo dominante.
Freddie (fm): anzi diventa quasi più il verso del parlato, il suono.
Rico: il suono della voce piuttosto che il significato delle parole.
Pogo (jp): la cosa interessante rispetto alla domanda è il tipo
di fuoco che viene posto sulla parola, più che su uno specifico
racconto. Probabilmente avremo dei momenti in cui determinate
immagini saranno a fuoco (i momenti di Alessandro Fiori) e
momenti in cui non si capirà più quanto la parola sia seguibile
e quanto invece diventi un suono. La parola ha questa forza,
riesce sempre a “rimandare” a qualcosa. In un contesto in cui
non ci sono parole basta che ne appaia una per fare da polo, per
diventare un magnete che attira l’attenzione in varie direzioni.
Su questo si può giocare molto: da un punto di vista musicale la
parola sicuramente è un elemento che unisce, per cui penso che
col contributo di Alessandro ci saranno molti agganci possibili.
Semmai, posso porre una domanda: quanto bisogno abbiamo di
generi, di racconti lineari, di testimonianze comprensibili in un
senso gerarchicamente definito?
Rico: ciò che accadrà sabato potrebbe essere molto difficile
da raccontare a qualcuno che non c’era, se non tecnicamente o
4
statisticamente; ci sono queste persone con questi strumenti,
cosa che potrebbe essere facile da raccontare (potrebbe): mentre
la relazione fra i musicisti e il rapporto con il pubblico saranno
difficili da trasmettere a chi non c’era. Un brano di Fiori si può
raccontare, però non lo utilizzeremo in questa maniera: non farà
quello che vorrà lui.
Quanta consapevolezza del lavoro di orchestrazione di Rico esiste sul
palco, mentre state suonando?
Rico: come ho detto lavoro tra virgolette, opero su quello che
stanno facendo loro, se introduco degli elementi si tratta di
contorno e di avvicinamento, se stanno suonando qualcosa non
viene chiuso o stravolto, è tutto basato sull’integrazione. Vengono
aggiunti degli elementi, io ho anche degli strumenti per musica
elettronica: un campionatore Nintendo DS come sintetizzatore,
e una pedaliera per modulare un input su un altro input, ma si
tratta di elementi che si sommano a quello che i musicisti stanno
facendo e lo integrano. Quindi rispondo dicendo che la percezione
di quello che sto facendo immagino sia parziale sul palco: qualcosa
può tornare dall’impianto, vogliamo fare arrivare anche il mio
operato sul palco per far sì che loro possano giocare ulteriormente
con quello che sto facendo. In ogni caso non suonano sempre tutti
contemporaneamente, ognuno di loro ha avuto la possibilità di
sentire come sto agendo sugli altri, potrebbe esserci una fiducia o
una sfiducia generale comunque abbastanza uniforme.
Chiara (fm): in ogni caso Rico ci ha sempre comunicato le
modifiche sul suono che stava facendo.
Rico: alcune cose le sentite anche voi, perché i monitor vi
rimandano il mio lavoro, quindi anche un suono iper-compresso,
estremamente brillante o grave arriva sul palco come percezione.
Questo a volte crea delle forme di microproblemi, nel senso che
se sto modificando molto il fuori finisco per modificare anche
l’ascolto sul palco: loro sentono i miei cambiamenti, e può capitare
che arrivi a modificare leggermente dei parametri che servono loro
come riferimenti per suonare. Però, in linea di massima, in questo
modo si ha sempre il polso della situazione.
Simon Reynolds
da Blissed out a Bring the noise a Retromania
di Simone Caputo
Simon Reynolds è uno dei critici musicali più noti e influenti nel mondo. Inglese, nato negli anni ‘60, come tanti giovani aspiranti giornalisti
di un tempo inizia a scrivere per una fanzine, Monitor, per poi arrivare qualche anno più tardi alle pagine di una celebre rivista degli anni
‘80, Melody Maker. La sua scrittura intensa, ma sempre chiara e diretta, affronta nel corso degli anni generi disparati, come dimostrano i
libri così diversi tra loro, che pubblica a partire dagli anni ‘90. Due le caratteristiche comuni a tutti i testi: il continuo tentativo di tenere
insieme racconto, analisi e sguardo sulla realtà, e l’ambizione a far emergere dalle parole sulla musica una sostanza teorica.
Dopo Blissed out: The Raptures of Rock (da poco ristampato da in una versione ampliata, blissedoutinfohype.blogspot.com) del 1990,
racconti e interviste sul rock della fine degli anni ‘80, miscela di teoria critica e “narrativa del corpo”, in cui registro poetico e polemico
convivono, Reynolds pubblica nel 1995, con la moglie Joy Press, The Sex Revolts: Gender, Rebellion, and Rock’N’Roll in cui il pop di quegli
anni, e la mascolinità e femminilità che lo pervadono, è osservato in quanto specchio della più ampia cultura popolare. Da qui in avanti
Reynolds si stabilisce negli Stati Uniti: a New York prima, a Los Angeles ultimamente.
Nel 1998 pubblica Energy Flash, primo suo libro che arriva in Italia, grazie ad Arcana nel 2000, col titolo Generazione Ballo/Sballo. Energy
Flash fotografa con attenzione la produzione dance degli anni ‘90 spesso snobbata dai critici perché «solo rumore per drogati»: attraverso
narrazione e reportage Reynolds ripercorre l’esplosione della 2step e della Uk garage, della breakbeat inglese e della cultura rave tedesca.
Con una forte idea teorica alle spalle: la breakbeat inglese, la techno belga, la jungle, deliri sonori lontani dalla techno di Detroit, rudi, fuori
controllo, che si mescolano all’ecstasy, pur nel loro deragliare furono la vera novità di quegli anni. Reynolds descrive la forza modulante
che le droghe ebbero sulla dance degli anni ‘90 e quanto il cambiamento delle combinazioni di consumo degli stupefacenti finì con l’essere
il motore stesso di creatività musicali: se la velocizzazione estrema dei brani fu il risultato dell’azione energetica provocata dall’esplosione
dell’uso delle anfetamine, il ritorno a psichedelie nervose e fratturate fu la conseguenza della paranoia che seguì gli abusi e il sogno utopico
delle prime ecstasy. Reynolds concentra inoltre con merito l’attenzione sulle relazioni esistenti tra i fenomeni legati al mondo della dance
e le vicende sociali dell’Inghilterra degli anni ‘90: la cultura rave come luogo di riaffermazione di una collettività di classe, rigetto di
forme dominanti di intrattenimento, occasione per la prolificazione di numerose sottoculture, intersezione tra classe e razza, opposizione
all’establishment non per forza di sinistra, anzi imprenditorialmente più vicina a modelli tatcheriani.
Quando alla fine degli anni ‘90 l’energia della la cultura rave sembra esaurirsi, Reynolds inizia a lavorare a Rip It Up and Start Again: Post
Punk 1978-1984, che viene poi pubblicato nel 2005. Post-punk (questo il titolo dell’edizione italiana, Isbn, 2006) è un lavoro che nasce dalla
percezione della forte influenza che intorno al 2000 il post-punk esercita su dance e indie-rock del momento; ma è anche un lavoro, per
certi versi, di autoanalisi, perché Reynolds investiga sugli anni in cui era teenager, iniziava a ascoltare e leggere di musica e si trovò a seguire
un fenomeno senza esattamente percepirlo come tale. Secondo Reynolds, mai come negli anni a cavallo del 1980, le pulsioni creative e le
spinte verso il nuovo si riverberarono in molteplici direzioni qualitativamente importanti. L’esposizione professionale, accurata e quasi
del tutto esaustiva, da sola non basterebbe, come di solito non basta nei libri che si occupano di musica, se Reynolds non accompagnasse
al racconto l’analisi delle motivazioni e delle idee che supportarono le varie correnti di espressione del post-punk, se i gruppi descritti non
fossero osservati dal punto di vista della collocazione socio-culturale, oltre che valutati per la loro sola musica. Il tutto per esporre una
tesi provocatoria quanto seria: il post-punk non fu affatto una prosecuzione del punk, e neppure una sua evoluzione. Il post-punk fu una
ripartenza da zero, che dal precedente movimento assunse la voglia di esprimersi senza pudori, ma smitizzandone il valore musicale. Il
post-punk non fu un genere: fu uno spazio di possibilità.
Alle parole dance culture, rave, post punk, fanno seguito le parole hip rock e hip pop, col libro Bring the noise del 2007: «Tentare di operare
una selezione “rappresentativa” di vent’anni di articoli e svariati milioni di parole era un’impresa immane. Perciò ho fatto un’altra cosa.
Hip-hop-rock non è una raccolta dei miei articoli preferiti, né si occupa di tutti i miei artisti preferiti: […] parecchie delle mie pietre miliari
sono sfuggite alla rete. Ho invece preferito sviluppare una sorta di storia della musica popolare degli ultimi vent’anni. Hip-hop-rock prende
le mosse laddove si chiudeva Post-punk 1978-1984, vale a dire grosso modo quando cominciai a guadagnarmi da vivere come giornalista
[…]. Passando al setaccio due decenni di interviste, recensioni, servizi speciali e saggi, ho seguito il filo dell’interazione tra musica bianca
e musica nera: più specificamente, la relazione ora accidentata ora feconda tra hip rock e hip pop». Bring the noise (pubblicato in Italia nel
2008 da Isbn, col titolo Hip-hop-rock) si interroga su quanto gli esperimenti “bianco su nero” abbiano costituito il motore del cambiamento
nella storia del pop. Un’interazione ricostruita attraverso una raccolta di articoli che è anche una sorta di biografia sonora di Reynolds e una
mappatura delle riviste per cui ha scritto: Melody Maker, New Stetesman, Guardian, Observer, i-D, Uncut, The Wire. Un collage non esente
da fraintendimenti, come scrive lo stesso autore: «Assai di frequente i bianchi hanno abbracciato la musica black, per poi “fraintenderla”
quando si sforzavano di superare la semplice emulazione e produrre qualcosa di originale: non di rado simili “bastardizzazioni” si sono
rilevate entusiasmanti, ben più di quando i bianchi sono effettivamente riusciti a imitare i neri con scrupolosa e fedele soggezione. Il
“fraintendimento” non si applica solo alla creatività musicale, tuttavia, ma anche ai ruoli dell’ascoltatore e del critico. Nessuno può riflettere
seriamente sulla musica pop senza prendere in esame la questione della razza; ed è altrettanto impossibile soffermarsi su queste questioni
senza rimanere disorientati. […] Il “fraintendimento” è altresì un aspetto inerente agli scambi interculturali in quanto tali. […] Ma d’altra
parte se segnale puro e zero distorsione fossero concepibili, non ci sarebbero attrito né scintille; la confusione è la materia prima, l’humus
naturale per la creatività e il cambiamento».
Quale futuro?
Oggi è tempo di Retromania, l’ultimo lavoro di Reynolds (ancora una volta Isbn, nella traduzione di Michele Piumini). Nell’articolo
di un paio di anni fa, Music in the Noughties (Gli Anni Zero, Isbn, 2009), Reynolds scriveva: «Se gli anni settanta hanno avuto la disco
music e il punk, gli anni ottanta l’hip-hop e gli anni novanta il rave e il grunge, qual è stato l’imprescindibile fenomeno musicale che
ha dominato il mondo della musica pop negli Anni Zero? (Imbarazzato silenzio)». Oggi il silenzio trova alcune risposte in Retromania:
«L’era pop che viviamo è impazzita per tutto ciò che è rétro e commemorativo, […] nostalgico blocco che impedisce di guardare avanti».
...continua a pagina 8
5
FATHER MURPHY
Pop psichedelico, lamenti e preghiere,
questo è lo stile dei Father Murphy,
band trevigiana attiva dal 2003. I
Father Murphy sono Freddie Zanatta
(voce, chitarra), Chiara Lee (voce,
keyboards,
percussioni),
Vittorio
Demarin (batterie, viola, voce). Si
muovono all’interno della Madcap
Collective, un’etichetta indipendente
nata a Treviso otto anni fa, che raccoglie
anche Comaneci, Figliotucano, Franklin
Delano, Gomma Workshop (progetto
parallelo di Vittorio Demarin), Gretel
e Hansel, Littlebrown, Stop The
Wheel, Wolther goes Stranger e altri.
La discografia dei Father Murphy è
composta da otto album, loro brani sono
presenti in varie compilation Madcap;
con il regista Alessandro Aronadio
(autore del loro primo videoclip)
hanno collaborato alla realizzazione
della soundtrack del film Due vite per
caso. Il loro tour è ricco di date fuori
dall’Italia, spesso in Olanda e Germania,
e godono di un forte apprezzamento
oltreoceano. No room for the weak è
il loro ultimo album, musica per
l’apocalisse: non c’è salvezza..
http://www.myspace.com/
reverendmurphy
ALESSANDRO FIORI
Alessandro Fiori canta, suona il violino,
recita, diplomatosi all’accademia di
arte drammatica Piccolo Teatro Città di
Arezzo, dipinge e scrive; Fiori si avvicina
giovanissimo alla musica e insieme
a Michele Orvieti e Gianluca Giusti
è membro fondatore dei Mariposa.
Violinista di Andrea Chimenti e Paolo
Benvegnù, dopo l’esperienza a fianco
del compositore Enzo Brusci all’interno
di TIMET, fonda il supergruppo Amore
nel 2004. Da qualche anno collabora
con Alessandro Stefana e con Marco
Parente, con quest’ultimo nel 2009
forma il duo Betti Barsantini. Attento
a me stesso, edito per Urtovox Records,
è il suo primo lavoro solista, album
nel quale tornano sia Stefana come
chitarrista, sia Parente come batterista,
con l’aggiunta di Enrico Gabrielli ai fiati.
L’ascolto libera l’orecchio dai luoghi
comuni e con morbidezza barocca
lascia a bocca aperta e labbra fredde. http://www.alessandrofiori.net
6
JEALOUSY PARTY
Non sense, ironia, poutpourry vocale,
melting pot sonoro, uno, zero, x.
Elettronica da citofono. Frullatori
e shaker mescolano testi e suoni
decoupati. Da Firenze arriva il nucleo
principale dei Jealousy Party composto
da Roberta WJM aka WJ Meatball
con mixer, JP Set (cd, md, microfoni,
percussioni), Mat Pogo con mixer,
voci reali e voci registrate, Edoardo
Ricci al sassofono contralto e soprano,
clarinetto basso, trombone; negli anni
hanno contribuito al progetto anche
Jacopo Andreini batteria e percussioni,
Andrea Caprara basso, Alessandro
Boscolo mixer, suono, registrazioni,
missaggio, master, Gimmy Gelli con
laptop e mix, Stefano Bartolini al
sassofono baritono e tenore. Attivi
dal 1995, pubblicano Now nel 2006
e Again nel 2008 sempre per Burp
Enterprise. Nel 2009 lanciano il
progetto Plus, che offre al pubblico
il disco dal titolo JP+Eugenio Sanna,
prodotto da Burp Publications e Setola
di Maiale, e seguito da un breve tour nel
2010. Mercato Centrale è la loro fatica
più recente.
http://www.myspace.com/
thejealousyparty
RICO
Riccardo Gamondi alias Rico è un
tecnico del suono e titolare dello studio
di registrazioni Fiscerprais (dove si
può andare per leggere vecchie riviste
rap e ubriacarsi mentre Rico registra,
mixa e masterizza il disco); ha lavorato
per gli OVO di Bruno Dorella e Stefania
Pedretti (seguendoli durante il loro
tour europeo), Bugo, Miss Violetta
Beauregarde, Eterea Post Bong Band,
solo per citarne alcuni. Ha più volte
dimostrato di avere l’aggressività
giusta per far urlare un campionatore
korg. Il suo è un pendere a lato, ma
talmente distorto da deviare spesso
verso il centro, basti ricordare i beat
che accompagnano il flow di Napo con
Uochi Toki, o come ritma l’incedere
del verbo nella collaborazione con
Zona MC. Con Uochi Toki ha curato e
realizzato sei album, di cui ricordiamo
almeno Libro Audio (2009) e Cuore
Amore Errore Disintegrazione (2010).
http://www.myspace.com/uochitoki
7
...continua da pagina 5
Non c’è nulla di sbagliato nel guardarsi indietro, ma c’è da chiedersi quanto sia un bene per la musica produrre suoni che potrebbero essere
stati realizzati venti, trenta o quaranta anni fa, se non ci sia qualcosa di sbagliato nel fatto che siano proprio i giovani a essere nostalgici,
quali conseguenze ha un “consumo” eccessivo di passato, quanto super-abbondanza e eccesso di disponibilità derivati dall’era-internet
stiano rendendo apatici gli ascoltatori, e artisti di retroguardia i musicisti. Naturalmente, subire l’influenza di chi è venuto prima non
significa di per sé, per Reynolds, essere rétro. «Non concordo del tutto con Norman Blake dei Teenage Fanclub – “Qualunque musica non
somigli ad altro nella storia del rock è irrimediabilmente terribile” mi ha detto –: ma come si può fare musica senza un punto di partenza?
Musicisti, artisti e scrittori imparano quasi sempre il mestiere copiando, almeno all’inizio. Allo stesso modo, essere un tradizionalista
musicale non significa necessariamente essere rétro». Una tradizione che si fonda su una memoria non consapevole si trasforma, però,
presto in moda. Certo «la “modizzazione”, – precisa ancora Reynolds – non basta a spiegare l’ascesa del rétro». Le ragioni hanno anche a
che fare con i cicli vitali interni dei generi e dei movimenti artistici. «È un processo analogo alla sindrome che gli economisti chiamano
“sovraccumulazione” (un surplus di capitale che non trova sbocchi per investimenti redditizi a causa della saturazione del mercato dei
consumatori, spingendo i capitalisti a darsi alla speculazione per scongiurare il tracollo). Come l’economia in tempo di boom, più fertile
e dinamico è un genere, più si afferma come equivalente musical-culturale della recessione: il rétro. Nella fase iniziale e iperproduttiva,
brucia tappe che avrebbero potuto richiedere più tempo, accumulando un’immensa scorta di idee che poi risucchiano le successive ondate
di artisti come un buco nero. Ecco spiegato come mai la dance degli anni duemila è rimasta invischiata in uno stallo ricombinante: proprio
perché nel decennio precedente si era mossa tanto in fretta e diffusa tanto ampiamente in un lasso di tempo così ridotto. Ma altrettanto
potremmo dire della musica pop in generale: gli anni di picco creativo (sessanta, settanta e parte degli ottanta) avevano reso irresistibile la
tentazione di essere ri-creativi». Quel che emerge dalle riflessioni di Reynolds è che la cultura, quindi la musica, in quanto sovrastruttura
delle fondamenta economiche, rifletta la natura nebulosa della nostra esistenza, e risenta, per certi versi, del capitalismo accumulatorio,
ma recessivo, di questi anni. Scrive Reynolds: «La moda – una macchina per creare capitale culturale e poi, a velocità incredibile, spogliarlo
del suo valore e gettare via le scorte – è dappertutto». La questione più importante che è anche l’interrogativo che chiude Retromania,
«La retromania durerà per sempre oppure si rivelerà una fase storica?», resta, però, un punto interrogativo. Se come Reynolds, carichi di
dubbi, speriamo che questo che abbiamo sùbito innanzi ancora non sia il futuro, la certezza è che la musica del presente viva una continua
accelerazione tutta interna, senza spinte verso l’esterno, in cui tutto e nulla, al contempo, hanno valore e non ce l’hanno, e in cui è più
difficile che mai incontrare qualcosa di davvero ignoto, davvero diverso.
Il teatro sulla strada
Manifesti polacchi in mostra
di Rodolfo Sacchettini
La Polonia è uno dei paesi europei che nel corso del Novecento ha dato un contributo fondamentale al teatro contemporaneo. Basterebbero
i nomi di Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Andrzej Wajda – i più importanti, i più celebrati – per capire la grande influenza che il teatro
polacco ha avuto in Europa, e molto anche in Italia. La mostra Tutto il teatro in un manifesto. Polonia 1989-2009, prodotta dalla Fondazione
Palazzo Ducale di Genova e il relativo catalogo curato da Sergio Maifredi e Corrado D’Elia, sono uno strumento molto utile per ripercorrere
e approfondire la ricca tradizione polacca e anche per riflettere sull’importanza di un oggetto spesso relegato a mere questioni di marketing
come il manifesto teatrale.
La storia del manifesto d’arte in Polonia è assai articolata e inizia verso la fine dell’Ottocento per svilupparsi soprattutto a partire dal
1918 con l’indipendenza della Polonia. Facoltà e Accademie cominciano a istituire corsi specifici coinvolgendo artisti di primo piano. Il
saggio contenuto nel catalogo di Agnieszka Dydo e di Krysztof Dydo, collezionista ed esperto dell’arte del manifesto, da cui provengono
le opere esposte nella mostra “Il teatro sulla strada” di Pistoia, ripercorre le varie tappe di questa interessante storia mettendo l’accento
al periodo tra il 1953 e il 1965, un lasso di tempo nel quale, nonostante la censura, l’arte del poster celebra i suoi maggiori trionfi. E lo
stesso accade nel decennio successivo con una grande ricchezza di proposte nonostante una censura ferrea. Il riferimento è soprattutto
a un immaginario surreale e fortemente cupo. I volti monotoni e squadrati del realismo socialista cominciano a farsi mostruosi e pieni di
mistero. Si guarda ad artisti come Bosch, Bruegel, Dalì, Arcimboldo, Goya, Hokusai, Picasso… Secondo Wieslaw Walkuski, noto artista di
poster, illustrazioni e pittura, la vivacità del manifesto derivava anche dal fatto che «non vi era alcuna forma di pubblicità (fortunatamente
per il Manifesto d’Arte), perché non vi era alcuna necessità di pubblicizzare un prodotto, un po’ perché mancava tutto, un po’ perché quanto
era prodotto aveva già un destinatario preciso».
Dopo il 1989 evidentemente cambia un po’ tutto, perciò osservare i manifesti in mostra a Pistoia e quelli raccolti nel catalogo, è utile per
seguire una storia gloriosa adesso inevitabilmente a contatto con un’altra forma di censura, quella del mercato, che spinge a semplificare
e omologare, e soprattutto a trasformare l’arte in pubblicità. In realtà in Polonia la forte tradizione artistica ha permesso di mantenere
una grande varietà di approcci e una vera qualità, che i manifesti esposti dimostrano. Tra i nomi più importanti: il maestro Waldemar
Swierzy e poi Wieslaw Walkuski, Wiktor Sadowski, Rafal Olbinski, Wieslw Grzegorczyk, Jerzy Czenriawski… Sarebbe interessante mettere
in parallelo questa storia alla vicenda italiana, certamente meno organizzata e più confusa, ma ricca comunque di grandi nomi. Se si
passano oggi in rassegna i materiali grafici di compagnie, festival e teatri è facile accorgersi che quasi sempre c’è una certa corrispondenza
tra qualità del lavoro e la qualità della grafica utilizzata. L’impressione generale è però che l’attenzione per i materiali grafici siano ormai
in gran parte strategia di promozione e di marketing. Abituare l’occhio a una grafica di qualità diventa perciò un esercizio utilissimo per
capire qualcosa in più nel mare magnum di pseudo proposte culturali. I manifesti, nel bene e nel male, possono dire tante cose e nella
distrazione diffusa, soffermarsi su un’immagine, può rivelare davvero sorprese inaspettate.
8
Introduzione a
EST/OVEST: stati dell’arte
a cura di Nevrosi
Una delle particolarità de Il gabinetto del dottor Caligari è il suo non aver fatto scuola. È un film che ha avuto un successo popolare come
pochi, eppure non ha avuto delle filiazioni. Se ci domandassimo quale possa essere il Caligari di oggi non troveremmo un’opera con
caratteristiche simili. Questo rispetto alla manipolazione, al ritratto della polizia che dorme e tanti altri aspetti legati al rapporto col
potere, ma non solo. Per trovare un’opera che ci convincesse e che non fosse pop (anche se è quasi impossibile oggi sganciarsi da questa
etichetta) siamo risaliti a Caligari. Non a caso il manifesto che abbiamo preparato per il festival va in una direzione opposta al pop, è gotico.
Partendo da questa suggestione della manipolazione (nel film Caligari controlla la volontà di un sonnambulo, spingendolo a commettere
azioni nefaste) abbiamo fatto partire alcuni fili che sono confluiti nel convegno EST/OVEST: stati dell’arte. Per noi il confronto fra Est e
Ovest rimane lo snodo su cui ci sembra importante confrontarci. Partiamo dalle cose di cui siamo intrisi, prendendo Arca Puccini come
occasione per studiare.
Al Salone dell’Editoria sociale dell’anno passato ascoltammo una relazione di Jaroslaw Mikolajewski, in cui si raccontava che chi illustrava
manifesti teatrali al di là della cortina di ferro doveva lavorare in sottrazione, perché la censura era molto forte e il potere andava dribblato.
Questo è il primo aspetto, forse il più semplice: lavorare contro un potere che censura. Se pensiamo all’Occidente di oggi è chiaro che non
si possono fare collegamenti diretti, perché, pur attraverso i tanti filtri che conosciamo, tutti possono dire più o meno quello che credono.
Per noi diventava fondamentale provare a mettere a confronto due visioni e due storie: la produzione culturale russa con le nostre vicende.
Partendo da Che cosa è l’arte? di Tolstoj, passando dai libri di Zachar Prilepin, per arrivare a Aleksandr Sokurov, che ha vinto l’ultima mostra
del Cinema di Venezia. Ci piace ricordarlo perché la forma che ogni anno proponiamo per i concerti di Arca Puccini, che quest’anno sono in
programma domenica sera nei cortili dell’Ex-tipografia, fin dall’inizio è ispirata al film Arca Russa di Sokurov: un tentativo di aggiramento
del contesto messo in atto grazie alla forma dell’opera d’arte. Arca Russa è un piano sequenza nelle sale dell’Hermitage, un immaginario
che “si chiude dentro” per fare uscire un ragionamento, un discorso. Questa riflessione sull’aggiramento, oltre che nel convegno, verrà
affrontata nella mostra “Il teatro sulla strada”, che ripropone proprio i manifesti di cui parlava Mikolajewski. Venendo a Zachar Prilepin,
per noi si tratta di un esempio di arte che sa stare al passo con la politica, evitando ogni tipo di retorica. La scrittura di Prilepin è del tutto
“politica”: una volta lo scrittore ha affermato che sarebbe possibile bruciare tutti classici, a patto che la scrittura sappia stare vicino alla
politica. Se non si riesce a fare questo, sostiene Prilepin, è impossibile essere scrittori nella Russia odierna.
Se da una parte c’è l’Est dall’altra c’è quindi l’Ovest, mondo complesso e infinito. Proprio per questo non potevamo che restare ancorati
all’ambito musicale, che è poi il motivo per il quale facciamo Arca Puccini. Simon Reynolds si pone in maniera molto diversa rispetto a
Prilepin. La sua è una scrittura “senza sensi di colpa”. Reynolds descrive, non propone un “carotaggio”, un affondo nel particolare per
afferrare il generale. La sua è una descrizione anglosassone, che non mette la politica al centro. Quello che però Simon Reynolds non ha mai
smesso di fare è stato cercare di tracciare delle connessioni, avendo in mente una storia: non ha mai rinunciato a un pervicace principio
della sistematizzazione di tutte le esperienze musicali che ha raccontato. Ha saputo vedere il formarsi di certi fenomeni prima che fossero
di dominio pubblico, facendo divenire le sue scritture “formative”. Per riportare tutto questo in un ambito italiano, in poche parole per
chiederci che cosa sta accadendo in Italia oggi?, non potevamo che invitare Goffredo Fofi, oltre a due figure che spostano il discorso in
ambiti più particolari: la musica per John Vignola, la letteratura come racconto dell’oggi per Paolo Cognetti (i suoi romanzi contengono
sempre domande politiche, la sua è una fotografia che interpreta).
Volendo infine rintracciare un altro filo allegorico, dobbiamo parlare del sonnambulismo. Cosa spinge a discutere, a riflettere insieme, a
fare un festival? Si può parlare, forse, di un metodo sonnambulo. Lo capiremo (forse) domenica notte.
Paolo Cognetti è nato a Milano nel 1978. È autore di alcuni documentari - Vietato scappare, Isbam, Box, La notte del leone, Rumore di fondo - che raccontano
il rapporto tra i ragazzi, il territorio e la memoria. Per minimum fax media ha realizzato la serie Scrivere/New York, nove puntate su altrettanti scrittori
newyorkesi, da cui è tratto il documentario Il lato sbagliato del ponte, viaggio tra gli scrittori di Brooklyn. Minimum fax ha pubblicato nel 2004 il suo primo
libro, Manuale per ragazze di successo, e nel 2007 la sua seconda raccolta, Una cosa piccola che sta per esplodere. Nel 2010 esce per Laterza New York è una
finestra senza tende.
Goffredo Fofi (Gubbio 1937) intellettuale non allineato ed esperto di cinema italiano ed europeo, conoscitore della letteratura occidentale ed est-europea, si
è occupato di critica cinematografica e letteraria, ha diretto e fondato riviste di interesse culturale e politico (tra cui Quaderni piacentini, Ombre rosse, Linea
d’ombra, Lo straniero, Gli Asini), ha scritto molti libri (tra i tanti: Alberto Sordi, Mondadori 2005; Totò, Mondadori 2004; Leggere, scrivere, disobbedire,
Minimum Fax 1999; Le nozze coi fichi secchi, L’Ancora del Mediterraneo 1999, Da pochi a pochi, Elèuthera 2006, La vocazione minoritaria, Laterza 2009
con Oreste Pivetta) e ha partecipato a molte esperienze di intervento sociale ed educativo dalla metà degli anni Cinquanta a oggi, a Palermo, Roma, Torino,
Milano, Napoli.
Jarosław Mikołajewski è nato a Varsavia nel 1960 e debutta nel 1991 con la raccolta A świadkiem śnieg (“E come testimone la neve”). Alla sua produzione
poetica ha affiancato un’intensa attività di traduttore dall’italiano, traducendo tra gli altri Dante, Petrarca, Michelangelo, Leopardi, Montale, Luzi, Penna,
Pavese e Pasolini e Camilleri. Collabora inoltre da diversi anni con la “Gazeta wyborcza”, il maggiore quotidiano polacco. In Italia sono stati tradotti i suoi Un
tè per un cammello, un thriller ironico abbondantemente farcito di citazioni letterarie e Uccisioni per amore. Alcune sue poesie, tradotte in diverse lingue,
in Italia sono state pubblicate su riviste e presentate in letture pubbliche. Primo Consigliere dell’ambasciata di Polonia e direttore dell’Istituto Polacco di
Roma, è mediatore culturale tra la cultura polacca e il contesto italiano.
Simon Reynolds (Londra 1963) è il critico musicale più famoso al mondo, dopo gli enciclopedici volumi Post-punk 1978-1984 e Hip-hop-rock 1985-2008,
riflette sul presente e sulle tendenze attuali della cultura pop. Per Isbn Edizioni è appena uscita la sua ultima fatica, Retromania: cosa succede se si calca
9
troppo la mano, attingendo da ciò che è venuto prima di noi? Simon Reynolds riflette sull’ossessione per il passato della nostra cultura nell’epoca di YouTube
e lo fa, come sempre, con il suo inconfondibile stile appassionante e divulgativo. Simon Reynolds si è fatto un nome negli anni ottanta sulle pagine di Melody
Maker, fino a diventare il più autorevole critico musicale contemporaneo. Inventore del termine «post-punk», ha collaborato, tra gli altri, con New York
Times, The Guardian, Rolling Stone, Observer, Wire, Uncut. Isbn ha pubblicato Post-punk 1978-1984, Hip-hop-rock 1985-2008 e Totally Wired.
Zachar Prilepin è nato nel 1975 a Nižnij Novgorod, Russia. Veterano della guerra in Cecenia (1996-1999), dove era arruolato negli OMON, i corpi speciali
russi, è giornalista, redattore della “Novaja gazeta” e membro di Drugaja Rossija (L’Altra Russia). Considerato uno dei migliori prosatori contemporanei
soprattutto per la lingua innovativa ed evocatrice, ha pubblicato finora quattro romanzi, racconti e alcuni saggi. Campione di incassi, l’autore è stato finalista
ai più importanti premi letterari russi degli ultimi anni (Nacionalnyj bestseller, Russkij Buker ecc.) e molti ne ha vinti, tra questi nel 2011 il premio SuperNacbest per il suo libro Grech (Il peccato), giudicato il miglior romanzo degli ultimi dieci anni. Sposato, ha quattro figli. I suoi libri sono tradotti in 11 lingue.
Dello stesso autore Voland ha già pubblicato Patologie.
John Vignola si occupa da anni di musica e critica musicale; negli anni novanta fonda un’etichetta indipendente, la Beware!, già On/Off Records, che
produce artisti come Lo-Fi Sucks! (P for Pistachio, 1997), i Perturbazione (Corridiors, 1998 e 36, 1998), Gatto Ciliegia Contro il Grande Freddo (#1 disco
giallo, 2000 e #2 disco blu, 2001). Ha curato alcune collane editoriali e pubblicazioni come Il libretto mosso del MEI. Dieci anni di musica al Meeting delle
Etichette indipendenti (Zona Editrice 2006). Ha collaborato e collabora con Rockerilla, Vanity Fair, Audioreview, Il Mucchio. Tutte le mattine su Radio Rai 2
conduce Twilight, un programma di musica, libri, eventi e cultura. Sempre per la Rai è recentemente approdato alla conduzione dello storico Stereonotte.
Patologie di Zachar Prilepin
di Nicola Ruganti
Zachar Prilepin, classe 1975, arriva in Italia quando in Russia ha appena vinto il premio “Supernatsbest” – 100mila dollari: un’economia
su di giri! – per il miglior libro di prosa del decennio, con il romanzo Грех (“Peccato”, non ancora tradotto in italiano) e scritto diversi
libri di successo. Intellettuale e militante nei partiti di opposizione al governo russo, ha pubblicato nel 2005 il suo primo libro, Patologie,
edito in Italia quest’anno, in occasione del Salone del Libro di Torino, per merito della casa editrice Voland. Il romanzo racconta la storia
di Egor Taševskij, soldato dei corpi speciali russi, gli OMON, dal momento in cui viaggia in elicottero verso Groznyj al momento in cui,
stremato dalla guerra, torna a casa. (Non) fa male ripercorrere, qualche anno più tardi, le strade cecene: significa ricordare «la politica
antiterrorismo di Putin» e la sordità europea davanti a quella bugia di regime denunciata – fino alla fine – da Anna Politkovskaja. I
racconti del massacro di Beslan in Ossezia del Nord, della strage nel teatro Dubrovka a Mosca, delle due guerre contro la Cecenia hanno
avuto una certa attenzione, anche a posteriori, in seguito all’assassinio della Politkovskaja. I reduci di entrambe le fazioni hanno scritto
e provato a restituire l’orrore: l’“italiano” Nicolai Lilin in Caduta libera, con esiti incerti, e tra le uscite più recenti La guerra di un soldato
in Cecenia di Arkadij Babčenko. Collaboratore, come Prilepin, della “Novaja Gazeta”, ha commentato laconicamente che sia i ribelli ceceni
sia i soldati russi dichiarano: «Voi avete ucciso noi», come a segnalare un cammino ancora molto lungo per una comprensione reciproca.
Ciò che rende interessante Patologie è il modo in cui Prilepin riesce a oltrepassare l’orrore – tutt’altro che spazzandolo
sotto il tappeto – collocandosi nel panorama della letteratura di guerra, per sfuggirne tuttavia immediatamente.
Le vicende di Patologie probabilmente si riferiscono alle memorie, rielaborate in romanzo, della prima guerra cecena: il periodo in cui
Prilepin, dal 1996 al 1999, è stato sotto le armi – anche se, come tiene a dichiarare, «non ha ucciso ceceni, non ha provato nemmeno
un decimo delle passioni e delle patologie dei suoi personaggi». La narrazione è diretta e organizzata in un ritmo serrato che coinvolge
le azioni militari ma anche i pensieri del protagonista: ne risulta un intreccio inconsueto tra la tragedia della guerra e un sistema di
riflessioni legate al quotidiano che mette in luce l’assurdo inconciliabile di vita e morte. Gli uomini sono «carne da cannone», i corpi dei
ribelli ceceni e dei soldati russi sono raccontati nella deformazione della guerra, continuamente aleggia l’incertezza di chi si trova costretto
nelle spire delle domande ultime: «Perché si muore?», «perché sono qui?». Se la questione diventa perché io sono vivo e il mio nemico
no, ci aiutano le parole di Egor: «‘Io ho ammazzato un uomo’, penso stancamente e non so come continuare il pensiero»; il blocco è totale.
L’impasse non è dettata dalle condizioni politiche o militari, ma da aspetti mentali legati all’ossessione. L’elemento cruciale che rende
altro questo romanzo dal cliché delle cronache dal fronte è il racconto, sviluppato in parallelo, di Daša, la ragazza di cui Egor è innamorato
quanto geloso. Egor va in guerra in Cecenia, la sua condizione è quella di un individuo gettato a sopravvivere tra i cadaveri, la possibilità
di rimanere sano è affidata al dialogo con i ricordi. Prilepin svela progressivamente qualcosa di più inquietante: il rapporto di Egor e Daša
è altrettanto segnato dalla patologia: le relazioni, i rapporti affettivi non sono una zona franca. Il carattere pregevole del romanzo sta nel
montaggio di sequenze parallele che raccontano un uomo incastrato in una duplice dimensione inquinata dall’angoscia e dalla paura: il
rapporto con la fidanzata intossica Egor almeno quanto la guerra in Cecenia. Daša racconta a Egor di aver avuto, prima di lui, ventisei
uomini, e lui entra in un tunnel di ossessioni che lo imprigionano: davanti all’ineffabilità della propria ragazza di poco più di vent’anni non
riesce che a chiudersi in un compulsivo «voglio avere qualcosa di mio!». Per Prilepin la questione del possesso è centrale visto che Egor
sceglie di ingabbiarsi in un egoismo polimorfo e perverso: «‘Tu mi hai derubato!’ Avrei voluto dire e non riuscivo. Derubato o donato?».
La sola scoperta dell’esistenza di un diario di Daša precedente alla loro relazione lo turba profondamente, e il desiderio di penetrare quei
segreti lo porta a una ricerca che lo porterà fino alla discarica della città in preda alla bramosia di possedere, a prescindere dalla certezza
di un affetto vicendevole. Le pagine dedicate a Daša sono numericamente inferiori, ma non si sente uno sbilanciamento, perché chiariscono
tutto il resto del romanzo. Anche il semplice spaccato di mondo universitario che compare nelle vicende di Egor e Daša restituisce in pieno
l’insensatezza di un sistema che gira a vuoto: sembrano i fotogrammi di un breve racconto che si inseriscono chirurgicamente nel quadro
generale del romanzo e mantengono la preziosa ferocia di uno sguardo neutro. Non è in nessuna misura «un romanzo documentario
o di denuncia» nel senso classico, ma un libro che decide di affrontare una questione di caratura sicuramente maggiore: la condizione
dell’uomo che porta con sé le nevrosi irrisolte del novecento, aggravando la propria situazione ma cercando comunque di sopravvivere.
Egor segue un solco obbligato: in guerra, braccato dall’orrore in agguato ad ogni pagina, solo raramente si aprono spazi di fuga almeno
ideale. Durante la preparazione alla battaglia, ben descritta come un rito di iniziazione all’assurdo e all’ineluttabile, Prilepin lascia uno
spiraglio di luce nell’atmosfera cupa dei villaggi ceceni: «Adesso prendo la rincorsa e sbatto la testa contro il cassone! Poi dico è stato
un attimo di follia…». Non c’entra solo la guerra, descrive qualcosa di più: l’obiettivo dev’essere quello di guardare alla possibilità, anche
remota, di “riderci sopra”, anche di fronte all’ampia e complessa vicenda del superamento dei propri limiti di resistenza e del conseguente
rischio di franare.
10
Scaletta
21.00 Mauro Stagi/Alessandra Maoggi/Manuele Atzeni
21.20 Lola’s Dead
21.40 Topsy The Great
22.00 Bad Apple Sons
22.20 Chambers
22.40 Walking The Cow
11
MAURO STAGI / ALESSANDRA MAOGGI / MANU ATZENI
Roberto Zucco è la reinvezione letteraria delle vicende di un criminale vagante che seminò terrore nelle strade francesi negli anni ‘80,
scritta da Bernard Marie Koltés. Il Roby’s Zoo di Mauro Stagi è una mitragliata di parole che sequenzano una rx delle nostre pianure, sono
occhi che descrivono ciò che tutti vedremmo in assenza di narcolessia. Le parole di Alessandra Maoggi affondano nella piaga, gli scratch
di Manu Atzeni liberano il free- style.
Le mie esibizioni sono di tutt’altra natura rispetto a quella musicale, essendo più performer e attore, anche se ho avuto sempre intorno
musicisti con cui dialogare. Quindi per me è già una novità affrontare un lavoro più dal punto di vista ritmico e musicale che da un punto
di vista interpretativo. Ma l’idea di questa performance/concerto è stata proprio quella di rendere una storia o meglio vicenda tragica
attraverso i suoni e linguaggi che si rifanno alle nuove sonorità urbane piuttosto che la musica elettronica e che fossero attuali e diversi
da quelli che di solito fanno parte del bagaglio di un attore, questo è stato il punto fondamentale da cui sono partito per sviluppare tutto il
lavoro. (Stagi)
LOLA’S DEAD
Si chiamavano Die fesche Lola, citavano Marlene Dietrich, poi la sexy Lola è morta e ora sono i Lola’s dead. Dal 2002 la formazione
attuale comprende: Tommaso Cantini, Edoardo Farnioli, Albero Coco, Lorenzo Cappelli. Senza legarsi a un genere definito, non
mascherano l’attitudine post-rock: la dialettica tra le due chitarre, una distorta e una limpida, offre sensazioni cupe e alle volte spettrali.
I nostri pezzi, lunghi e ad ampio respiro si prestano male ad una drastica selezione. 20 minuti per noi equivalgono a 2 soli pezzi, una
selezione estrema. Quali? Perché? Beh, per far spiccare cioè che Lola è, oltre che morta, ovviamente. Ma per fare questo è bene rimarcare ciò
che più è radicato del nostro stile, ma anche la direzione intrapresa dal lavoro più recente. 2 pezzi abbiamo detto, e allora viene naturale: un
pezzo consolidato e un nuovo arrivato.
La nostra è una ricerca in più direzioni. È una ricerca sulla melodia, con la presenza di un cantato anche là dove non te lo aspetti.
È una ricerca nei suoni, con intriganti puliti e bombardanti distorti. È una ricerca strutturale, perdendo la pratica comune di riproporre il
riproposto. Non è una ricerca al consenso.. ma se arriva tanto meglio! (Lola’s Dead)
TOPSY THE GREAT
Topsy the Great fondono il punk al noise in uno sviluppo articolato, introdotto da accelerazioni e ripensamenti e da impianto ritmico
che si risolve nella ciclicità e nella reiterazione di complesse strutture metriche. Nel 2009 esce il loro primo ep omonimo e con questo si
presentano al pubblico dei live; l’anno successivo esce VOL.II. Attualmente lavorano al loro nuovo disco.
Di solito in 35-40 minuti ci rientrano 13-14 pezzi, in 20 minuti ce ne stanno 7: una divisione quindi, o un fratto 2 se preferite. I 7 pezzi che
eseguiremo, oltre ad essere suonati con una soluzione del tipo 1°-2°-3° pausa 4°-5°-6° e 7°,li abbiamo scelti perchè ci sembrano adatti a
raccontarci: un racconto riassumibile in una sorta di entrata - bagno - uscita. (Topsy The Great)
BAD APPLE SONS
I Bad apple sons sono Clemente Biancalani, David Matteini, Andrea Cuccato, Andrea Ligia. Hanno aperto i concerti de Il Teatro degli
Orrori e dei Marlene Kuntz. Nel 2008 vincono la XX edizione del Rock Contest di Controradio. Coward (2007) è il loro primo ep e nel
2010 esce l’album. Influenzati dall’underground, musicano un’oscurità a tratti psichedelica.
In questi pochi minuti i Bad Apple Sons, proponendo per la prima volta pezzi inediti della loro produzione, ricostruiranno un percorso teso
alla ricerca di una musica essenziale, scarna nei suoni ma al contempo schizofrenica e violenta, tesa alla totale partecipazione emotiva
dell’ascoltatore. Venti minuti claustrofobici, quindi, densi di suggestivi impatti sonori e lirici, ma anche di silenzi palpitanti di attesa. I Bad
Apple Sons vi augurano una buona serata. Che Dio vi benedica.(Bad Apple Sons)
CHAMBERS
Le note dei Chambers partono dalla cima di un picco: quando le ascolti ti trovi a valle, e vieni travolto. Loro dicono che la parola
rilassato non esiste: Andrea (voce), Alberto (chitarra), Theo (chitarra), Gigi (basso), Nicola (batteria) sono il nucleo sonoro da cui sgorga
l’hardcore. Stargli di fronte può significare scendere negli abissi: oppure inseguirli, per decifrare il rumore. Nel febbraio 2010 esce il loro
album (ST, vinile).
Abbiamo pensato soltanto a che cosa in questo caso avrebbe il respiro troppo lungo e a concentrare più energia possibile in 20
minuti. Nient’altro (Chambers)
WALKING THE COW
È un folk rigato da inflitrazioni electro. Sono motivetti di accordi semplici che restano in testa dopo pochi secondi. È una voce che soffia
melanconia, ma poi presto svolta dimenticando il passato. Walking the cow è Michelle Davis, Paolo Moretti, Nico Volvox, Dathys B.,
Martino Lega.
L’esibizione dei Walking the Cow è la trasposizione scenica della risposte ad alcune domande che le mucche stesse si sono poste: Costola
rotta, Lavoro, Teatro, Runner.
Non è necessario riflettere sulle domande, ma apprezzare la qualità delle risposte; come sempre. Il silenzio è miglior modo per apprezzare il
flusso consequenziale. Noi portiamo le risposte. Voi state per portare le domande. (Walking The Cow)
12