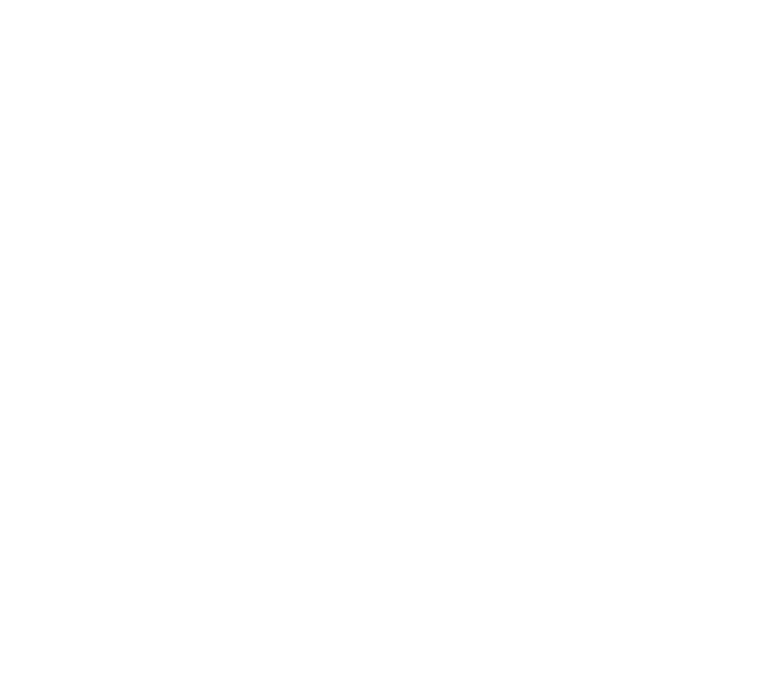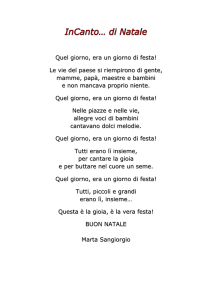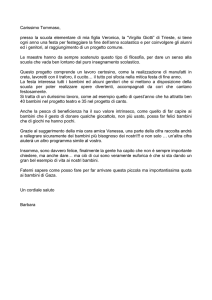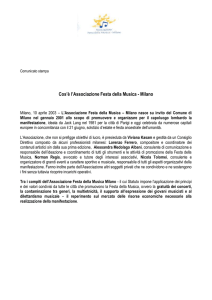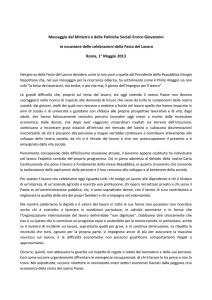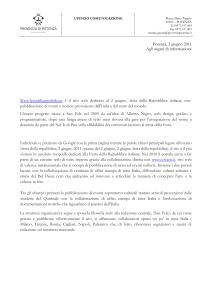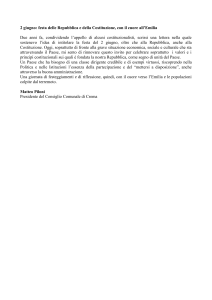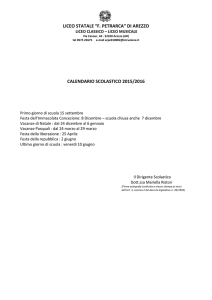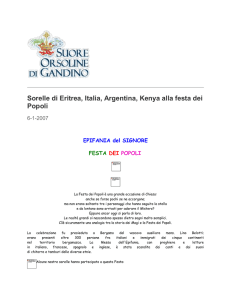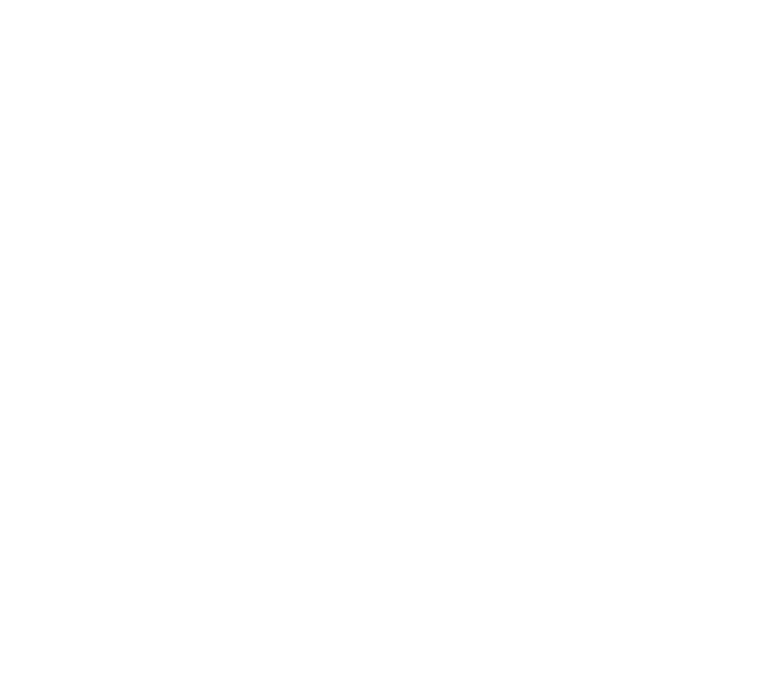
Sommario:
1 Introduzione - di Ugo Leone
2 Feste e canti del Vesuvio - di Peppe D’Argenzio
3 Qualche spunto di riflessione... - di Augusto Ferraiuolo
4 Festa della Madonna dell’Arco - di Raffaele Di Mauro
5 Festa dei quattro Altari - di Raffaele Di Mauro
6 Festa delle lucerne - di Raffele Di Mauro
7 Festa della Madonna di Castello - di Raffele Di Mauro
8 Festa di San Michele Arcangelo - di Raffele Di Mauro
Introduzione
di Ugo Leone
Il Parco Nazionale del Vesuvio è in primo luogo una eccezionale concentrazione di risorse naturalistiche e di rarità biologiche, in qualche modo resa possibile dalle apparenti contraddizioni tra una montagna e il mare, un cuore caldo e
pulsante come quello del vulcano incastonato dentro una metropoli.
Tanto basterebbe per farne un Grande Attrattore di livello mondiale, come
in effetti è: un attrattore che genera milioni di visite, anche se troppo spesso
superficiali e frettolose.
Ma a questa monumentalità orografica e a questa grandezza di immagine
e si aggiungono le opere dell’uomo: le straordinarie città di Pompei, Ercolano
e Oplonti, che il Vulcano ha voluto distruggere quasi per conservarle.
Si affianca la lunga teoria delle straordinarie ville vesuviane, crinale di architettura e civiltà tra il Vulcano e il mare, tanto importanti quanto, ancora, misconosciute al grande pubblico.
E il Vulcano si adorna dei tanti paesi, quasi una collana intorno al Monte,
ognuno con la sua forte identità, con la tipicità delle proprie tradizioni, che
affondano le radici nel paganesimo, e le rinnovano nei riti delle stagioni e dei
Santi. Tradizioni tutt’altro che perdute o stravolte: ma che trovano periodica
alimentazione nelle feste, momenti collettivi di grande partecipazione e forza
4
emotiva, veri e propri episodi di un etnos non sopito né tantomeno stemperato
dalla globalizzazione.
Feste talmente grandi, originali e sentite, da meritare appieno il riconoscimento di Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, secondo i crismi dell’UNESCO.
La musica è il collante di tutto questo: e se il suono della Medina di Marrakech
ha conseguito il “marchio UNESCO”, non diversamente dovrebbe essere per
la Musica delle Feste Vesuviane.
Un fenomeno millenario, ma universalmente noto da pochi anni, e come
tale studiato e valorizzato dai più grandi etno-antropologi. Ma al contempo un
fenomeno vivo e vitale, che si presta a letture filologiche delle espressioni più
tradizionali, come pure a rivisitazioni e contaminazioni, come tutti i fenomeni
vivi di questo mondo.
E al quale il Parco Nazionale del Vesuvio dedica la massima attenzione:
a recuperarne le molteplici espressioni, a raccoglierne e catalogarne le fonti
anche nell’ambito del suo “Polo delle tradizioni”, a pubblicarne e promuoverne
le espressioni, come in questo pregevole CD di cui siamo grati al Maestro Giuseppe D’Argenzio, che con tanta passione e competenza lo ha curato.
5
Feste e canti del Vesuvio
di Peppe D’Argenzio
Tammurriate, fronne‘e limone, canti ‘a ffigliola sono alcune tra le forme più
importanti della musica di tradizione orale della Campania e dell’area Vesuviana.
Il Vesuvio con la sua forza magica e minacciosa è l’epicentro di un territorio in cui queste forme musicali nascono e si espandono verso tutta la regione
nelle varianti in cui vengono studiate da etnomusicologi e ricercatori. Attraverso queste forme, da sempre, in occasione delle feste religiose legate ai cicli
delle stagioni, le comunità si ritrovano per riaffermare i loro legami sociali.
Nonostante le trasformazioni degli ultimi decenni, queste manifestazioni mantengono nei paesi dell’area Vesuviana una forza e una vitalità altrove
scomparse.
Il tradizionale sistema economico legato all’agricoltura e ai suoi cicli ormai
si mescola con un’economia più complessa e con un sistema di diffusione
culturale che sottopone queste realtà a continue interferenze e trasformazioni. Eppure l’intensità con cui alcuni appuntamenti rituali sono sentiti e vissuti,
provoca nello spettatore che vi partecipa dall’esterno uno stupore e una fascinazione particolare…. a volte inquietante, altre commovente, ma sempre ricca
di suggestioni.
Curare un progetto editoriale legato alle feste ma soprattutto alla musica
7
dell’area vesuviana rappresenta per me una grande opportunità di riscoperta
ma anche la difficile impresa di fare una sintesi quanto più divulgativa, utilizzando sia esempi musicali originali sia musiche che in qualche modo sono state
influenzate dai suoni e dalle voci di questo territorio. Il mio è essenzialmente
un approccio da musicista piuttosto che da studioso o da etnomusicologo.
Negli anni settanta grazie al lavoro pionieristico di Roberto De Simone e
della Nuova Compagnia di Canto Popolare in molti siamo stati sedotti dalla
scoperta di un patrimonio musicale che in Italia era rimasto piuttosto nell’ombra.
Per molti musicisti questa scoperta rappresentò un orizzonte nuovo e la
possibilità di ricercare un’identità nazionale alla nostra musica. Un modo per
sentirsi meno colonia dell’industria musicale anglosassone.
Dopo i primi entusiasmi e i primi ingenui tentativi di appropriarci di queste
modalità, probabilmente in molti di noi, e sicuramente in me, insorse un senso
di frustrazione nello scoprire quanto poco riproducibili fossero certe tecniche di
canto o di esecuzione strumentale.
Senza appartenere a determinate comunità e senza aver posseduto e
appreso queste tecniche sin dall’infanzia, la semplice imitazione delle stesse
produceva solo delle brutte copie e non faceva un buon servizio a questo patrimonio.
A questo punto in maniera rispettosa mi sono ritirato ad osservare, a seguire questi fenomeni musicali con curiosità e interesse dall’esterno, a cercare
di capirli avendoli sempre come punto di riferimento nella musica che avrei
fatto in seguito.
8
Il seguito è stato un lungo percorso con gli Avion Travel nelle cui musiche,
pur lavorando su forme di canzone d’autore, l’attenzione verso le tradizioni
sonore della nostra terra è sempre stata molto forte.
Poi è venuta l’esperienza attuale con L’Orchestra di Piazza Vittorio, progetto
in cui l’incontro tra musicisti in gran parte immigrati, diventa l’ipotesi per la
creazione di una musica del Mondo, originale, che trae però ispirazione dalle
diverse fonti e forme di tradizione musicale di ciascun componente. Questa
esperienza mi ha riportato, in un altro modo, a rivivere certe problematiche
riguardanti l’autenticità dei valori musicali e il rapporto con le culture di provenienza e d’appartenenza.
L’aspetto problematico da affrontare quotidianamente è quello di una cultura musicale, spesso appresa oralmente in famiglia o nella comunità d’origine,
soggetta oggi a trasformazioni continue attraverso incontri con altri musicisti,
con altre musiche e soprattutto con una dimensione globalizzata dello spazio
e del tempo che annulla e pone sullo stesso piano tutte le differenze. Non è
più possibile pensare ad un territorio e ad un sistema culturale chiuso in cui le
tradizioni si possano perpetuare senza mutazioni.
La ricerca per compilare la scaletta di questo CD inevitabilmente è partita da
domande attinenti a queste riflessioni.
Cosa rimane di una tradizione ampiamente documentata in un’opera ormai storica, fortunatamente in via di ristampa, come “Canti e tradizioni della
Campania” a cura di Roberto De Simone, che negli anni settanta fece un im9
portante lavoro di documentazione portando in studio alcuni tra i più significativi interpreti della tradizione musicale campana?
Quale è ed è stato il ruolo di un interprete come Giovanni Coffarelli, già presente nella suddetta opera di De Simone ed ancora oggi attivo come motore
pulsante e come testimone autentico della tradizione. Animatore di una associazione, “La paranza di Somma Vesuviana” Coffarelli è ancora l’epicentro di
un importante attività di documentazione sul territorio.
Come dobbiamo poi considerare l’opera di un gruppo ormai storico come ‘E
Zezi che ha innestato sulle forme musicali della cultura contadina le tematiche
di trasformazione di una area un tempo agricola, ora metropolitana? Come
si racconta in musica, utilizzando modelli e forme della tradizione, il lavoro in
fabbrica che sostituisce quello della campagna?
Che significato ha per un gruppo pop dal respiro musicale internazionale
come gli Almamegretta riproporre in una versione dub il testo di una tammurriata tra le più diffuse come “Sanacore”?
Perché un affermato jazzista napoletano come Marco Zurzolo dedica un
intero progetto alle musiche della Madonna dell’Arco?
E’ possibile trascurare il ruolo rappresentato negli ultimi anni da Marcello
Colasurdo? La sua vocalità incarna tutta la sapienza antica mettendola al servizio di esperienze moderne che sconfinano i generi e le forme….attraversando musica, teatro e cinema.
Inoltre come raccontare nel frattempo la vitalità e la vivacità delle “paranze”
che si riuniscono nelle feste popolari per suonare, cantare e ballare per l’intera
giornata?
10
Che ricambio generazionale c’è in questo ambiente?
A queste domande io non voglio e non posso dare delle risposte approfondite,
né voglio esprimere giudizi di merito. Le riflessioni restano sullo sfondo e spiegano in qualche modo le scelte di questa selezione musicale.
Sicuramente in questo CD ci sono molte lacune e molte forzature, ma quello
che più mi interessa è creare una suggestione… evocare un mondo sonoro
con la sua ricchezza ma anche con tutte le domande e gli stimoli che offre.
Il primo impulso è stato quello di organizzare una scaletta musicale che
fosse rappresentativa ed esaustiva di tutto quello che in termini musicali accade oggi in quest’area.
Mi sono però presto reso conto che quest’impresa, oltre che essere difficilissima, rischiava di concretizzarsi in una compilazione puramente sociologica,
probabilmente utile al fine di una catalogazione, peraltro sicuramente incompleta per miei limiti di conoscenza, ma insufficiente a cogliere le connessioni
che questa musica mette in moto. E poi lo scopo principale era creare una
selezione musicale piacevole all’ascolto.
Voglio precisare che questa scaletta è stata maturata partendo da una consapevole idea di tradimento. Credo che un CD, cosi come tante altre forme di
divulgazione della tradizione orale, rappresentino uno snaturamento, anche se
non sempre negativo.
Le tradizioni popolari vanno vissute innanzitutto dalle comunità che le esprimono.
11
Nel momento in cui si cerca di raccontarle bisogna sapere che, oltre
all’aspetto di studio, si può solo forse suggerire il potenziale evocativo e il fascino che questi materiali possono suscitare.
A fianco della documentazione scientifica rigorosa possono e devono esistere anche altre forme di diffusione più creative, pur sempre rispettose, ma
più adatte a suggestionare ascoltatori estranei al territorio.
Per ciò ho voluto privilegiare una scelta meno filologica. Ho cercato di offrire una grande varietà timbrica ed espressiva che tenesse conto sia di materiale fedelmente rappresentativo della tradizione attraverso registrazioni, anche
meno recenti, di forme e interpreti autentici, sia di esperienze, cantori e gruppi
appartenenti ad una scena musicale che sconfina, attraversando Napoli e la
Campania, e racconta, anche fuori di questa regione, il suono e la musica di
questo territorio cosi fertile.
Ho inserito quindi anche musiche di contaminazione che oltre a raccontare l’identità dei vari interpreti, riescono ad evocare le fonti sonore di questa
realtà che è molto più complessa di una semplice cartolina.
Penso che la conservazione e la documentazione di queste realtà andrebbe realizzata in una maniera più continuativa e approfondita nelle sedi e nei
modi più opportuni per catalogare tutta la storia delle ricerche sul campo fatte
negli ultimi decenni, ma anche per monitorare lo stato presente e la diffusione
di queste musiche e dei suoi interpreti.
Questo lavoro, anche se non potrà essere di grande divulgazione, dovrà
rappresentare per gli addetti ai lavori e per le nuove generazioni una miniera
da cui attingere. Dall’altro lato scoprire che questa musica è in grado di in12
fluenzare ed ispirare artisti non solo locali è la testimonianza più forte di tale
ricchezza.
Altri paesi, penso al Brasile, alla Spagna o al Portogallo, sono riusciti a
coltivare un legame talmente forte con la musica di tradizione orale al punto
da avere una musica moderna fortemente connotata da questi legami. In Italia
molte regioni sono ancora in tempo per non rescindere definitivamente questi
legami: penso alla Campania ma anche ad altre regioni del meridione. Sulla
base di queste convinzioni mi sono mosso per compilare questo CD per questa parte d’Italia, tra le più vive musicalmente.
Per quanto riguarda i testi ho chiesto ad Augusto Ferraiolo, antropologo ed
etnomusicologo che insegna da qualche anno all’università di Boston, un contributo e una riflessione sul lavoro dopo averglielo fatto leggere. Desideravo
avere un punto di vista qualificato che in qualche modo asseverasse o confutasse le mie scelte non proprio ortodosse. Con Augusto ho mosso i primi passi,
diversi anni fa, accompagnandolo nelle sue ricerche sul campo e lui mi ha
introdotto al mistero e al fascino del mondo delle tradizioni popolari e sempre
con lui ho cercato per un periodo, anni fa, di riproporre, non certo con risultati
indimenticabili, questo patrimonio musicale sui palcoscenici.
Oggi lui si occupa negli Stati Uniti di studiare proprio le trasformazioni e
le permanenze nelle feste tradizionali delle comunità italiane di immigrati ed
era per me la persona adatta a valutare un lavoro su materiali di tradizione in
questo tempo di grandi trasformazioni.
Grazie ad Augusto sono entrato in contatto con Giulio Bulfoni un fotografo suo
13
collaboratore, che ha già all’attivo diverse pubblicazioni di prestigio, che mi ha
messo a disposizione il suo prezioso archivio fotografico.
La scelta delle feste da raccontare e documentare si è limitata alle cinque
feste che dopo una ricerca più ampia presentavano dei motivi di interesse
particolare dal punto di vista della valenza etno-antropologica, ma anche della
partecipazione popolare. Avevo bisogno di qualcuno che per la descrizione di
queste cinque feste popolari, descritte riportasse un pò di rigore ed esattezza
per rispetto dei protagonisti ma anche per offrire ai lettori una documentazione fedele di ciò che oggi accade in questi appuntamenti rituali che scandiscono l’anno delle comunità vesuviane.
Raffaele Di Mauro è un giovane etnomusicologo che ha già curato diverse
pubblicazioni di prestigio e collabora con la cattedra di etnomusicologia del
maestro-professore Pasquale Scialò presso l’istituto Suor Orsola Benincasa
di Napoli. Nei suoi studi si è occupato delle tammurriate così come di canzone
napoletana ed è stato per me un importante punto di riferimento anche nella
ricerca e nella valutazione del materiale musicale da pubblicare sul CD.
14
Qualche spunto di riflessione...
di Augusto Ferraiuolo
Se vi capitasse di assistere alla festa della Madonna dell’Arco, il Lunedì in
Albis a Sant’Anastasia – ed è inutile dire che si tratta solo di un esempio, tutte
le altre feste della zona sono analoghe, potreste aver modo di osservare una
serie di fenomeni di estremo interesse antropologico. Non mi riferisco solamente al rituale, complesso e profondamente radicato sia nella tradizione che
nel tessuto sociale della zona, non mi riferisco al pellegrinaggio e ai fujenti che
a tutt’oggi ancora lo compiono, declinando con comportamenti penitenziali di
vario genere una religiosità popolare tutta da analizzare.
Non mi riferisco alle pratiche devozionali quali l’offerta di ex voto che, a
partire dal XV secolo, adornano il santuario e narrano la grandezza del santo
taumaturgo e la sua umanità. E non mi riferisco neanche a quell’aspetto musicale che, situandosi a metà tra la preghiera e il piacere ludico, e’ intimamente
connesso con la festa. Fronne, canti a figliola e tammurriate sono da sempre
un momento fondamentale dei rituali connessi ai culti mariani in Campania.
Oggi ancora di più, perché si caricano, come tutto il resto della festa, di simboli
e significati ulteriori.
E sono questi segni, questi nuovi codici arricchiti e contestualizzati in un
tempo che disloca la tradizione nella modernità e postmodernità, nonché in
uno spazio che reclama una globalizzazione oramai avvenuta, sono questi
segni, dicevo, a cui mi riferisco più direttamente. Sono i segni di quello che in
17
una parola potremmo definire “cambiamento”.
Pensate alle implicazioni insite, ad esempio, nella proibizione di portare
dentro la chiesa i toselli, quei grandi ex voto dipinti, trasportati a spalla da due
o più fedeli, con uno specifico passo cadenzato (‘a cunnulella). Il problema non
e’ ovviamente quello di una autenticità tutta da definire e dimostrare, o della
presunta scomparsa di una tradizione ”aulica”. E’, più generalmente, quello
della relazione di potere tra una classe egemonica, rappresentata dalle gerarchie ecclesiastiche, e una classe subalterna, in questo caso rappresentata
dalle Associazioni o dai fedeli. Il tutto nel quadro aspramente dialettico dello
scontro tra religiosità ufficiale e religiosità popolare.
Pensate alle implicazioni che ha la presenza di differenti gruppi etnici
durante il pellegrinaggio: che devoti immigrati dallo Sry Lanka si confondano
all’interno delle Associazioni, con i cui membri condividono pratiche e credenze
religiose (non a caso quelle popolari), stendardi e uniformi (massimo simbolo
dell’identificazione e dell’appartenenza), è segnale di una realtà mutata, oramai globale, molto lontana dal localismo che una ideologia del folklore come
sopravvivenza e come nostalgia inevitabilmente comporterebbe.
Pensate agli ex voto, tradizionalmente tavole dipinte, su cui leggere la narrazione dell’evento miracoloso che porta alla salvezza fisica e spirituale, ma
anche oggetti d’argento rappresentanti le parti del corpo malate e poi guarite
dalla divinità. La tipologia ovviamente non finisce qui: abiti nuziali, oggetti preziosi, trecce di capelli sono solo esempi di come un fedele si privi di cose per
lui significative per farne omaggio al dio taumaturgo. Oggi non è eccezionale
vedere ex voto compositi: la fotografia del fedele e l’immagine votiva del santo
18
– elementi invarianti – si vengono a trovare accanto ad oggetti come siringhe,
cucchiai, fiale di acqua distillata e involucri di carta d’alluminio, a testimonianza
di nuove insidie terrene (la tossicodipendenza) per le quali chiedere protezioni sovrannaturali.
Pensate alla musica. Immaginare che non siano avvenuti cambiamenti
in questo particolare ambito è, semplicemente, irrealistico. Fusioni, contaminazioni, straniamenti e dislocazioni, rivisitazioni e sopravvivenze, tutto suggerisce quella fondamentale tensione tra tradizione e modernità. E dico subito
che illudersi che sia questo un fenomeno nuovo è fuorviante: le generazioni
precedenti hanno attraversato, per fortuna, analoghe situazioni perché, per
definizione il folklore, in quanto cultura viva, non è cosa immutabile e ferma,
ma continuamente in movimento, talvolta anche caotico. Ovviamente cambia
la dimensione, la velocità, la profondità di tale cambiamento: certamente in
epoca di mass media e globalizzazione la trasformazione e’ onnipervasiva,
quasi totale, rapidissima. Ed e’ una trasformazione inevitabile.
La scelta, estetica ma anche di prospettiva di studio, diventa allora tra la
ricerca di una ipotetica autenticità perduta e l’analisi delle trasformazioni prima
sociali quindi culturali che generano i nuovi approcci musicali. Personalmente
ritengo non produttivo parlare di autenticità, concetto ambiguo, scivoloso se
non addirittura pericoloso quando da un lato reclama, direi inevitabilmente,
una specificità etnica e non una solidarietà di classe, e, dall’altro, propone
come valore fondamentale la nostalgia nei confronti di qualcosa ormai “perduto”. Tutto questo suggerisce una visione della cultura folklorica come statica,
isolata, dominata dall’entropia, incapace di rinnovarsi. La realtà dei fatti e’ pro19
fondamente diversa: è una realtà dinamica, che privilegia confronti e dialettiche, talvolta anche aspri, comunque vivi.
Tutto ciò è evidente nella scelta degli interpreti e dei brani proposti: da
Marcello Colasurdo, che si muove completamente a suo agio tra la Real World
di Peter Gabriel e le frequentazioni, anche oggi, dei pellegrinaggi, a Giovanni
Coffarelli, interprete tradizionale, che ha raggiunto una dimensione ulteriore
grazie a Roberto De Simone e al suo lavoro di ricerca e riproposizione negli
anni settanta. E da questa ricerca sono qui proposti sia i canti sul tamburo di
Rosa Nocerino e Titina Raia, come pure “Il secondo coro delle lavandaie”,
tratto dalla Gatta Cenerentola. Gli spazi di analisi sul rapporto tra tradizione e
trasformazione sono già interessantissimi, con questi pochi esempi.
E a ciò si aggiunge la proposta di un gruppo come ‘E Zezi, fondamentale
riferimento di quella rilettura politica del folklore, che lo contestualizzò non solo
nelle campagne ma anche nelle fabbriche. Fino alla rilettura di una tammurriata molto frequente nella tradizione vesuviana (Sanacore) proposta, a seguire,
prima dalla Paranza di Somma Vesuviana, quindi dagli Almamegretta e Raizz.
Tutto a coprire uno spettro ampio che va dallo scongiuro contro il maltempo,
recitato da Zi’ Riccardino Esposito Abbate, fino alle rielaborazioni del Triotarantae e Marco Zurzolo, decisamente attenti a discorsi musicali globali.
E non faccia impressione il carattere frammentario o caotico che potrebbe
essere evidenziato. E’ questa, infatti, come direbbe Gramsci, la caratteristica
peculiare di questa cultura.
20
21
Festa della Madonna dell’Arco (Sant’Anastasia)
di Raffaele Di Mauro
La Madonna dell’Arco, la cui festa si svolge a Sant’Anastasia il lunedì in Albis,
occupa nel panorama del culto mariano in Campania un posto di primissimo
piano per la grande e numerosa partecipazione devozionale, tanto da contendersi, tra le cosiddette “madonne sorelle”, con la sola Madonna di Montevergine il primato e il ruolo, per così dire, di “grande sorella”.
Le “madonne sorelle” indicate dai fedeli sono talvolta sette (indicazione
prevalente nell’area napoletana e riportataci in primis da Roberto De Simone)
altre volte tre (indicazione riscontrata dal sottoscritto in alcune zone dell’area
casertana). La Madonna dell’Arco è sempre presente, esercitando un ruolo centrale sopratutto nel secondo caso ancor più che nel primo laddove la
centralità è invece riservata alla Madonna di Montevergine. Questa essendo
l’unica madonna “nera” rappresenta l’autunno e l’inverno da contrapporre alle
sei madonne “bianche” (la cui indicazione varia da paese e paese) che rappresentano invece la primavera e l’estate.
Non a caso già Enrico Cossovich nell’800 (in quell’opera fondamentale che è
“Usi e costumi di Napoli” del De Bourcard) metteva in relazione le due Madonne parlando della festa della Madonna dell’Arco come una sorta di “appendice”
di quella di Montevergine.
Questa affermazione oggi, almeno dal punto di vista partecipativo, potrebbe es23
sere rovesciata, dato che la Madonna irpina ha perso nel corso della seconda
metà del’900 quel ruolo che ancora agli inizi del secolo scorso sembrava avere
(così come felicemente rappresentato da Raffaele Viviani nell’opera “Festa di
Montevergine” del 1928) rispetto al culto della Madonna di Sant’Anastasia che
sembra meglio “resistere” allo scorrere del tempo e alle trasformazioni epocali
avvenute nel secondo dopoguerra.
Il culto della Madonna dell’Arco (il nome “dell’arco” è probabilmente dovuto
alla vicinanza in quei luoghi dell’antico acquedotto di Claudio) sembra risalire
al lunedì in albis del 1450 (ci sono testimonianze discordanti sull’anno ma non
sul giorno).
In quell’anno accadde il famoso episodio legato al gioco della “palla-maglio”
(una sorta di golf rudimentale) durante il quale un giovane, bestemmiando
dopo aver fallito un colpo, scagliò violentemente la palla verso l’immagine della
Madonna presente nella vicina edicola campestre, la quale, colpita, prese a
sanguinare.
All’episodio seguì un processo sommario presieduto da Raimondo Orsini,
conte di Sarno, che condannò e fece impiccare il giovane.
A questa prima circostanza “miracolosa” fa seguito un altro episodio, la
cui datazione stavolta sembra essere certa, accaduto sempre di lunedì in albis
il 1590 ad Aurelia Del Prete che si vide cadere entrambi i piedi dopo che l’anno prima, nello stesso giorno, aveva imprecato contro l’immagine benedetta.
Questo secondo “miracolo” (che da allora caratterizza questa come una singolare madonna “punitiva” e “vendicativa” assai diversa dalla tradizionale e
24
benevola figura tramandataci dalla chiesa cristiana) suscitò un vasto clamore
all’epoca tra i fedeli .
I piedi della Del Prete, dopo un processo canonico, furono depositati in
una gabbietta di ferro all’interno del Santuario che in seguito a questo eccezionale avvenimento fu fatto costruire nel 1593 (la prima pietra fu posta dal
vescovo di Nola il 1° maggio).
Il Santuario fin dal 1594 fu affidato alla gestione dei padri domenicani che da
allora, a parte alcune piccole “parentesi” storiche, lo custodiscono fino ad arrivare ai giorni nostri.
La particolarità, e anche la popolarità, della festa della Madonna dell’Arco è
legata soprattutto a coloro che ne sono a tutti gli effetti i protagonisti ovvero i
cosìdetti fujenti (quelli che scappano) chiamati anche vattienti (quelli che battono, da vattiare che significa battezzare nel senso di iniziare).
Questi due nomi sono legati a due dei comportamenti rituali legati a questo culto: la corsa incessante (spesso a piedi nudi) e il battere costantemente i
piedi quando si è “costretti” a fermarsi. I fujenti sono organizzati in associazioni
(secondo le stime fornite dai padri domenicani se ne contano più di 350 in tutta
la Campania) e giungono al santuario in gruppi (denominati paranze) vestiti
con la loro tipica divisa (bianca, con una fascia rossa in vita e una fascia azzurra a tracolla) e trasportando dei toselli (costruzioni votive in legno, cartapesta
ecc.).
Oltre alla corsa e al battere dei piedi (che assume quasi il carattere
di una danza), il rituale dei fujenti è caratterizzato dagli episodi di crisi e isteria
25
(cadute a terra accompagnate da grida, contorsioni e svenimenti) a cui essi
danno vita una volta giunti all’interno del santuario, che richiamano alla mente
episodi e gesti simili riscontrabili (come già a suo tempo osservato dall’antropologa Annabella Rossi e dallo stesso De Simone) in un altro fenomeno rituale
dell’Italia meridionale: il tarantismo pugliese con le scene di crisi isteriche delle
tarantate nella cappella di San Paolo a Galatina.
Le caratteristiche sono quelle di un rito di iniziazione primaverile caratterizzato
da una preponderante partecipazione maschile e probabilmente imbevuto fortemente di tradizioni religiose pre-cristiane.
Il rito dei fujenti è stato totalmente “ignorato” dalle fonti ufficiali, dalle stampe seicentesche fino agli inizi del ‘900 (il primo a riferirne sarà padre Raimondo
Sorrentino nel 1930 parlando di “uno spettacolo strano ma non bello e tantomeno religioso”) e a partire dal 1966, e un po’ per tutti gli anni ’70, sarà apertamente osteggiato dalla chiesa che, talvolta “proibendo” e talvolta “pregando”
o “raccomandando”, attraverso il bollettino ufficiale “La Madonna dell’Arco”,
cercherà di imporre delle “norme” comportamentali per i fujenti, dimostrando
così in modo lampante il proprio disagio di fronte a queste forme di religiosità
popolare nel vano tentativo di “correggerle”.
Da segnalare inoltre sono le numerose tavolette ex-voto dipinte presenti
nel santuario a connotare il forte contesto miracolistico del culto legato anche
a prodigiose liberazioni dal demonio e dalle fatture di cui si hanno notizie a
partire dal XVII secolo.
26
Dal punto di vista musicale tre sembrano le forme principali adoperate nel culto
della Madonna dell’Arco connesse ad altrettanti momenti sia preparatori che
successivi alla festa.
La voce di questua (o voce d’a cerca), legata al momento immediatamente precedente al lunedì in albis quando le paranze vanno in giro appunto per la
questua o cerca, che consiste in una particolare forma vocale senza accompagnamento musicale (assai simile stilisticamente alle fronne e ai canti a figliola)
caratterizzata dal classico stereotipo iniziale (“chi è devoto”) e riscontrabile
anche in altre simili voci napoletane per la raccolta delle offerte (ad es. per la
Madonna del Carmine o per S. Anna).
Abbiamo poi una tipica marcia bandistica intonata appunto da una banda che
accompagna le paranze nell’ultima domenica che precede la Pasqua quando
si può assistere ad una scena che viene ripetuta ogni volta ci si imbatte in
un’edicola della Madonna dell’Arco: al comando del capo-paranza tutti i componenti si buttano con la faccia a terra rimanendo in tale posizione fino a nuovo ordine mentre la banda suona.
Infine l’ultimo momento musicale è quello legato alle tammurriate che si
svolgono nel pomeriggio del lunedì in albis al “ritorno” dal Santuario nelle zone
circostanti, così come avveniva fino ad alcuni decenni fa per la festa di Montevergine al cui ritorno ci si fermava a Nola per le tammurriate e le gare di canti
a figliola.
Data l’enorme partecipazione di fedeli provenienti da qualsiasi parte della
Campania, nella festa della Madonna dell’Arco sono ascoltabili, oggi più che
27
mai, tammurriate riferibili a diversi stili legati a differenti aree (vesuviana in
primis, agro nocerino-sarnese, amalfitana ecc.) ma ancora oggi quella predominante in questa festa (come testimoniano anche le registrazioni di De
Simone degli anni ’70) sembra essere quella di area giuglianese. Non a caso
i giuglianesi sono assai devoti proprio alla Madonna dell’Arco al cui santuario
si recano appunto il lunedì in albis e alla Madonna di Briano (in Villa di Briano,
provincia di Caserta) dove si recano invece la domenica in albis.
Quella giuglianese è una particolare forma di tammurriata con un ciclo
vocale tripartito (con l’alternanza di canto a distesa, quindi a ritmo e poi ancora
a distesa prima della vutata o rotella finale) che corrisponde ai 3 modelli melodici suonati dal sisco (flauto a canna singola che loro stessi costruiscono e di
cui sono assai “gelosi”) che sembra “guidare” l’esecuzione di questo specifico
stile areale di tammurriata che dal punto di vista ritmico e coreutico presenta
forti elementi di aggressività, quasi “guerreschi”, i quali sembrano sposarsi
bene con il carattere “vendicativo” e “punitivo” della Madonna dell’Arco.
28
Festa dei quattro Altari (Torre del Greco)
di Raffaele Di Mauro
La festa cosiddetta “dei quattro altari” è la più importante ricorrenza di Torre del
Greco e, seppur non abbia origini torresi, Torre del greco è l’unico paese dove
essa è sopravvissuta nei secoli e ancora attualmente si svolge.
La festa ha, probabilmente, origini napoletane ed è volgarmente chiamata
anche “festa ‘e l’uttava” perché si svolge nell’ottavo giorno dopo la celebrazione del Corpus Domini a cui essa, come vedremo, è legata, pur essendo una
cosa leggermente diversa.
Ma procediamo con ordine, avvalendoci anche del prezioso contributo di alcuni storici locali della festa tra i quali Raffaele Raimondo.
Innanzitutto Corpus Domini e Ottava è la stessa festa, dedicata all’Eucarestia,
perché durava appunto otto giorni fin dalla sua prima istituzione avvenuta con
Bolla papale di Urbano IV l’11 Agosto 1264.
Ancor prima, fin dal 1208, nella città belga di Liegi si celebrava la festa
del SS. Sacramento dopo che, come si narra, una suora del luogo (tale suor
Giuliana) aveva avuto una visione in cui il Signore stesso gli aveva ordinato che venisse celebrata annualmente una festa in onore dell’Eucarestia. Or
bene, a Napoli, secondo delle testimonianze storiche, fin dalla prima metà del
XIII sec. si celebrava la festa del SS. Sacramento dell’Eucarestia e dal 1264
in poi, dopo la suddetta bolla, la festa acquistò man mano sempre maggiore
31
importanza tanto che nel 1310 Roberto D’Angiò iniziò a far costruire la chiesa
del Corpus Domini (oggi conosciuta come Santa Chiara).
Si sa che la processione collegata alla celebrazione, a Napoli, seguiva un
percorso ben preciso e una volta raggiunta la strada della Sellaria o del Pennino, dove sorgeva l’edificio del Seggio del Popolo, ci si fermava e dallo stesso
edificio veniva impartita la benedizione solenne al popolo. Nel 1456 Alfonso
I d’Aragona, forse per punire il popolo di qualche ribellione, fece abbattere
quest’edificio e da allora in poi ogni anno nello stesso posto veniva eretto un
catafalco (una specie di palco con funzioni principalmente “funerarie” ma non
solo) detto appunto Catafalco della Sellaria o del Pennino. Una parte di questo
catafalco era adattata a palcoscenico e su di esso venivano rappresentati i
“misteri” (primo elemento in comune come vedremo con la festa torrese), quadretti biblici musicati da valenti musicisti.
Abbiamo notizie di una rappresentazione, avvenuta ancora sul Catafalco
del Pennino addirittura nel 1806 durante il cosiddetto “decennio francese”, di
un mistero dal titolo “Il monte prodigioso di Oreb” musicato da Giovanni Paisiello su libretto di Antonio Rota. La pratica di far costruire questo catafalco, infatti, sopravvisse per secoli e fu mantenuta anche dai Borboni, probabilmente
fino al 1848, anno dopo il quale non venne più ripresa.
Ora le domande da porsi sono le seguenti: cosa c’entra tutto questo con la
festa dei quattro altari? E quando quest’ultima nacque? Agli inizi del ‘500
Sant’Antonio Maria Zaccaria, fondatore dell’ordine dei barnabiti, aveva istituito
la pratica delle “quarant’ore”, che consisteva appunto nell’esposizione conti32
nua della SS. Eucarestia per un periodo di quarant’ore, e che si concludeva
con la benedizione Eucaristica impartita ai fedeli da quattro punti diversi (quattro altari) che simboleggiavano i quattro continenti allora conosciuti (Europa,
Asia, Africa e America) a significare l’ubiquità e l’universalità dell’Eucarestia.
E’ assai difficile stabilire esattamente come e quando questa pratica divenne
una celebrazione esterna.
Secondo Raimondo (che ha tratto notizie dal canonico Carlo Celano vissuto nel ‘600) la festa dei Quattro Altari (ci riferiamo a quella “esterna” alla
chiesa) inizia a Napoli sotto il viceregno di Don Antonio Alvarez di Toledo nel
periodo che va dal 1622 al 1629. La festa si svolgeva al Largo di Castello (oggi
piazza Municipio) e i quattro altari erano serviti da quattro ordini religiosi (i
domenicani, i teatini, i carmelitani e i padri dell’oratorio, che era una congregazione più che un ordine) distribuiti in altrettanti posti differenti della piazza.
Celano, in un suo volume del 1693, dice che “nella piazza di Castello …
nel giovedì che chiude l’ottava del Corpus Domini fanno una solennissima
processione per le strade intorno alla chiesa, che veramente è degna d’esser
veduta, perché in ogni capo strada vi si fa, con bizzarro e nobile teatro, un
altare ricco di tesori di argenti, e questi sono al numero di quattro; si può dire
che questa sia una delle belle feste che si faccia nella nostra città”.
La festa è decritta anche da Stendhal (che come si sa era stato più volte
in Italia) nel suo romanzo “Il rosso e il nero” uscito nel 1830, dove però essa
viene “trasferita” nel paesino francese di Verrierès, luogo di ambientazione della sua opera. E’ assai difficile dire se Stendhal avesse visto la festa a Napoli,
dove sicuramente è stato, o a Torre del Greco (tesi avallata da Raimondo ma
33
difficilmente dimostrabile) dove probabilmente non è mai stato. E’ invece sicuramente a Napoli che vede la festa lo studioso tedesco Carlo Augusto Mayer
(il quale ci dà peraltro la conferma che negli anni 30 dell’800 veniva ancora
eretto il catafalco in piazza del Pennino) e che, nel 1840, distingue la festa del
Corpus Domini da quella dei Quattro Altari (“otto giorni dopo vi è la festa dei
quattro altari, dove ha pure luogo una grande processione … si vedono allora
quattro grandi altari eretti per strada e ornati con tappeti preziosi, vasi e altre
pompe”).
Ora c’è da chiedersi: quando la festa dei quattro altari si è trasferita anche a
Torre del Greco? La festa, a Torre del Greco, è da sempre legata ad un preciso
avvenimento storico avvenuto nel 1699 ovvero il “riscatto baronale” che aveva
visto come protagonista la cittadina vesuviana e aveva portato alla proclamazione di “barone” del torrese Giovanni Langella, soprannominato “Giuvanne
delli pigni”.
Secondo Raimondo è proprio in seguito a quest’episodio che la cittadina
di Torre del Greco prese a festeggiare la festa dei quattro altari abbinandola
alla commemorazione del “riscatto baronale”. Una prova, secondo lui, è data
dal fatto che Celano nella sua opera del 1692 pur parlando di Torre del Greco
per altre cose e della festa dei quattro altari di Napoli, non fa alcun cenno sul
fatto che essa si svolgesse pure nella cittadina vesuviana. Fatto sta che da
quel momento la festa si svolge a Torre mescolando proprio i due aspetti, quello religioso legato alla processione “dell’ottava” e quello civile legato al “riscatto
baronale”, elemento fortemente identitario del popolo torrese. 34
Un’altra cosa certa è che fin dal ‘700 si svolgevano a Torre del Greco due
processioni: una nel giorno del Corpus Domini che si effettuava nella parte alta
della città, l’altra nel giorno “dell’ottava”, che era poi la festa dei quattro altari,
nella parte bassa, sul “mare seccato” (abbascio ‘o mare), dove si realizza ancora oggi.
Momento fondamentale della festa era, ed è, la preparazione degli altari, che
in passato iniziava la Domenica delle Palme accompagnata dalla musica e dai
fuochi d’artificio, e che erano, come da tradizione, in numero di quattro, disposti nei quattro posti della città dove poi avvenivano le benedizioni: Largo del
Carmine (oggi piazza Luigi Palomba), Largo S. Giuseppe, Marina della città
e Piazza S. Croce. Tali notizie confermano, a nostro avviso, che l’indicazione
di “festa dei quattro altari” derivi (così come per le “quarant’ore”) dalla pratica
di benedire da quattro “altari” diversi, anche se qualcuno ha avanzato l’ipotesi
che il “quattro” sia da riferirsi anche alle quattro arti: pittura, scultura, musica
e architettura. In seguito gli altari sono diventati delle gigantesche rappresentazioni a carattere tematico sacro e biblico (così come per i “misteri” celebrati
ed eseguiti sull’antico Catafalco della Sellaria) e sono diventate molte più di
quattro: in pratica quasi ogni strada ha un proprio altare.
La festa ha acquisito il suo carattere fortemente “artistico” soprattutto a partire
dalla fine dell’800 grazie all’opera di Enrico Taverna (originario di Torino) che
istituì a Torre una vera e propria Scuola d’Incisione sul Corallo e di Arti decorative e figurative, che da allora iniziò a sfornare una lunga serie di veri e propri
“artisti” del campo. Oltre agli altari, così come a Napoli, anche a Torre protago35
nisti erano i tappeti, che qui venivano realizzati con segatura e colori in polvere
distribuiti su carta incollata per terra, con cornici di fiori e rami di rosmarino.
A partire dal secondo dopoguerra, la festa conobbe una sorta di “rilancio”
soprattutto grazie alla partecipazione “attiva” del già citato studioso locale Raffaele Raimondo che cominciò a sperimentare l’uso di luci sincronizzate con la
musica su colossali pannelli, avvalendosi dell’apporto di un “mago” delle luci
qual’era l’elettricista Nicola del Gatto (la cui firma “distintiva” era un gatto nero
apposto sulle proprie luminarie).
Oggi la festa dura solitamente tre giorni ed è caratterizzata oltre che dagli
innumerevoli altari (altro che quattro!), da spettacoli di cabaret, musica leggera, tammurriate e quant’altro, per poi concludersi con i tradizionali “fuochi a
mare”.
Tutti questi elementi rendono la festa molto suggestiva all’occhio del visitatore esterno anche se in qualche modo, per alcuni osservatori, sembrano
avere un po’ stemperato quell’afflato religioso e insieme civile, in senso fortemente identitario, che animava in origine questa celebrazione del popolo
torrese.
36
Festa delle lucerne (Somma Vesuviana)
di Raffele Di Mauro
La festa delle lucerne, che si svolge a Somma Vesuviana ogni quattro anni
solitamente dal 3 al 5 Agosto, è senza dubbio una delle più singolari di tutto
il panorama rituale campano e forse meridionale. Probabilmente la festa ha
preso avvio verso il 1600 dopo che, nel 1595, la chiesa intorno alla quale si
sviluppa il Casamale (borgo medievale che si estende sul Monte Somma a circa 200 metri di altezza) fu insignita del titolo di Collegiata e dedicata a S. Maria
Maggiore o “della Neve”. Prima, quando era solo un convento, era titolata a S.
Giacomo e dopo, con la costruzione della chiesa, a S. Maria della Sanità.
La festa delle lucerne è quindi legata indissolubilmente al culto della Madonna della neve la cui celebrazione ricade proprio il 5 Agosto, giorno conclusivo della festa. Il culto della Madonna della Neve ha origine a Roma quando,
in seguito a una “miracolosa” nevicata secondo gli studiosi avvenuta il 5 Agosto del 352 d.c. sotto il pontificato di Papa Liberio, fu fatto costruire sul colle
Esquilino, dove si era verificato l’evento, un santuario che da allora fu indirizzato alla venerazione di “S.Maria della Neve”. Tale culto è presente e assai
diffuso non solo in Campania (ad esempio a Torre Annunziata dove, secondo
la tradizione, nel XIV sec. alcuni pescatori ritrovarono in mare una cassa contenente l’immagine della Madonna, poi siccome il ritrovamento era avvenuto il
5 Agosto, la chiesa dove fu trasportata l’immagine fu dedicata a “Santa Maria
ad Nives”) ma anche in Calabria (nel cosentino, a Bocchigliero) oppure nel
39
Lazio (a Frosinone) o in Piemonte (a Novi Ligure, in provincia di Alessandria).
La collocazione temporale della festa delle lucerne, secondo Roberto De Simone, la fa collegare inequivocabilmente a particolari riti agricoli celebranti la
fine del ciclo estivo e alla “morte dell’estate”. Non a caso nella tradizione contadina, per la quale spesso l’anno non ha 4 stagioni ma è bipartito solamente
in vierno (inverno) e staggione (estate), si dice che “Austo è capa ‘e vierno”
ovvero “Agosto è principio d’inverno”.
La rappresentazione della festa, come detto, dura tre giorni (talvolta solo
due o addirittura quattro) e culmina sempre il 5 Agosto, giorno della celebrazione della Madonna della Neve,
nella processione finale. La preparazione della festa però inizia qualche giorno
prima, verso la fine di Luglio, ovvero la settimana precedente, quando vecchi e
bambini (guidati da un mast ‘e festa scelto tra i più anziani) popolano le strade
del Casamale dando ciascuno il proprio contributo all’allestimento scenico che
diventerà lo “spazio” della festa.
Diversi ed articolati, come vedremo, sono gli elementi. Nei vicoli del Casamale viene innanzitutto preparato un complesso apparato (definito ‘e cupole)
costituito da cordoni di felci su cui sono avvolte catene formate da anelli di
carta crespa colorata e rami di castagno applicati sui muri per nascondere le
pareti degli edifici. Tale struttura iniziale ospiterà poi i telai che sono assi di
legno che formano il perimetro di diverse figure geometriche, rombi quadrati
o triangoli, sospese da pali laterali e disposte in numero variabile a seconda
della lunghezza del vicolo.
40
Su questi telai saranno sistemate le lucerne e innanzi ad essi verrà rappresentata la “scena del banchetto” con due pupazzi (‘o viecchio e ‘a vecchia)
seduti intorno a un tavolo. A concludere, in fondo alla serie di telai, è collocato
uno specchio che serve ad accentuare l’impressione di profondità e ad accrescere l’effetto visivo.
Le protagoniste della festa sono però senza dubbio le lucerne (dette lucernelle) consistenti in piccole coppe di terracotta tonda, con un unico beccuccio
ricavato dal bordo piegato (‘ o lucign’). Esse sono praticamente dei lumi ad
olio (esclusivamente olio vergine d’oliva ci tengono a precisare gli anziani) che
vengono accesi in modo da illuminare tutto l’arredo prima allestito e creando
quell’impatto visivo che è la sigla originale di questa festa unica nel suo genere. Da non dimenticare altri due elementi: le zucche che, liberate dalla polpa e
dei semi (usati poi per fare ‘e semmente ‘nfurnate), vengono intagliate in modo
da formare occhi, naso e bocca (venendo così chiamate ‘e cape ‘e muorte) e
le quali si illuminano grazie a delle fiammelle poste al loro interno; e le fontane
create per l’occasione con cannule e tubi.
Diversi e complessi sono i segni rituali individuabili in quest’articolata rappresentazione scenica. Molti elementi rimandano alla celebrazione della “morte
dell’estate” o comunque alla fine di un ciclo estivo così come indicatoci da De
Simone: le lucerne notturne, le zucche che raffigurano una testa di morto, i due
banchettanti (chiara simbologia legata alla morte) ecc. Ma gli stessi elementi
possono essere letti anche in funzione rigenerante: “’o vecchio” e “’a vecchia”
sono anche un uomo e una donna capaci di procreare, la zucca e la lucerna
41
simboleggiano anche chiaramente i due organi riproduttivi sessuali: il fallo e
la vagina. Oltre a questi vanno sottolineati anche gli altri elementi “rituali” presenti nella festa ad esempio le figure geometriche rappresentate, lo specchio,
l’acqua delle fontane.
In questa zona l’acqua è anche un mezzo di protezione dai pericoli dell’eruzione del Vesuvio, per cui ci si appella alla “ muntagna fredda” o “fresca”, utilizzando il tipico stereotipo verbale adoperato nei canti a figliola ma anche nelle
voci di venditori).
L’utilizzo poi dell’olio di oliva ha una sua particolare valenza simbolica
perché, non dimentichiamolo, questo spesso veniva adoperato a scopi taumaturgici come medicina popolare.
L’ultimo e importante aspetto da rilevare relativo alla festa delle lucerne è la
completa assenza (quasi un “divieto”), durante la sua celebrazione, di tutto
quel repertorio musicale fatto di tammurriate, fronne, canti a figliola ecc. che invece costituiscono il “sottofondo” sonoro dell’altro grande momento rituale che
coinvolge gli abitanti di Somma Vesuviana ovvero la festa della Madonna di
Castello (dal sabato in Albis al 3 Maggio). Ciò a conferma che i sommesi sono
ben coscienti che l’esecuzione di queste forme musicali rappresenterebbe uno
snaturamento di quello che è il significato profondo della festa delle lucerne. C’è da dire che però la musica non è del tutto assente. C’è un apposito “Canto della Madonna della Neve” eseguito durante la processione che si
svolge il 5 Agosto, che è un canto polivocale religioso, o meglio paraliturgico,
eseguito senza accompagnamento strumentale e costituito da frasi testuali
42
che vengono ripetute due volte (la prima volta con un disegno vocale melismatico in cui prevale più che altro l’aspetto sonoro, la seconda volta invece in uno
stile più sillabico tale da favorire una maggiore copmprensione del testo). Questo canto è tramandato in particolare da Elisabetta Raia, una delle ultime
“depositarie”, che ci ha informato che la sua esecuzione è una tradizione di
famiglia (lo ha appresso dai suoi antenati) e che esso veniva cantato già dagli
inizi di Agosto verso il tramonto facendo ben attenzione a non farsi vedere da
nessuno perché “la voce doveva andare per l’aria”, come se provenisse dal
nulla.
Vi proponiamo il testo del canto così come pubblicato in un volumetto da
Adriana Esposito e Marco Vitagliano Stendardo:
O Maronna io rella neve
O Maronna io rella neve
Puoi iotare alli tuoi fedeli
Puoi iotare alli tuoi fedeli
Tuoi fedeli li puoi iotare
Tuoi fedeli li puoi iotare
O Regina della pietà
O Regina della pietà
Tutti i lumi alluminati
43
Tutti i lumi alluminati
O Regina della pietà
O Regina della pietà
Alli piedi della Madonna
Alli piedi della Madonna
S’è calata ‘na bella stella
S’è calata ‘na bella stella
Al chiarore del sole ardente
Al chiarore del sole ardente
Molta neve la biancheggiò
Molta neve la biancheggiò
44
Festa della Madonna di Castello
(Somma Vesuviana)
di Raffele Di Mauro
Somma Vesuviana è senza dubbio nell’ambito dell’area vesuviana, ma potremmo dire dell’intera regione campana, uno dei centri più importanti dal punto di
vista dei rituali folklorici. Le ragioni sono molteplici (non ultima, la presenza
ancora “attiva” di alcuni vecchi “depositari” della tradizione che si impegnano
a tramandarla e a promuoverla) ma una in particolare: il culto della Madonna
di Castello legata all’omonimo santuario situato sul Monte Somma e costruito
probabilmente verso la fine del ‘400, lì dove anticamente sorgeva un castello
normanno (da qui il nome). A tale Madonna è dedicata la festa (detta anche
Festa della montagna) che si svolge proprio a Somma in un periodo che va
dal sabato in albis (Sabato dei fuochi) al 3 Maggio (tre della croce), che vede
coinvolte numerose paranze locali e che attira i fedeli di tutti i paesi della fascia
pedemontana vesuviana ma non solo.
Molte sono le somiglianze con il culto della Madonna di Montevergine (il santuario situato su un monte, la salita e la discesa spesso cantata e danzata,
l’esecuzione dei caratteristici canti a ffigliola ecc.) ma la differenza fondamentale è che la Madonna di Castello è situata sul Vesuvio e molto probabilmente
il suo culto potrebbe derivare da uno molto più antico legato alla “montagna di
47
fuoco”. Non a caso a Somma nel primo giorno della festa, il Sabato in Albis,
chiamato in modo emblematico Sabato dei Fuochi, vengono accesi intorno al
santuario numerosi falò notturni sui “tuori” (oggi soprattutto fuochi pirotecnici),
che danno come l’impressione della lava che scorre, quasi a volerne “esorcizzare” la paura. E non a caso la festa un tempo si concludeva il 3 Maggio
bruciando una croce di legno (che oggi invece è stata sostituita da una di ferro)
sulla cima della montagna, da qui la denominazione di “tre della croce”.
Secondo la tradizione del posto, riportataci anche da Roberto De Simone, il
culto della Madonna di Castello ha origine dal rinvenimento di una testa bruciata di una statua dopo un’eruzione. Questa testa sarebbe stata ritrovata da
uno scultore di santi che aveva una figlia paralitica, la quale, dopo aver avuto
in sogno l’apparizione della statua, sarebbe “miracolosamente” guarita.
A tal punto il padre, ricordandosi della testa bruciata, avrebbe ricostruito il
corpo della statua con delle sembianze fisiche tipicamente contadine (grassa,
fianchi larghi ecc.) tanto che da allora i fedeli la chiamano anche “Mamma
Pacchiana”, vale a dire Madonna contadina.
Secondo alcuni studi la scultura originale della statua lignea della Madonna sarebbe stata portata a Somma da Carlo Carafa nel 1622 ma sarebbe
andata dispersa dopo la disastrosa eruzione del 1631.
C’è però anche un’altra leggenda legata al santuario ovvero quella di un
tesoro nascosto nei paraggi per ritrovare il quale bisognerebbe uccidere un
bambino neonato a mezzanotte. Secondo De Simone quest’ultima leggenda è
un altro indizio che il culto abbia origini antichissime e sia probabilmente legato
48
a riti con uccisioni di bambini, sostituiti in un secondo momento da agnelli o
altri animali.
Un altro rito particolare legato a tale festa è quello della preparazione della
pertica o “perticella” (perteca) che si pratica soprattutto il 3 Maggio. Consiste
nella preparazione di rami dell’albero di castagno che vengono liberati da tutte
le fronde, facendo in modo da lasciare una piccola sporgenza (’a curnecchia)
vengono poi addobbati con fiori e rami di ginestra, collane fatte di nocciole
(’a ntrita) o castagne (’a nserta), piede e muso di vaccino lesso (’o pere e ‘o
musso) e portano appesa alla sommità l’immagine della Madonna di Castello
(’a fiurella).
La perticella così preparata e dedicata alla Madonna, viene donata alla
propria donna, accompagnandola spesso con l’intonazione di canti a figliola.
Nella pratica della perteca è possibile individuare una simbologia fallica legata
ad antichi culti propiziatori della fecondità della terra.
Numerosi e continui sono i pellegrinaggi dei singoli fedeli che nel periodo descritto (dal sabato in albis al 3 Maggio) si recano al santuario per rendere
onore alla “Mamma Pacchiana” ma i protagonisti della festa sono senza dubbio le diverse paranze (Paranza dello Gnundo, Paranza del Ciglio ecc.) che
in modo particolare nei due giorni festivi (quello iniziale e quello conclusivo)
“salgono” verso il santuario in momenti diversi e fermandosi in posti differenti, preparando e consumando lauti banchetti (legati probabilmente ad antichi
rituali per augurare l’abbondanza e un buon raccolto) con gustose libagioni,
49
accendendo, come già ricordato, falò e, soprattutto, cantando e ballando. E’
proprio quest’ultimo punto di vista, quello musicale-coreutico, ad arricchire in
modo emblematico i festeggiamenti in onore di questa Madonna vesuviana.
Il repertorio eseguito dalle diverse paranze e da alcuni straordinari esecutori
(tra tutti ricordiamo Giovanni Coffarelli e Rosa Nocerino) è costituito principalmente da fronne, canti a figliola e tammurriate, che qui di seguito brevemente
andiamo ad analizzare.
Piccola appendice musicale:
La fronna è un’espressione musicale tipica ed esclusiva della Campania. Si
tratta di una particolare forma di canto eseguita a distesa, senza accompagnamento strumentale, le cui tematiche si riferiscono in genere all’amore, al sesso
e alla morte. Spesso veniva adoperata anche come forma di comunicazione
con i carcerati.
Dal punto di vista strettamente musicale essa è costituita solitamente da
due frasi melodiche (struttura bipartita AB, a volte ripetuta ABA¹B) di cui la prima attacca in genere sul quinto grado e termina con una cadenza intermedia
sul terzo grado, invece la seconda frase attacca di solito sempre sul quinto
grado per terminare però con una cadenza finale sul primo grado (tonus finalis). Il profilo melodico, assai melismatico, è essenzialmente discendente e si
muove su una scala di 5 o 6 suoni (raramente si raggiunge l’ambitus di un’ot-
50
tava) con il caratteristico quarto grado aumentato. Dal punto di vista testuale
tipico è l’uso di vari stereotipi iniziali, tutti metricamente equivalenti (quinari),
che hanno il precipuo scopo di preparare rime o assonanze: “fronna ‘e limone”
(da cui il nome), “’o mare e arena”, “anella anella”, “albero ‘e noce” ecc.
Il canto a figliola è un particolare tipo di canto, anch’esso eseguito senza
accompagnamento strumentale, legato principalmente al culto della Madonna
di Montevergine, detta anche “Madonna nera” oppure “Mamma schiavona”. La
denominazione a figliola, o più precisamente “’a ‘ffigliola” è proprio in riferimento alla Madonna (quella di Montevergine ma anche la Madonna di Castello)
in onore della quale viene intonato questo tipo di canto, il quale, però come
abbiamo già ricordato e come già segnalato da De Simone, è legato anche al
rito della perticella diffuso proprio a Somma.
Dal punto di vista musicale molte sono le somiglianze con le fronne (attacco sul quinto grado, profilo melodico discendente, ambitus di 5-6 suoni con
quarto grado aumentato) ma numerose sono anche le differenze: il canto a
figliola ha generalmente una struttura monostica (una sola frase melodica A,
che può essere ripetuta con variazioni AA¹), invece che bipartita, con cadenze
tutte sul primo grado, ed è generalmente sillabico non melismatico.
Ma la caratteristica fondamentale, che differenzia in modo inequivocabile
il canto a figliola dalla fronna, è la presenza del coro nella cadenza finale:
tale cadenza è intonata (con il solista che dà l’attacco) su vari stereotipi finali,
anche qui tutti metricamente equivalenti (senari), tra i quali ricordiamo “’a ‘ffigliola” (da cui il nome), “’a majesta soia”, “’a Mamma Schiavona”, “aggio ritto
buono” ecc.
51
Sia le fronne che i canti a figliola possono essere eseguiti in forma staccata,
separatamente, ma molto spesso vengono usati come una sorta di introduzione o “preludio” alla tammurriata. La tammurriata vesuviana, che si esegue
anche a Somma per la Madonna di Castello, è per certi versi lo stile areale
di canto sul tamburo in Campania più diffuso e anche più “famoso” tanto da
rappresentare una sorta di “modello base” da cui gli altri stili relativi ad aree
diverse si differenziano (maggiormente quelli dell’area amalfitana e dell’area
giuglianese che hanno caratteristiche proprie assai marcate, in modo minore
quello dell’area nocerino-sarnese che invece presenta molte affinità con lo
stile vesuviano, forse dovute anche alla maggiore vicinanza geografica).
Dal punto di vista musicale la tammurriata dell’area vesuviana presenta tutti
gli elementi tipici del canto sul tamburo in Campania, molti dei quali comuni
anche alle altre aree, vale a dire: ritmo binario con un ciclo di 4 battute o pulsazioni, profilo melodico discendente con un attacco sul quinto grado, ambitus
melodico pentatonico con quarto grado aumentato, chiusura sulla tonica prolungata sulla cosiddetta “vutata” o “rotella”, struttura strofica con alternanza di
endecasillabi e settenari o ottonari, uso di interpolazioni testuali (le cosiddette
“barzellette” o “stroppole”) costituite da ottonari autonomi (spesso con chiare
allusioni sessuali), uso di particolari stilemi fonici come la trasformazione in
“a” di tutte le vocali nelle cadenze (quest’ultima caratteristica è assai diffusa,
oltre che nella tammurriata campana, in diversi repertori tradizionali soprattutto
dell’area meridionale).
La tammurriata vesuviana ha una velocità ritmica “media” rispetto a quelle
52
delle altre aree (molto più lenta è infatti la tammuriata amalfitana per la Madonna Avvocata di Maiori, più veloce e serrata è invece la tammurriata giuglianese
per la Madonna dell’Arco o di Briano) e l’attacco del canto è quasi sempre “sfasato” rispetto all’inizio del ciclo ritmico (attacco in levare) rispetto ad esempio
alla tammurriata amalfitana in cui attacco melodico e ciclo ritmico coincidono
(attacco in battere).
Dal punto di vista dei temi testuali diversi sono i riferimenti: magico-simbolici, religiosi, storici ecc. Il testo più celebre, assai diffuso nell’area vesuviana e
cantato anche in onore della Madonna di Castello, è quello che ha inizio con i
due endecasillabi forse più noti di tutta la tammurriata campana: “Bella figliola
ca te chiamme Rosa, che bellu nomme mammeta t’a mise”.
53
Festa di San Michele Arcangelo (Ottaviano)
di Raffele Di Mauro
San Michele Arcangelo è il santo patrono della cittadina di Ottaviano ed è a
lui che è dedicata la festa che qui si tiene ai primi di Maggio, nei giorni intorno
all’8, data centrale della celebrazione.
San Michele insieme a Gabriele e Raffaele è uno dei tre arcangeli menzionati dalla Bibbia ed è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le orde
di Satana.
Il culto di San Michele ha probabilmente origini orientali, infatti l’imperatore Costantino I nel IV sec. d.c. aveva fatto costruire a Costantinopoli un imponente santuario in suo onore, il Micheleion. Ma fu dal secolo successivo che
il culto si diffuse in tutta l’Europa in seguito all’apparizione dell’arcangelo sul
Gargano in Puglia. La tradizione vuole che nel 490 un ricco signore pugliese,
di nome Elvio Emanuele, aveva smarrito un toro della sua mandria il quale si
era andato a nascondere in una grotta del Gargano.
Dato che il toro non voleva in alcun modo lasciare la caverna il signorotto
aveva deciso di ucciderlo lanciando una freccia, la quale però stranamente
aveva invertito la direzione colpendo e ferendo lui stesso. In seguito questo
signore aveva narrato l’episodio a San Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto,
al quale si dice che l’8 Maggio di quello stesso anno apparve per la prima volta
San Michele Arcangelo, che gli avrebbe ordinato di destinare quella grotta
al culto cristiano. Il vescovo non aveva però esaudito la richiesta del santo,
55
cosa che fece invece quando San Michele gli apparve una seconda volta due
anni dopo (nel 492), predicendogli la vittoria contro il re barbaro Odoacre che
teneva sotto assedio Siponto. Si narra che sui barbari si abbattè una furiosa
tempesta di sabbia e grandine che li indusse a ritirarsi. Quest’episodio spinse
il vescovo a recarsi in preghiera fuori la grotta, situata nella cittadina di Monte
Sant’Angelo in provincia di Foggia, dove l’anno dopo fu fatto edificare il santuario, tutt’ora esistente, di San Michele Arcangelo, inaugurato il 29 Settembre
del 493.
Ma quando il culto si trasferì anche ad Ottaviano?
Non abbiamo notizie certe ma è verso la fine del XVI sec. che il paese
sceglie San Michele come suo protettore.
I primi documenti storici risalgono invece ai primi anni del XVII sec. Due
sono le leggende diffuse tra la popolazione che legano la città di Ottaviano al
culto di San Michele. La prima narra che in un momento di forte carestia che
affliggeva la popolazione di Ottaviano, gli abitanti si rivolsero in preghiera al
loro santo patrono e in seguito accadde un episodio: un giovane biondo e bello
si presentò ad un commerciante delle Puglie per acquistare da lui una grande
quantità di sacchi di grano, pagando il tutto con un anello di gran valore che
portava al dito.
I sacchi furono mandati ad Ottaviano e quando gli abitanti presero ad
indagare sull’identità del loro sconosciuto benefattore non tardarono molto a
capire che questi sicuramente era San Michele. Ciò era confermato dal fatto
che uno di quelli che aveva accompagnato il carico di grano, entrando in chie56
sa e guardando la statua di San Michele, disse che essa somigliava al giovane
biondo che aveva comprato i sacchi pagando con l’anello che, non a caso non
era più al dito della statua. L’altra leggenda narra, invece che nel 1779, quando
i francesi cercavano di occupare Ottaviano, essi erano stati scacciati da una
schiera di angeli, sotto forma di moscerini, guidati proprio da San Michele.
Sebbene la ricorrenza liturgica del Santo ricorra il 29 Settembre (quando comunque il santo viene commemorato con una celebrazione nella Chiesa Madre di Ottaviano e con il cosiddetto “incendio del campanile”, simulato con fuochi d’artificio), la festa patronale come abbiamo detto si svolge principalmente
l’8 Maggio (data della prima apparizione del santo sul Gargano) iniziando però
qualche giorno prima (di solito il 6) e concludendosi due giorni dopo, cioè il 10.
L’8 Maggio, momento centrale della festa, ha inizio all’alba con la cosiddetta
“diana”, ovvero una lunga serie di fuochi pirotecnici “a terra” che partendo
da ogni quartiere portano alla Chiesa di San Michele, mentre la popolazione
(grandi e piccoli) segue correndo il percorso di “esplosioni”.
Questa pratica è diffusa anche in altri paesi della Campania per le diverse
feste patronali. Il sottoscritto ha assistito qualche anno fa personalmente ad
una “diana” effettuata nel paese di Sant’Antimo in Napoli, in occasione della
festa dedicata all’omonimo santo, che causò addirittura alcuni feriti tra i partecipanti, colpiti involontariamente dai fuochi. Dopo la “diana”, ad Ottaviano, l’8
Maggio si tiene la Santa Messa seguita da una processione accompagnata da
bande musicali. Ma il momento culminante della giornata è il tradizionale “volo
degli angeli” che viene effettuato in Piazza Annunziata e che secondo alcuni
57
ha avuto inizio in questa cittadina nel 1861.
Questo genere di rappresentazione è molto diffusa in Campania, soprattutto nel periodo pasquale, ed è svolta in relazione alle feste dedicate alla
Madonna (ricordiamo ad esempio il “volo dell’angelo” che si tiene a Giugliano
in onore della Madonna della Pace nella domenica successiva alla pentecoste), ai Santi Patroni (è il caso della festa patronale della già citata Sant’Antimo
dove oltre alla “diana” si effettua anche il “volo”) e nella rappresentazione della
lotta contro il “Grande Antagonista” (cioè Satana).
E’ quest’ultimo proprio il caso di San Michele che, oltre ad essere il santo
patrono di Ottaviano, come sappiamo, rappresenta da sempre uno dei principali “avversari” del demonio ed è raffigurato, nell’iconografia cristiana, alato, in
armatura con la spada o lancia con cui sconfigge Satana (che assume spesso
le sembianze di un drago). Quest’aspetto è confermato dal fatto che proprio
ad Ottaviano fino agli anni ‘50 del secolo scorso si teneva, a conclusione della
festa patronale, una rappresentazione sacra (chiamata “’A cascata”, cioè la
caduta) per ricordare proprio la vittoria di San Michele Arcangelo su Lucifero.
Il “volo degli angeli” viene effettuato da un bambino e una bambina vestiti
da angeli, con ali ed elmi, che vengono sospesi in alto su delle funi mosse attraverso un congegno di carrucole (chiamato “’o carruocciolo”) e i quali
muovendosi sopra la testa del pubblico devoto intonano un antichissimo inno
all’Arcangelo accompagnati dalla banda musicale.
La tradizione vuole che ad Ottaviano i due bambini scelti appartengano
sempre alla famiglia dei Duraccio, conosciuta nella città con il soprannome di
58
“maccaronari”.
Il “volo” viene addirittura ripetuto quattro volte: prima in Piazza Annunziata
come detto, poi in Piazza Piediterra, quindi Piazza Taverna ed infine Piazza S.
Giovanni.
La rappresentazione popolare del “volo degli angeli” simboleggia secondo
Roberto De Simone “la discesa al regno sotterraneo compiuta da un ragazzo
o da una ragazza simbolo dell’eroe puro (Orfeo, Enea, Cristo) il quale visita
gl’inferi per poi tornare alla luce … l’azione stessa è legata ad un filo magico
connesso ad un pericolo di precipitare verso l’immagine e non più risalire: filo
che è sostenuto emotivamente dalla comunità tesa a recuperare il senso della
vita attraverso un viaggio misterico di carattere collettivo”.
Altro momento importante della festa (che ricordiamo attualmente dura quattro
giorni ed è accompagnata da concerti
di musica classica, bandistici e di musica leggera) è la giornata
conclusiva del 10 Maggio quando nel pomeriggio, in piazza San Lorenzo, si
svolge il “Palio degli asini”.
Fino ad alcuni decenni fa fra il 7 e l’8 Maggio si svolgeva in piazza Mercato una fiera di bestiame a cui accorrevano i cosidetti “vatecari” (carrettieri)
provenienti da tutti i paesi vesuviani. La fiera si concludeva con la corsa degli
asinelli, da cui il nome di “Palio degli asini”. Questa tradizione, secondo alcune
testimonianze, è assai antica ed è stata riportata in vita nel 1997 grazie all’attività del Circolo “A. Diaz” di Ottaviano.
Da quell’anno il 10 Maggio tutte le contrade del paese partecipano al “pa59
lio” ciascuno con un proprio asinello cavalcato da un fantino che porta i colori
della contrada di appartenenza; ovviamente chi arriva per primo vince il “Palio”, così come accade per il più noto “Palio di Siena”. Nella tarda serata, sotto
il Monte Somma, viene organizzato uno spettacolo conclusivo di fuochi pirotecnici a cui partecipano quattro “fuochisti” che gareggiano al suon di bombe e
esplosioni colorate. Ancora una volta è proprio l’elemento “fuoco” a concludere simbolicamente la festa patronale di una cittadina che nasce proprio ai piedi
del vulcano Vesuvio, per fortuna momentaneamente “dormiente”.
60