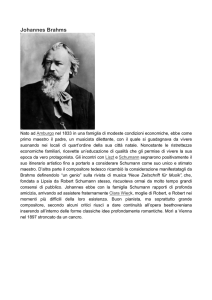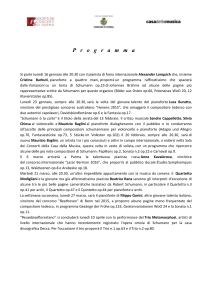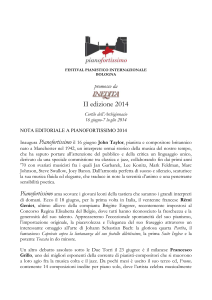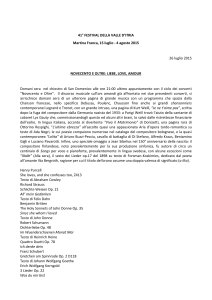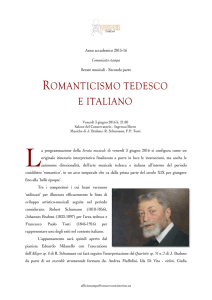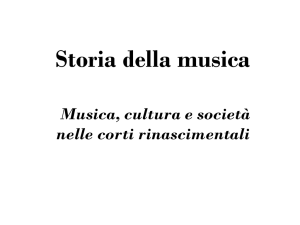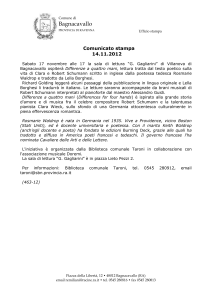ROBERT SCHUMANN
CARNAVAL op.9
Il Carnaval di Robert Schumann è sicuramente uno dei cicli pianistici a piano a solo più interessanti della
produzione del Romanticismo tedesco.
I venti brani che compongono il ciclo sono stati scritti dal compositore tra il 1834 e il 1835, essi sono
“frammenti di vita” del compositore uniti all'estro compositivo e quindi all'arte musicale stessa.
Schumann struttura il ciclo pianistico nel seguente ordine:
– Preambolo, tema con variazioni
– Pierrot
– Arlecchino
– Valzer Nobile
– Eusebio
– Florestano
– Coquette
– Replica
– Farfalle
– A.S.C.H.-S.C.H, Lettere Danzanti
– Chiarina
– Chopin
– Stella
– Riconoscimento
– Pantalone e Colombina
– Valzer tedesco, Intermezzo: Paganini
– Confessione
– Passeggiata
– Pausa
– La “Marcia dei Fratelli di Davide”
GLI ASPETTI SONORI E COMPOSITIVI DI CARNAVAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
scrittura accordale
sonorità prevalentemente omoritmica dove viene enfatizzato l'effetto ricorsivo e
percussivo della musica, ma anche con alcuni aspetti contrappuntistici
passaggi repentini dal maggiore al minore
l'uso di improvvisi “vuoti sonori” con finalità espressiva
scrittura dal forte e incisivo fraseggio melodico con una precisa e ben distinta divisione dei “ruoli” delle
due mani : alla mano destra è affidata la linea melodica, alla mano sinistra è affidato l'accompagnamento
(uso della struttura della forma del Lied)
virtuosismi incentrati sul “tocco pianistico”
effetti di trasposizione: imitazione della tecnica e della poetica musicale di altri compositori
contemporanei a Schumann (dimensione di onirismo virtuosistico)
forte scrittura verticale con giochi di intreccio delle voci attraverso richiami e trasposizioni tra la mano
destra e la mano sinistra
Schumann aveva ardentemente sognato di diventare un grande virtuoso del pianoforte, uno strumentista
prima che un compositore e perciò all'inizio della sua produzione e carriera artistica, si era impegnato in una
sostanziosa e copiosa produzione di composizioni per pianoforte a solo.
Papillons è stato il primo ciclo pianistico scritto da Schumann nel 1832 come una serie di danze e romanze
per pianoforte pubblicate separatamente come pezzi singoli e poi raccolti e rivisti come un ciclo pianistico, a
questo primo lavoro erano seguite le Davidsbündlertänze ovvero le “Marce dei Fratelli di Davide” tema
che ritroviamo anche nell'ultimo titolo dell'album di Carnaval che chiude il nuovo ciclo pianistico.
Schumann insomma nell'arco di tempo che corre dal 1830 al 1835, scrive ben tre cicli pianistici, forma
inedita, nata sulla falsa riga dei cicli di valzer di Schubert, ma riorganizzati in una forma e soprattutto in un
contenuto poetico musicale del tutto nuovo.
Durante gli anni trenta dell'Ottocento Robert Schumann si era posto il problema di come la forma della
sonata per pianoforte si sarebbe dovuta evolvere dopo Beethoven e dopo Schubert.
“Oggi giorno non è così semplice saper scrivere una sonata per pianoforte, ma non per la difficoltà di
scrivere musica, quanto per saper cosa sia giusto scrivere ...”
Il giovane Robert Schumann sentiva che la stagione di Beethoven e Schubert aveva creato capolavori
pianistici enormi, una letteratura per questo strumento mai vista prima di allora; non solo, Schumann sentiva
che quel tipo di forma compositiva era intrinsecamente legata a un ben preciso momento storico che era
giunto alla fine.
Ma come proseguire quindi se la forma sonata non riusciva più ad esprimere le “forme” dell'epoca storica in
cui Schumann si sentiva immerso ?
“Forme musicali dell'epoca storica in cui si vive” ...
Schumann è stato uno dei primi compositori dell'epoca moderna a capire che l'arte e la musica sono
espressioni non solo di un' universalità dell'Arte in quanto tale, ma che esse sono il frutto dell'epoca storica
che le ha generate.
In poche parole la storia genera continuamente forme che sono l'espressione del proprio tempo storico.
Schumann aveva avuto l'intuizione che la modernità in cui lui era immerso aveva necessità di una nuova
forma che svolgesse il ruolo che aveva svolto la sonata nell'epoca di Beethoven (una generazione prima).
I cicli di danze, i cicli di romanze e i cicli di notturni che il compositore di inizio Ottocento affronta sono le
risposte, le forme che egli dà per parlare di sé della propria arte e del mondo che lo circonda.
Il Carnaval di Robert Schumann stilisticamente è interamente costruito da scene, tableaux su “quattro note” o
meglio, l'intero ciclo compositivo poggia su un materiale musicale “a priori” che fa da base comune e da
scheletro di tutta l'opera. Le tre “sfingi musicali” (successioni accordali di base) sono:
– mi b, do, si, la (sfinge n°1)
– la b, do, si (sfinge n°2)
– la, mi b, do, si (sfinge n°3)
Alla base della composizione quindi si ha il criptaggio di lettere (a, s,ch) che hanno in realtà un preciso
valore semantico; esse vanno a costituire le iniziali della boema città natale della fidanzata ufficiale di
quegl'anni di Robert Schumann: Ernestine Von Fricken nata a Asch.
Insomma alla base dell'intero componimento c'è un omaggio di Schumann alla sua compagna.
Questo è fortemente presente nel ciclo anche nel decimo brano soprannominato “Lettere danzanti” dove le
iniziali del titolo svelano il sottile gioco compositivo che sta alla base dell'intero componimento.
In Schumann arte e vita corrono su continui intrecci, scambi e rimandi.
Nel Carnaval spazio considerevole è dato alla “sfilata delle maschere” : ci sono forti riferimenti alle
maschere e ai “tipi” della commedia dell'Arte quali Pantalone, Colombina, Coquette, Pierrot e Arlecchino.
All'interno della sfilata delle maschere ne compaiono però due inedite: Eusebio e Florestano.
Chi sono?
Florestano ed Eusebio non sono personaggi di Canevale e non appartengono a maschere della tradizione
canevalesca, ma essi sono le proiezioni interiori dei due principali e opposti stati d'animo che caratterizzano
il compositore Robert Schumann, ovvero la mitezza (Eusebio) e l'irruenza (Florestano) pseudonimi con i
quali il compositore amava spesso firmarsi negli articoli musicali sulla sua rivista.
Schumann quindi simbolicamente, in questo ciclo pianistico offre al lettore attraverso due brani musicali,
una chiave di lettura, una porta d'accesso all'interiorità stessa dell'autore.
Ma Schumann in questo ciclo si spinge ben oltre; oltre al piano della sfilata mascherata e al piano interiore
dell'io del musicista, c'è anche un omaggio a figure concrete e reali, ad amici e colleghi suoi contemporanei.
In Chiarina, Chopin, e Paganini Schumann dipinge attraverso il pianoforte tre “omaggi” musicali: il primo a
Clara figlia del maestro di pianoforte di Robert Schumann e sua futura moglie, il secondo a Chopin
attraverso una “falsa citazione” che imita lo stile e la dialettica musicale di Chopin. Qui Schumann porge un
omaggio al suo coetaneo e amico polacco, creando un brano caratterizzato da un forte uso del pedale e da un
forte lirismo intimistico (tratti salienti della poetica chopeniana) infine a Paganini talentuosissimo violinista e
compositore italiano.
Alla luce di quanto detto si può definire Schumann un narratore musicale, poiché filtra la sua vita i suoi
amori e i suoi amici trasformandoli in materiale (e materia fisica) della sua musica. Egli stesso diventa una
maschera, una maschera nuda composta da vari parti, perso nel tumulto di una festa in maschera dove si “È”
e allo stesso tempo non si “È”.
Il ciclo pianistico si conclude sul brano della “marcia dei fratelli di Davide”
... Perché?
Schumann parte dal mito biblico di Davide contro Golia e i Filistei: Davide, piccolo ragazzino che sconfigge
la brutalià di Golia, enorme ma stupido guerriero.
Nel gergo giovanile e universitario dell'epoca, Golia e i Filistei erano i benpensanti, i “residenti”che
consideravano “i giovani” come degli scavezzacollo indisciplinati, inetti alla vita e talvolta come potenziali
“pericoli pubblici” in una parola dei barbari.
Il brano conclusivo del ciclo del “Carnaval” è dunque un omaggio alla gioventù studentesca, scapigliata e
irrequieta che non sopporta il perbenismo benpensante dei “vecchi” che avevano imposto, dopo la fiammata
della Rivoluzione francese e del bonapartismo, il “ritorno all'ordine”, la Restaurazione e il ritorno “dei
codini”.
Attorno agli anni trenta dell'Ottocento si assiste alla prima contestazione studentesca della storia. I giovani e
le nuove generazioni si sentono estranei alla mentalità dei vecchi, a una società che li imprigiona e li
costringe a sottostare a riti, protocolli, stili di vita che non li rappresentano.
Schumann nel suo rapporto osmotico arte-vita, dentro la sfilata giocosa di Carnaval, propone nell'ultimo
brano una riflessione amara sullo stato di salute della società di inizio Ottocento, sottolineando con lo stile
eroico del brano, una volontà di reazione creativa e di impegno civile.
Filippo Zattini