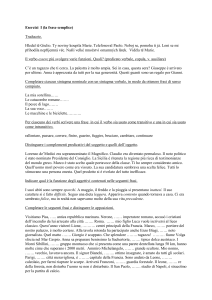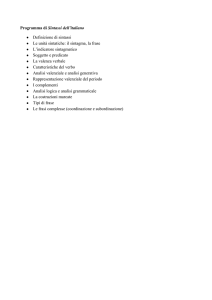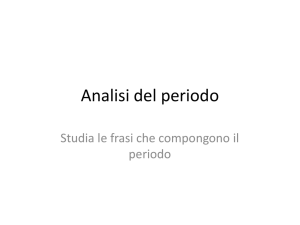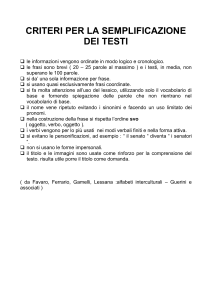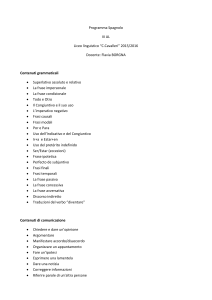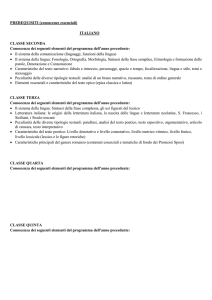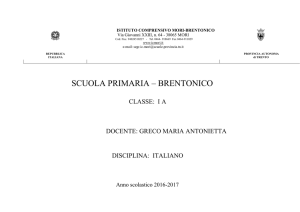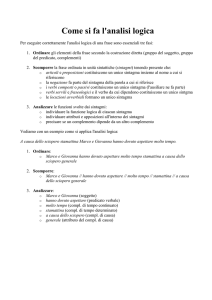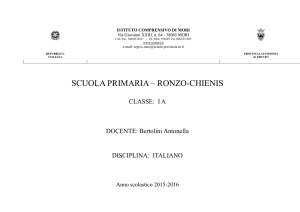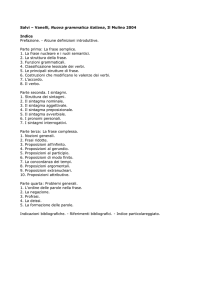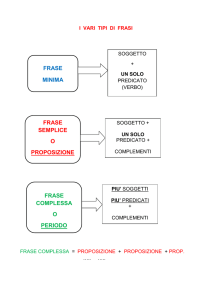SINTASSI
elementi introduttivi
Dott.ssa Beatrice Morandina - Università degli studi di Macerata
LINGUISTICA
La linguistica è costituita da più discipline che hanno oggetti
di studio diversi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
FONETICA
FONOLOGIA
MORFOLOGIA
SINTASSI
SEMANTICA
PRAGMATICA
frase)
(che studia i foni)
(che studia i fonemi)
(che studia la struttura della parola)
(che studia la struttura della frase)
(che studia il significato)
(che studia la prosodia e le implicature della
SINTASSI = COMBINAZIONI DI
PAROLE
Sintassi = si occupa di combinazioni di parole che possono essere di
due tipi:
1) combinazione di parole più piccole di una frase = sintagmi
2) combinazioni di parole che comprendono più frasi = discorsi o
testi; dove la frase è insieme di più sintagmi.
PAROLA = concetto molto discusso che assume valori differenti
(parola fonologica, morfologica, sintattica, semantica).
PAROLA SINTATTICA = coincide con quella morfologica ma da un
punto di vista diverso: la morfologia per la quale la parola è il
costituente massimo, si occupa della struttura interna della
parola; mentre la sintassi, per la quale la parola è il costituente
minimo, indaga le relazioni tra varie parole determinando la loro
appartenenza a classi diverse.
Caratteristiche linguaggio
umano
La sintassi si basa su alcuni presupposti:
RICORSIVITA’ = essendo la lingua un sistema aperto dove si
possono creare sempre parole nuove e frasi nuove, si
possono costruire frasi sempre nuove di lunghezza
indefinita, inserendo in una data frase un’altra frase e così
via. (da frasi semplici a frasi complesse)
OCCORRENZA = partendo dal fatto che si devono delimitare
le parti del discorso e non le singole parole, si stabilisce
quali sono le parole che possono ricorrere o no assieme
ad altre e quali sono le posizioni di tali occorrenze.
CRITERIO DISTRIBUZIONALE = le parole si distribuiscono
all’interno della frase secondo la classe a cui
appartengono.
CI SONO VARI TIPI DI SINTAGMI CIOE’ DI RAGGRUPPAMENTI DI PAROLE:
SN = SINTAGMA NOMINALE ulteriormente scomponibile in compl. + N
SV = SINTAGMA VERBALE ulteriormente scomponibile in V (+ compl.(+ SN))
SA = SINTAGMA AGGETTIVALE ulteriormente scomponibile in A + compl.
SP = SINTAGMA PREPOSIZIONALE ulteriormente scomponibile in P + Compl.
Compl. = si intende genericamente l’intero argomento della testa
che può essere ad es, det., sn, ecc.
SINTAGMI = si riescono a delimitare i sintagmi grazie ad alcuni criteri
principali:
Movimento = parole che fanno parte dello stesso gruppo si spostano
insieme
Ininseribilità = un costituente non può essere interrotto tramite
l’inserzione di altri costituenti
Enunciabilità in isolamento = le parole che formano un gruppo possono
essere pronunciate anche da sole e non in una frase completa, dato
un contesto opportuno.
Coordinabilita’ = due sequenze di parole possono essere coordinate
solo se appartengono alla stessa categoria (es.: *a mezzanotte E il
poliziotto; Gianni è tornato nella sua città E nel villaggio della sua
infanzia)
.
VALENZA
Ci sono elementi della frase che richiedono assieme ad essi la
presenza di altri elementi. La presenza di tali altri elementi può
essere obbligatoria (ARGOMENTI) oppure facoltativa
(ELEMENTI CIRCOSTANZIALI)
Potremmo dire che gli ARGOMENTI partecipano al processo
mentre i CIRCOSTANZIALI forniscono il contesto.
Bisogna ricordare che, sia nel caso della valenza verbale che
della valenza dei nomi, possiamo avere elementi che
ammettono più costruzioni.
Valenza verbale
A seconda del numero di argomenti che li
accompagnano possiamo avere 4 classi di verbi:
1) avalenti (zerovalenti)= non sono accompagnati da
alcun argomento (es.: piove, nevica,)
2) monovalenti = accompagnati solo da un argomento
(nome o sintagma nominale o frase): (es.: Antonio parla,
bisogna che Antonio parta).
3) bivalenti = accompagnati da due argomenti, (il primo
sempre nome o SN mentre il secondo può essere nome o
sn oppure una frase): (es.: Giovanni teme il giudizio)
4) trivalenti = accompagnati da tre argomenti (due gruppi
nominali e un gruppo preposizionale): (es.: Giovanni dice
qualcosa a Pietro)
Valenza dei nomi
I nomi come i verbi hanno una loro valenza: ci sono nomi
argomentali e nomi non-argomentali (DIPENDE DAI
CONTESTI, LO STESSO NOME PUO’ ESSERE SIA
ARGOMENTALE CHE NON):
NOMI ARGOMENTALI = debbono essere seguiti da un
complemento di specificazione. Anche i nomi
argomentali possono apparire da soli ma il loro argomento
è recuperabile in base al contesto. Realizzano una
funzione semantica definita (ruolo tematico) (es. la
partenza di Gianni = indica l’individuo che parte). NOMI
“ASTRATTI” (la costruzione della basilica)
NOMI NON-ARGOMENTALI = possono ma non debbono
seguiti da un complemento di specificazione.
Normalmente l’argomento che segue indica relazione di
possesso. NOMI “CONCRETI” (quella basilica)
1) mono-argomentali = corrispondono a verbi monovalenti:
es.: la camminata di Gianni (= Gianni cammina)
2) biargomentali = di solito derivati da verbi transitivi: es.: la
spiegazione di Newton della forza di gravità (= Newton ha
spiegato la forza di gravità)
3) trivalenti = come verbi trivalenti: es.: il dono di una collana
a Maria da parte di Antonio. (=Antonio ha donato una
collana a Maria).
TIPI DI FRASI
FRASE SEMPLICE = si intende una frase che in essa non
contiene altre frasi.
FRASE COMPLESSA = si intende una frase che in essa contiene
altre frasi.
FRASI PRINCIPALI O INDIPENDENTI = si intendono frasi che
hanno senso compiuto.
FRASI DIPENDENTI / SUBORDINATE / SECONDARIE = si intendono
frasi che da sole non hanno senso compiuto.
MODALITA’ DELLE FRASI:
1) dichiarative (enunciative)
2) interrogative (distinte in interrogative
si/no e interrogative WH)
3) imperative
4) esclamative
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE FRASI:
POLARITA’ = oppone le frasi positive da quelle negative
DIATESI = oppone le frasi attive da quelle passive
SEGMENTAZIONE = le frasi segmentate sono quelle che
“staccano” un determinato costituente da tutti gli altri:
1) dislocate a sinistra (pronome di ripresa è facoltativo) : es.
questo film, non lo avevo mai visto.
2) tema sospeso (elemento non è mai preceduto
dall’eventuale preposizione che avrebbe nella frase non
segmentata; il pronome di ripresa è obbligatorio): il
presidente, la folla invocava soltanto lui.
3) topicalizzate (non c’è pronome di ripresa): Gianni ho visto
ieri
4) dislocate a destra : lo riferirò ai giudici, quello che ho
sentito.
5) frasi scisse : (frase principale verbo essere + dipendente
introdotto da che): è in piazza che Gianni parlerà stasera.
TIPI DI FRASI DIPENDENTI
FRASI INCASSATE = dipendenti da quella precedente, di
vari livelli: es. Maria ha detto [che Gianni crede]1 [che
Paolo abbia mentito]2
FRASI ARGOMENTALI = (la cui presenza è obbligatoria)
1) soggettive (es.:è possibile che Gianni parta domani)
2) oggettive o completive (es.: Gianni ha detto che partirà
domani)
3) completive nominali (frasi che sono argomento del
nome = es.: il fatto che i soldati si comportino così non ha
meravigliato)
4) interrogative indirette (es.: Gianni non sa chi partirà
domani)
FRASI CIRCOSTANZIALI:
1) temporale (es.: quando è arrivato Antonio, abbiamo potuto
cenare)
2) causale (es.: dato che Antonio è arrivato tardi, abbiamo cenato in
fretta)
3) finale (es.: abbiamo aspettato Antonio per cenare tutti insieme)
4) consecutive (es.: abbiamo mangiato tanto che non abbiamo
finito il dolce)
5) condizionali (es.: se Emma avesse telefonato, avremmo potuto
partire insieme)
6) concessive (es.: benchè io avessi avvertito Antonio, il gruppo era
partito)
7) comparative (es.: abbiamo scritto relazioni più articolate di quanto
fosse richiesto)
FRASI RELATIVE
1) restrittive = indicano una delimitazione (es.: gli studenti, che non si
sono iscritti [solo quelli e non tutti gli studenti], non possono sostenere
l’esame)
2) appositive = aggiungono informazioni (Gianni, che non si è iscritto
[aggiungo un’informazione spiegando il perché], non può sostenere
l’esame)
LA TEORIA DELLA GRAMMATICA GENERATIVOTRASFORMAZIONALE
Rappresenta una delle più importanti e complete teorie
riguardanti lo studio della sintassi ed è stata sviluppata da
NOAM CHOMSKY a partire dagli anni Ottanta.
Bisogna notare che la teoria di Chomsky si è sviluppata
nell’arco di un ventennio attraverso varie fasi dove sono stati
individuati elementi diversi: di conseguenza anche la teoria si
è evoluta in sottoteorie che trattano aspetti e caratteristiche
particolari del linguaggio. Alcune tra le sottoteorie più
importanti che prenderemo in esame sono:
TEORIA DEI PRINCIPI E DEI PARAMETRI
TEORIA DELLA REGGENZA E DEL LEGAMENTO
TEORIA X - BARRA
Alcuni concetti fondamentali della
Grammatica Generativotrasformazionale:
SI FONDA SULL’IDEA DI UNA GRAMMATICA UNIVERSALE INTESA COME TEORIA DELLA
CONOSCENZA E NON DEL COMPORTAMENTO.
SISTEMA DI PRINCIPI, CONDIZIONI E REGOLE CHE SONO ELEMENTI E PROPRIETA’ COMUNI A
TUTTE LE LINGUE UMANE.
TUTTE LE LINGUE HANNO PROPRIETA’ COMUNI MA ALL’INTERNO DI ESSE SI POSSONO
INDIVIDUARE DELLE CARATTERISTICHE CHE VARIANO DA LINGUA A LINGUA:
PRINCIPI = ESISTONO DEI PRINCIPI COMUNI A TUTTE LE LINGUE (FORMANO GRAMMATICA
UNIVERSALE)
PARAMETRI = ESISTONO ANCHE PARAMETRI SPECIFICI DI CIASCUNA LINGUA
(GRAMMATICA PARTICOLARE)
LINGUA = “INSIEME DI SPECIFICAZIONI DI PARAMETRI ALL’INTERNO DI UN SISTEMA
INVARIANTE DI PRINCIPI DELLA GRAMMATICA UNIVERSALE”.
PARLANTE = CONOSCE UN INSIEME PRECISO DI PRINCIPI POTENZIALMENTE APPLICABILI AD
OGNI LINGUA E UN INSIEME DI PARAMETRI CHE POSSONO VARIARE DA UNA LINGUA
ALL’ALTRA ENTRO CERTI LIMITI DEFINITI.
ACQUISIZIONE = APPRENDERE IL MODO IN CUI QUESTI PRINCIPI SI APPLICANO AD UNA
LINGUA PARTICOLARE E IL VALORE APPROPRIATO PER CIASCUN PARAMETRO.
COMPETENZA
=
“IL
SISTEMA
LINGUISTICO
CONCEPITO
COME
RAPPRESENTAZIONE MENTALE DELLA GRAMMATICA, CIOE’ L’INSIEME DI
CONOSCENZE CHE UN PARLANTE IDEALE DI UNA DATA LINGUA POSSIEDE E
CHE E’ SOTTOSTANTE AD OGNI SUA PRODUZIONE LINGUISTICA. CIO’ CHE
PERMETTE AL PARLANTE DI PRODURRE E CAPIRE INFINITE FRASI E DI
RICONOSCERE FRASI GRAMMATICALI DA FRASI AGRAMMATICALI.”
ESECUZIONE = DATI E FRASI PRODOTTE CONCRETAMENTE (TALVOLTA CON
ERRORI, LAPSUS, CATTIVA ORGANIZZAZIONE, “DISTURBI” DELLA SITUAZIONE,
CHE PERO’ NON INTERFERISCONO CON LA COMPETENZA)
GRAMMATICA = DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA E NON DELL’ESECUZIONE.
TEORIA LINGUISTICA = CREAZIONE DI UNA GRAMMATICA FORMALE CHE
INDIVIDUA LA STRUTTURA INTERNA DELLA MENTE UMANA.
PRINCIPIO DELLA DIPENDENZA DELLA STRUTTURA
LA CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO SI BASA SU RELAZIONI STRUTTURALI CHE
ESISTONO ALL’INTERNO DELLA FRASE E NON SULLA SEQUENZA DELLE PAROLE.
LA FRASE HA UNA STRUTTURA SINTAGMATICA: UNA FRASE NON E’ UNA
SEMPLICE SUCCESSIONE LINEARE DI PAROLE MA E’ STRUTTURATA IN SINTAGMI
(RAGGRUPPAMENTI STRUTTURALI DI PAROLE) CORRELATI L’UNO ALL’ALTRO.
L’ANALISI DELLA FRASE VIENE COMPIUTA ATTRAVERSO LA SUDDIVISIONE IN
COSTITUENTI IMMEDIATI CIOE’ L’INDIVIDUAZIONE DEI SINTAGMI E LA LORO
ULTERIORE SUDDIVISIONE IN COSTITUENTI PIU’ PICCOLI.
STRUTTURA PROFONDA = STRUTTURA SOTTOSTANTE/SOGGIACENTE A QUELLA
CHE SI MANIFESTA (STRUTTURA ASTRATTA CHE SOGGIACE AD OGNI FRASE
EFFETTIVAMENTE PRODOTTA)
STRUTTURA SUPERFICIALE = STRUTTURA CHE SI MANIFESTA CONCRETAMENTE (LA
FRASE COSI’ COME APPARE)
Ci sono tre tipi di RAPPRESENTAZIONE della STRUTTURA:
DIAGRAMMA AD ALBERO
PARENTESI ETICHETTATE
REGOLE DI RISCRITTURA
1) Diagramma ad albero:
FRASE:
Il bambino mangia
la mela
SINTAGMA
NOMINALE
SINTAGMA
VERBALE
DETERMINANTE
NOME
VERBO
IL
BAMBINO
MANGIA
SINTAGMA
NOMINALE
DETERMINANTE
NOME
LA
MELA
2) Parentesi etichettate:
F = Il bambino mangia la mela
[F [SN IL BAMBINO] [SVMANGIA [SN LA MELA]]]
3) Regola di riscrittura:
F
SV
SN SV
V SN
Teoria dei principi e dei
parametri
Ogni individuo conosce principi applicati alla lingua e
mediati da variazioni parametriche.
La conoscenza del linguaggio non consiste di regole
come tali ma di principi soggiacenti dai quali derivano le
regole.
Le regole quindi sono il modo per indicare la
combinazione di principi.
Ciascuna lingua è costituita da particolari interazioni tra
principi, parametri e proprietà lessicali.
La grammatica generativa assume l’esistenza, nel
linguaggio, di due componenti fondamentali: un
lessico e un sistema computazionale.
Linguaggio
costituito da:
Lessico
Insieme di classi di parole
ciascuna dotata di proprietà
sintattiche, semantiche,
morfologiche e fonologiche
Sistema
computazionale
Assegna ad ogni espressione
linguistica una descrizione
strutturale
LINGUAGGIO
LESSICO
SISTEMA COMPUTAZIONALE
STRUTTURA PROFONDA
SINTASSI
STRUTTURA SUPERFICIALE
FORMA FONETICA
rappresentazione attraverso
sequenza di suoni
FORMA LOGICA
rappresentazione alcuni aspetti
significato
La struttura profonda rappresenta il punto di congiunzione tra
il lessico e il sistema computazionale: le descrizioni strutturali a
livello di struttura profonda sono collegate alle proprietà del
lessico e vengono poi trasformate in rappresentazioni di
struttura superficiale. Le rappresentazioni della struttura
superficiale vengono convertite da un lato in rappresentazioni
in FORMA FONETICA struttura sintagmatica , dall’altro in
rappresentazioni in FORMA LOGICA componente semantica.
C’è bisogno di un sistema per descrivere i suoni reali cioè di
una rappresentazione fonetica, c’è bisogno di un sistema per
rappresentare il significato, cioè di una rappresentazione
semantica; e c’è bisogno di un sistema per descrivere la
struttura sintattica che li collega, cioè di un livello di
rappresentazione sintattica.
La struttura sintattica collega forma fisica con significato
astratto.
Sintassi quindi attraverso principi e parametri rende conto
della relazione tra forma fonetica e forma logica.
Trasformazione o
movimento
La trasformazione o movimento consiste nel passaggio dalla
struttura profonda soggiacente, livello nel quale tutti gli elementi
della frase stanno nella loro posizione originaria (funzioni
grammaticali corrispondenti alle valenze), alla struttura
superficiale al livello della quale gli elementi sono stati mossi per
assegnare ad esempio ad una frase la modalità interrogativa o
passare da una frase attiva a passiva:
es.: hai mangiato che cosa al ristorante
profonda
che cosa hai mangiatot al ristorante?
superficiale
struttura
struttura
La relazione tra struttura p e struttura s è una relazione di
movimento: il movimento modifica una struttura p per dare una
struttura s. Tuttavia nella struttura superficiale rimangono le
tracce del movimento (indicate qui con t) che pur non avendo
alcun contenuto fonetico mantiene tuttavia tracce nel
contenuto mentale cioè nella forma logica.
PARAMETRO TESTA
Specifica l’ordine di alcuni elementi di una lingua
Permette di esprimere delle generalizzazioni concernenti la
struttura dei sintagmi
TESTA: Elemento essenziale di ogni sintagma.
Es. il SN ha come testa N; il SV ha come testa V; il SP ha come
testa P, il SA ha come testa A.
Parametro testa indica la diversa posizione che la testa
assume rispetto agli altri elementi del sintagma a seconda
della lingua presa in esame: testa iniziale (a sinistra) o testa
finale (a destra). In tutte le lingue le teste si trovano nella
stessa posizione per tutti i sintagmi. (es. l’italiano è una lingua
con parametro testa a sinistra quindi in tutti i tipi di sintagmi
dell’italiano ritroveremo la testa a sinistra rispetto agli altri
elementi contenuti nel sintagma).
Principio di proiezione e
ruolo θ
Principio di proiezione = richiede che la sintassi tenga
conto delle caratteristiche lessicali dei vari elementi.
Ciascuna voce lessicale ha una determinata valenza e
tale valenza ci indica il numero degli argomenti che
devono accompagnarla, ma non ci indica la categoria
sintattica che può variare a seconda della voce lessicale.
Entrata lessicale offre solo delle restrizioni sul tipo di parole
che possono occorrere in un determinato tipo di
costruzione.
Entrata lessicale non offre descrizione della relazione di
significato che sussiste tra voce lessicale e argomenti che
realizzano le sue valenze.
Ruolo tematico o ruolo θ
La relazione di significato tra voce lessicale (nome, verbo, aggettivo, ecc.) e
argomenti è detta ruolo tematico (ruolo semantico) o ruolo θ.
Ruoli tematici:
1)
Agente = autore dell’azione
2)
Paziente = cosa colpita dall’azione
3)
Scopo = punto finale verso cui è rivolta l’azione
4)
Tema = la cosa mossa da un’azione
5)
Esperiente = entità che sperimenta un certo stato d’animo
6)
Beneficiario = entità che trae profitto da un’azione
Uno stesso ruolo tematico può essere realizzato tramite categorie sintattiche differenti
ma ciò non è arbitrario ANZI in alcuni casi AD UN DETERMINATO RUOLO TEMATICO
CORRISPONDE SEMPRE UNA REALIZZAZIONE TRAMITE UNA DETERMINATA
CATEGORIA SINTATTICA: LA SELEZIONE C (CATEGORIALE) è DETERMINATA DA
SELEZIONE S (SEMANTICA) (es. agente sempre realizzato da SN, nella passiva
compl. d’agente si realizza come SP poiché non è argomento ma circostanziale)
PRINCIPIO DI PROIEZIONE
Esiste una corrispondenza biunivoca tra argomenti e ruoli θ.
Ogni argomento ha un ruolo θ ed uno solo, ed ogni ruolo θ è
assegnato ad un argomento ed uno solo.
Le proprietà delle entrate lessicali si proiettano sulla sintassi
della frase.
Garantisce che le proprietà delle entrate lessicali siano
mantenute durante tutta la derivazione della struttura
(trasformazione da struttura p a struttura s) : per esempio
garantisce la traccia mentale non realizzata foneticamente
ma obbligatoria per il principio di proiezione. (es.: chi1 prevedi
che Gianni incontrerà t1 a roma?) [dove chi non è argomento
ma operatore e quindi il tema obbligatorio per il verbo
incontrare e realizzato da un SN lascia la traccia]
Tale principio ci permette anche di verificare la
grammaticalità di una frase poiché possiamo riscontrare la
mancanza di ruoli obbligatori per esempio.
reggenza
Relazione sintattica altamente astratta che sussiste tra un elemento
“reggente” ed uno che viene retto.
Gli elementi reggenti sono tutti quelli che possono essere le teste lessicali
di un sintagma (N, V, A, P) e la categoria flessionale (fless) finita (ciò
significa che deve esserci il morfema attaccato al verbo che contiene
tempo e accordo = “Mary plays the play” dove plays indica sia tempo
presente che genere sing.; mentre nel caso di “he considers Mary to play
the piano” dove play è privo di flessione e preceduto dal marcatore
infinitivale to).
PRINCIPIO DELLA REGGENZA PROPRIA = le categorie lessicali reggono
“propriamente” mentre le categorie non lessicali no. Quindi N, V, A, P,
sono automaticamente elementi che reggono propriamente, mentre
FLESS non lo è.
Influenza unidirezionale dall’elemento reggente verso l’elemento retto.
(es. Prep. A regge SN e quindi pronome prende forma me e non forma
io).
Oltre al principio di proiezione dove vengono definiti i ruoli assegnati agli
argomenti di un’entrata lessicale, grazie alla reggenza vengono ora
assegnati:
1) caso (teoria del caso) determinati casi vengono assegnati a
determinate posizioni di una struttura (es. viene da me e non da io)
Parametro del soggetto nullo o
parametro pro-drop
Etichetta pro che rappresenta il soggetto
fonologicamente vuoto che è presente in queste frasi e
da to drop che significa “lasciar cadere”. Riguarda il fatto
che in una lingua siano possibili o meno delle frasi
dichiarative senza che compaia un soggetto (frasi a
soggetto nullo o senza soggetto).
PRINCIPIO DELLA CATEGORIA VUOTA = indica una
categoria vuota in generale che può essere
1) quella della traccia t di un movimento
2) quella determinata dal PRINCIPIO DI PROIEZIONE ESTESO
che assume che tutte le lingue debbano avere un
soggetto.
“UNA CATEGORIA VUOTA DEVE ESSERE PROPRIAMENTE
RETTA”
Qualsiasi categoria vuota che sia t (traccia movimento) che
pro (caduta soggetto) deve trovarsi in relazione strutturale di
reggenza.
In altri termini per avere una frase a soggetto nullo ci deve
essere un elemento che regge propriamente il soggetto (e
quindi anche se non realizzato ne deve dar conto
foneticamente):
Es.: in italiano: sono a Torino
implica che la categoria
fless. può reggere propriamente la categoria vuota pro: pro
sono a Torino.
Es.: in inglese: speak dove la categoria fless. non è in grado di
comportarsi come una categoria lessicale e quindi non regge
propriamente la categoria vuota pro dando luogo ad una
frase agrammaticale.
Es.: in italiano: parla dove categoria fless. ha tratti nominali
quali lei/lui, sing.
Solo le lingue che contengano FLESS come elemento in grado
di reggere propriamente permetterà dei soggetti nulli (la
categoria fless. deve contenere dei tratti nominali)
Principio del Legamento (forma di
reggenza)
Si chiede se determinate espressioni all’interno di una frase
possano o meno riferirsi alla stessa entità alla quale si
riferiscono altre espressioni.
Riguarda il modo in cui i pronomi e altri tipi di nomi si
pongano in relazione uno con l’altro. (condizioni nelle
quali due espressioni possono essere coindicizzate)
Le classi di parole implicate sono:
1) espressioni referenziali
2) anafore
3) pronomi liberi
PRONOMI
PRONOMI PERSONALI = io, me, mi, tu, te + pronomi riflessivi
PRONOMI CLITICI = mi, ti, lo,la, ci, vi, li,le.
1) ricorre in posizione rigida (non può ricorrere nella posizione
in cui sono gruppi nom. o pronomi liberi dotati della stessa
funzione)
2) posizione condizionata dal verbo a cui sono collegati
(proclitici se lo precedono, enclitici se lo seguono)
3) non può comparire in isolamento
4) non possono essere coordinati tra loro
PRONOMI LIBERI = me, te, lui,lei, noi, voi, loro
Uso deittico = il loro riferimento è interno all’enunciato ma non
esplicito.
Uso anaforico (personali possono essere deittici mentre
riflessivi sempre anaforici)= rimanda ad elemento presente
all’interno della frase detto ANTECEDENTE.
1) ESPRESSIONI REFERENZIALI: la loro referenza è
necessariamente basata su qualcosa che si trova all’esterno
della proposizione, non su qualche elemento interno.
Es.: Aldo sparò a lui (Aldo è una porzione di linguaggio messa in
relazione con una porzione del mondo postulato)
2)ANAFORE : hanno antecedente all’interno della
proposizione di cui fa parte
Es.: Aldo sparò a se stesso (se stesso ha lo stesso indice di Aldo, si
riferiscono alla stessa entità) però: Oscar disse che Aldo sparò
a se stesso (se stesso non può che essere riferito ad Aldo, non
ad Oscar).
3) PRONOMI (personali): non hanno antecedente nella
proposizione. Hanno antecedente all’esterno oppure in
un’altra proposizione
Es.: Aldo sparò a lui (lui non ha come antecedente Aldo)
Es.: Oscar disse [che Aldo sparò a lui] (dove lui ha come
antecedente Oscar che si trova in un’altra proposizione).
DIFFERENZA ESSENZIALE TRA ANAFORE,
PRONOMI E ESPRESSIONI REFERENZIALI
Concetto di proposizione diventa dominio locale= dove prop. È
solo un esempio.
Per es.: Marta vedeva [se stessa correre sulla neve] dove
apparentemente anafora non è legata alla proposizione però
tale prop. È infinitivale e ha come sogg. Un’anafora . Quindi non
c’è relazione di reggenza tra fless. non finito e sogg. Quindi va
inteso come dominio locale non solo la prop. Incassata ma
anche la prop. Principale.
1) anafora è legata in un dominio locale
2) pronome è libero in un dominio locale
3) espressione referenziale è libera
Tale principio si integra con le specificazioni di tipo lessicale
poiché i principi dipendono dalla conoscenza di quali parole
sono anafore e quali pronomi.
Ancora una volta stretta relazione tra sintassi ed elementi
Teoria x-barra
La struttura sintagmatica è un sistema per cogliere le
relazioni strutturali della frase per mezzo del concetto
“consiste di”. Un sintagma consiste di uno o più costituenti.
La struttura sintagmatica della frase è una gerarchia in cui
ogni costituente consiste successivamente di altri
costituenti, finchè restano solo elementi non espandibili
ulteriormente.
Nella teoria x-barra si afferma che ogni sintagma è
conforme ad alcuni requisiti:
1) sintagmi sono endocentrici = ogni sintagma contiene
almeno una testa
2) la testa di un sintagma deve appartenere a una
determinata categoria in relazione al tipo di sintagma (es.
un sintagma nominale contiene una testa nominale: SN
N
3) ci sono 4 tipi di sintagmi lessicali: SN, SV, SA, SP.
4) ogni sintagma consiste di una testa lessicale (S,V,A,P,) e di
altri elementi che a loro volta sono sintagmi:
Es.: geloso di Maria = SA = A [geloso] + SP[P[di] + SN[maria]
La teoria x-barra sostiene che il livello sintagmatico (SX, in cui X
sta per qualsiasi categoria lessicale) non è sufficiente a
cogliere tutti i dettagli della struttura ma che è necessario un
livello intermedio:
Es.: saluta suo figlio dalla finestra = SV = V (saluta) + SN (suo
figlio) + SP (dalla finestra)
In questo schema non si distingue tra la relazione che
intercorre tra saluta e suo figlio dove salutare è verbo transitivo
(monovalente) e richiede argomento e la relazione tra
salutare e dalla finestra dove dalla finestra è solo elemento
facoltativo aggiuntivo (circostanziale)
Sembra quindi esserci un livello intermedio che rende conto di
queste relazioni: C’E’ UNA PROIEZIONE DI V SEGNALATO CON
V1 :
SV
V1
SP
dalla finestra
V
saluta
SN
suo figlio
La sintassi X-barra prevede un livello intermedio per tutti i
sintagmi.
Si chiama teoria X-barra perché a seconda del livello di
espensione vengono assegnate le barre: il livello più alto
possiede due barre, livello intermedio una barra e la testa zero
barre: SN = NII, mentre N= testa.
Ogni sintagma è costituito da una testa e da una serie di
complementi (sintagmi completi) determinati dalle proprietà
lessicali della testa.
La struttura X-Barra deve includere il livello in cui si coglie la
relazione tra testa di categoria zero e il suo complemento:
XI = X + COMPL / COMPL + X (posizione dipende dal
parametro testa)
Bisogna inoltre segnalare che i sintagmi hanno anche un terzo
elemento principale cioè SPECIFICATORE (art. o pron.
Dimostrat.) che stanno al fianco di XI
XII = XI + SPECIFICATORE / SPECIFICATORE + XI
Si ha quindi una successione di
specificatore + sintagma principale +
compl.
Si aggiunge sintagma flessionale che
porta morfema grammaticale in alto
Si ha poi sintagma complementatore
per prop. Incassate.
Bibliografia di base
Si segnalano i seguenti manuali di base da cui sono stati tratti esempi e
definizioni:
1) Graffi-Scalise, Le lingue e il linguaggio, Il Mulino, Bologna, 2002
2) Cook-Newson, La grammatica universale, Il Mulino, Bologna, 1988
3) Graffi, Sintassi, Il Mulino, Bologna, 1994